IL VOLO DI UNA BAMBINA CHIAMATA ARI

IL VOLO DI UNA BAMBINA
CHIAMATA ARI
PEFAZIONE, ANTEFATTO ED INTENZIONI CON PIANO DELL'OPERA
Oggi è il 30 dicembre 2012. sono le 14 e 07
Avevo prenotato un posto in prima fila per la fine del mondo prevista da un sacco di ' visionari ', anche antichissimi, per il 21-12-2012 ma evidentemente questo evento da me e da altri tanto atteso ed auspicato, non si è svolto.
Stamattina, veramente era quasi mezzogiorno quando sono riuscita a scuotermi dal mio torpore, che sonno non è ma neppure veglia, e mi sono trovata ancora una volta con una lunga giornata davanti a me, e probabilmente una lunga vita.
Non ho voglia di nulla e di nessuno.
Né di parlare né di vedere nulla e nessuno.
Ho una tristezza infinita dentro ed il dolore del mio corpo spezzato che mi rode e mi morde, come fa da tanto, troppo tempo, ventiquattrore su ventiquattro.
I pensieri suicidi sono costanti e ricorrenti, sono veramente l'unico mio desiderio.
Ma a contrapporsi hanno due potenti forze.
La prima è sapere che con il gesto estremo della rinuncia alla mia vita molti soffrirebbero e questo ancora mi dispiace.
È evidente che non sono ancora arrivata a quel punto, dove sono arrivata dieci volte nel corso della mia vita, in cui non mi dispiace più assolutamente di nulla.
La seconda forza sono proprio i dieci tentativi falliti che ho lasciato dietro di me.
Per raccontarvi il tutto, trascrivo qui una lettera che scrissi l'anno scorso alla donna che amavo ed ancora, ahimè, amo e che mi aveva accusato, come d'altronde molti altri prima e dopo di lei, di aver messo in scena ognuno di quei tentativi con due precisi intenti.
Il primo era creare una storia di pazzia alle mie spalle e quindi avere la pensione di invalidità..... e oggi penso sorridendo che basterebbe un pensiero del genere per essere dichiarati irrimediabilmente e definitivamente pazzi!
Il secondo motivo è quello di attirare l'attenzione su di me e ricattare chi, di volta in volta, si voleva allontanare da me interrompendo la relazione amorosa, costringendolo quindi a ritornare sui suoi passi..... ed anche questo è un motivo di gran lunga più folle dei tentativi di suicidio in se stessi!!!
Sicuramente se una persona arriva a farsi così tanto male con un intento del genere non ha più nessuna rotella che gira per il verso giusto.
No, io volevo ASSOLUTAMENTE MORIRE.
Ma non ci sono riuscita ed in modo davvero incredibile.
Quindi le scrissi questa lettera per cercare di spiegarle cosa c'era nella mia mente.
Febbraio 2012
Mi hai detto: "Quando uno vuole morire sa come e cosa fare e non si fa ricoverare in ospedale."
Rispondo....
Quando una persona decide di togliersi la vita, in quel momento è ancora viva.
È un morto che pensa, che cammina.... ma è ancora vivo.
La paura è un sentimento atavico, che ti resta nella carne: anche quando hai abbattuto l'ultima barriera, lei è ancora lì.
Quando decidi di ucciderti vedi tutto nella tua mente:
Vedi il tuo corpo esanime. Chi lo troverà, o almeno chi pensi lo potrà fare. Vedi i congiunti che piangono. Il funerale solitario. Senti nella testa i pensieri di tutti. Sai cosa c'è stato tra te e coloro che ti hanno abbandonato. Sai cosa proveranno quando si troveranno di fronte alla tua morte. Sai benissimo che oltre a punire te stessa stai punendo anche loro.... ed in parte ti togli la vita proprio per quello. Solo in parte, ma anche quello è uno dei motivi per i quali arrivi a fare quel gesto.
Eccetto forse per chi si toglie la vita in un gesto di follia immemore e allora non ha pensieri, almeno.... non credo, non lo so, perchè a me non è mai successo, io ho solo un vuoto che grida. Poi c'è anche chi si toglie la vita per i sensi di colpa, che è ancora tutta un'altra cosa..... ma non è il mio caso.
Sembra impossibile ma ci siano cose di cui anche uno che sta per suicidasi ha paura, ma è così.
Nei giorni, o mesi, durante i quali tu pensi al tuo gesto, passi in rassegna i vari modi possibili.
Ma ci sono cose che non puoi fare....
Gettarti da un ponte, per esempio.
A parte il fatto che ci sono persone che sopravvivono a cadute da grandi altezze..... ho conosciuto una ragazza che si era buttata dall'ottavo piano.
Era tutta storta e distrutta, sfigurata in viso, zoppa, deforme, ma viva e camminava pure! Ottavo piano..... che dici, sono pochi per morire, otto piani sul cemento?
Ebbene, io di quello ho paura.
Da ragazzina mi buttai per un tuffo da circa otto metri di altezza. Quegli otto metri furono infiniti. Li risento ancora tutti dentro di me. Avevo sedici anni, ne sono passati quaranta.
Ma li sento ancora. Quando toccai il pelo dell'acqua il dolore fu molto grande, deflagrante. Non mi ferii nè altro, solo perchè sono molto forte. Ci sono persone che hanno perso la vita per cose così. Io non mi feci nulla, ma non potrei mai più gettarmi volutamente da una certa altezza, almeno non in condizioni di facoltà mentale.
Una corda attorno al collo e poi giù.
Anche a quello ci sono persone che sono sopravvissute.
Ma passi due o tre minuti in agonia se non ti si spezza l'osso del collo immediatamente.
E con la fortuna che ho io, di sicuro non si spezzerebbe.
Due tre minuti di agonia. Senz'aria....
Sempre da ragazzina una volta rischiai di annegare: mi ero immersa in apnea ed ero entrata tra gli scogli sott'acqua. Incontrai una piccola caverna sommersa e mi ci infilai dentro. Poi cercai di tornare indietro ma per un lungo attimo non riuscii ad orizzontarmi. Infine, con un ultimo guizzo, cambiai direzione e ritrovai la via per uscire. Rimasi sotto quasi due minuti. Me lo dissero gli amici terrorizzati che mi videro finalmente riemergere. Ero allenata allora, un minuto e trenta secondi era un'apnea normale per me... Quella volta uscii sul pelo dell'acqua all'ultimo secondo possibile. Ancora pochissimo ed avrei aperto la bocca, avevo la maschera, ed avrei respirato acqua. Perché ci sono movimenti in cui, alla fine, non puoi evitare di farlo.
Infatti chi muore annegato ha i polmoni pieni d'acqua. L'ultimo disperato gesto del corpo è cercare di respirare e così respiri l'acqua nella quale sei immerso.
Quei trenta quaranta secondi che passai senza ossigeno, li ho impressi indelebilmente nella carne anche quelli.
Non posso pensare di affrontare due tre minuti di quella agonia, appesa ad una corda, non posso pensare al mio viso livido e sfigurato dopo la morte.
Ci sono cose di cui anche un suicida ha paura.
Un revolver.
A parte il fatto che che bisogna procurarselo e senza soldi non è poi così facile....
A parte che ci sono moltissime persone sopravvissute a colpi di pistola.....
Una volta tenni in mano il revolver di Antonio, il mio secondo marito, era freddo, gelido, quel metallo, ma era incandescente nelle mie mani!
Così pesante che non riuscivo a sostenerlo, pure se pesava meno di mezzo chilo ed io ne sollevavo facilmente cinquanta a quei tempi.
Lo riposi e lo obbligai a nasconderlo, smontato. Poi glielo feci riportare a casa dei suoi genitori. Io e quell'arma non potavamo vivere sotto lo stesso tetto, sentivo la sua presenza, nel fondo dell'armadio dove era stato riposto, m'inseguiva, sentivo il suo freddo peso nelle mie mani.
Non potrei sparami, mai. Chissà, forse un retaggio delle mie vite precedenti, può anche essere.
Ho sempre scelto due modi.
Le pillole, perchè ti addormenti. e te ne vai. Una morte dolce. Voglio morire per smettere di soffrire, non per soffrire di più! Cerco la pace a questa agonia che ho dentro.
Ma non è mai stato così, anzi, in due occasioni ho avuto delle convulsioni tremende, non le auguro al peggiore dei miei nemici!
Soprattutto l'ultima volta, quella di ottobre duemilaotto.
12 ore di convulsioni, che sono immemori a livello conscio, a parte le prime, ma che il mio corpo ha registrato e ricorda.
Quella volta ingerii 850 pillole, non le ho contate io, mi è stato detto dopo, le hanno contate loro, dalle scatole vuote.
Più di trecento erano di Gardenale.
Quando entrai in coma, dodici ore dopo, e dico: dodici ore di convulsioni e poi il coma!!! Proprio allora, o forse qualche ora dopo, perchè non si erano accorti del mio stato e credevano che finalmente dormissi.... mi avevano ulteriormente sedato, dopo avermi tenuta legata al letto di costrizione per dodici ore, aggiungendo il sedativo al Gardenal!! Solo quando Ale, cercando il mio telefono, salì nella stanzetta in soffitta dove avevo ingoiato le pillole, trovò la montagna di scatole vuote, le mise in una busta e le portò a quei beduini, che non mi avevano fatto neppure un tossicologico dando per scontato che fossi semplicemente fuori di me per isteria e non per le convulsioni.... solo allora si accorsero che ero in coma!!
Nessuno sopravvive. Lo dissero chiaramente che era impossibile! Quando mi fecero la lavanda gastrica, era già passato troppo tempo, circa quattordici/quindici ore, e lo stomaco era vuoto, i medicinali tutti in circolo..... sei giorni di coma.
Eppure sono sopravvissuta.
Sono entrata nella morte, l'ho vissuta, la ricordo e l'ho descritta. Per tutti i sei giorni di coma, ho sorriso. Chiedilo ad Ale o a Maietta, che si sono alternate al mio capezzale.
Mi sono svegliata sorridendo.
Nessuno sopravvive, io si.
Mi hanno rimandato di qua.
Il taglio delle vene.
Quello lo posso fare.
É un dolore che fa bene in quel momento!
La prima volta ero stata ricoverata in psichiatria nel 2001 e non avevo lo strumento adatto. Usai uno specchio rotto. Ma mi trovarono gli infermieri che non avevo ancora finito il taglio e mi ferii soltanto.
Precedentemente avevo ingerito anche degli psicofarmaci, non ero pratica e pensai di averne presi molti, mentre non furano sufficienti. Quella volta il mio fu un tentativo confuso, stavo male, ero sotto l'effetto di psicofarmaci e all'inizio delle cure, quindi non capivo un granché. Volevo semplicemente morire, ma non sapevo cosa stavo in effetti facendo.
Le volte successive invece ero completamente lucida.
La seconda volta è narrata nel mio libro "Io non sono di qui".
Ma anche lì una telefonata di Dana allertò il proprietario del campeggio, che chiamò i soccorsi.
Il dissanguamento, che per la maggior parte delle persone sarebbe stato più che fatale, per me non era ancora terminato. Sono troppo forte.
La terza volta la stessa cosa, mi trovò la direttrice del centro di accoglienza e mi raccontarono che il letto era completamente intriso di sangue.... ma neppure quella volta mi fu dato di morire. Passò tutta la notte prima che mi trovassero. Mi tagliai le vene all'una e mi trovarono alle otto passate di quel mattino.
Ricordo le lacrime della direttrice quando, qualche giorno dopo, forse due, me la trovai di fianco al letto, mentre ero ancora semincosciente. Per il resto non ricordo nient'altro che la fase attiva del taglio, effettuato all'inizio nel lavandino del bagno e alla fine nel mio letto, per poi avvolgermi negli asciugamani.
Anche quelle due volte non avrei dovuto sopravvivere, nessuno sopravvive a cose simili...... io si!
Ho visto molti animali morire col veleno per i topi.
Non c'è nulla da fare!! E' un veleno che non perdona, quando sono passate sei ore dall'ingestione non c'è più nulla che si possa fare, perchè il sangue si decoagula e si creano emorragie interne inarrestabili.
Ricordo l'autopsia su un cane, fatta nella clinica veterinaria dove facevo assistenza quando studiavo e avevo ventun anni.
Aprimmo l'addome di quel povero cucciolo di pastore tedesco.
Lo feci io: m'insegnavano ad usare il bisturi su animali già morti.
Fui inondata dal sangue che quel povero animale aveva accumulato nella cavità addominale, era stato curato per due giorni, ma morì lo stesso.
Quel tre aprile 2011 io feci il conteggio su internet della mia dose letale. Una proporzione fra i grammi di veleno per i dieci chili della povera bestia e me, risultato: una dose di trecento grammi di quei granuli doveva essere più che sufficente.
Io ne ho ingerito cinquecento..... per sicurezza.
Ci ho messo sei ore per farlo.....più o meno... ci sono i miei scritti che lo raccontano, basta rileggerli. Molte ore, comunque. Ho cominciato dopo le due del pomeriggio.. più o meno.
Anche di questo non sono sicura, se le due, l'una o le tre.... lì attorno, non sono certo momenti in cui guardi l'ora.
Primo pomeriggio insomma ed Ale è arrivata all'una di notte, più il tempo che arrivasse l'ambulanza e giungesse all'ospedale, ho rifiutato anche il comune sale, non ho preso neppure un bicchier d'acqua, neppure un'iniezione... per tre giorni.
Non è successo nulla.
Non sono neppure andata in coma.
Nulla di nulla.
Allora ho accettato la vitamina kappa, perchè, nel frattempo, ero uscita dal trip suicida e il pensiero di te e le lacrime di chi mi stava intorno mi hanno spinta a farlo.
Così mi hanno sedato e fatto la lavanda gastrica, come se servisse dopo 3 giorni, la dottoressa della rianimazione non voleva neppure farla, disse: "è troppo tardi."
Ma lo psichiatra le rispose: "fai il tuo lavoro."
Non riuscii ad ingerire il tubo e così mi sedarono.
Lo stomaco era vuoto, e per forza!! erano passati tre giorni!!
Quando cominciai ad espellere quella roba le feci erano blu e per diversi giorni restarono di quel colore.
Nessuno sopravvive. Io si!
Perché sono andata in ospedale?
Ricordo la voce del proprietario del campeggio, quando mi trovò: "oh, mio dio, no....."
Anche allora ero incosciente, ma sentivo.
Non so come sia possibile, ma è così.
Ricordo il viso di pietra di mia figlia quando chiamò l'ambulanza, la prima volta, nel 2001.
Ricordo il viso di Monica quando mi trovò nel letto tra urine e vomito, la volta delle 350 pillole, maggio 2008, tra il primo taglio delle vene, agosto 2007 e il secondo, agosto 2008.
Anche quella volta lo feci di notte. Bevvi del vino per ingerire le pillole, psicofarmaci potenti, compreso parecchioTavor.
Me lo prescrivevano ma io non lo assumevo. C'erano anche En e Rivotril. Farmaci letali: di En ne ingerii tre bottigliette. Più le pillole e il vino, che dovrebbe essere incompatibile con quei farmaci. Forse l'aver vomitato mi salvò, ma che ne so...
Quando ingerii il veleno per topi non volevo che i vicini mi trovassero e mi avrebbero trovato loro.
Secondo le mie previsioni sarei andata in coma nel giro di un paio d'ore e quando chiamai Ale già cominciavo già a sentirmi male. Non volevo traumatizzare delle altre persone innocenti e poi c'era Gine..... Ricordai Jerome che abbaiava e non voleva far entrare i soccorsi quando mi tagliai le vene in campeggio, poi arrivò una bambina della quale era amico, lo fece uscire e lo legò. Lui abbaiava ed era così furioso e il proprietario del campeggio mi disse di aver pensato d'abbatterlo.
Non volevo che Gine soffrisse, non lo merita.
Così ho pensato di andare a morire dignitosamente in un letto d'ospedale, senza sconvolgere nessun altro.
Non lo credi? Fai tu.
Nessuno sopravvive, ma io si.
Perché???
E che ne so, cazzo.
Che ne so.
Dio solo lo sa se vorrei essere finalmente morta.
Ecco, più o meno i pensieri che compongono questa seconda potente forza che mi separa dal suicidio sono questi: come farlo senza soffrire troppo e come riuscire a morire, sapendo di aver messo in atto azioni oltre il limite ultimo ed estremo per lo standard di un essere umano senza essere morta!!
Mi dico che può accadere ancora?
Non posso più affrontare altri ricoveri in psichiatria o altre sofferenze inutili.
Mi chiedo perché.
Mi chiedo cosa, Dio, la vita, il destino, vogliano da me.
Stamattina ho pensato al primo comandamento:
Io sono il signore, Dio tuo. Non avrai altro Dio all'infuori di me.
Non ho mai rispettato questo comandamento e non mi basta essere certa della sua presenza per essere felice.
Le donne e gli uomini che ho amato sono stati per me, volta dopo volta, il mio Dio.
In altri casi il mio Dio è stata la mia mente, la mia intelligenza.
Alle volte mi dico che forse è proprio questo che devo imparare: ad avere come unico Dio quello che mi sta imponendo la vita, in ogni modo, anche contro la mia volontà.
Ma i giorni sono lunghissimi.
Il dolore del mio corpo spezzato è forte e continuo.
Il tormento esteso.
Il dolore della mia mente sovreccitata, immenso.
Il senso di vuoto e di solitudine, spaventoso.
Il nonsense della mia esistenza, totale.
Ma, sopra a tutto c'è il dolore per questa donna, che amo così teneramente, come una figlia, e che mi odia così tanto per quello che le ho fatto.... è devastante. E lo sento dentro di me.
L'ho scritto e lo riscrivo:
è una spada rovente che rovista eternamente nelle mie viscere.
Ora quella voce mentale, quel maestro interiore che mi obbliga a fare le cose, mi sta dicendo da mesi, o forse da sempre, che devo redigere questa mia autobiografia.
Ho appena terminato di scriverne uno stringato riassunto, che comunque è venuto lunghissimo, e l'ho intitolato:
UNA BAMBINA CHIAMATA ARI.
Avevo già iniziato questo lavoro a marzo di quest'anno in una parziale stesura intitolata
"IL VOLO DI ARI", poi interrotta per problemi vari con le persone di cui parlo e che hanno fatto parte integrante della mia vita, almeno dal mio punto di vista!!
Si arrabbiano con me per quello che scrivo, nonostante io stia usando un nome d'arte diverso dal mio ed abbia cambiato anche i loro nomi per mantenerle nell'anonimato......
Oggi ho deciso: comincio una stesura totale di quanto da me scritto in prosa e lo unirò seguendo l'ordine cronologico dello svolgimento dei fatti che narro.
Il risultato sarà un libro poderoso, perché conterrà tutto quanto da me scritto, anche i libri già pubblicati o qui resi pubblici.
Aggiungerò anche altro.... tutto quello che mi verrà in mente man mano!
Perchè??
Così, per avere qualcosa da fare, o forse per obbedire a questa tirannica voce interiore, o per allontanare da me progetti suicidi... o solo perchè è la mia vita!
Così dò inizio a questa opera che intitolo:
IL VOLO DI UNA BAMBINA
CHIAMATA ARI
Ma ho bisogno di un pubblico che mi legga.
Se ti piace leggere ed hai letto qualcosa di me, questa è l'occasione per leggere tutta la mia prosa in un colpo solo.
Se hai già letto tutto o buona parte, ricomincia.
Le riletture sono sempre foriere di nuove suggestioni ed illuminazioni.
Grazie se lo farai e se non lo vuoi fare che ci fai qui?
Io scrivo per te.
Mi sto chiedendo se in questo momento sei tu, il mio Dio.
Credo di no. Non mi dà felicità scrivere, anzi, è un compito, un obbligo tormentoso e tormentato.
Ma comunque scrivo per te.
29 novembre 2014
mi accorgo, tornando qui dopo molto tempo, che ho lasciato questa mia opera incompiuta, così, sospesa a metà di un capitolo..
ma, da allora, non sono stata più in grado di portarla avanti..
per terminare questa mia autobiografia, o almeno arrivare fino al 2012, quando avrete finito di leggere qui, andata all'autobiografia breve, ' UNA BAMBINA CHIAMATA ARI ' cercate il momento in cui mi sono interrotta e continuate lì..
so, o almeno credo, che, prima o poi, terminerò questa opera.. ma quel tempo non è ancora giunto..
e di questo vi chiedo di scusarmi...
vi abbraccio con gratitudine ed affetto....
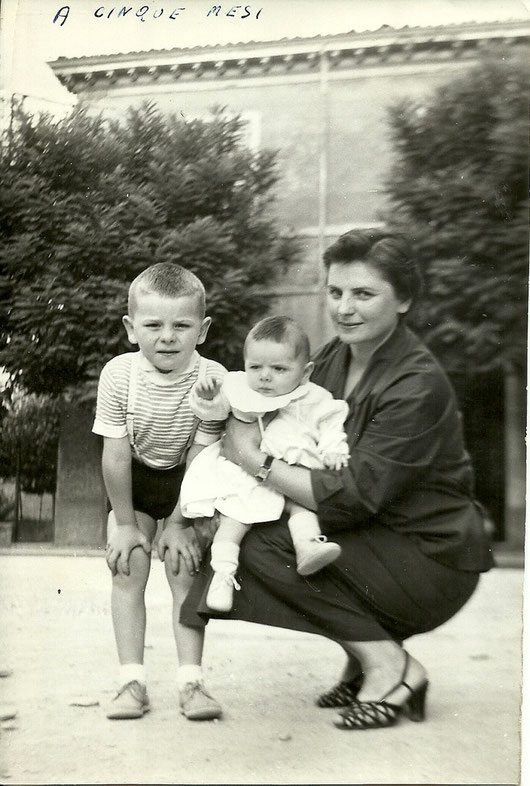
CAPITOLO PRIMO
Si comincia
Oggi è il 31 dicembre 2012.
A 57 anni 10 mesi e 30 giorni dall'inizio di questo mio viaggio mortale, vedo ormai delineato, e quasi del tutto scritto, il racconto della mia vita, questo volo di un angelo che nulla e nessuno ha saputo sporcare o spezzare.
Questo angelo che non sono io, Ari, ma che è dentro di me e che si è vestito di questo sfortunato e doloroso karma umano per spezzare le sue catene, espandendo questa energia di rinnovamento in ogni direzione, temporale, spaziale e dinamica.
Sento che devo fare questo.
Lo sento e lo so da sempre, sin da bambina, quando, ancora alle elementari comprai un quaderno a righe e scrissi un titolo: "Le avventure di Lucky, cucciolo coraggioso."
Non scrissi altro, ma sentivo, sapevo che quel libro lo avrei dovuto completare.
E sapevo anche che quel cucciolo coraggioso e sfortunato ero io.
In questa mia autobiografia racconterò quanto mi successe, cercando di ritrovare la me stessa di ognuna di quelle avventure e lo farò come se lo stessi raccontando ad un fantomatico ascoltatore, rivolgendomi a lui in prima persona.
Ma questo è un lui cumulativo di maschile e femminile.
Un termine che non esiste mentre invece bisognerebbe inventarlo. Alcune lingue hanno il neutro, ma per far riferimento ad animali e cose... anche qui io ho qualcosa da eccepire: un animale non è una cosa e anche se sono fermamente convinta che pure le cose possiedano un'anima ed abbiano un loro modo di comunicare con noi, per gli animali è diverso: sono esseri superiori a noi, connessi con l'Uno in maniera totale e diretta, mentre noi abbiamo il peso di una mente affogata nelle illusioni da dover superare, prima di poter giungere a questa fusione.
Quindi vedo la necessità di coniare un termine che indichi lui e lei. Ci penserò su e cercherò di trovarlo.
Tornando al discorso sulla mia autobiografia, dato che alcune pagine sono già state scritte e non serve che aggiunga altro, le integrerò qui, indicando la fonte dei miei vari scritti da cui le ho tratte.
Infatti comincio questo mio lavoro con l'antefatto del mio romanzo–diario "Io non sono di qui."
Questo scritto è stato composto nel maggio 2007, nella mia roulotte, quando Dana mi disse che non mi amava perchè amava Elisa, ma che avrebbe accettato di continuare a fare l'amore con me...... direi che si adatta quasi perfettamente alla mia situazione odierna.
A distanza di cinque anni e mezzo mi trovo ad un punto della mia vita assai simile.
Anche se diverse differenze esistono: ora so chi sono e cosa sono venuta a fare qui. Allora non sapevo dell'esistenza di questo angelo dentro di me e inoltre so per certo di aver concluso il mio percorso riguardante i rapporti di coppia.
Ho imparato a stare da sola.
Ho imparato la differenza tra il sesso e l'amore.
Ho imparato a scegliere quello che voglio veramente e non ad accontentarmi.
Inoltre so che mi resta solo il compito di darne testimonianza.
CAPITOLO SECONDO
Lo specchio opaco
Solo attraversando il più intenso dei dolori, la peggiore delle paure, il più profondo sconcerto, la più acuta disillusione, si arriva veramente al fondo di sé, ci si spoglia di tutte le maschere e si resta nudi come bambini, puliti come coloro che non esistono e che non possiedono niente, puri come chi non ambisce a nulla, nuovi come chi non sente il desiderio di ricominciare, tranquilli come chi non deve aspettare.
Molte volte ho ripreso da capo la mia vita senza accorgermi che, in effetti, il mutamento che apportavo era solo un cambiarsi d’abito e mi sono accostata alle mie speranze e ai miei sogni con la certezza che li avrei raggiunti, che ce l’avrei fatta, che sarebbe stata la volta buona.
Ma regolarmente ogni volta mi sono infranta su completi disastri e fallimenti.
Io non so capire gli altri e non so farmi capire dagli altri.
Ho sempre avuto un forte bisogno di conferme dalle persone che mi sono state intorno, necessità di apprezzamenti, di riconoscimenti, come se tutte le mie azioni non avessero valore in quanto tali, ma solo agli occhi degli altri.
Sono sempre andata incontro alle persone che via via ho conosciuto, sempre affamata del consenso altrui, sempre condizionata dall’attenzione che gli altri erano disposti a concedermi.
Per questo motivo mi sono trasformata in una persona dal carattere accondiscendente, tranquillo e refrattario ai litigi, ma la mia tensione interiore, la mia profonda insicurezza, il non vedermi e il non conoscermi se non riflessa negli occhi di qualcun altro, ha finito per rendermi troppo esigente.
La mia totale disponibilità, la mia totale abnegazione in tutto quello che ho affrontato – lavoro, relazioni interpersonali, amicizie, legami sentimentali e sessuali – diventava così difficile da contraccambiare che, dopo un certo lasso di tempo, ognuno si è allontanato da me, in apparenza non per colpa mia, sempre senza accuse precise, senza litigi: così, solo per il fatto che ero insostenibile.
Io non so camminare sulle mie gambe, non so stare da sola.
Se non ho una persona alla quale pensare, se non ho qualcuno a cui scrivere poesie, se non ho qualcuno da aspettare, io non mi sento viva.
Oggi io ho rotto i rapporti con il genere umano.
Non chiederò più amore a nessuno. Non mi aspetterò più di essere cercata, compresa, capita, apprezzata, amata, perché io non rappresento nulla di tutto ciò.
Questo è il mio karma.
Oggi lo vedo chiaramente e lo accetto.
Non desidero più morire. Desidero vivere così, da sola come in effetti sono, facendomi compagnia, senza aspettare niente, senza dare niente.
Così non mi sentirò più incompresa e rifiutata.
Non coinvolgerò più nessuno nella mia vita, non deluderò e non asfissierò più nessuno.
Scruterò nella mia mente, scoprirò quello che c’è dentro.
Capirò quello che sono, quello che faccio e cosa devo aspettarmi dai miei comportamenti.
Se poi qualcuno richiederà qualche cosa da me, se riuscirò, gliela darò: qualche pensiero, qualche illuminazione, affetto e amore fisico per Dana.
Ma non c’è null’altro dentro di me se non la certezza che comunque questo mio essere ha un senso, - anche se non lo vedo e non lo capisco - e la certezza che la mia preghiera di protezione per le persone che mi stanno accanto ha un valore, ha un’effettiva necessità, perché io ho la capacità di assorbire il dolore degli altri, ho la capacità di trasmettere energia positiva.
Questo farò, ma null’altro, per il momento, finché la luce non avrà scostato le cortine del buio che mi avvolge, buio nel quale cerco una certezza.
Avendo elargito tutto sempre a tutti senza ricavarne mai niente di positivo, avendo cercato e offerto tantissimo amore senza mai essere ricambiata e senza che nessuno si sia sentito amato da me, senza che nessuno sia stato felice grazie a me, ora vedo: quello che devo fare è stare con me, non dare nulla, non chiedere nulla, non aspettarmi nulla da nessuno, vivere del sole che splende, della pioggia che cade, della terra che produce i suoi frutti, delle parole che mi sgorgano da dentro, del senso di appartenenza a un genere che non capisco ma del quale occasionalmente faccio parte, aspettando senza desiderarlo l’ultimo giorno della mia vita.
Non devo desiderare più nulla, non devo avere più bisogno di nulla e, come sono veramente riuscita a fare, non devo avere più nulla e più nessuno, affermando comunque che la mia vita ha un valore.
Sono l’espressione di una legge infinitamente saggia che in me trova un senso e una necessità e per questo semplicemente vivrò, come specchio di una mente sconvolta che afferma la sua unica verità…
PARTE PRIMA
La mia infanzia
CAPITOLO TERZO
Grida di vita e di morte Mia madre e Balena Quattrocchi
Sono nata il primo febbraio 1955 in via Natale dell'Amore.
Il mio vero nome conserva le stesse prime tre lettere iniziali del nome che ho scelto come nome d'arte, lettere che sono: Ari Ama.
Un nome, un programma..
- ciò che segue è tratto dalla seconda stesura di Io non sono di qui -
Non saper amare, non poter amare, non riuscire ad amare…
Il mio cuore: pensieri chiusi come un guscio, in una nuvola nera, in una nebbia densa che impastoia le parole.
I gesti si cristallizzano, la mano non si tende, il sorriso non nasce.
La carezza ritorna nella tasca sempre chiusa e quegli occhi che aspettano sono laghi di attesa, profondi e scuri.
Quelle labbra appena sfiorate sono archi tesi senza frecce.
Quel riso che non sgorga dalla gola è l’aborto di tutta la musica dell’universo.
Non saper amare è un buco nero.
Risucchia e inaridisce tutto dentro, prosciuga e indurisce tutto fuori.
Mia madre…
Ricordo la casa dove sono nata.
Avevo tre anni quando l’hanno demolita per costruirvi sopra e per volontà di mio padre, - ahimè -, un orrendo condomino di sette piani, nel quale ancora vivono mia madre e mio fratello con la
moglie.
Ma allora la speculazione edilizia era appena cominciata e, invece che una terrificante piaga dell’umanità, sembrava, come sempre accade al sorgere delle cose malvagie, una meravigliosa
possibilità di migliorare notevolmente il tenore di vita della gente comune.
Era una casa ottocentesca, a due piani, con la facciata di mattoni a vista, che correva con la lunghezza di due comuni caseggiati lungo una via di Imola appena fuori dalle mura del centro
storico.
Ricordo il portone d’ingresso di legno scuro con la volta e l’inferriata alla sommità, come usava allora.
L’androne era lungo e ombroso. A destra correvano le scale per il piano superiore. In fondo c’era un’ampia cucina non troppo luminosa, con il camino in un angolo e una finestra vicino all’acquaio
di granito, il tavolo centrale con le sedie impagliate e la credenza laccata color crema coi pomelli di vetro, sull’altra parete.
Vicino alla porta della cucina c’era quella che scendeva in cantina.
Per un scala stretta e ripida si accedeva a uno stanzone di due o tre vani, poco illuminati. Il pavimento era di terra battuta e le pareti di mattoni ricoperti di un graticcio di piccole e fini
canne per mascherare le fioriture del salmastro e dell’umidità.
Nella polvere erano adagiati e abbandonati materiali vari, tra i quali damigiane, bottiglie di vino, cassette da frutta e tutta una popolazione di ombre alle quali io non ho mai attribuito una
definitiva appartenenza, ma che erano vive e pulsanti, pur nel sonno della dimenticanza.
Erano creature sottilmente minacciose, anche se parzialmente addomesticate dalla protezione famigliare.
Erano odori e suoni attutiti provenienti dal passato.
Io scendevo di nascosto, col cuore in gola, per prendere bottiglie nelle quali stipare petali di rosa da far macerare nell’acqua con l’aiuto di un ago da calza rubato alla mamma e creare così la
mia personale e originalissima «acqua di rose».
Oppure staccavo dalle pareti qualche pezzetto di quel canniccio per poi salire alla finestra del bagno e soffiare via bolle di sapone, diafane e coloratissime, fragili e piene di fantasie,
attingendo acqua e detersivo per i piatti da un bicchiere che mamma mi aveva finalmente preparato, cedendo alle mie estenuanti insistenze.
L’odore della cantina mi avvolgeva come un mantello, quando aprivo la porta, ed era come se mi attirasse e mi respingesse insieme.
Era un odore vinoso e polveroso, acre di muffe e di salnitro, di terra umida e di ferraglia in disfacimento. Era l’odore di qualche topo e del nostro gatto, Giacomino.
Era qualcosa nel quale immergersi un attimo per poi scappare via, con la sensazione di aver vinto una sfida, assaporando nuovamente il profumo dell’aria fresca.
Una sfida che mi affascinava nonostante la paura provata nel lanciarla.
Io avevo un sacro terrore del buio e ho continuato a soffrirne fino all’età di ventitre o ventiquattro anni.
Ma la voce del buio mi chiamava e io mi avvicinavo a lei come attratta dal canto della mia sirena interiore.
Una volta ottenuto quello che cercavo, chiudevo trionfante e ancora allarmata la porta dietro di me e tornavo nella mia casa, quella che non
aveva sottofondi oscuri e retroscena paurosi.
Correvo allora con la canna e il bicchiere di saponata alla finestra del bagno, che si trovava nel pianerottolo, tra le due rampe di scale.
Il bagno era stato costruito in un secondo tempo ed era esterno alla casa, adiacente solo con la parete sulla quale era stato ricavato l’ingresso. C’era un piccolo sgabello tra il lavabo e la
tazza del water e io lo spostavo sotto l’orlo della finestra usandolo come piedistallo per poter far scendere le bolle e poi guardarle volteggiare lentamente e voluttuosamente verso il
basso.
Qualcuna si accendeva di un ultimo sfavillio e poi, come gonfiata dall’espansione interna del suo essere, scoppiava in uno spruzzo di goccioline.
Altre, invece, mollemente adagiate nell’aria che le corteggiava, rubavano dolci e cangianti ricordi di un arcobaleno visto chissà dove e chissà quando e si posavano sulle superfici che al piano
sottostante le accoglievano: il terreno, le foglie di una rosa, la ghiaia della corte, il ramo di un arbusto o il fiore dell’aiuola di trifoglio lilla che correva per tutto il giardino.
E dove si posava, esitava un attimo più o meno lungo, decorando l’oggetto che l’aveva accolta della sua lucida meraviglia e poi scoppiava, lasciando l’impronta di sé, che lo rendeva ancora per
qualche tempo più vivo e colorato, come se la sua essenza durasse ancora un po’ dopo la sua dissoluzione.
La mia camera da letto era invece al piano superiore, vicina a quella dei miei e di mio fratello.
Quelle stanze io non le ricordo, ma sento ancora la voce dei miei che a letto parlavano tra loro prima di dormire, mentre io ancora non cedevo al sonno e, come un fantasma, riecheggia il colore
rosa antico di una coperta matrimoniale e il bagliore un poco polveroso di un lampadario di vetro soffiato color giallo scuro e rosa, con foglioline e arzigogoli di metallo.
Nella mia camera c’era un’étagère di legno scuro.
Mi ha accompagnato nei miei spostamenti fino a non so più quale trasloco, per essere poi alla fine sacrificata all’immondizia quando ormai l’età era così avanzata che non era più proponibile
alcun tentativo di restauro.
Il nome le dava una pompa che non aveva, dato che era una piccola mensola a tre ripiani, con ciascuna delle spalliere formata da tre listarelle di legno in scala triangolare, ma raccoglieva i
miei pochi giocattoli e alcune cianfrusaglie: i miei tesori.
Così, nella mia accesa fantasia infantile, l'étagère appariva un mobile da re.
Sul lettino a una piazza, poi, c’era la cosa che mi piaceva di più della mia camera: la sopracoperta di cotone grosso e un po’ ruvido, con stampati tutti i personaggi della fiaba Bambi di Walt
Disney.
Assieme all’allegro cerbiatto, con le belle macchie bianche sul dorso fulvo acceso, c’erano la madre non ancora morta, il coniglietto e le farfalle, nascosti nella vegetazione di un bosco
luminoso e fiorito, del quale io percorrevo col dito i sentieri segreti e rubavo suoni e odori, così che i miei viaggi immaginari trovavano sempre nuovi itinerari fino a che il sonno non mi
vinceva e non mi rapiva per i corridoi dei miei sogni.
Una mattina mi svegliai e chiamai la mamma, ma la casa era silenziosa e nessuno mi rispondeva.
La luce filtrava già dalle finestre, il giorno era sorto da un pezzo, ma nessuno rispondeva al mio richiamo, che diventò un pianto e poi un singhiozzo che mi stringeva così forte la gola e il
petto da impedirmi di respirare.
Un senso di abbandono, gelido e spaventoso, invase ogni cellula del mio piccolo corpo.
Avevo due anni circa, come poi confermò mia madre nel risalire a questo ricordo.
Il tempo che trascorse finché lei, Renza, non giunse al mio richiamo mi sembrò e mi sembra ancora, rammentandolo, così vivido e presente come se lo stessi vivendo in questo momento, infinito e
intollerabile.
Poi risuonò la sua voce che mi ammoniva dalle scale di smettere di piangere e la sua presenza austera, della quale sentivo un assoluto bisogno, finalmente mi sottrasse alla morsa della mia
infinita paura.
Piangevo molto da piccola.
I seri problemi di salute dei primissimi mesi si protrassero fin quasi al primo anno di età, insieme alla penosa incertezza sulla mia sopravvivenza, e la gastroenterite che mi minava la salute mi
provocava acute sofferenze.
Nelle foto di quando avevo sei mesi si vede una piccola ranocchia – e pensare che appena nata pesavo quattro chili e duecentocinquanta grammi! – con i capelli rasati a zero, un odioso vestitino
di trine bianco e un’aria triste e sofferente, contrastante con il sorriso smagliante ma freddo di mio fratello, di cinque anni più grande di me e l’aria da azdora affaccendata ed efficiente di
mia madre.
L’azdora era, nelle campagne romagnole, la moglie del fattore o del mezzadro, che gestiva il pollaio e l’orto, custodiva la chiave della
dispensa ed esercitava il comando sui figli e spesso anche sul marito.
Era l’anima rustica e affaccendata delle nostre campagne, dove non si buttava via niente, dove la terra era generosa e l’estro del contadino molto scaltro nel ricavarne il massimo profitto.
Erano donne in carne, tornite ma non grasse, dal sorriso fiero e orgoglioso, indurite e rese asciutte dall’ambiente aspro in cui vivevano che prosperava grazie alla loro ingegnosa
operosità.
Tale sembrava mia madre a trent’anni, quando mi mise al mondo.
Io ricordo perfettamente la mia nascita, come la rivivessi ora.
Lo stanzone della sala parto era gremita dalle sue grida, che cercava di soffocare ma che le squarciavano il petto, contro ogni sua volontà. Infermieri e medici biancovestiti si affaccendavano
attorno a lei, cercando ogni nuovo o antico rimedio per farmi uscire da quello stretto canale di carne che mi stringeva come una morsa, al quale io mi aggrappavo e mi contorcevo con tutta la mia
inconscia disperazione.
A nulla servì ogni tentativo e allora ecco la maschera con l’etere togliere la coscienza alla stremata partoriente ed il coltello, il bisturi affilato, incidere il suo ventre rigonfio e maturo
come ad estrarre il nocciolo da una pesca.
La tagliarono da sotto lo sterno fino al pube ed ella ebbe il ricordo di me impresso nella sua carne come un marchio a fuoco, fatto per la vita.
Così mani estranee mi trassero da quella culla che era diventata quasi una bara, cianotica, anossica, morente o forse già morta.
E non respiravo.
Allora l'ostetrica si fece portare una bacinella di acqua molto calda ed una di acqua gelata e mi immerse ripetutamente d'alluna all'altra, sculacciandomi vigorosamente la schiena, in modo che lo
shock termico e le scossa mi obbligassero a contrarre i polmoni e ad emettere quel primo assolutamente insostituibile respiro.
Io so che non sapevo che fare, che soffrivo che avevo paura, ma che, si, respirai, ruggii tutto il mio dolore, il terrore, il mio sollievo e il mio ego, fino a liberare ogni intoppo nei miei
polmoni, nel naso e nella bocca, superando ogni ostacolo interiore solo per la volontà di esistere, di vincere quella stretta che mi voleva condurre nel regno dal quale io volevo uscire, il
grembo della morte.
E vissi, vissi , vissi.
Ma lei, la mamma mia, colei che mi aveva voluta e tenuta dentro si sé per quei lunghi nove mesi, lei, dopo che fu ricucita come un grossolano sacco di iuta ormai vuoto e riportata ancora
addormentata nel lettino della degenza, lei, fu trovata in un lago di sangue, ormai abbandonata all’oblio, alla fine, da mia zia, che, vedendola sbiancare innaturalmente, sollevò il lenzuolo e la
coperta posta pietosamente, ma invano, a riscaldarla.
Lottò tre giorni tra la vita e la morte, ma mio nonno faceva il barelliere proprio in quell’ospedale, - che da fuori sembrava più una antica villa patrizia, con scalone semicircolare ad
attorniare ai due lati l’ingresso immerso nel verde - e donava spesso il suo sangue in cambio di cibo e carne da portare a casa alla già numerosa nidiata affamata che aspettava il suo ritorno,
accontentandosi per se stesso di un quarto di vino rosso, grosso e corposo.
Quella volta egli fece dono delle sue vene alla carne della sua carne e il rubicondo suo sorriso vinse dentro le membra esauste della sua giovane figlia, strappandola ad un amaro destino,
riportandola a coloro che la stavano aspettando, tra tutti io.
Mi misero nome Arianna, - nome scelto da mio fratello in onore di una sua compagnetta che gli piaceva assai - battezzandomi in fretta e furia, così come in fretta diedero i sacramenti di morte a
mia madre, non sapendo quanto tempo ci restasse da vivere, e mi adagiarono tra le braccia di un’altra puerpera, che aveva dato alla luce il giorno prima un bel bambino, sano e bello.
Lei era una donna forte di Romagna e aveva tanto latte anche per me: io, nonostante non riconoscessi l’odore di quella pelle estranea né la voce, mi avvinghiai al suo seno turgido di fluido
vitale e lasciai che si placasse, suggendo con energia, la fame che da tante ore mi torturava, sentendo il liquido caldo entrare nella mia bocca, lievemente salato, e scendere nel mio stomaco
ormai rattrappito: latte materno caldo e vivificatore, grato di sapore e di consistenza, giusto per me.
Per tre giorni bevvi di quel nettare, ignorando l’agonia della mia vera madre e saziandomi di quell’abbondanza generosa e offerta con amore da una madre in affitto, dolce donna dal grande cuore
genitore.
Finalmente i medici decisero che Renza si era ripresa abbastanza ed era fuori dalla sua agonia di morte e quindi decretarono che fosse pronta anche ad attaccarmi al suo seno.
Così io provai per la prima volta il suo abbraccio, il suo calore, riconobbi il suo odore: mia madre.
Ma quanto dolore ancora nel suo povero corpo martoriato e nella sua mente sconvolta dalla paura e dalla sofferenza!
Le sue braccia erano rigide e non aveva sorrisi per me, poiché a stento ancora tratteneva la vita tra i denti e il suo latte, anche se abbondante, si era guastato e mi ammalò
gravemente.
Aggiungo oggi che inoltre, quando mi vide per la prima volta, la mia testa di capelli rossi la infastidì acutamente.
Detestava le persone con quel colore di capelli.
In Romagna, a ricordo dell'invasione gallica, c'è parecchia gente che ha capelli rosso carota, la pelle molto chiara, spesso ricoperta da efelidi e gli occhi azzurri o verdi o grigi.
Vengono chiamati ' gaggi ', per l'esattezza: "e gag" o "la gagia", se si trattava di una femmina.
Ebbene, mia madre detestava quel colore e chi appartenesse a quella categoria, cosi spudoratamente non occultabile.
Vedermi così le provocò un'immediata e viscerale repulsione che non le è passata mai. Ogni volta che mi ha guardato i suoi occhi mi hanno sempre raccontato quanto mi vedesse brutta..... sempre.... ogni volta....
Cominciò così la mia lenta agonia, uno stillicidio durato sei mesi, perché ogni goccia di quel latte amaro rivoltava le mie viscere con dolori acuti e strazianti: perdevo peso e piangevo, giorno
e notte.
A sei mesi pesavo come il giorno della mia nascita, quattro chili e duecento grammi ed ero una piccola triste, inconsolabile, insopportabile figlia.
Solo l’intervento provvidenziale e ormai insperato del farmacista con un rimedio antiquato come l’acqua seconda di calce, mi salvò la vita.
Mio padre sacramentava che avevano speso inutilmente un sacco di soldi per farmi visitare da tutti i dottori e i luminari di Imola: come poteva un rimedio così semplice e poco costoso rivelarsi
efficace?
Ma mia madre insistette, tanto le avevano ormai provate tutte e la rovina ai rovinati non fa paura.
Infatti il farmacista mise in acqua della calce viva, poi la scolò e la rimise di nuovo in acqua: dopo un certo tempo di posa me la diedero da bere, disinfettando così il mio intestino
malato.
Da allora ripresi a crescere di peso ed ebbi salva la vita, ma ormai il danno nel mio piccolo cuore era fatto: continuavo a piangere, dato che il meccanismo per attirare l’attenzione di mia madre
e ottenere le sue cure, era quello.
Il mio pianto continuo aveva stancato incredibilmente i miei poveri genitori, che non potevano neppure dormire. Infatti mio padre, che essendo ragioniere doveva recarsi in ufficio e stare attento
a quello che faceva, perché allora i conti si eseguivano a mente, finì per trasferirsi a dormire in un’altra stanza.
Mia madre si ritrovò ad affrontare la sua debolezza fisica e la mia, un altro bimbo, mio fratello, che pur essendo molto tranquillo comunque era pur sempre un impegno notevole, e tutta la casa da
mandare avanti.
Mio padre per aiutarla le comprò la prima lavatrice, semiautomatica, che però risolveva solo in parte i problemi da affrontare.
A volte mia zia Teresina si prendeva cura di me, anzi spesso, dato che abitava col marito nella «casina», una dependance che sorgeva nel nostro vasto cortile. Ma era in attesa del suo primo
figlio, che sarebbe nato dieci mesi dopo di me, quindi più di tanto non poteva fare.
Mi cantava le canzoncine.
Mi piaceva quella della Bella Fantina e gliela chiedevo continuamente. Lei mi stringeva al seno prosperoso e me la cantava con la sua voce viva e un poco stonata.
Mi appoggiavo al suo respiro caldo e mi sentivo felice…
Ma non era mia madre.
Mia madre era una donna severa e poco incline ai gesti d’affetto.
Nata dopo cinque fratelli, mia nonna, quando vide che era giunta una femmina, in preda ad oscuri presagi di sofferenze e difficoltà, fuori di senno per la preoccupazione ed il parto, avrebbe
voluto buttarla nel canale e così porre fine a quella piccola vita innocente, già gravata di dolorose pesantissime responsabilità, appena venuta al mondo.
I presagi di nonna non si dimostrarono errati e Renza, che aveva un carattere forte ed indipendente, venne piegata a suon di busse e di privazioni ad una vita di piccola schiava, per aiutare la
madre, perennemente incinta, a crescere i fratelli giunti dopo di lei, che le volevano stare sempre in braccio, anche se quasi pesavano più di lei: in tutto mia nonna diede la vita a tredici
figli, di cui due morirono in tenerissima età.
Non patirono mai la fame più nera, neppure in tempo di guerra, quando Renza, che aveva dodici anni, gestì da sola un piccolo negozio di alimentari, col quale salvò la famiglia, perché gli
annonari, i controllori delle schede delle merci che entravano e uscivano, tutte contrassegnate da bollini per evitare il mercato nero, chiudevano un occhio se mancava qualche chilo di zucchero o
di farina, sapendo che dodici figli erano tanti da sfamare.
Ma il clima in casa era duro.
Tenere in riga tutti quei figlioli era una gran fatica per il nonno, che solo con i nipoti si mostrò dolce e affettuoso: con i figli, urla e cinghiate.
La nonna poi era una querula rompiscatole, sempre incinta e sempre a lagnarsi di tutto, poveretta.
E pure i fratelli di mia madre volevano fare le veci del padre nei suoi confronti e quindi lei crebbe vessata su tutti i fronti.
Non le fu permesso di andare a scuola, cosa che lei desiderava tantissimo, essendo dotata di viva intelligenza e desiderio di sapere ed emancipazione, mentre vedeva i fratelli maggiori studiare
per diventare maestri.
Fu fermata alla seconda elementare, nonostante il suo continuo ribellarsi, tutto il giorno stava con i piccoli in collo e il bucato da fare.
Non si lamentava del duro lavoro, ma la domenica ella voleva uscire a passeggio tra i portici del centro dell’antico borgo, dandosi un velo di cipria e una lacrima di rossetto, come facevano le
sue amiche che venivano da famiglie più agiate e aperte, però ad ogni passo doveva nascondersi dietro una colonna o la nicchia di un porta perché le amiche, che facevano buona guardia,
l’avvertivano del passaggio di uno o dell’altro dei fratelli suoi controllori, che l’avrebbero ricondotta a casa e di nuovo rinchiusa, dopo una razione di cinghiate.
Erano offese e violenze che lei incassava senza battere ciglio, senza dare loro la benché minima soddisfazione, poi, fuggiva di nuovo di casa alla prima occasione, a volte, mentre dopo pranzo si
faceva la siesta pomeridiana, calandosi dal balcone.
Furono colpi che le insegnarono così la supremazia maschilista e il suo duro destino di donna, nata per lavorare senza riposo e riprodurre figli, come animali.
Ma Renza era una persona orgogliosa e molto vitale.
Mise su una corazza di tutto rispetto e proseguì la sua vita ad onta di coloro che la osteggiavano.
Era bella e vivace, senza sapere di esserlo, fiera come una puledra indomita, ma trovò chi le mise il morso e la piegò al compito di donna, moglie e madre.
Dopo la sbandata delle truppe italiane dell’otto settembre, tutta la famiglia si rifugiò in una grotta naturale nascosta tra colline lussuriose di vegetazione spontanea, dividendo fame e
promiscuità con altre famiglie lì radunatesi per scampare alla ritirata dei tedeschi che risalivano la penisola italiana seminando morte e distruzione ovunque passassero.
Proprio lì Renza incontrò mio padre, che nello stesso luogo, abbandonata la divisa militare, si era nascosto con la sorella più giovane.
Si innamorarono, anche se lui, ragioniere e universitario, la trattava con sufficienza, perché ella era un fiore selvatico, nato tra le spine.
Appena tornò la pace, mia madre riuscì a vincere le resistenze del suo fidanzato, partorite dalle sue fissazioni mortifere, dato che non voleva lasciare orfani poiché era convinto che sarebbe
morto a 49 anni come entrambi i suoi genitori, cosa che poi accadde effettivamente, e si sposarono un mercoledì di giugno, la mattina alle sei, vestiti con gli abiti migliori ma senza pompa magna
o pranzo nuziale, partendo poi immediatamente per un viaggio di nozze sul Lago di Garda, meraviglioso per lei che non aveva visto altro che il piccolo borgo dei suoi natali.
Di quel viaggio resta ancora un dagherrotipo in bianco e nero che mostra il suo fine e bel viso incorniciato da un foulard per proteggersi dal vento di poppa della barchetta che li portava a fare
il giro del lago, accanto a lui, alto e distinto, con la folta capigliatura scura spettinata dall’aria frizzante di quella indimenticabile giornata di sole.
Essi erano vestiti alla moda degli anni cinquanta, lei con la gonna a ruota ed una semplice camicetta, lui con pantaloni sportivi ed un gilè
di lana a scacchi e stavano a farsi fotografare a fianco della campanella per gli avvisi e gli allarmi.
Da quel giorno, Renza passò da una prigionia violenta ed ignorante, ad una più fine e apparentemente rispettosa, ma costretta alla sudditanza psicologica da quell’uomo tanto maggiore di lei per
ceto ed autostima, che le incuteva, insieme ad un ardente amore e passione, anche tanta soggezione.
Andarono ad abitare nella casa avita dei genitori di mio padre, appunto quella bellissima costruzione che io ricordo, arricchita da un rigoglioso giardino interno ornato di palmizi, stile
coloniale, grande e che però andava lentamente sgretolandosi e disfacendosi.
Dopo due anni di matrimonio nacque mio fratello Angelo, anche lui con taglio cesareo, un bellissimo bambino biondo con gli occhi azzurri, calmo e riflessivo, intelligentissimo e portato per le
arti matematiche e la fisica, un figlio perfetto, che fu la loro gioia, che non diede loro nessun problema, crescendo sereno e fecondo di sogni e speranze.
Per questo mio padre si legò a lui di un affetto morboso, cercando di dargli tutto ciò che a lui era mancato dopo la morte prematura dei suoi genitori, diventando geloso di quel figlio unico nel
suo genere, amato ed adorato da tutti e reagendo in modo sempre più apprensivo nei suoi confronti, rasentava la patologia.
Fu per questo che Renza, pensando che un altro figlio avrebbe portato aria nuova in casa e avrebbe allentato la pressione sul primo da questo legame soffocante per tutti e tre, tanto fece e tanto
insistette, che alla fine convinse mio padre a farla concepire.
Così, io venni procreata come un intervento curativo, non per un effettivo desiderio di me....
Mia madre mi narra sempre che, quando lei si ribellava alla ferrea disciplina impostale, sua madre si lamentava aspramente e le augurava di ritrovarsi poi in età adulta con una figlia ugualmente
ribelle, che le avrebbe fatto provare quello che lei stava provando in quel momento.
La «maledizione» di nonna si era avverata puntualmente: io fui la spina nel fianco di mia madre.
La mia testa di riccioli rosso rame vagava indomita e velocissima in ogni angolo della casa e ogni oggetto era un fantastico gioco: la pentola e il suo coperchio una sonora batteria, una sedia
sdraiata per terra con un cordino attaccato ed in mano un fuscello per frustino, era il mio cavallo: Furia, col quale galoppavo sfrenatamente per le pianure estese della cucina dai muri ingrigiti
dal fumo del camino.
Una grande scatola vuota era il mio vascello sul quale solcare le tempeste dei sette mari fino ed oltre le Colonne d’Ercole; due pezzi di legno legati insieme a croce erano Excalibur, brandita
con coraggiosa arroganza per uccidere spaventosi draghi o malvagi maghi e salvare avvenenti principesse e poveri orfani.
Un tappeto sul quale mi sedevo afferrandomi saldamente alle nappe, era il magico strumento di volo per librarmi sulle dorate e ondulate dune di un remoto deserto africano, guardando in basso le
fila dei cammellieri snodarsi, chiusi nei loro mantelli blu e recarmi così alla mia oasi gravida di palmizi dai dolcissimi datteri tra i quali risuonava una cristallina e perpetua fonte di acqua
purissima che celava l’ingresso alla mia grotta segreta, dove custodivo, per poi distribuirlo ai poveri che incontravo lungo il cammino, un favoloso e inesauribile tesoro sfavillante di pietre
preziose dai colori e le forme del mio adorato caleidoscopio.
Tutta la grande casa risuonava delle mie grida, dei miei canti, imparati alla scuola materna ed eseguiti perfettamente con una potente e
intonatissima voce bianca.
E quando mia madre si lagnava di me con mio padre, cioè sempre, lui le rispondeva: "L’hai voluta? Adesso goditela!".
E lo diceva nel nostro bel dialetto colorito, lui che era figlio di maestri e parlava solo l’italiano, proprio per sottolineare la nemesi della realtà oggettiva.
Una nemesi che si era materializzata nella mia testa di capelli rosso rame, colore che mia madre odiava, fino al punto di tenermi rasata a zero per diverso tempo, nella speranza che scurissero.
Cosa che si avverò solo in età adulta, quando, se avessi avuto il mio gradevole colore originale, mi sarei risparmiata tempo e denaro dalla parrucchiera.
Fu così che fui strappata dal seno caldo e accogliente della mia balia, che mi riscaldava e mi saziava facendomi addormentare serenamente e consegnata al seno colmo di quel latte avvelenato che
mi contorceva le viscere, abbandonandomi ad un dolore incomprensibile senza abbracci confortanti.
Il mio pianto era continuo e una volta mia madre mi prese sulle ginocchia e mi sculacciò di santa ragione. Io avevo all’incirca un anno e lo ricordo benissimo, ma questo racconto è fiorito più
volte sulle labbra di lei con una specie di trionfo, come a sancire una vittoria e non invece la sua sconfitta, dato che io non avevo nessuna colpa del fatto di piangere nè di stare male ed ero
troppo piccola per essere educata a sculaccioni, soprattutto per superare un problema del genere.
Ma allora la pedagogia era quella e l’indole di mia madre l’assecondava.
Quando fui un po’ cresciuta (avevo ormai tre o quattro anni), poiché la mia abitudine di piangere persisteva, lei inventò un ottimo sistema per farmi smettere.
Facendo leva sul mio spiccato orgoglio e sulla mia permalosità molto accentuata, quando per strada qualche conoscente, incontrandoci, mi rivolgeva dei complimenti, sottolineando quanto fossi
bella, cosa che forse era vera o forse no, dato che per lei bella non lo ero di sicuro, lei rispondeva sempre:
"Sarà pure una bella bambina, ma piange sempre! "
E fu così che io smisi di piangere, cosa che sicuramente significò fare dell'altro male a me stessa.
Mio fratello invece, che io adoravo, se ne stava quieto e silenzioso a studiare la sua amata matematica e a smontare radio, ricavandone valvole, diodi e strani congegni che poi ricuciva col
piccolo saldatore a piombo che gli era stato regalato.
Io lo scrutavo, senza che lui se ne accorgesse, dallo spiraglio della porta socchiusa e mi sembrava un potente mago alla ricerca della pietra filosofale.
La sua calma e riflessività risaltava sulla mia vivacità da ragazzaccio e mia madre, che aveva sognato una dolce bambina da vestire di trine e pizzi che lei stessa era abilissima a confezionare,
si trovava un figliolo maschio perfetto, sempre pulito e in ordine, al quale non rivolgere mai il benché minimo rimprovero perché non ne aveva bisogno e che quindi adorava e ammirava
sconfinatamente e, di contrappasso, una figlia femmina che sembrava uno scugnizzo napoletano, sempre con le mani sporche di terra o chissà cos’altro, con i delicati golfini dai colori pastello
che mi faceva con tanta pazienza, tutti sfigurati da macchie d’erba o di fuliggine e polline di fiori.
Così erano eterni rimbrotti e sgridate e a volte sculaccioni, che lei m'impartiva con la sacrosanta intenzione d'insegnarmi a diventare l’ educata e leggiadra fanciulla che avrei dovuto essere,
lasciando nel mio animo sensibilissimo un amaro convincimento che ella non mi amasse affatto, che anzi mi disprezzasse, che non mi volesse accanto a sé, convincimento sottolineato e reso più
saldo dal suo essere asciutto, senza baci né abbracci, che da bambina non aveva ricevuto mai, e dal fatto che non mi rivolgesse complimenti e vezzeggiativi, che io proprio non le ispiravo.
Fu così che il forte disagio, la grande estraneità al comune essere che era già stampato in me dalla mia concezione, si sviluppò ogni giorno di più verso un futuro complesso e doloroso.
Il dolore è un abitante subdolo del tuo corpo, silenzioso, discreto, tanto che spesso non ti accorgi neppure di lui...
ma non paga l’affitto.
Abita ogni tua stanza, si allarga mano a mano che ti allarghi tu, cresce un centimetro se tu sali di un centimetro e ti fa da contrappeso.
Io mi abituai presto al suo passo felpato e ad appoggiarmi a lui, cercando un equilibrio che non trovavo da nessun’altra parte.
Lui era sempre presente e mi porgeva, con il suo sorriso mesto, sempre qualcosa a cui pensare, qualcosa di cui scrivere, qualcosa da cercare o da cambiare.
Non so quando lui sia diventato il padrone della mia casa, quando anche l’ultima cambiale sia scaduta non pagata e lui si sia impossessato di tutti i miei averi, so solo che mi ha lasciato la
possibilità di continuare ad abitare dove avevo sempre vissuto, ad usare le vettovaglie che mi avevano fornito, le risorse che mi erano state donate.
Cominciai allora ad irrobustirmi e così presero il via altre torture.
Avevo appetito, ma mi si centellinavano le razioni di cibo.
Mio fratello mangiava come un cavallo, ma era magro e stava crescendo. Quindi il suo piatto era sempre colmo.
Io guardavo la mia piccola porzione e soppesavo tutto nel mio cuore.
Meno cibo mi veniva concesso, meno amore ricevevo.
Per me era così.
Stavo per morire a causa del cibo e questo il mio corpo non l’aveva dimenticato.
Cibo uguale vita uguale amore.
Mi alzavo la notte spinta dalla voglia di mangiare ma il frigo era tenuto appositamente vuoto.
Io divoravo qualsiasi cosa, anche la crosta avanzata del parmigiano. Non potevo dormire con quel vuoto dentro.
Ero molto miope dalla nascita e, non vedendoci bene, incespicavo spesso, cadevo e mi facevo male.
Ma non venivo consolata da mia madre: anzi, ella mi sgridava perché non avevo fatto attenzione.
Fu la mia maestra delle elementari che si accorse che non vedevo bene. Così l’oculista mi prescrisse gli occhiali.
Occhiali pesanti, dalla montatura scura, con la lente che faceva cerchi e rimpiccioliva i miei occhi verdazzurro.
I compagni di gioco mi chiamavano «Balena Quattrocchi».
Io li picchiavo forte e loro mi prendevano in giro sempre di più. Così correvo in camera mia a leggere.
Non piangevo, no, non piangevo quasi più. Fuggivo con la fantasia. Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Spinarella, Zanna Bianca, Piccole donne, Pattini d’argento, Il corsaro nero, I viaggi di Gulliver,
Moby Dick, Senza famiglia, Oliver Twist, Il piccolo principe, Il giardino segreto, erano la mia vendetta, erano la mia pelle, erano il mio orizzonte e alle tre di notte ancora la luce sul
comodino brillava nel silenzio della casa.
Io, la mano premuta sull’occhio troppo stanco, leggevo con l’altro, che ancora mi seguiva e vagavo lontano dalla prigione del mio cuore solitario.

CAPITOLO QUARTO
Mio padre
- Le parti in corsivo sono tratte da "Io non sono di qui "
La perdita…
È come strapparsi qualcosa da dentro.
Ore, voci, discorsi, attese, abitudini, ritmi, certezze.
Un orologio interno che all’improvviso cessa di scandire i momenti e lascia vuoti assordanti.
Parossismo di sostituzioni, cambiamenti, spostamenti.
Traslochi durante i quali vanno smarrite cose che erano lì da troppo tempo, da sempre.
Costruzioni credute immortali che crollano travolte da soffi immani e rivelano orizzonti fino ad allora sconosciuti.
Poi ci si guarda dentro e non si riconosce ciò che si vede, lo si rifiuta.
Si desidera solo spasmodicamente ciò che era, ciò che non c’è più.
Ci si chiede allora, nell’attimo della fine, di visualizzare l’ultimo battito, cristallizzare l’ultimo respiro, registrare l’ultima parola.
Ma è troppo tardi.
Indietro non è permesso tornare, mai.
Ci si illude, ma si va avanti per inerzia, aggrappandosi a quei residui di abitudine che ancora tenacemente persistono dentro di noi.
Non ci si arrende all’evidenza: si rimuove, si dimentica, si seppellisce e non si ricorda.
Ma dentro di noi la perdita continua a lavorare, a scavare.
Stalattiti e stalagmiti crescono fantastiche e oscure, creano un nuovo sé: una persona che non riconosceremo ma che porterà avanti la nostra vita.
Mentre una bambina rimasta sospesa nel tempo piange silenziosamente su quella tomba ancora calda, gli anni passeranno, invano.
Mio padre…
Era affascinante come un divo del cinema.
Alto e snello, elegante con qualsiasi cosa indossasse, anche col pigiama, ma di una bellezza discreta, trattenuta, riservata.
I capelli neri erano folti e robustissimi. Vivevano di vita propria e io questo l’ho ereditato da lui. Li portava alla Rodolfo Valentino, tirati da parte con la brillantina - e ne doveva usare
parecchia perché la loro indole ribelle era restia a piegarsi.
Quando si asciugava i capelli in bagno col phon, io andavo sempre a guardarlo, perché alla fine dell’operazione gli stavano dritti ed era come se avesse una criniera leonina intensamente
scura.
D’estate però se li tagliava a spazzola, perché amava molto nuotare.
Il suo sorriso era spontaneo ma leggero e un poco triste, le labbra sottili e ben disegnate, il mento piccolo con la fossetta.
Gli occhi scurissimi e lucidi erano acuti e malinconici.
Tutta la sua persona era attraente ma qualcosa in lui lo rendeva degno di rispetto, fino a incutere soggezione.
Era come se mettesse sempre una certa distanza tra se stesso e gli altri, anche se era sempre cordiale e gentile, misurato e ben educato.
Quando rimase orfano di entrambi i genitori, andò a vivere con la sorella più piccola da uno zio paterno.
Aveva diciotto anni e suo padre e sua madre se ne andarono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, portati via tutti e due da un tumore ed avevano entrambi, nel giorno della loro scomparsa, 49
anni.
Dopo il diploma in ragioneria frequentò per tre anni la facoltà di Economia e commercio a Bologna, ma la guerra interruppe i suoi studi e gli impedì di conseguire la laurea.
Fu arruolato, naturalmente, ma non andò mai al fronte; lui si definiva un imboscato: sicuramente lo aiutò il fatto che suo padre fosse stato un gerarca fascista.
Per l’intera durata del conflitto rimase a Napoli, a sbrigare scartoffie al Castel dell'Ovo.
Dopo l’armistizio del 8 settembre, abbandonò la divisa e venne a «sfollare», come si diceva allora dalle parti nostre, sulle colline vicine a casa, in una serie di grotte naturali, dove rimase
per diversi mesi fino alla Liberazione.
Lì conobbe mia madre. Si sposarono poco tempo dopo la fine della guerra.
Lavorò tutta la vita come impiegato di concetto per il comune della nostra città.
Era ordinato e molto preciso, addirittura pignolo, pulito e metodico, abitudinario. Tornava dal lavoro e sebbene avesse molti amici di gioventù che lo ricercavano assiduamente, non andava al bar
o a passeggio per il centro o la piazza ma, riposti l’abito scuro impiegatizio e la cravatta, indossate la vestaglia da camera e le pantofole, si sedeva sulla sua poltrona e si dedicava alla vita
familiare.
Con gli amici usciva insieme a mia madre, dato che erano tutte coppie sposate e a turno si trovavano nei rispettivi alloggi per i loro raduni. Ma a casa nostra non veniva mai nessuno.
Amava il comfort e le comodità casalinghe. Quando, dopo tanti sacrifici, riuscì a costruire il condominio che ancora porta il suo nome sulla vecchia casa di famiglia e finalmente ci trasferimmo
nel comodo appartamento con riscaldamento e doppi servizi di cui uno con vasca da bagno, realizzò uno dei più grandi sogni della sua vita.
Era «ammalato di mattone», come si dice da noi e investì l’intero suo patrimonio in quel progetto, diventando talmente parsimonioso da privarsi praticamente di tutto. E tenendo a stecchetto anche
noi.
Non che ci sia mai mancato niente, anzi: il cibo (sorvolando sul problema della mia pinguedine) era sempre di prima qualità e abbondante, ma
certamente lo spreco non era nei suoi geni.
Era comunque assai goloso. A colazione versava nove cucchiaini di zucchero nella tazzona di latte e caffè, che consumava in cucina prima di uscire per il lavoro, inzuppandoci il pane avanzato il
giorno prima, che era ancora più buono.
E la domenica mattina si entrava insieme nella sua pasticceria preferita ad acquistare un cabaret di paste per festeggiare il giorno di riposo: le sceglievamo io e lui, con complice allegria,
indicando con il dito oltre la limpida vetrina, una dopo l'altra, quelle di nostra scelta e scambiandoci occhiate di cameratismo...
Ma questo solo dopo che il palazzo fu terminato e pagato. Prima di ciò il dolce domenicale consisteva in una generosa porzione di crema pasticcera che mia madre cucinava di buon’ora in modo che
si raffreddasse, a volte nella variante «zuppa inglese» o con l’aggiunta di fragole e panna nel mese di maggio.
Era talmente squisito il piacere che lui attingeva dai dolci e l’importanza che attribuiva a questi riti familiari, di compenso nel giorno del riposo, di gratificazione e riconoscimento per tutto
l’impegno profuso, che io tuttora vivo le medesime sensazioni e per tutta la vita ho cercato nei dolciumi quello che avevo perso e che man mano perdevo.
Un cioccolatino, per me, è stata è e sarà una carezza di mio padre.
Amava anche le innovazioni tecnologiche.
Fu tra i primi nella nostra città ad acquistare il televisore, che all’epoca offriva un unico canale ed era un ingombrante cassone metallico verniciato di verde scuro, poggiato su di un alto
trespolo a quattro gambe.
La lavatrice e il frigorifero io me li ricordo da sempre, con la scritta REX dorata e a forma di corona che luccicava sulla superficie laccata di bianco.
Quando avevo otto anni acquistò la sua prima automobile.
Era una Fiat seicento, di colore azzurrino, con le portiere che si aprivano controvento. Veniva da Torino ed era stata usata pochi mesi da un operaio della fabbrica costruttrice, per cui
acquistarla costava molto di meno. Era molto fiero della sua auto e metteva sempre anche un po’ di benzina super, oltre a quella normale, che le sarebbe bastata sicuramente, tanto per darle tutto
quello che pensava si meritasse. La teneva pulita e in perfetto ordine. E non le fece mai il più piccolo scortico o bozzetto.
La domenica, poi, era il giorno della gita in macchina. Caricata tutta la famiglia, con il cestino delle vivande che mia madre preparava il giorno prima sfornellando in cucina tutto il
pomeriggio, ci portava a visitare i luoghi non troppo lontani della nostra terra.
San Marino, Gradara, Pomposa, Gabicce, Milano Marittima, la pineta di Pinarella.
Molto spesso andavamo al mare anche d’inverno, a camminare sulla battigia e a raccogliere conchiglie.
D’estate ci recavamo sul monte Fumaiolo o a Camaldoli, nelle antiche e fresche foreste, per sfuggire un po’ all’afa della pianura.
I picnic erano allegri e i piatti che mia madre preparava erano apprezzati da tutti gli ospiti.
Io ero felice.
La libertà di correre e giocare tra i prati o in riva al mare mi galvanizzava e non mi fermavo un attimo. Sia che avessi altri bambini con cui giocare, i miei cugini per esempio, oppure che fossi
da sola.
Amavo guardare fuori dal finestrino i campi e le colline che si snodavano al nostro passaggio.
Mi perdevo oltre l’infinito che si apriva al mio sguardo abituato al piccolo orizzonte che mi offriva il cortile dietro casa.
In riva al mare mi protendevo verso l’ignoto.
In viaggio cantavamo sempre delle canzoni, io e il babbo, oppure con i cugini, a volte con mio fratello.
Erano canzoncine ingenue e ripetitive oppure erano i motivi in voga quando lui era giovane e durante ogni gita le ripercorrevamo con scrupolo fino allo sfinimento degli altri ospiti.
Ce n’era una poi, "La pecora nel bosco", che si poteva cantare all’infinito, perché non aveva una conclusione e ci perdevamo in questo gioco innocente, in barba a chi protestava,
stanco delle nostre voci insistenti.
A volte, si tornava a notte fonda e io mi sdraiavo, finalmente zittita, sul sedile posteriore e guardavo il cielo.
La luna seguiva ostinatamente il nostro viaggio. Sembrava proprio che non volesse lasciarci e che ci proteggesse, illuminando la strada verso casa con la sua luce intima e discreta.
La luna e la ferma mano del babbo che teneva il volante, silenzioso e tranquillo, erano la certezza del ritorno a casa, la certezza della continuità.
Io gli piacevo, perché ero molto diversa da lui, che era taciturno.
Mio padre amava il mio instancabile chiacchiericcio.
Io sapevo l’ora del suo ritorno dall’ufficio, come un cagnolino fedele e lo aspettavo all’ingresso della stradina, dove parcheggiava la sua automobile, per salutarlo ed abbracciarlo.
Lui non rifuggiva il contatto fisico, anzi, mi cercava sempre con il suo braccio o con la mano. Non mi dava molti baci, solo prima di andare a letto.
Ma le sue carezze erano leggere e rassicuranti, il suo cingermi le spalle e attirarmi a sé, contro la sua anca, mi rincuorava.
Non voleva essere chiamato papà, ma babbo, perché, diceva, la parola papà era un'americanata che toglieva il rispetto alla figura paterna ed
io lo chiamai sempre babbo, con un senso di grande orgoglio dentro.
La sera, dopo cena, sedevamo davanti alla tv per guardare i programmi.
Nella sala da pranzo c’erano due grandi poltrone a grosse righe verde scuro e chiaro con alti schienali e braccioli imbottiti, che mamma aveva rivestito di copertine di cotone grosso e lucido
color rosa antico, perché non si sciupassero.
Una era per lei, l’altra, quella di sinistra, per il babbo.
Lei non sempre si fermava per godere della televisione, assillata dall’esigenza di tenere la casa in ordine e perfettamente pulita come piaceva a loro. Inoltre dedicava molto tempo alla cucina e
ai lavori a maglia e all’uncinetto, confezionando golf e pullover, borse e pantofole, centrini e tende non solo per noi ma anche per i parenti e i conoscenti.
Ma per me e il babbo, l’appuntamento serale era sacro.
Io sedevo su di un seggiolina di legno ricavato adattando il mio seggiolone dell’infanzia, al quale erano state segate le gambe e tolto il
tavolino pieghevole. Erano tempi, quelli, in cui non si gettava nulla e tutto veniva giustamente riciclato, adattato.
La mettevo lì, sulla sinistra, vicino alle lunghe gambe del babbo, che lui teneva compostamente accavallate, quasi a sfiorarle, in modo tale da potermi appoggiare a lui.
Guardavamo il telegiornale, che mi annoiava molto, perché in parte non lo comprendevo e in parte era davvero tetro: ma lo sopportavo con malcelata impazienza, pregustando il seguito dello
spettacolo. Infatti, poi, avrebbero mandato in onda Carosello, una trasmissione molto famosa, interamente composta di reclame pubblicitarie.
Non c’era sera che io non la guardassi e sapevo a memoria tutte le canzoncine, le filastrocche e le frasette stupide e accattivanti degli articoli pubblicizzati.
Era un incanto e una giostra, anche se in bianco e nero. Ma durava dieci minuti.
Purtroppo, quando c’era la scuola, finito Carosello bisognava andare tutti a nanna, lo dicevano anche alla tv con uno slogan reiterato che era entrato nelle bocche di tutti, e io a malincuore
andavo a letto, anche se poi non dormivo subito, ma leggevo fino a tardi.
D’estate invece o il sabato, potevo stare alzata e guardare il programma della prima serata.
Studio Uno e le gemelle Kessler, con le loro lunghe gambe eleganti che al babbo, e a me, piacevano tanto; il mingherlino e bizzarro Don Lurio, che si esibiva in balletti moderni, per allora…
Raffaele Pisu, Walter Chiari, Mina, Alberto Lupo, Delia Scala, Gino Bramieri, che raccontava barzellette; Alighiero Noschese, con le sue imitazioni.
La neotelevisione che era ancora intelligente e piaceva a tutti.
Ascoltavo i commenti del babbo e mi sembravano giusti, a volte geniali. Mi sembrava che desse le parole ai miei pensieri.
Poi c’era la boxe. Nonostante l’ora tarda, papà mi permetteva di guardare gli incontri del sabato sera, anche se mamma brontolava che non era uno spettacolo da bambine.
Benvenuti, Griffith, Muhammad Ali. Lui si infervorava e mi spiegava le particolarità tecniche dei colpi e dei diversi stili.
Ammiravamo la forza e la potenza, il coraggio e la resistenza, l’abnegazione.
Egli mi raccontava la storia di quegli uomini che si guadagnavano da vivere dando e prendendo pugni.
Io sentivo il loro sudore e il loro sangue su di me.
E quando il nostro campione per caso perdeva eravamo molto tristi, ma lodavamo lo stesso lo sforzo e l’impegno che lui ci aveva messo e ci chiedevamo quanto male gli avesse fatto quel pugno che
lo aveva mandato al tappeto.
Pensa, babbo, quanto ti sarebbe piaciuto adesso il pugilato in tv, a colori, con il ralenti e il replay…
A novembre del 1965 papà fu colto da forti coliche renali scatenate dall’accumulo di renella. Fu ricoverato d’urgenza, con nostro grande sgomento, ma lo dimisero presto, con una prognosi
falsamente rassicurante… A marzo era spacciato.
Mia madre ottenne per lui un posto letto all’ospedale universitario di Parma e gli rimase accanto fino all’ultimo giorno.
Io e mio fratello fummo sistemati presso due zie diverse.
Nessuno mi disse che il mio babbo stava morendo.
Durante quell’estate ebbi le mie prime mestruazioni.
Sapevo cosa mi stava accadendo, perché mio padre durante l’inverno, vedendo che il momento si stava avvicinando, mi aveva parlato e mi aveva preparato all’evento, ma io non trovai il coraggio di
chiedere degli assorbenti a mia zia.
Nascosi così le mutandine sporche nel fondo del mio cassetto. Un giorno, quando rincasai dopo il mare, la zia mi redarguì aspramente davanti a mio fratello e ai miei cugini. Seguendo il cattivo
odore che emanava, aveva scoperto il mio segreto.
Quel giorno provai la più intensa vergogna della mia vita, non riuscendo neppure a piangere.
Mi rintanai in un angolo, scura in volto e rimasi per molto tempo nascosta, in preda a un senso di disperata solitudine.
Una volta durante quei mesi che mi sembrarono lunghissimi, assillati dalle mie continue richieste, mi portarono a trovare mio padre in ospedale.
Fu la mia zia prediletta ad accompagnarmi. Io ero allegra e ciarliera, felice di rivedere il mio babbo in una città rinomata come Parma.
Arrivati in ospedale, dopo aver percorso lunghi corridoi bianchi che emanavano un forte odore di disinfettante e medicinali, arrivammo alla sua camera.
Lui era molto pallido, seduto sul letto. Magro da fare spavento.
Invece mia madre, sembrava stesse benissimo, mentre poi si seppe che era gonfia dal tanto stare seduta di una sedia al suo capezzale, giorno e notte.
Mi aspettavo un sacco di feste dal mio babbo, ero sicura che mi avrebbe parlato per tutto il tempo.
Invece non fece altro che scherzare con mia zia.
Mi rivolse a malapena la parola. E io ci rimasi molto male.
Solo ora posso capire quanto il suo cuore si stringesse al vedermi, al sapere che stava per morire e mi avrebbe dovuto lasciare, ma allora di certo non lo potevo immaginare.
In agosto lo riportarono nella nostra città. Io rientrai dal mare e fui sistemata dalla solita zia. Lo andavo a trovare spesso. Però ancora non avevo capito che stava morendo. Domenica 28 agosto
gli chiesi se voleva fare la comunione con me e lui, contrariamente al suo solito, che quello era un motivo di dissidio tra noi, dato che sempre io gli chiedevo di venire a messa con me ma lui si
rifiutava dicendo che amava Dio, ma non i preti, quel giorno mi rispose di sì.
Così il cappellano della casa di cura ci comunicò entrambi e pregammo insieme. Ma lui era debolissimo.
Fu l’ultima volta che lo vidi.
Si spense alle sei del mattino seguente.
Io mi alzai quel giorno, in preda ad una tristezza che mi soffocava la gola.
Mi sedetti sul letto e poi rimasi lì, con le gambe penzoloni, stranita.
Fu allora che sentii mia zia e mio cugino parlottare, ma subito non capii cosa stessero dicendo.
Allora mi diressi in cucina dove loro stavano facendo colazione: l'atmosfera era tesa e le loro espressioni erano strane.
Mi diressi con lo sguardo verso mia zia, interrogandola con gli occhi.
Lei mi cinse le spalle con un braccio e mi disse che il babbo stava molto male.
Mio cugino, che era più piccolo di me, allora sbottò:
"Ma non mi avevi detto che era morto???"
Così lo seppi.
Il pomeriggio mia zia mi accompagnò in un negozio a comprare una gonna blu con un golfino del medesimo colore per il funerale, spiegando che avevo appena perso mio padre.
Il commesso mormorò:
— Poverina…
Io mi sentivo come galleggiare.
Al funerale c’era tantissima gente. Pioveva. Corone di fiori, mazzi e cuscini, una lunga fila di persone dal viso triste, alcuni piangevano.
Rividi mia madre e mio fratello.
Lei mi appoggiò un braccio sulla spalla ma non disse una parola.
Mio fratello sembrava una statua di sale.
Loro non piangevano e io neppure.
Quando calarono la bara scura a lucida nell’apertura posteriore della tomba di famiglia, io pensai che sicuramente c’erano dei ragni, di cui avevo il terrore, e tanto buio, che altrettanto
temevo.
E mi misi a piangere.
Non ricordo chi mi strinse una mano sulla spalla.
Ma non fu mia madre. Lei era annientata. Pensai che mio padre sarebbe stato lì per sempre, al buio e con i ragni.
Tornammo a casa, dopo mesi.
Ora so che lui era il cuore della nostra casa e della mia infanzia.
La nostra famiglia era finita. Sepolta con lui, al buio e con i ragni.
La perdita…
Anche questo passo è stato pubblicato in Io non sono di qui e, insieme al capitolo che parla di mia madre, è stato buttato giù nell'estate 2007 in cui vissi nella roulotte.
Avevo moltissimo tempo a disposizione, per la prima volta ero lontana dai miei figli e potevo pensare a me.
Furono quella e la successiva, due estati di continui tuffi nel passato che facevano venire alla superficie dei miei pensieri tutte le sorde emozioni che si rotolavano nel profondo della mia mente e del mio corpo.
In modo che io le potessi raccontare, le potessi esternare e fu come se, dopo essere state messe su di un file del pc, diventassero una cosa esterna da me, qualcosa che uscisse dalle mie fibre dentro le quali erano impresse a fuoco e mi lasciassero, finalmente, per darmi adito di smettere di soffrire così violentemente.
Ma della morte di mio padre io non ho smesso mai di soffrire.
La mia vita si divide in: "quando c'era il babbo" e "dopo la morte del babbo".
La sua presenza era come un colore di fondo, un sapore che percorreva interamente le mie giornate, un odore che riempiva l'aria dei miei respiri, anzi, dovrei dire: un profumo.
Era una valenza, era una sicurezza.
Era un punto di riferimento.
Un pomeriggio, già abitavamo nel condominio, quindi io potevo avere dieci anni, tornai piangente in casa perché i miei amici, che erano tutti maschi, mi avevano canzonato.
Io ero arrabbiatissima: ero molto molto permalosa, in modo straordinario.
Lui, in pantofole e giacca da camera, come suo solito, mi attirò a sé, mi asciugò le lacrime sulle guance sporche di giochi all'aperto e mi chiese cosa fosse successo.
Io glielo raccontai, perché a lui sapevo che avrei potuto dire tutto, o quasi.
Vidi il suo sguardo rabbuiarsi. Mi disse, molto serio che era proprio il mio essere permalosa che faceva sì che i miei amici mi prendessero in giro, che se io non avessi mostrato di soffrire alle loro provocazioni, si sarebbero ben presto stancati ed avrebbero cercato qualcun altro su cui sfogare la loro rabbia e stupidità.
E anche mi ammonì ad imparare a stare da sola: "Sei una bambina speciale," mi disse, "a molti piacerà farti soffrire." e si rabbuiò ancor di più in volto.
Io ero un maschiaccio, amavo i giochi maschili, la bici il pallone la guerra, la lotta, la corsa, il perenne movimento, i soldatini le biglie, le automobiline i carrarmati, le costruzioni.
Forse, anzi, di certo mio padre aveva capito la mia natura omosessuale.
Ma non ebbe il tempo di parlarmene.
Quando si accorse che stavano per venirmi le prime mestruazioni, fu lui, pochissimi mesi prima di morire, un pomeriggio in cui il sole primaverile accendeva il piano color mogano dei mobili della nostra sala, mi disse che aveva qualcosa di molto importante da dirmi. Si sedette sulla sua poltrona e mi fece accomodare su quella di fianco a lui, che era di mamma, e non sulla mia solita seggiolina, come a volere sottolineare l'importanza di quello che mi stava rivelando.
Fu un dolore interiore, che dissimulai bene, sentire che gli stavo rubando e mi stavo rubando qualcosa di molto bello, perché io quello che babbo mi disse quel giorno, del ciclo e del modo in cui nascevano i bambini, lo sapevo già da almeno da tre anni.
Ugualmente però, quel giorno, mi sentii speciale, come di più ancora mi sentii quando, pochissimo dopo, divenni signorina, come si diceva allora.
E fu mio padre la persona a cui mi rivolsi quando, recandomi in bagno, scorsi il mio primo sangue mestruale.
Andai da lui festosa ed orgogliosa e lui dolcemente mi raccomandò di andare da mamma che mi avrebbe dato l'occorrente.
Li rivedo ancora, quei suoi occhi un po' mesti.
Sapeva già di dover morire e d'altronde lo aveva sempre saputo, che sarebbe morto così giovane.
Un'altra volta lui mi fece sentire ancora più speciale, quando cioè comprò una macchina da scrivere e mi insegnò ad usarla, permettendomi di accedervi ogni volta che ne avessi avuto voglia o bisogno.
Mia madre protestò vigorosamente perché di certo l'avrei rotta, ma lui la rintuzzò dicendole che era molto importante che noi ragazzi fossimo stati al corrente delle scoperte tecnologiche e ne avessimo seguito il passo.
Poi si rivolse a me e mi disse: "E tu, vero che non la romperai?".
Io la conservo ancora, quella macchina da scrivere ed è ancora funzionante.
Ma troppe cose avrei da scrivere su di lui:
Il suo sguardo che si posava sulla sua auto appena lavata e lucida.
L'odore della liquirizia che sempre mangiava alla sera e che, dopo quarant'anni dalla sua morte, ancora si percepisce aprendo il cassetto del suo comodino che è a casa di mia madre.
Il suo russare che a volte mi spaventava, di notte.
Il suo gesto di dare la carica con la molla alla pendola che era di suo padre.
La sua stilografica e l'orologio d'oro da taschino, con la catena e le doppie casse. Il suo pennello ed il rasoio automatico con il quale si radeva.
Il suo ufficio, che io costruii con i mattoncini di costruzioni avuti in regalo per il mio undicesimo compleanno.
Anche lì mia madre non era d'accordo, che non erano giochi da femmina ed io ero già troppo grande per una cosa così, ma lui le rispose quietamente come era suo modo, che se a me quelli facevano piacere, era giusto che quelli io avessi.
Così ebbi in dono un secchiello di costruzioni Plastic City e la prima cosa che costruii fu proprio il suo ufficio, dove a volte la mamma mi aveva portato e che io vedevo come un tempio votivo, con quei libroni contabili, le scrivanie di legno massiccio, gli schedari e quell'odore di carta, polvere ed inchiostro, dato che ancora con l'inchiostro si scriveva.
Ricordo l'evento straordinario che mi preoccupò tantissimo della sua operazione ai polipi nasali e quel suo nasone fasciato ed il volto sofferente.
E quella volta che io avevo gli orecchioni e stavo molto male e lui si mise le mie babbucce di lana sulle orecchie, avevo quattro anni o forse meno e, nascondendosi a me sotto la spalliera a piedi del letto, mi faceva "cucù", facendomi ridere di terrore.
E le eterne discussioni con mia madre che era tutto un: non fare questo non fare quello e lui che la redarguiva: "Lasciala stare, deve fare le sue esperienze, deve imparare da sola, deve rompersi quella testa dura contro il muro, altrimenti non capisce!".
O quando mi curava una strana infezione che mi venne a otto anni sulla gamba destra, che andava medicata e spremuta per fare uscire il pus, cosa che io lasciavo fare con coraggio, pur se sentivo un acuto dolore, ma era il babbo e si prendeva cura di me.
E la grandiosa festa che diede per la mia prima comunione, con tantissimi invitati un rinfresco favoloso e tantissimi regali tutti per me.
Quando m'insegnò a nuotare avevo quattro anni e mezzo, tenendomi con le sue mani sicure adagiata sul pelo dell'acqua e facendomi sentire la forza che mi sosteneva, indicandomi come abbandonarmi ad essa.
Imparai subito a galleggiare, a fare il morto, e poi i movimenti del nuoto. Lui era un potente nuotatore a stile libero e mi mostrò ed insegnò tutti gli stili, ma io sono una ranista nata e lui mi consigliò di assecondare la mia natura.
Poi si faceva cingere il collo con le mie braccia e s'immergeva, portandomi dove non toccavo, appoggiata sulla sua schiena.
Sott'acqua io vedevo i suoi capelli fluttuare, le bolle d'aria che emetteva e sentivo la sua pelle contro la mia.
O quando mi caricava sul cannone della bici e mi portava a vedere il treno ed i campi, per me meravigliosi, appena fuori dalle mura della nostra cittadina.
Oppure la domenica d'inverno in spiaggia, camminavamo io e lui sulla rena bagnata in cerca di conchiglie, le più belle, le più colorate, rare e preziose.
Quando mi insegnò ad andare in bicicletta... ma quanti anni avevo? Non so, ero piccolissima!! tolse le rotelline di sicurezza per bambini, mi esortò a non aver paura e a pedalare forte così l'aria mi avrebbe sostenuta.
Oppure quando mi assicurò i primi pattini a rotelle con le cinghie e mi sostenne, per poco, visto che imparai subito, per farmi prendere sicurezza e confidenza con quel nuovo gioco incredibilmente bello.
E quella volta che morì il nostro vicino di casa, Giacinto, grandissimo amico mio. Erano i nostri dirimpettai quando avevo otto anni ed abitavamo nella casa del suo amico dottore. La Peppa, Giacinto e la loro figliola che studiava alle magistrali e che si chiamava Felicina. Andavo sempre da loro e la sera mi davano una mezza tazzina del loro caffè, che di certo era d'orzo, caldo e zuccherato, raccomandandomi di non dire nulla alla mamma che sicuramente non sarebbe stata d'accordo. Erano affettuosi, gentili, comprensivi e mi adoravano: si facevano raccontare tutte le mie avventure, ascoltandomi come stessero assistendo ad un evento eccezionale.
Una sera, al mio voler andare di là da loro, come mio solito, babbo mi chiamò a lui, mi avvolse con le sue braccia e mi spiegò che il mio amico Giacinto era improvvisamente volato in cielo, perché il suo cuore tanto buono aveva cessato di battere ed ora era tra gli angeli e mi salutava da lassù.
Io piansi, sentendo la crudeltà di quella mancanza e gli rivolsi piangendo un sacco di domande su cosa stesse facendo ora il mio amico, come avrei fatto io senza di lui, come avrebbero fatto la sua Peppa e la sua Felicina, quel pomeriggio avevamo imparato insieme a memoria la poesia "La fontana malata" di Guido Gozzano, che io imparai prima di lei anche se frequentavo solo la terza elementare.
Chh roch chh facevano i miei singhiozzi e lui che mi abbracciava stretta.
Se penso alla mia infanzia, quasi dovunque vedo i suoi occhi, ovunque sento la sua presenza: lo devo dire al babbo, lo devo chiedere al babbo, lo devo fare per il babbo, lo devo mostrare al babbo.
Per anni, dopo la sua scomparsa, io ho sentito chiaramente il rumore della sua auto nella stradina sotto casa all'ora del suo ritorno.
E appollaiata sulla una lastra di marmo, che aveva sopra un muretto di mattoni alto quasi due metri per sostenere il cancello del cortile del condominio, un giorno scrissi una poesia, avevo dodici anni, i cui ultimi versi erano:
"Restano solo cartacce bagnate
bagnate come il mio cuore."

CAPITOLO QUINTO
Mio fratello, i nonni e i prozii paterni
e la storia della bellissima Cademis …
Anche questo passo in corsivo è tratto da ' Io non sono di qui '.
Lo squartatore di bambole
Amavo mio fratello.
Più grande di me, era posato e tranquillo per quanto io ero scalmanata. Io non stavo mai zitta, lui taceva, tenendosi tutto per sé.
Era ed è ancora, un genio in matematica. In quinta elementare giocava con i logaritmi che aveva scoperto e studiato da solo.
Per me due più due ha sempre fatto cinque, o tre, a seconda del mio stato d'animo.
Lui era uno scienziato.
Nella sua camera pezzi di vecchie radio con valvole e diodi: lui le smontava per poi farne di nuove che funzionavano, ma emettevano solo suoni da vecchie cornacchie raffreddate.
Io mi affacciavo allo spiraglio della porta della sua camera e lo spiavo con occhi innamorati. Lui, sembrava non si accorgesse neppure di me.
Quando nacqui ricominciò a bagnare il letto.
Sicuramente per lui, coccolato e viziato, fu un duro colpo vedermi sortire fuori dal nulla.
Avrò avuto circa quattro anni quando mi regalarono una splendida bambola.
Di solito succedeva che i doni destinati a me non mi venissero consegnati, ma solo mostrati e poi messi via, perché altrimenti li avrei rovinati.
Quella volta tanto piansi e tanto insistetti che me la diedero.
Aveva il viso di bachelite e lunghi ricci di stoppia biondo cenere, un vestito rosso pieno di trine e un cappello di paglia con i nastri.
Le braccia e le gambe erano snodabili, aveva calze di cotone di un bianco immacolato e scarpette nere lucide.
Gli occhi, poi, orlati da ciglia bionde, si aprivano e chiudevano a seconda della posizione che le facevi assumere ed erano di un meraviglioso azzurro intenso.
La boccuccia era rosa e dischiusa in un sorriso che mostrava una perfetta fila di dentini bianchi.
Io amavo quella bimba dolce e aggraziata: era tutto quello che non ero io e me la stringevo teneramente al petto cantandole le canzoncine apprese dalla zia.
Una mattina tornando dalla scuola materna non trovai la mia bambina, che avevo lasciato adagiata nel mio letto. La cercai disperata.
La ritrovai smembrata e appesa ai fili per stendere i panni, sotto la pergola.
Era stato mio fratello a tagliarla a pezzi e ad appenderla lì, in quel luogo dove lui sapeva io mi recavo spesso per giocare, perché la struttura della pergola era interamente rivestita da un
rampicante che aveva piccoli fiorellini bianchi che emanavano un profumo dolce e leggermente speziato, che mi piaceva moltissimo.
La vedo ancora. Tanti piccoli pezzi del mio cuore.
Nessuno gli disse niente, non so perché, nonostante io piangessi, disperata, lui non fu sgridato. Semplicemente i pezzi della mia bambola, vennero gettati via.
Ma io amavo mio fratello e volevo dargli qualche bacio.
Lui mi respingeva fieramente, con una smorfia di plateale disgusto su quel suo viso ben modellato.
Ogni anno però lui frequentava il campeggio in montagna col prete della parrocchia e stava via un mese.
Io tremavo dentro di me al pensiero di non vederlo per quel lungo periodo.
Così, la notte prima della partenza, aspettavo che tutti si fossero addormentati, io mi addormentavo sempre dopo di tutti poiché leggevo a lungo ogni sera, e sgusciavo silenziosamente nella sua
camera, andando a posare delicatamente un bacio sulle sue guance, mentre lui, ignaro di tutto, seguitava a dormire.
Poi me ne tornavo nel mio letto.
E mi sentivo una ladra d’amore.
Il rapporto con mio fratello è un'altra delle problematiche irrisolte della mia vita: io e lui siamo due mondi diversi, due mondi paralleli, assolutamente non ci capiamo. Io ci ho provato ad amarlo, io ci ho provato ad avere un rapporto bello con lui, ma per me vi è solo una porta chiusa che non si è aperta mai, anche quando tra noi vi sono stati periodi più rilassati.
L'ultima volta che ho cercato di avere da lui quello che ho sempre desiderato e non ho avuto mai, è stato qualche anno fa. Non riesco a ricordare con precisione il momento ma so che ancora non ero caduta dalla scala.. Di certo però avevo passato dei momenti assai difficili. Mia madre stava male in quel periodo e noi figli temevamo per la sua vita. Ogni giorno mi scriveva una mail per dirmi le sue condizioni, che per fortuna migliorarono, tanto è vero che oggi ha 88 anni e sta discretamente, se si pensa all'età che ha ed alle sue svariate patologie. Approfittai allora di quello scambio epistolare per scrivergli una lettera di cui non ricordo le parole, ma il succo del mio discorso era che ormai eravamo grandi, che avremmo dovuto tirare fuori gli scheletri dall'armadio della nostra infanzia ed avere quel rapporto che tra due fratelli si auspica esista. Sto cercando di ricordare e credo che questo avvenne dopo le 850 pillole del 2008 ma assolutamente ho solo un vago ricordo. Come ho già scritto altrove, i due anni seguenti, fino alla caduta ed oltre, sono avvolti in una nebbia scura dalla quale riemerge solo qualcosa. Comunque so che qualche tempo dopo io mi recai a trovare i miei, facendo un viaggio in aeroplano ed andai da mia mia madre. Io e lui ci incontrammo per caso fuori, in strada e lui mi parlò molto duramente. Mi disse che era giunta l'ora che io la smettessi. Che imparassi a tenere i miei problemi per me, che facessi come lui; che io non sapevo quanto difficile fosse stata la sua vita ma che mai aveva rotto le scatole agli altri. Aveva sempre risolto i suoi problemi da solo. E che quindi io dovevo assolutamente comportarmi allo stesso modo e smettere di rompere.
Di certo le sue parole così dure mi ferirono molto. Ora, esaminando il tutto con cuore più sereno e più saldo, se dal punto di vista esteriore la sua vita non presenta traumi evidenti, ad eccezione della morte del padre avvenuta quando aveva sedici anni, io so cosa lui ha respirato. Certo, è stato il preferito e questo fa di mio fratello una persona forte con la capacità di gestire i suoi stati emozionali, cosa che evidentemente io non ho, ma la tragedia di fondo della nostra famiglia consisteva in una profonda dicotomia. All'apparenza eravamo una famiglia modello ma bnella sostanza non era così. Ho saputo da mia madre solo pochissimo tempo fa cose che davvero non avrei mai potuto immaginare. Terribili tensioni tra lei e mio padre, altri traumi ed episodi tragici della sua infanzia. Non so se li narrerò qui, quando arriverò a raccontare del momento in cui ne venni a conoscenza.
Ci devo ragionare sopra, nel frattempo e forse non lo farò.
Ma di certo fu questo micidiale meccanismo che triturò il mio equilibrio psichico, ed è chiaro che pure mio fratello di quello si sia cibato, negli anni della sua vita.
Ora egli si prende cura amorevolmente di mia madre, per fortuna, dato che io non posso più farlo, e mi ha esortato a tenerla fuori il più possibile dai miei guai, cosa che sto cercando di fare, desidera che nostra madre viva il più serenamente possibile gli ultimi anni della sua vita assai dolorosa e difficile.
Io so di lei moltissime cose che lui non sa, dato che ho sempre raccolto i suoi sfoghi e le sue tristezze. Ma so anche che lui riesce a farla felice mentre io sono sempre stata e sempre sarò sempre causa di un profondo disagio interiore.
Quindi il fatto che sia lui ad accompagnarla al suo ultimo giorno mi rende serena. Sò che è in buone mani.
Ma ci sono due ricordi assai belli che ho di mio fratello e desidero raccontarli.
Quando avevo dodici o tredici anni, di questo sono certa perché mio padre era morto da poco ed io frequentavo ancora le scuole medie, mio fratello si recò a Bologna per assistere ad un concerto dei Jethro Tull, un mitico gruppo storico di quegli anni che ha segnato la storia della musica e del costume contemporaneo.
Non so per quale ragione lui decise di portarmi con sé ed i suoi amici. Fu un gesto anomalo nei miei confronti che giunse dal nulla e rimase nel nulla. Mia madre cercò di opporsi, al suo solito ma il volere di mio fratello era legge e così quella volta questo giocò in mio favore. Ricordo il viaggio in treno con quei cinque sei ragazzi più grandi di me che io conoscevo bene, frequentavano assiduamente la nostra casa, e li amavo ed ammiravo in modo sconfinato esattamente come facevo con mio fratello.
Già viaggiare in treno era una cosa emozionante per me, che forse in quei giorni mi era capitata di fare solo due o tre volte. Loro stessi erano vivacemente eccitati ed allegri e si rivolgevano a me in modo gentile e scherzoso, cosa che mi riempiva di euforica felicità. Poi arrivammo nella grande città: ricordo l'immensa stazione, tanti treni e binari, come mai avevo visto, lunghi viali che percorremmo a piedi di gran carriera, diretti al palazzetto dello sport dove si teneva il concerto.
Era gremito di giovani vestiti alla moda di quegli anni: pantaloni a zampa di elefante, bandane colorate, mio fratello ne portava una rossa al collo, magliette multicolori e camicie fiorate con lunghi baveri dai becchi appuntiti. Capelli lunghi e barbe fluenti, esattamente come portava lui e devo dire che ancor oggi ha una capigliatura leonina ad onta dei sessanta suonati già da un po', retaggio di quella di mio padre. -
Il palazzetto era riempito di questa moltitudine vociante ma un po' "svaporata" non so, non riesco a trovare un altro termine. Tutti fumavano. Io allora non lo sapevo ma ora so che quell'odore dolciastro che si sentiva nell'aria era hashish e marijuana. Anche mio fratello con i suoi amici ne fumavano ed io vedevo la loro allegria salire così come la tensione di tutta la moltitudine che sembrava palpitare come fosse un sol organismo formato da miriadi di cellule colorate.
Poi fu fatto buio, si accesero grandi riflettori sul palco, anch'essi multicolori, che scagliarono scie fosforescenti tra le volute di fumo ed arrivarono loro, i mitici suonatori.
Tuttuttutrurttutturu tuttutturututturu …..tuttutturututturu tuttutturu tutturu....
Chi ricorda sa di cosa sto parlando: del mitico flauto traverso e di quelle note melliflue e cristalline da incantatore di serpenti che entrarono in ogni testa, in ogni cuore. Sempre come un sol organismo, tutti, io pure, cominciammo ad ondeggiare assecondando l'entrare in noi di quelle note e vibrando con esse. Era una danza, una danza dell'amore e della libertà. Chi ad occhi chiusi, chi sussurrando piano la musica ed accompagnandola con la propria voce, chi baciando la propria ragazza, chi perdendosi ancor di più nel fumo della canna che aveva tra le labbra, fu come se tutti ci innalzassimo dal suolo e levitassimo.
Io, di certo stordita a mia volta dal fumo – non sono mai riuscita a fumare ma di fumo passivo ne ho esercitato davvero tanto, nella mia esistenza, rapita dalla musica, che ho sempre amato e sentito in modo viscerale, mi guardavo intorno affascinata da quei ragazzi grandi che sembravano essere tornati bambini, assai più piccoli di me.
Fu bellissimo, uno dei ricordi più incredibili della mia vita.
Il secondo è di natura assi più intima. Quando mi mandarono in collegio in quinta ginnasio e ci rimasi per tutto il primo trimestre, mio fratello mi scrisse alcune lettere.
Mi arrivò la prima, che non attendevo ed io la guardai, la rigirai un po' tra le amni, prima di aprirla.
Una lettera di mio fratello: che cosa preziosa.
Ricordavo le sue cartoline postali spedite dal campeggio montano estivo, assai rade e laconiche, che ugualmente erano tenute in gran conto dai miei che le ricevevano e me le mostravano, quasi fossero reliquie. Quella era una busta bianca con sopra la sua calligrafia ineguale e stonata, quasi illeggibile, come la mia. Dentro due foglietti scritti fitti. Cosa mi raccontasse non lo ricordo più. Quelle lettere sono andate perdute nel corso dei miei 22 traslochi. Ma ricordo benissimo che piansi, leggendole, ogni volta. Che le lessi e le rilessi. Che mi sentii importante ed amata: mio fratello si era chinato su di me dandomi quel bacio, anche se incorporeo, che avevo tanto desiderato ed atteso.
Ma quando tornai a casa lui fu più freddo di prima, con me, quasi quella sua apertura lo imbarazzasse e non ebbe mai più una parola.
Quando nel 1997 lui ebbe una crisi con la moglie, io lo accolsi in casa mia, spostando mio figlio più piccolo a dormire con la sorella e dandogli una stanza tutta per sé. Gliela feci trovare tutta in ordine e pulita, come è sempre stato mio costume vivere, e il più accogliente possibile. Lui si guardò intorno e quasi si commosse, mormorando parole di impacciato ringraziamento per quella accoglienza che forse lui non si attendeva così calorosa. Rimase solo qualche giorno, poi tutto si sistemò e lui tornò a casa sua.
Io so che mio fratello ha un cuore buono. È molto amato da tutti, assai più di me, che sono diventata un orso solitario e che ho diversi "nemici".
Lui, invece, ha molti amici e con la sua famiglia vive una bella unione. Di certo mio fratello è molto migliore di me, come ben si vide fin dall'inizio. Solo che con me si è comportato in modo così duro..... è evidente che sono io il problema, per tutti!
Mio nonno si chiamava Arturo ed era figlio e nipote di maestri: a sua volta maestro sposò una maestra; la sorella di sua moglie era maestra ...un
luogo di cultura.. ma .. tanti scheletri negli armadi.
Lui morì a 49 anni di un tumore, come sua moglie, la nonna Annamaria, non ricordo quale dei due mori per lo stomaco e quale per il fegato.
Anche mio padre morì a 49 anni, per i reni.....
Anche il mio stomaco ed il mio fegato sono molto ammalati, mentre i reni vanno bene... per ora.
Mio nonno era un dandy, vestiva elegantemente, finemente e in modo costoso, portava panama bianchi e bastoni di bambù
Era un maestro severo.
Mio padre frequentò le scuole elementari come suo allievo e mi raccontò sempre della terribile severità del padre che, per non essere tacciato di favoritismi nei confronti del figlio, pretendeva
il doppio da lui rispetto agli altri allievi.
Mio padre mi raccontava questo con un misto di dolore, orgoglio, tristezza, stupore, accettazione e comprensione.
Ricordo i suoi occhi volare lontani, sui banchi di una scuola amara e dura.
Soffrì infinitamente alla morte dei genitori, che amava e rispettava infinitamente.
Dopo la perdita dei suoi andò a vivere con la sorella più piccola, dallo zio paterno, anch'egli maestro e la moglie ostetrica.
Il rapporto di amore e devozione per questi nuovi genitori continuò per tutta la sua vita, e la mia ,finché loro vissero e morirono molto anziani.
Ricordo le mie regolari visite a questi strani zii, che avevano un vecchio cane, che io volevo assolutamente accarezzare e portare al guinzaglio, cosa che mi veniva negata ogni volta, perchè era
"sporco" secondo loro.
Io non osavo protestare, guardavo con tanto amore il piccolo vecchio cane bianco e fulvo, una specie di volpino, e lo accarezzavo da lontano, così quando mi vedeva giungere nella sua casa, mi faceva
silenziose feste, standosene buono buono a cuccia, su di una vecchia coperta in un angolo, ma scodinzolando battendo la coda sul suo giaciglio e ricambiando il mio sguardo d'amore in
silenzio.
Ecco, ricordo, si chiamava Fritz... non so da quanto tempo non pensavo a Fritz... il primo cane della mia vita.
Ma io, piccola seduttiva e ruffiana, riuscivo sempre a dargli una carezza o un bacetto di nascosto, appena la guardia si allentava, come al solito io "facevo finta" di obbedire e poi facevo
quello che volevo.
Era l'unico modo che avevo: accondiscendere alla rigidità dei miei familiari e poi, serenamente, col sorriso, senza rabbia, scendere dalla sedia troppo alta per le mie gambotte, trotterellare un
pò per il "tinello buono", guardando senza toccare i ninnoli sui mobili austeri, il grande attaccapanni da muro dov'era appeso il panama dello "zio" e il bastone di canna, la grande
credenza intagliata e intarsiata coi vetri molati e dietro, in bell'ordine, stoviglie col filo d'oro e bicchieri di boemia, intarsiati a loro volta.
Ma con la coda dell'occhio guardavo Fritz e soprattutto la zia, che aveva il compito di sorvegliarmi mentre gli uomini parlavano sempre di cose "importanti".
Ed ecco che arrivava il momento giusto, mentre il babbo e lo zio s'infervoravano nella politica o negli affari di famiglia, pur tenendo il tono della voce basso perchè io non sentissi, ricordo
che parlavano della sorella del babbo, sposata "male" con un uomo "troppo di mondo" e delle sue vicissitudini che sconvolgevano mio padre e i suoi genitori putativi.
Così la zia-guardiana, ad un certo punto, veniva rapita in cucina da qualche sua faccenda e io sapevo che era giunto il momento. Fritz mi aspettava e io affondavo le manine cicciotte nel suo pelo
ispido e vetroso, lui ansimava di felicità col suo fiato caldo e un po' maleodorante, ma io sapevo, sentivo, che quello era un odore naturale, assai migliore dell'odore di chiuso che veniva dagli
armadi della camera da letto dove io ero entrata solo pochissime volte, dall'odore che c'era in cucina, un odore poco buono, che non mi piaceva affatto! Fritz, invece, aveva gli occhi dorati e
dolci, vivi e caldi, non duri come quelli di tutti coloro che mi guardavano dall'alto in basso e io mi sentivo così piccola e sperduta nei confronti di quegli esseri che io chiamavo nel mio cuore
"I GRANDI"
Ma grandi in cosa, se neppure sapevano dirmi cose belle, ma solo: "Stai zitta, stai ferma, stai composta, non ti sporcare, non toccare, sei una signorina ormai..." e io avevo si e no tre
anni?
Volevo urlare di gioia al cielo, sedermi sulla terra, raccogliere fiori.. giocare con il piccolo vecchio cane, accarezzare il piccolo vecchio cane...
Ed ecco che la "zia" tornava con dei piccoli bicchieri intarsiati da liquore su di un vassoio d'argento con ricami d'argento, sul quale era adagiato un pizzo prezioso fatto all'uncinetto, tutto
ghirigori, fatto da lei come tutte le donne della mia terra facevano, arte nella quale mia madre eccelleva.
Sul pizzo era anche posta una bottiglia da liquore, molto importante e preziosa, con intarsi d'oro sul cristallo grosso e corposo, piena di rosolio rosso shockante.
Un rosolio delizioso, manufatto della 'zia' che era una cuoca romagnola di ottima levatura, come tutte le donne di quella famiglia borghese fino al midollo.
In uno dei piccoli bicchieri da liquore, compagni gemelli della bottiglia, gli altri colmi fino all'orlo, era versato un piccolo rubino, la mia dose di dolce tormento alcoolico, che io accoglievo
con grande gioia e golosità, seduta tranquilla con le gambe penzoloni, mentre Fritz, continuava a guardarmi innamorato e scodinzolante dalla sua cuccia di lana vecchia come lui e forse, anzi
sicuramente, più di lui.
Bevevo il goccio di rosolio come una concessione ad avere io pure un seppur piccolo diritto, un seppur piccolo posto alla mensa dei grandi e il liquido denso pastoso, forte e zuccherino mi
bruciava graffiandomi la gola.
Era una stimmate.
La nonna paterna, invece, era bruttina, dimessa, aveva il naso grande, come un appunto negativo sul suo dolce viso.
Ricordo che mia madre scrutava attentamente il mio, se per caso non portassi la reliquia non apprezzata della nonna morta.
Anche mio padre aveva un naso importante, ma lui ‘ era un uomo ‘. A lui stava bene, a lui era permesso di essere se stesso.
Alla piccola donna che fu sua madre, no,
Barbra Streisand venne dopo e pure lei si fece la rinoplastica...
Non so molto di lei, trovai diversi anni dopo la morte di mio padre, guardando un cassetto pieno di vecchie foto che mia madre custodisce gelosamente, un doppio foglio di quaderno scritto a penna stilografica.
Era il testamento spirituale che la nonna, donna colta e sensibile, aveva lasciato ai figli.
Forse mio padre non l'aveva mai mostrato a sua sorella o forse era caduto nel dimenticatoio di una vita densa di colpi di scena. Fatto sta che quel semplice foglietto conteneva invece un tesoro assai prezioso.
Le ultime parole che mia nonna lasciò a chi restava erano di un amore intenso, di una bellezza davvero incredibile, intrise di luce e di fede in loro e nelle loro capacità.
Quando le lessi, piansi di commozione e mi domandai perché mio padre non avesse pensato a lasciarmi qualche riga scritta in suo ricordo. Di lui, nella sua bella grafia ottocentesca, ho solo le correzioni alle ricette di cucina in un vecchio e prezioso libro, ricettario ad opera di pellegrino Artusi. Quel libro, che io conservo gelosamente e che mi ha seguito ovunque, insieme ad un'edizione dell'ottocento della Divina Commedia illustrata da Gustav Dorè, sono tra i pochissimi oggetti che mi restano di mio padre.
A quel tempo pensai che, seppure mi dispiaceva separarmi da quei preziosi fogli d'amore, era giusto che fosse mia zia ad averli e glieli portai.
Questo accadde credo dopo il mio ritorno, 1996 e seguenti, tornata dal ravennate dopo la separazione dal mio secondo marito.
Anche mia zia e mia cugina si commossero alquanto nel leggere quelle parole.
Dopo la morte di mia zia, avvenuta nel 2006, mia cugina mi ringraziò ancora d'averlo fatto, accadde il giorno in cui mi aveva invitato a casa sua a bere un tea e mi donò un ciondolo formato da un topazio azzurro montato in oro bianco dicendomi che era uno dei gioielli che mia zia aveva amato di più e che me lo dava in suo ricordo e per ringraziarmi anche di essermi presa cura di lei per qualche mese, prima della sua morte.
Infatti, io stavo già abbastanza male ed avevo smesso di lavorare ma accettai di recarmi tutte le mattine fino alle sedici, ora del rientro di mia cugina dal lavoro, per accudire la zia che, ammalata di tumore al fegato, era avviata verso il suo ultimo giorno; compito che io cercai di portare in fondo con tutto l'amore e la cura che mi fu possibile. I rapporti con quella zia erano stati sempre un po' asciutti. Lei di certo mi voleva molto bene ma era una donna molto riservata ed io una nipote molto caotica. Inoltre fra noi il ricordo di quell'estate al mare, di cui ho parlato più sopra.
Volli, allora, in quei mesi, cancellare quell'amaro che era tra noi.
Ci riuscii, mia cugina mi disse che la madre le aveva confessato di essersi trovata molto a suo agio con me, riuscendo a vincere il suo grande pudore nel farsi accudire come fosse stata una neonata, cosa che la imbarazzava moltissimo. Disse alla figlia poi che i racconti delle mie avventure, gli aneddoti, le follie varie ed il mio ricordare con lei i tempi andati, quelle favolose estati nella villetta al mare, rivelandole piccoli segreti da bambini che lei ignorava, l'avevano aiutata molto a passare quelle ore difficili.
Ora anche lei riposa nella cappella funeraria di famiglia.
Il culto dei morti è sempre stato molto sentito dai miei. Infatti il 2 novembre di ogni anno fin da quando ero piccolissima mi conducevano a visitare i nostri defunti.
Era un appuntamento importante come il Natale ed il compleanno.
Mi vestivano a festa e tutti insieme si varcava quell'immenso cancello di ferro battuto, nero e tutto decorato di foglie, che chiude l'accesso al cimitero monumentale dalla nostra cittadina, mettendo una chiosa netta e scurissima all'imponente muro bianco di recinzione alto tre metri o forse più.
Fuori c'era tutto un andirivieni di gente, fiori, lumini, automobili; ai panchettini attorno l'ingresso diversi distribuivano i cartoncini decorati in bianco e nero, simbolo di donazioni in moneta fatte ai vari enti benefici della città. Quegli incaricati ritiravano le piccole somme di denaro e scrivevano con una penna il nome del defunto alla memoria di cui erano devolute le offerte e, più sotto, il nome di chi le porgeva. Il cartoncino era forato agli angoli superiori ed un cordino pendeva da quei fori, serviva per fissare il "Ricordino" a qualche appiglio di fronte alla sepoltura che si andava a visitare, in modo che i familiari del defunto potessero vedere chi si era recato in quel pellegrinaggio votivo a porgere ancora una volta cordoglio, vicinanza e mesto ricordo.
Fuori quindi vi era un via vai notevole ma dentro, ecco, dentro era come si aprisse un'oasi.
Il ghiaietto bianco del viale d'accesso era rigorosamente rastrellato e sempre molto abbondante e cricchiolava discretamente, come un canto di sottofondo, ai nostri passi.
I viali alberati erano cinti da filari di alti e scuri cipressi profumati, assai austeri ma intimi.
Dentro il silenzio: tutti parlavano a bassa voce, bisbigliando e limitando le parole al minimo. Così mi veniva ammonito di fare e così io pure mi comportavo.
Nell'aria vi era un intenso profumo di fiori, che però era un poco disfatto, troppo dolce, troppo morbido, quasi molle, quasi fermentato.
L'emblema del disfacimento della morte.
Si faceva il giro, camminando piano.
Prima ci si recava alle tombe esterne, nei campi in erba dove file e file di tumuli avevano una lapide sopra, un po' innalzata dal terreno e in verticale un piccolo cippo o croce o statua o altra lapide, che recava le iscrizioni del caso: la foto, il nome e cognome, la data di nascita e di morte e una piccola iscrizione in memoria, epitaffio. Tutto quello che restava di una vita.
I miei genitori mi dicevano: ' Questo è il tale, questo è il tal altro...'
E ogni anno c'ero nuovi defunti da andare a visitare, come petali caduti di un fiore che diventasse sempre più sparuto.
Spesso accadeva che i miei si fermassero a parlare sottovoce con qualche conoscente che incontravano. Io allora mi allontanavo un poco lungo la fila di quei tumuli e leggevo i nomi dei defunti, guardando le loro foto, allora tutte rigorosamente in bianco e nero. E pensavo che quei visi a volte belli, altre allampanati o strambi, quella schiera di occhi fissi sull'obbiettivo della macchina fotografica, erano chiusi per sempre. E li vedevo, come avessi una vista dotata della capacità di andare sotto terra, composti nelle loro casse, come avevo visto in qualche film alla televisione. E anche cercavo di immaginare che vita avessero avuto, soffermandomi a leggere gli epitaffi: ' Esemplare moglie e madre ' 'Onesto galantuomo dedito al lavoro ed alla famiglia ' 'Grande lavoratore e padre affettuoso ' ' Madre amabilissima che si prese cura di tutti '… sembrava davvero che tutti quei defunti fossero esempi di virtù. C'erano poi le statue: gli angeli con l'ala spezzata, o in atto di preghiera. Ma quelle erano più comuni nella parte coperta, dove c'erano le tombe di famiglia a cappella, come la nostra.
Infatti, dopo il giro per i campetti esterni fatto passando a trovare il nonno materno, lo zio di mio padre da parte di madre, che aveva sperperato tutto il capitale avuto in eredità con il gioco e le donne, altri parenti alla lontana e amici, tra i quali un giovane aviatore amico di liceo del babbo che era caduto con il suo aeroplano e la cui tomba era formata appunto da un'ala di quest'ultimo, eroe e giovane vita immolata alla patria, arrivavamo camminando all'alta costruzione lunga e stretta che recava queste cappelle votive poste una accanto all'altra. In ognuna di quelle vi era una quantità di mezzi busti di illustri dottori o studiosi, qualche nobildonna, notai e avvocati che mi guardavano immobili, seri e compunti, severi alcuni, accigliati, quasi la morte li avesse tramutati essi stessi in quelle statue, colpiti da un maleficio di qualche potente e malvagio mago, come nelle favole.
E i fiori bianchi, i crisantemi a palloncino oppure i gigli e i garofani, si sprecavano. Anche i miei, prima di entrare, ne compravano un mazzo e davano offerte per quei ricordini, facendosene consegnare una certa quantità; come pure acquistavano qualche lumino. Io mi offrivo di portare i fiori e mi piaceva tanto reggerli tra le braccia, come fossero un neonato, sentendo il loro profumo e il fresco tocco liscio dei loro petali e foglie. Ad ogni tomba visitata, un fiore veniva aggiunto al vaso che già si trovava lì e che i congiunti avrebbero ornato di grandi mazzi di altri fiori freschi. Allo stesso modo veniva appeso il ricordino. I lumini andavano sempre nella tomba del nonno materno, il mio amato nonno Marsilio.
Io, posati momentaneamente i fiori, reggevo il lume mentre mamma fregava lo zolfanello e guardavo la fiammella accendersi. Poi si apriva la piccola teca di marmo e vetro nella quale si collocava la piccola luce. Mi avevano insegnato a posare un bacio sulla foto gelida di quella tomba ed io lo facevo con grande affetto. Poi mi segnavo con il segno della croce e recitavo "L'eterno riposo", la preghiera per i defunti.
In tutto quel cerimoniale la tristezza era assai presente ma, vicina a babbo e mamma, veniva come addomesticata. Volevo sempre andare a portare un fiore all'amico Peppone, facendo allungare il giro consueto, dopo che lui morì.
Ma arrivati di fronte alla nostra tomba di famiglia la commozione cresceva di tono.
Due grandi foto in bianco e nero, ovali ed incorniciate di legno intarsiato, mostravano il volto dei nonni paterni. Dietro il cancellino di ferro battuto nero ornato di foglie e roselline, che era tenuto sempre unto per evitare che arrugginisse e che era sempre fiorito di tutti quei ricordini appesi alle corolle delle roselline, queste grandi immagini troneggiavano. In mezzo ed ai lati vi erano dei vasi colmi di fiori, lumini ardevano in diversi angoli. Mia madre apriva il cancellino, ammonendomi di non avvicinarmi per non sporcarmi, cosa che accadeva invece regolarmente tutte le volte, ed aggiungeva altri fiori, cambiava l'acqua nel vasi recandosi alla fonte poco lontano, preceduta da me che l'aiutavo azionando il braccio di ferro della pompa. Si accendevano nuovi lumi e si dicevano orazioni. Si leggevano sui ricordini i nomi di coloro che erano passati a portare una preghiera o un saluto. Dietro alle grandi foto, attaccata al muro, c'era e c'è ancora, una grande lastra di marmo grigio chiaro, sulla quale erano istoriati i nomi dei miei bisnonni, genitori della nonna paterna, in onore dei quali la nonna stessa e la sorella avevano acquistato quella tomba di famiglia, l'unico bene materiale che io possiedo, in comproprietà con mio fratello e i miei cugini paterni.
Le foto di questi due miei bisnonni, Pasquale e Maria, invece erano sul retro, si percorreva a ritroso un tratto di quella specie di galleria, si scendevano quattro o cinque scalini ed in un viottolino all'aperto ci si trovava a costeggiare il retro di tutte quelle cappelle, che si trovavao ad un livello inferiore ed avevano delle aperture con grata, attraverso le quali si accedeva alla stanza sotterranea che conteneva i loculi.
Questi retrocappalla erano molto più spogli e spartani degli ingressi anteriori, ma il nostro aveva sempre piante fiorite o mazzi di crisantemi e il lumino sempre acceso dietro al cancellino d'ingresso. So che mia madre vi si recava spesso, da sola, durante tutto l'anno, per fare la pulizia e la manutenzione anche di questa nostra casa funebre.
Sopra la grata erano appese tre lapidi. Quelle laterali recavano le foto ed i nomi con le date dei bisnonni. Quella centrale una foto che mostrava una bellissima giovane. Era la zia Cademis, sorella del nonno paterno, morta a diciannove anni. L'epitaffio parlava della sua bellezza "che un tragico destino volle spezzar".
Io, da quando imparai a leggere ed appresi quelle gravi e misteriose parole, sempre chiesi di sapere quale fosse quel "tragico destino" ma per anni mio padre mi rispose, accigliato e rattristato, che lo avrei saputo solo quando sarei stata abbastanza grande per capire. Quel suo misterioso e grave discorso sanciva la fine di ogni mia insistenza, anche se io spesso tornavo con il pensiero a quanto non conoscevo, interrogandomi oscuramente. Non fu mio padre a raccontarmelo. Troppo presto anche lui scese da quella grata, quel giorno di fine agosto 1966, in cui pioveva come fosse novembre.
Qualche giorno dopo, piangendo, mia mamma pose, tra i due grandi ritratti dei nonni, una altra mensolina di legno, scarna e a gambe lunghe, sulla quale poggiò la più bella fotografia incorniciata del mio babbo, quella che piaceva di più a lei e che gli era stata scattata il giorno della mia cresima, poco prima di quello della sua morte.
A quei tempi le foto si scattavano solo in occasioni particolari, non come ora che, con l'avvento dei cellulari, siamo diventati tutti fotografi.....
Dopo la morte del babbo per mesi, forse anni e di certo fino a quando aprì il negozio cominciando a lavorare, mia madre si recò a piangere su quella foto. Spesso l'accompagnavo, in quel caso non si faceva tutto il giro lungo, magari si passava a dare un saluto al nonno Marsilio ed un bacio sulla sua gelida foto, oppure quando morirono altri della nostra famiglia, come un fratello di mia madre e la mia cugina sedicenne, s'andava a trovare anche loro. Altrimenti andavamo dritte alla nostra cappella e ci fermavamo, in lacrime entrambe, di fronte a quel trittico, tutti e tre morti a 49 anni. Con mia madre che diceva a mio padre, sottovoce, mentre piangeva: "L'avevi detto sempre e così hai fatto. Così hai voluto lasciarmi qui." e questo era un vero rimprovero, che mio padre se ne era andato lasciandola sola a crescere noi, compito davvero difficile, a lottare contro tutti i problemi pratici ed economici e contro la tristezza e la solitudine di quel letto matrimoniale, che in casa nostra si tagliava a fette.
Io cercavo di sostenere mia madre, cercavo di consolarla, di parlarle. Le dicevo che il babbo ci guardava e ci proteggeva da lassù e al dolore acutissimo di quella perdita si mescolava a quello sconvolgente di mia madre, che aveva un qualcosa di assai amaro.
Amaro che solo l'anno scorso mia madre mi ha svelato da dove venisse, era giugno 2012, quando sono tornata nella mia cittadina per le nozze della mia secondogenita.
La famiglia di mio padre era una ricca famiglia borghese ma l'animo umano ha sepolcri ben più paurosi delle tombe.
Ad emblema di quelli, qui vi racconto il tragico destino della prozia Cademis, che mia madre mi raccontò poco dopo la morte di mio padre, ritenendo finalmente, che quella disgrazia mi avesse reso abbastanza grande da poterla conoscere.
La zia Cademis era davvero bellissima. La foto dell'epoca la ritrae vestita alla moda degli anni venti, con una di quelle pettinature lisce e corte ornate da cinte preziose che reggevano piume o altro e la relativa lunga collana di perle candide più volte arrotolata attorno al collo.
Era anche lei una maestra e fidanzata con un bravissimo giovane col quale era in procinto di sposarsi.
Il fratello più grande era quel nonno che aveva costumi piuttosto frivoli, libertini e assiduo frequentatore delle lussuose case d'appuntamento per giovani ricchi ed a modo, che rispettavano le mogli e le fidanzate sfogando i loro bassi istinti con queste giovani perdute.
Un giorno un amico lo incontrò a spasso per i portici della nostra città e gli disse, in gran segreto e complicità, che una nuova giovane e bellissima ragazza era giunta ad allietare le notti dei giovanotti bene in una cittadina limitrofa e lo esortò a seguirlo la notte stessa per poterla conoscere, e mai la parola "conoscere" espresse la concezione biblica bene come in questo caso.
Fu così che mi nonno seguì questo prezioso "amico" ed entrato nel casino, ornato di ricchezza quanto di marciume, si trovò di fronte alla sorella che, non paga della vita elegante ma moralissima che svolgeva in famiglia, aveva avuto bisogno di portare avanti per qualche tempo quella doppia pericolosissima vita, di certo non per mancanza di denaro ma per assenza di stimoli.
Come si può immaginare scoppiò un immenso scandalo, non so altri particolari ma è come se immaginassi il viso severo ed austero di mio nonno, sbiancato dalla collera e dalla vergogna, urlare, gridare, inveire contro quella povera fanciulla che, di certo, vedendolo entrare nella camera in cui attendeva i suoi "ospiti" si sarà sentita morire e forse è addirittura svenuta, oppure, che so, lo abbia affrontato con orgoglio o rabbia, rinfacciandogli mancanze che io non conosco. La mia immaginazione crea una scena tragicamente caotica.
Ma il fatto oltremodo grave fu che non si riuscì a contenere lo scandalo tra le mura domestiche, il fidanzato della ribelle e scostumata Cademis venne informato di tutto e lasciò su due piedi la sua promessa sposa, così la vita della giovane era definitivamente rovinata, così come la sua reputazione e quella di tutta la famiglia.... fu così che, per redimere se stessa e tutti i parenti, si suicidò.
Prese una notevole quantità di barbiturici ma non morì subito. Solo dopo quaranta giorni di dolorosissima agonia, divorata negli organi interni, spirò, avendo però nel frattempo, ricevuto il perdono di tutti quanti, fidanzato in testa.
È da svariati anni, che non mi reco sulla tomba dei miei cari, né so se lo farò mai più date le mie difficili condizioni di salute.
Vi è anche un altro suicida, il cui ricordo è sepolto in quella cappella votiva: il padre o forse il nonno di mio nonno Arturo, non ne sono sicura.
In tarda età questo mio antenato rimase vedovo, venne accolto nella casa del figlio sposato e non volendo essere di peso, ma sentendosi assai solo, un giorno in cui sapeva di essere in casa da solo, fece un accurato bagno, indossò i suoi abiti migliori, si sdraiò su di un divano e si sparò un colpo alla tempia.
Certo, il suicidio come rimedio di una vita divenuta insostenibile, io ce l'ho scritto nei miei geni.
Anche mio padre, avendo asserito per tutta la vita che sarebbe morto a quarantanove anni, quando poi ciò accadde in prstica mise in atto una sorta di suicidio, anche se di altro genere....

CAPITOLO SESTO
I nonni materni, gli zii e i cugini,
pesci, lucertole, pesci, formiche ed altri animali....
Quindi su quattro nonni ne ho conosciuti solo due.
Ricordo molto bene mio nonno materno nonostante sia morto di una leucemia fulminante quando io non avevo ancora tre anni.
Impiegò pochi mesi per spegnersi, era assai forte, ho perfettamente nella mia memoria la sua immagine.
Aveva i capelli bianchi bianchi, un bell'uomo dal volto rubizzo e le guanciotte sempre accese, cosa che io ho preso da lui.
Aveva gli occhi chiari e il suo volto sorrideva di natura.
Il volto della gente della mia terra è spesso così, improntato al sorriso ed alla simpatia.
Si chiamava Marsilio, alla faccia dei nomi romagnoli che sono famosi per la loro strana ilare follia.
Mia madre lo ricorda come un padre severo che mai ebbe un gesto d'affetto nei loro confronti, solo cinghiate.
Eppure, con suo grande stupore, coi nipoti cambiò ed aveva sempre un bel sorriso e le caramelle in tasca. Dei suo svariati nipoti riuscì a conoscerne solo tre: mio fratello, poi io e infine mio cugino Davide, nato alla fine del mio stesso anno.
Di lui rivedo il sorriso solare e la sua bici nera: ci saliva agilmente, in rincorsa, come facevano gli uomini del tempo, veniva vicino a me, mi sollevava con le sue braccia forti, mi sedeva sul cannone e mi portava in giro per il quartiere popolare nel quale viveva. Ricordo il cancello d'entrata della sua casa, aveva pali di sostegno di metallo con alla sommità delle pigne, il tutto pitturato in rosso acceso. Ricordo perfettamente il sali-scendi di quelle viuzze e poi al ritorno giocavamo a nascondino in cucina!
Mi nascondevo sotto il tavolo e lui fingeva di non vedermi e di disperarsi "Dove sei? Dove sarà mai??" ed io ridevo della sua ingenuità, pensando che fosse assai sciocco a non vedermi visto che non ero ben nascosta, mentre la zia Peppina, ancora in famiglia perché nubile e lo resterà, in piedi sulla soglia di casa asciugava i radicchi colti nell'orto, chiusi in un canovaccio, dopo averli lavati con l'acqua della fontana a pompa che faceva cigcigcig e poi chhhh... gettando l'acqua in un lavello di graniglia giallina.
Ricordo molto bene, ovviamente, anche mia nonna materna, che era sempre stanca perché ammalata di cuore.
Si spense in ospedale che avevo 14 anni e fui proprio io che mi presi cura di lei, in quel suoi ultimi mesi. Quando andai a trovarla mi disse che era stata appena ricoverata, che la mia mamma e le mie zie erano molto indaffarate e stanche mentre io ero giovane ma ormai grande ed ero la maggiore delle sue nipoti, poteva rivolgersi solo a me, le altre erano ancora troppo piccole.
Quindi mi chiese di recarmi da lei ogni giorno, dopo la scuola, per aiutarla e lavarla, perchè alzarsi dal letto le era impossibile in quei giorni. M'insegnò come fare, con la spugna ed un catino di acqua calda, mi chiese di lavarla anche nelle parti intime e non aveva vergogna perché, mi disse, tanto eravamo fatte tutte uguali. Poi le cambiavo la biancheria, le mettevo una camicia da notte fresca di bucato, le ravviavo i capelli bianchissimi con il pettine, passandoli e ripassandoli. Le davo anche la cena, ma aveva poco appetito ed insisteva sempre perchè mangiassi quello che lei non voleva: mi piacevano molto le sue mele cotte, lei le lasciava sempre per me.
Non fu una nonna affettuosa, tutt'altro, era dura come mia madre ed ora mia madre, che oggi ha 88 anni, le somiglia fisicamente molto ed io sto somigliando sempre di più a loro.
Si chiamava Argentina e passò la sua vita sempre incinta.
Ebbe tredici figli, il più grande morì in guerra sul fronte russo, ma il suo corpo non fu mai ritrovato. Anche lui, si chiamava Walter, era maestro di scuola, ma era affetto da una miopia molto forte, come suo fratello penultimo nato, Giovanni detto zio Nino, e come me. Quindi, quando passò alla visita di leva fu riformato, ma per lui era così importante andare a combattere e dare il proprio contributo alla patria, che tanto fece, scrivendo persino a Mussolini in persona, che alla fine fu arruolato, divenne tenente e fu spedito a macellarsi in Russia.
I suoi subalterni lo videro cadere in una furiosa battaglia sotto la neve, in una ritirata precipitosa ed il cadavere si perdette. Mia nonna non lo credette mai morto e lo attese fino all'ultimo giorno della sua vita, facendo tutte le ricerche che le fu possibile fare, scrivendo anche al papa, ma invano. Allora si sentiva raccontare ogni tanto di qualcuno che anche a distanza di molti anni, tornava in Italia dalla Russia, dopo magari essersi rifatti una vita là, disertori o fuggiaschi, ma lui non tornò mai.
Povera nonna, con un figlio nella pancia, uno in grembo e tutti gli altri attaccati alle sottane.
L'ultimo lo ebbe intorno ai cinquant'anni, credette fosse la menopausa, invece....
Quando era in attesa, ogni volta, smetteva di mangiare e viveva di acqua e zucchero. Ebbe anche molti aborti, non si sa bene se spontanei o procurati.
Perdette altri due figli maschi, erano molto piccoli e si chiamavano tutt'e due Vincenzo, uno mori a due anni di polmonite, l'altro appena nato perché la levatrice constatò che aveva il filetto della lingua troppo tirato e glielo incise con un paio di forbici, facendogli venire il tetano (!!!!!)
La povera nonna litigava con il nonno in continuazione, alle volte tornava ebbro dall'osteria e lei gli snocciolava la sequenza delle mancanze dei figli: Bruno ha fatto questo, Enzo quest'altro.... e allora erano grida e cinghiate.
La povera nonna costrinse il marito a dormire con i figli per non avere più rapporti con lui, perchè ogni volta la lasciava incinta.
La povera nonna si ammalò di mal di cuore che era ancora molto giovane e ne morì, finita dalle fatiche di tutti quei figli e dolori, a 62 anni.
Sono contenta di averla accudita su quella sua ultima soglia e di averlo fatto con tanto amore.
Certo la famiglia di mia madre era assai più proletaria di quella del babbo ma tutte quelle zie e zii colorarono la mia infanzia ed adolescenza. Ebbi un bel rapporto con quasi tutti loro. Certo ci fu qualche scontro quando fui adolescente, perché ero molto vivace ed ebbi il primo ragazzo che avevo solo dodici anni. Infatti fu lo zio Enzo che convinse la mia mamma a spedirmi in collegio, poiché mi vide baciarmi con quel ragazzotto, per strada, sotto casa.
Ma mi accorgo, ripensandoci un attimo, che ho moltissimi bei ricordi delle zie e zii.
Fra tutti il primo che mi viene in mente è lo zio Pino, era il marito della sorella di mio padre, ed era di natali assai umili.
Che uomo particolare, quello!
Magnanimo e favoloso elargitore di regali quale io non ho mai più visto né avuto: lui amava regalare cose costose e soddisfare desideri e capricci di tutti.
Questo era fonte di gioia nell'immediato, ma poi lo portava a dilapidare ingenti somme ed a rimanere senza soldi, cosa già molto meno apprezzabile. Ma, a parte i problemi che ebbe con la sua famiglia, io ricordo lui, il bene folle che gli volevo, bilanciato dall'altrettanto folle terrore che avevo delle sue ire improvvise.
Lui era diverso, a lui piaceva giocare, ridere, scherzare ed aveva una fantasia inesauribile.
Dava nomignoli e soprannomi a tutti. Io per lui ero "Ibus Quinteribus Illis, nata a Brisighella."
Gli chiedevo sempre cosa significasse quel nome che sapeva di latino e di antico ma lui mi rispondeva, tutto serio, che l'avrei scoperto solo da grande, che era un segreto molto importante. Ed io stavo a scervellarmi...
Rimase famosa la risata che tutti fecero quando io, l'estate tra la quinta elementare e la prima media, quindi l'ultima che mio padre trascorse con noi tutti nella villetta al mare della sorella, un giorno a tavola saltai su e gli dissi, tutta compresa: "Sai zio, l'anno prossimo studierò il latino ed allora scoprirò quello che significa il mio nome..." e ci rimasi male, dato che ero molto permalosa, perché tutti risero...
Solo da grande appresi il vero significato di quel nome e cioè che con un po' di fantasia ed attenzione si può far sognare un bambino e farlo sentire speciale.
Ricordo anche altre sue battute del genere, tipo i film che lui mi consigliava di andare a vedere: "La fuga della cavalla morta" e "La secchia rapita".
Era un uomo davvero originale, un vero artista ed ha lasciato impronta di sé come grande e famoso fotografo.
Ma aveva un lato iracondo del carattere: tutto ad un tratto si rabbuiava e diventava furioso, gridava, ci scacciava.
Io non sapevo mai come affrontarlo e scappavo via piangendo, quando faceva cosi. Così come non ho mai saputo né so affrontare nemmeno ora gli iracondi e i prepotenti, mi inibiscono profondamente ogni altra reazione immediata che non sia chiudermi in me stessa e restare profondamente offesa da quel comportamento.
Fumava come un turco, accendendo la nuova sigaretta con il mozzicone di quella che aveva appena consumato. Andava avanti così a rotazione per tutto il giorno. Come a rotazione passavano i bicchierini di brandy.
Non lo vidi né lo percepii mai ubriaco, a parte per questi cambi di umore così repentini....
Lo zio Pino era il nostro capitano. Aveva una barchetta di vetroresina, un piccolo cabinato di sei metri con la vela ed un motore entrobordo, che teneva al porticciolo turistico da diporto che si trovava a poche centinaia di metri dalla sua casetta.
Veniva a chiamarci alle quattro del mattino, bisbigliando. Noi bambini dormivamo tutti in una stanza e lui non voleva svegliare la figlia maggiore e mio fratello. Quindi ci toccava lievemente, scuotendoci e chiamandoci per nome: "Topi – era il soprannome di mio cugino Marco più piccolo di me di un anno – Ibus, è ora! …"
Immediatamente ci alzavamo e ci scrollavamo il sonno di dosso con l'aria fresca della notte che ci accoglieva, ancora buia e silenziosa. Il porticciolo per le barche da diporto era li, vedevamo i pennoni degli alberi luccicare nel buio e sentivamo i tintinnii dei cavetti metallici delle vele. Ci andavamo a piedi, con passo spedito: nella barca tutto era già pronto per la pesca. Lo zio aveva già caricato le esche ed il resto.
Lui, appunto, era il nostro capitano, mio cugino era il tenente di vascello ed io ero il mozzo. Ma a me andava benissimo così. Mollare gli ormeggi e tirare dentro i palloni respingenti era mio compito, che eseguivo con grande forza e celerità, mentre le ancore le levavano lo zio e mio cugino.
Uscivamo dal porto a motore: tum tum tum tum tum … tuonava quell'ammasso di ingranaggi e le paratie del molo rimbalzavano quei colpi come fosse il battito del cuore della barchetta, che a me sembrava un transatlantico. Poi, fuori, in acque più alte, issavano la vela e la barchetta si trasformava in un veliero. Mio zio insegnava a mio cugino a portare la vela, io intanto preparavo le esche spezzando le sarde che erano troppo grosse. Non mi venne mai in mente che io pure avrei potuto imparare ad andare a vela: io ero il mozzo ed ero altrettanto importante, il mio compito era basilare. Così si viaggiava per un paio d'ore, nel silenzio del fiato del vento che gonfiava la vela e lo sciacquio delle onde lisce come l'olio nella calma della notte estiva che pian piano sfuggiva nel mattino. Il sole sorgeva, spuntando dall'acqua come una grossa arancia e sembrava gocciolasse, grondante, appena ne usciva fuori, l'orizzonte acceso come in un incendio. La barca filava via veloce ed io volavo con lei. Ci voleva tempo per arrivare all'appuntamento con i pescherecci che ci attendevano. Mio zio era amico di tutti i pescatori del paesino e sapeva dove fossero, sicuramente se lo comunicavano con la radio. Si andava alla pesca dello sgombro.
Lo sgombro è un grosso pesce azzurro che vive in branchi assai numerosi. Almeno, allora era così. Quindi per pescarlo era necessario attirare l'intero branco. I pescatori partivano prima di noi e, giunti dove credevano avrebbero trovato le loro prede, pasturavano, cioè spargevano, facendo avanzare le barche molto lentamente, una scia di sardine ed altro pesce piccolo in stato di evidente frollatura. Perché, era chiaro, più puzzava quella roba, più potente era l'attrazione che esercitava. E, davvero, la pastura aveva un odore per me insopportabile. Per pasturare venivano non solo gettare notevoli quantità di questo pesce quasi marcio ma anche immersi nell'acqua fagotti di pastura contenuti in reti dalla maglia fine, che facessero uscire il sangue ed i brandelli di carne un po' alla volta, con il movimento del peschereccio, lasciando una scia che potesse venir percepita per un notevole numero di miglia. Era così che il branco veniva attirato e quella era la fase più lunga e delicata di quel tipo di pesca: se non si riusciva nel proprio intento, si tornava a casa senza aver preso proprio nulla. Ma il branco alla fine, presto o tardi giungeva: si vedeva l'acqua diventare viva, incresparsi di dorsi argentati ed azzurrini, di pinne di code, di guizzi e salti. A quel punto pescare era davvero un gioco da ragazzi: con la canna o direttamente con la lenza, come facevano noi, si gettava in acqua un pezzo di esca più solida in modo che restasse impigliata all'amo e si calava questo grosso uncino di acciaio, che era lungo come una delle mie piccole dita. E il pesce non tardava assolutamente a "beccare", mangiando l'esca ed ingoiando l'amo, al quale restava poi impigliato. Quando sentivo tirare la lenza che tenevo lenta in mano, la lasciavo un po' scorrere, perché il pesce avesse il tempo di inghiottire bene l'esca e non potesse più sfuggire, poi riavvolgendo velocemente la lenza al grosso pezzo di sughero che era la sua dimora, traevo a bordo la preda. Io avevo setto, otto e nove anni ma ero una bambina forte e sveglia. Ero un'ottima pescatrice, quella che sempre tirava su il maggior numero di pesci, perché, instancabile, gettavo e rigettavo il mio amo finché la vasca adibita a contenere il pesce non era piena.
Una volta pescai un piccolo pesce spada, piccolo per la sua razza, che raggiunge dimensioni di un metro e più, ma piuttosto grosso per me!! Lo zio mi aveva insegnato che per slamare il pesce, appena tirato su dall'acqua, bisognava afferrarlo e appoggiarlo, stringendolo forte, contro la pancia, in modo che non potesse più guizzare via e così io facevo, pesce dopo pesce. Ma quella spadina aguzza e dura, lunga almeno venti centimetri, si impigliò nella stoffa del mio costumino intero, arancione lo ricordo bene, squarciandola e graffiandomi la pelle dello stomaco. Quella volta, tornati a casa, fui decantata a tutti come una coraggiosa lupa di mare e lo zio non la finiva più di raccontare a tutti la scena, che credo sia stata davvero peculiare, di questa mocciosetta che tirava fuori dall'acqua questo pescione, che poteva essere sui due/tre chili di peso, e indifferente al dolore del graffio ed alla situazione particolare, lo teneva acchiappato forte forte e lo slamava con la maestria di un vecchio pescatore, gettandolo poi nella vasca, insieme agli altri e accorgersi solo allora del costume strappato, del sangue dalla ferita, ma nonostante questo rimanere a bocca aperta nell'ammirare la sontuosa preda, che non aveva mai visto prima, esclamando: "Che bello, zio, che bello!!!" battendo le mani. Quella volta mi sentii un eroe, davvero. Credo sia stato il giorno più glorioso di tutta la mia vita.
Tutto quel pesce che portavamo a casa, oltre ad essere cucinato per noi per un paio di giorni, veniva distribuito ad amici, parenti e vicinato. Eravamo i pescatori di un sacco di gente che, felice, accettava e ringraziava di quel pesce freschissimo. Forse non era molto prelibato, ma io pensavo che lo sgombro avesse il sapore migliore di tutti i pesci che mi facevano mangiare. Cotto in graticola con un ripieno di pan grattato aglio e prezzemolo, un po' amarognolo, non aveva quell'odore di pesce che non ho mai gradito molto. Cioè, l'odore del pesce non mi dava fastidio, affatto, né il maneggiarlo o altro ma non riuscivo a mangiarlo.
Non sono mai riusciti a farmi buttare giù il "brodetto", una specie di caciucco, che a tutti sembrava ottimo e che mio zio cucinava in modo speciale. Ma a me, davvero, quello faceva ribrezzo. Invece ero ghiotta di "poverazze", quella specie di vongole che c'erano allora, che avevano un sapore piccante, e che ora è stata sostituita da un'altra specie, venuta dai mari orientali. Eravamo sempre noi che le andavamo a raccogliere, queste poverazze, al mattino presto, quando una particolare posizione della luna creava una bassa marea piuttosto estesa. Allora si camminava per chilometri chinandosi ad estrarre dalla sabbia i molluschi chiusi nelle loro valve. La loro presenza era segnalata da una piccola bollicina d'aria, che si vedeva nell'acqua bassissima, oppure da una fessurina altrettanto minuscola: il mollusco teneva le valve della sua conchiglia socchiuse, in modo che l'acqua vi scorresse dentro, portandogli il cibo e questo era la sua fine.
Le raccoglievamo a secchielli interi io e mio cugino, inseparabili per tutta l'estate. Come pescavamo sempre col retino i gamberi lungo le pareti del porto, allora se ne trovavano in quantità, oppure "l'acquadella" per la frittura, un pescetto lungo pochi centimetri che veniva infarinato e fritto ed era buono solo se freschissimo. Lo zio ci aveva regalato un "bilancino", una piccola rete quadrata di un metro per un metro che si tirava su con un'asta, una corda ed una piccola carrucola. Io e Marco ci recavamo sul ponticello che stava sul passaggio dell'acqua di mare dal porticciolo verso una piccolo laghetto salmastro che era lì dietro.
Proprio in quel luogo c'era il passaggio di quei pescetti: come lo sapessimo, non lo so, forse ce lo aveva detto lo zio, e noi lì calavamo il nostro bilancino, pazienti, per ore intere, pescando la frittura per tutta la famiglia.
Sembra proprio una favola, raccontata così: acque pulite, pesce abbondante che si poteva avere gratis, senza problemi di licenze di pesca o altro. Bastava solo avere due braccia giovani e forti e la voglia di vivere.
Ed io di quella ne avevo in abbondanza.
Ma le avventure in mare sono state davvero tante, come tante le volte che noi tre andammo, sgusciando via nella notte, senza neppure avvisare le mamme, che altrimenti si sarebbero opposte, e tornando a pomeriggio inoltrato completamente cotti, anzi, abbrustoliti dal sole, così tanto che spesso il giorno dopo io avevo la febbre e più volte mi si piagarono le spalle, avevo la carnagione troppo bianca e sensibile, facile alle scottature. Ma che importava? Al largo, poi, lo zio ci permetteva di fare il bagno e di tuffarci dalla poppa, che aveva una parte più bassa, dove si apriva il cancellino dell'ingresso: io e mio cugino eravamo davvero degli ottimi nuotatori. Lui si stancava rapidamente, era molto magro ed anche più piccolo di me, gli veniva freddo, cominciava a battere i denti, le labbra gli diventavano blu e doveva uscire dall'acqua.
Io ero come un piccolo cetaceo ed in quel caso sentirmi una balena non mi dispiaceva affatto! Lasciavo gli occhiali a casa per paura di perderli, anche se vedevo pochissimo ero in grado di portare avanti il mio compito di sbrogliare le lenze, mentre lo zio e mio cugino reggevano le vele, indirizzando il vento del ritorno, si aggrovigliavano sempre ed era necessario lasciarle lì, mentre c'era il branco e prenderne un'altra per continuare a pescare. Quindi, messo tutto a posto, io mi sedevo a poppa, di fianco a questo groviglio di fili sottilissimi e quasi trasparenti e piano piano, con santa pazienza, dipanavo tutto, facendo su ogni lenza attorno al suo pezzo di sughero. Prendendomi sempre gli elogi dallo zio ed i suoi sguardi di approvazione, sembrava avessi davvero una particolare attitudine a quell'ingrato compito.
Evidentemente avevo già sviluppato la pazienza per le situazioni complicate.
In acqua io ero agile e resistente, veloce nel mio stile a rana, riuscivo a restare in apnea per un paio di minuti fin da piccolissima, indossavo sempre la maschera perché non riesco a tappare il naso con il respiro e l'acqua mi va in gola, succede a causa dell'operazione di tonsillectomia, nella quale mi asportarono anche le adenoidi, subita a tre anni .
A dieci anni riuscii a toccare il fondale a dodici metri di profondità, senza pinne, portando allo zio una manciata di sabbia, per dimostrargli che ci riuscivo perchè non ci poteva credere. Eravamo di fianco al "Paguro", una struttura per la trivellazione del metano che si trovava circa a venti chilometri dalla costa ed il fondale lì era misurato. Non c'erano dubbi. Dodici metri.
Io stavo comunque ore ed ore in acqua per tutta l'estate. Ormai i miei si erano arresi e mi avevano lasciato via libera, senza più cercare di limitare il tempo dei bagni, anche perché era un'impresa costringermi a tornare a riva.
Mia zia Teresina, trascorreva un paio di settimane ogni estate con tutti i suoi bambini in una casetta in affitto vicino alla villetta e veniva lasciata a guardia di tutti noi quando mamma tornava a casa per preparare il pranzo, e lei diceva che io ero la sua disperazione, dato che di me dalla riva si vedevano solo i piedi e le gambe tornare fuori un attimo per poi immergersi di nuovo. In effetti io andavo dove non toccavo, allontanandomi dagli altri e amavo moltissimo nuotare radente il fondale ed ammirare granchi pesciolini, alghe, conchiglie e pesci ago. Non che ci fosse poi tutta questa folla di pesci, dato il fondo sabbioso, ma c'era sempre qualcosa di bello da vedere e poi mi scatenavo in lunghe serie di capriole, in avanti e indietro. Ne eseguivo decine e decine senza riprendere fiato.
Decisamente l'acqua era il mio elemento.
In quella villetta ho passato le estati più belle della mia vita.
Avevamo una stanza piuttosto grande nella dependance, tutta piena di giochi, acquistati dallo zio generoso per noi. C'era persino un tavolo da ping pong e poi avevamo di tutto: il monopattino, materassini gonfiabili per andare in acqua, palle e palloni, persino un canotto a remi con dentro una piccola ancora, a bordo del quale io e mio cugino Marco trascorrevamo ora intere in mare, subito fuori dalla zona segnata dalla boa.
Poi c'erano le carte e gli scacchi, la dama, il tetris, il monopoli, il mercante in fiera, un'amaca. Un anno mio zio comprò un grosso pappagallo cacatua che allietò tutti quanti, vicini compresi, con le sue grida. C'era anche una voliera e dentro uccellini di ogni tipo. Lo zio mi dava spesso delle piccole e saporitissime uova da bere. Nessuno degli altri lo voleva fare ma per me quello che diceva lo zio Pino era Vangelo. E poi erano davvero buone, quelle ovette ed io mi sentivo tanto Robinson Crosuè, che era il mio eroe prediletto. Dopo pranzo, quando avevamo la consegna del silenzio fino alle quattro per far riposare i grandi, giocavamo a canasta tutti e quattro, ma io perdevo sempre e mi adombravo alquanto, così spesso mi perdevo in giochi silenziosi dentro la mastella di latta per il bucato: era la mia zattera, dopo aver naufragato con il mio veliero che stava affondando all'orizzonte del piccolo giardino, diventato una barriera corallina di un'isola sperduta, in un mare in tempesta, salvandomi miracolosamente su quella vasta spiaggia bianca che era il ghiaietto, mentre il roco gracchiare del pappagallo era il vociare di una intera foresta vergine e quell'amaca di fibre plastiche era un residuato di rete e tele del mio veliero affondato. Mi immedesimavo così tanto nel mio gioco che un giorno, fingendo di pescare dalla tinozza, con una delle lenze e dei grossi ami, pescai il cucciolo di pastore tedesco che lo zio aveva portato a casa pochi giorni prima!
Il povero cagnetto, incuriosito dai miei movimenti, venne ad annusare l'amo, che sicuramente puzzava di pesce, e non si sa come rimase infilzato per il naso. Cominciò a cainare come impazzito, richiamando tutti quanti ed io, che non mi ero accorta di nulla, stordita, come risvegliata da un sogno e riportata improvvisamente alla realtà, non seppi spiegare cosa fosse successo e mi presi una lavata di capo memorabile, con relativa punizione "senza gelato per una settimana".
Il povero cucciolo piangeva disperato mentre il vicino di casa, pratico di cani, gli levava l'amo dal naso e lo medicava, mentre io piangevo disperata, mi dispiaceva da morire aver fatto del male a quel tesoro di animaletto che adoravo, ma anche di rabbia perché nessuno credeva alla mia innocenza, non avevo fatto nulla, era accaduto e basta ed io non me n'ero neppure accorta.
E questa, come si vedrà, è stata la costante della mia vita.
Come si fa a raccontare tutto?
Le infinite e ripetute partite a bigliardino, dieci lire la partita, dieci palline che rotolavano rumorosamente nella buchetta quando, infilata la moneta, si tirava con forza il pistone che ribaltava l'alloggiamento interno. Giocavamo femmine contro maschi, io e mia cugina eravamo una coppia temibile e vincevamo spesso. Io stavo in porta ed avevo riflessi notevolissimi, parando d'istinto un gran numero di tiri.
C'era anche il juke-box che con la stessa cifra ti faceva ascoltare tre canzoni, le facevamo risuonare senza sosta mentre giocavamo, nella sala del bar dello stabilimento balneare della signora Dina, lo aveva chiamato "Bagno Angelo" in onore del figlio maschio, Angelo appunto, riccio, biondo e con gli occhi azzurri. Lui aveva imparato a lavorare fin da piccolissimo e benché fosse appena più grande di me, non si unì mai a giocare con noi. La madre lo adorava ed io lo guardavo sempre come fosse un fenomeno strano e un essere superiore.
E che dire delle merende dopo il bagno, con la schiacciatina e la gazzosa succhiata dalla boccetta di vetro con la cannuccia "slurp slurp", oppure il "bombolone", un grosso krapfen alla crema, o lo spiedino di frutta caramellata che vendeva il nostro vicino di casa, portandolo a spasso per la spiaggia dentro una teca di legno con i vetri a sventola sopra, in modo da mostrare la merce e prenderla comodamente ma preservandola dalla polvere e dalla sabbia, era assai pesante e lo portava a tracolla per ore, appoggiato al braccio muscolosissimo con un manico quadrato di legno. Ogni mattina, prestissimo, la moglie aiutata dalla figlia friggevano i bomboloni e tagliavano a pezzettoni la frutta, infilandola nello spiedino di legno, per poi calarla una ad una nel pentolone di zucchero fuso. Quando lo zucchero si freddava quella frutta diventava deliziosa. Lavoravano sodo ma avevano sempre il sorriso sulle labbra. La loro casa era proprio a fianco alla villetta della zia: sul retro preparavano le cose da mangiare e dall'altro lato gestivano un negozietto di giocattoli ed articoli da spiaggia. Noi compravamo sempre da loro tutta una serie di cose: le ciabattine di plastica infradito, le nostre uniche calzature estive, palette, secchielli, palline, biglie per giocare sulla sabbia, formine, stampini.... Ce n'era una, mi ricordo, che mi piaceva tantissimo, una specie di formina per fare dei mattoncini rettangolari. Si riempiva con la sabbia ben bagnata, si pressava forte e poi con uno stantuffo a molla si azionava un doppio fondo che scodellava il mattoncino. Quanti castelli ho costruito così!!! e altri con il secchiello e la paletta, seduta in riva al mare, dove l'acqua lambiva la sabbia. Costruzioni composite e turrite di ghirigori a pinnacolo, costruiti facendo gocciolare dalle dita unite a cuneo dell'acqua marina densa di sabbia, che si depositava come una stalagmite. Tutti quei castelli avevano il loro bravo ponte levatoio sul fossato, che gli girava intorno e dove versavamo con i secchielli l'acqua, come fosse un vero fossato, mettevamo le conchiglie come ornamento e le bandiere fatte con i bastoncini e la carta del gelato. Ci riunivamo in gruppo anche con bambini sconosciuti che erano venuti a passare le vacanze al mare per costruirli, spesso anche con bambini tedeschi e francesi o inglesi. Tanto per giocare non serve parlare la stessa lingua e poi ci capivamo lo stesso! Io facevo amicizia con tutti, per poi piangere calde lacrime ogni volta che qualcuno di loro, concluse le vacanze assai più corte delle nostre, tornava a Milano o chissà dove.
In attesa di fare il bagno i giochi erano tanti, oltre ai castelli e alla pista con le biglie, fingevamo di essere in una gelateria, mettendo in tante buche una accanto all'altra sabbia asciutta o bagnata, conchiglie triturate e bastoncini vari. Qualcuno poi aveva i tamburelli, i progenitori delle palettone con cui ora si gioca una sorta di tennis da spiaggia. Erano tamburelli veri e propri che suonavano, belli armonici, quando la pallina toccava la superficie.
A volte saltava fuori qualche racchettina da volano e noi avevamo sempre le bocce o le piastre, ovviamente io avevo una mira pessima perchè non vedevo il classico "tubo" e quindi mi stancavo subito di perdere tragicamente ogni volta.
E poi c'era la palla, nello stabilimento balneare c'era una rete per la pallavolo, quello che poi è diventato il "beach–volley", ed era un divertimento che non stancava mai. Così come l'altalena e lo scivolo, facevamo salti da spericolati, spingevamo l'altalena al massimo, restavamo in piedi sul seggiolino di legno e a volte salivamo gli uni sulle spalle degli altri: sotto mio fratello, poi io e sopra i due cugini, entrambi assai magri.
Mio zio ci fotografò, in posa durante quegli esercizi da ginnasti da circo, ho ancora quelle foto.
Ne ho diverse che immortalano quanto sto narrando.
Dovrei passarle allo scanner ma sono sempre così stanca.
Quindi spingevamo al massimo quelle altalene, avevano corde assai lunghe, e nel punto di massimo slancio saltavamo atterrando sulla sabbia. Viene da chiedersi come abbiamo fatto a non farci mai male, neppure una volta, eravamo davvero spericolati.
Tornavamo in spiaggia anche il pomeriggio per fare un altro bagno e al ritorno a casa, in attesa della cena, compravamo sempre un ghiacciolo al Bar Gelo, dall'altra parte della via, un chioschetto di legno verde. Io lo volevo verde, alla menta, o rosso, all'amarena, ma anche bianco, all'anice: com'era buono!
Lo succhiavamo lentamente, osservando il ghiaccio diventare sempre più incolore. Sul bastoncino infisso in quel ghiacciolo colorato e dolce c'era la possibilità di trovare una scritta: "Hai vinto!" e poterne ricevere un altro in omaggio. Io vincevo assai più spesso di mio cugino e questo lo faceva arrabbiare molto.
Ogni sera dopo cena, facevamo la passeggiata nel centro della cittadina balenare, traghettando il porto canale sopra una specie di chiatta quadrata trainata da corde tese tra una sponda a l'altra. I quei primi anni costava cinque lire, le corde venivano fatte scorrere con una carrucola, tirate a mano da un nerboruto pescatore chiamato Caronte, che in quel modo arrotondava le entrate di famiglia. Poi anche quello aumentò fino a cinquanta lire e Caronte comprò un motorino a scoppio, per fare il suo lavoro.
In centro c'era così tanta di gente che si doveva fare lo slalom e lo struscio per camminare. Arrivavamo fino al Grand Hotel, una costruzione alta e tutta decorata sui muri rosa, era tutta illuminata ed aveva davanti un ampio giardino sempre fiorito, con vialetti di ghiaietta bianchissima e rastrellata con cura, scrupolosamente, al bordo dei quali posteggiavano due o tre carrozze tirate da cavalli lustri e ben pasciuti, che attendevano clienti per portarli a spasso sul lungomare. Io andavo sempre ad accarezzare quelle bestie mansuete, chiedendo il permesso al proprietario che me lo concedeva sorridendo bonariamente, aspiravo con grande piacere quell'odore così particolare che emanava dalla loro pelle calda e fina, liscia come la seta.
Ho sempre provato una spontanea quanto un'incredibile attrazione e tanto amore per i cavalli.
Ci fermavamo ogni sera alla gelateria "Nuovo Fiore" che, secondo noi, aveva il gelato migliore e ne compravamo uno per ciascuno. Io, sempre alla panna e cioccolato, la panna era così cremosa e le commesse la allungavano in un ciuffo snello in cima al cono... era una meraviglia!
A volte noleggiavamo dei tandem, due a due, oppure un risciò, dove salivamo tutti e quattro e correvamo a rottadicollo per il viale affollato fra le auto semiferme, scampanellando e ridendo come pazzi.
Un paio di volte all'anno andavamo con i genitori a mangiare la pizza al "Forno magico" e fu proprio lì che io bevvi la mia prima birra a dieci anni. Com'era buona quella pizza con quella birra. Non ho mai più assaporato nulla che la eguagliasse.
Spesso andavamo anche all'arena all'aperto a guardare qualche film. Il fatto che mia cucina avesse otto anni più di me e mio fratello cinque, ci dava una notevole libertà, anche perchè loro due erano assai posati e responsabili. Anche mio cugino Marco era piuttosto tranquillo: il terremoto e combinaguai della situazione ero sempre io, anche se ero assolutamente ubbidiente e non facevo mai qualcosa che mi venisse vietata, anche se poi finivo per rompere le scatole ad oltranza per ottenere il permesso. Alla fina mia madre non ne poteva più e mi diceva: "Fai come ti pare." e con quello mi metteva in scacco matto, perché io non osavo agire di testa mia contrariando la volontà dei grandi e non osavo più chiedere perchè avevo ricevuto la risposta definitiva.
Quindi, sotto il controllo dei due ragazzi più grandi, andavamo dappertutto, anche guidati da loro in svaghi più adatti agli adolescenti: ma io e Marco eravamo assai svegli e l'orgoglio ci portava a svegliarci ancor di più. Ci avevano insegnato a giocare a canasta ed a poker, perchè bisognava essere in quattro per poterlo fare e quindi la nostra presenza era necessaria. Io amavo molto giocare a carte, lo amo tutt'ora, e non puntavamo denaro il gioco era fine a se stesso.
Spesso andavamo al mini-golf, con una manciata di spiccioli si potevano noleggiare una mazza da golf ed una pallina a testa. Ci venivano consegnati anche un foglietto ed una matita per segnare il punteggio. Si partiva quindi dal primo parterre, il più semplice, per arrivare all'ultimo, il sedicesimo, il più complesso. Erano percorsi obbligati su piccole piste di cemento bordate da muretti bassi ed arricchite di svariate difficoltà costituite da curve a gomito, tubi tunnel ed altre invenzioni in muratura quali castelli e ponti, per far aumentare il numero di tiri e la difficoltà per far entrare la pallina in buca. Inutile dire che io non ero molto brava in quel gioco, anche se mi affascinava, e che mi arrabbiavo regolarmente, perchè ero sempre il fanalino di coda della classifica finale.
Mi piaceva molto di più andare alla sala giochi "Las Vegas", un ampio negozio probabilmente ricavato in un garage che aveva il soffitto più basso del solito ed era gremito di macchinette per far giocare i bambini. Quelle di allora erano molto diverse da quelle odierne tutte elettroniche, c'erano piani che s'inclinavano e palline che venivano spinte da molle, azionate da bottoni che bisognava spingere, ed altre diavolerie del genere, un mini bowling ed un cesto da basket, ma l'attrazione maggiore per noi era il mai sostituibile bigliardino ed un bigliardo vero e proprio su cui imparai a giocare a stecca ed a boccette.
A pensarci bene la cosa più bella era essere lasciati soli e liberi scorrazzare e vivere "da bambini".
Non avevamo mai la presenza dei grandi direttamente addosso: sapevamo di essere sorvegliati, che c'era sempre un genitore a cui far riferimento e a cui comunicare i vari spostamenti ed attività, anche la signora Dina, del Bagno Angelo era come una seconda madre per tutti noi e ci teneva sempre sott'occhio.
Ma la presenza degli adulti era tangenziale, solo di controllo e contenimento: giocavamo tra di noi bambini e ragazzetti e ci rapportavamo a modo nostro e con le nostre regole.
Credo che questa sia stata davvero la grande bellezza di cui ho potuto godere, non come i miei figli ed i bambini d'oggi che invece devono fare ogni cosa a strettissimo contatto con un adulto, perchè i costumi sociali sono molto cambiati ed i pericoli oltremodo aumentati.
Noi passavamo ore ed ore da soli, senza che si sapesse con esatta precisione dove fossimo. Il paesino era assolutamente tranquillo, il traffico di auto assai scarso e noi avevamo imparato subito le regole per stare alla larga dai problemi, camminando sempre sui vasti marciapiedi. A quei tempi le automobili si fermavano per lasciarci attraversare e nessun adulto ci ha mai infastidito, né rapito, né rapinato o spaventato in nessun modo.
Mi rendo conto che già allora nelle grandi città era così per i bambini, ma noi eravamo in una vera isola felice: non vi era violenza, droga o altro, in quei giorni nelle cittadine della Romagna e vivere lì era davvero come una favola.
Trascorrevamo l'intera estate allo stato brado e questo ci rendeva decisamente felici.
D'inverno in città giocavo tantissimo con i miei cugini da parte di madre, tutti più piccoli di me. Anche quelli furono tempi assai felici per me e durarono fino alla morte di mio padre.
Con Davide, il figlio della zia Teresina, avevo un'intesa eccezionale. Abitava in un palazzone formicaio accanto al fiume, in un rione piuttosto popolare, ad un chilometro circa da casa mia ed io andavo da lui tutti i giorni. Di fronte vi era un'area abbandonata con una casa semidiroccata e pericolante nel mezzo, che noi chiamavamo "il campetto".
Quello era il nostro campo di battaglia. Vi era una banda rivale e nostra nemica, assai violenta ed agguerrita. Ogni giorno ci si contendeva il terreno a sassate e lotta corpo a corpo. Non vi erano mai né vincitori ne vinti, ma non interessava: l'importante era tornare a combattere il giorno dopo.
Però ci fu una volta in cui ci unimmo tutti.
Trovammo un cane abbandonato, una cagnolina, veramente e, dopo mille insistenze, ottenemmo di poterla tenere presso quella casa abbandonata. Le facemmo quindi una cuccia di assi di legno inchiodate con chiodi e martello, tutti materiali trafugati in qua ed in là, come pure le ciotole per il cibo e l'acqua. Ogni bimbo portò qualcosa e anche i nostri "nemici" ci chiesero di partecipare. Consideravano quel cane anche il loro. Ci proposero una tregua e noi, dopo un concitato conciliabolo accettammo, io ero il capo naturalmente visto che ero la più grande e la più prepotente.
Riunendo le forze riuscimmo a sistemare la povera bestia, una specie di cane da caccia, era bianca con piccole macchie nere grosse come chicchi di grano sparse dappertutto.
La chiamammo Laika, in onore della cagnetta russa andata nello spazio. Ma si prospettò subito il pericolo degli accalappiacani, da noi odiatissimi. Allora ci informammo e ci venne detto che se il cane non avesse avuto la regolare medaglietta, sarebbe stato sicuramente preso e portato al canile per poi sopprimerlo.
Noi ci arrabbiammo tantissimo e racimolammo il denaro per pagare quella tassa, le comprammo anche un collare con relativo guinzaglio di cuoio rosso ed una spazzola per pulire il suo pelo semilungo dai residui dell'erba e del fango, ma non trovammo nessun adulto che si prese la responsabilità di firmare per noi ed intestarsi il cane. Nessuno dei nostri genitori accettò.
Allora io, che ero troppo testarda, pensai di recarmi a parlare con il sindaco. Tutti furono d'accordo e quindi decidemmo all'unanimità di andare tutti insieme ma io sola, unica femmina tra tanti maschi, avrei fatto da portavoce.
Fu così che una torma di una trentina di bambini dai sei ai nove anni invase in una mattina d'estate il comune della nostra cittadina, un grandissimo e bellissimo palazzo medioevale sito nella Piazza del Popolo, non molto lontana dal nostro campetto.
Ricordo che un usciere ci venne incontro, tra l'allarmato ed il divertito e ci chiese cosa volessimo. Io parlai e mostrai la cagnolina, da me tenuta al guinzaglio, che con un'aria implorante lo guardava scuotendo freneticamente la coda. Dissi che non ce ne saremmo andati di lì finché non avessimo avuto la certezza che la nostra Laika sarebbe stata rispettata e dichiarata di nostra proprietà.
Il sindaco fu allora chiamato. Io non ricordo se venne proprio lui di persona o mandò qualcuno in sua vece, fatto sta che qualcuno arrivò, ci fece entrare nel suo ufficio, che era grande e con i soffitti altissimi e le pareti decorate di grandi quadri a sfondo scuro, come quelli che si trovavano in chiesa. Lui mi ascoltò attentamente, mentre parlavo sostenuta dai mormorii sottovoce di rafforzamento della mia ciurma e alla fine ci elogiò per il nostro senso civico. Ci accompagnò all'ufficio preposto e si intestò personalmente la proprietà della povera Laika, che fu festeggiata allora da tutti noi, in un coro rumoroso ed allegro.
Quell'uomo straordinario, io ricordo assai bene il suo viso che era molto bello, ci strinse la mano uno per uno, guardandoci negli occhi e chiedendoci i nostri nomi ed i nomi dei nostri genitori. Quando io gli dissi il nome di mio padre ebbe un sussulto e mi squadrò da capo a piedi, poi mi strinse ancor più vigorosamente la mano, dicendomi che egli era un suo grande amico, ed in effetti il mio babbo lavorava per un ente comunale.
Poi ci raccomandò di avere grande cura della bestiola e di tornare da lui se ci fosse stato qualche problema, dopo di che si accomiatò, salutato dal nostro coro di auguri e ringraziamenti.
Tornammo a casa esultanti, facendo un grande schiamazzo per strada, continuammo a raccontarci e a raccontare a tutti quelli che incontravamo la nostra grande avventura, che sollevò una grande eco in quel rione popolare. Per giorni e giorni molti dei "grandi" vennero a farsi narrare la storia e spiegare, increduli, i particolari....
Laika visse molto tempo lì, il cibo davvero non le mancò mai, ed io la portai anche dal veterinario, al macello comunale, che le praticò il vaccino. D'estate le facevamo il bagno e le mettevamo nel pelo la polvere antiparassitaria, come ci aveva raccomandato di fare il veterinario.
Ero io che le toglievo le zecche con una grande destrezza e senza alcuno schifo quando, nonostante la polvere, le si attaccavano addosso. Decisamente ci sono nata con l'istinto di quello che fu poi il mio lavoro per una grande parte della mia vita.
Poi il campetto fu spianato, la casa demolita e un parcheggio con un parchetto apparsero al suo posto.
Di certo molto più utili, civili ed architettonicamente belli, furono piantati degli alberi ed il parcheggio era davvero necessario, ma a noi tolsero il nostro campo di battaglia e diventammo molto tristi: qualcosa di favoloso e meravigliosamente pericoloso non esisteva più e non ci restò che andare a giocare sulle sponde del fiume.
Così facemmo, ma un giorno mio cugino mi chiese se avessi voluto vedere qualcosa che era davvero pericoloso per me che ero una bambina.
Punta nell'orgoglio e nella curiosità, che erano entrambi decisamente assai vivi e presenti in me, accettai e così decidemmo di andarci subito.
Non seppi mai e non gli chiesi mai come ne fosse venuto a conoscenza.
S'incamminò, seguito da me, lungo il sentiero che correva sulla sponda del fiume in direzione delle colline. Passammo il Ponte Vecchio, con le sue alte campate a dorso d'asino in pietra grezza ed uscimmo dalla città. La vegetazione divenne più lussuriosa e fitta, il canneto quasi nascondeva il sentiero all'occhio. Mentre camminavamo io gli chiesi di raccontarmi cosa stavamo per vedere, ma lui mi disse soltanto di stare pronta a fuggire quando sarebbe stato il momento, raccomandandomi di correre il più forte che mi fosse stato possibile.
L'emozione mi aveva chiuso lo stomaco ma la curiosità era troppo forte. Così saltellavo baldanzosa al fianco del mio luogotenente, dichiarando che non avrei avuto nessuna paura.
Camminammo per parecchio, quando finalmente arrivammo ad una radura posta ad un'ansa del fiume e vidi: a distanza di cinquanta passi su una specie di terrapieno che faceva come un trampolino sull'acqua, un nutrito gruppo di ragazzotti tutti più grandi di noi stava facendo il bagno nel fiume, completamente nudi, tuffandosi ripetutamente nell'acqua, che lì doveva essere abbastanza alta e tornando a riva a nuoto.
Restammo in silenzio a guardarli, ero davvero colpita ed incuriosita da quello spettacolo e poi sapevo che era una cosa proibita e quindi ne assaporavo tutta la pericolosa bellezza.
Poi uno di quei ragazzacci ci scorse, nonostante avessimo cercato di restare nascosti e ci additò alla compagnia.
Un improvviso coro di grida, lazzi e parolacce si levò: "Una donna, una donna, ehi, sei una puttana? Quanto vuoi? Vieni qui che ti ciuliamo tutti! (diallettismo che significa fregare, in senso lato) Puttana, vieni qui puttana! Mi fai un pompino, eh??"....
E qualcuno di loro cominciò a correre verso di noi, così, nudo com'era. Io guardavo il loro genitali, anche se non erano i primi che vedevo, che stavano rizzandosi per l'eccitazione. Molti di loro avevano preso in mano il loro piselletto irrigidito e mo lo mostravano con gesto volgari.
Allora ebbi paura, mi volsi precipitosamente e mi diedi alla fuga, spingendomi ad andare il più veloce che mi fu possibile, mentre sentivo i passi di mio cugino che mi seguiva da presso e le voci dei ragazzacci che ci incalzavano; "Dove vai, puttana! Torna qua che ti volgiamo ciulare! Ehi tu, bambino, te la vuoi ciulare tutta tu??".
Corremmo senza voltarci finché le voci non si spensero dietro di noi e anche dopo, fino a raggiungere la panchina che era il nostro quartier generale.
Non parlammo di quello che era successo, né di quello che i ragazzacci mi avevano detto: io ero stata assai coraggiosa ed avevo superato la prova che mi era stata proposta. Tutto finì lì.
Ma io sento ancora quelle voci. Mi fecero male, quelle parole che per me erano quasi inedite, ma soprattutto l'energia violenta che vi si celava dentro.
Ero io una puttana? Non lo sapevo, non avevo ancora chiaro il concetto.
Allora mi confidai con la mia amica Sandra che mi disse che le puttane lo facevano con tutti gli uomini, per denaro. Mi disse anche che sapeva che al cavalcavia si potevano vedere perché era lì che loro si trovavano di solito. Così decidemmo di andare a vedere. In bicicletta, io davanti e lei dietro, ci recammo velocemente, con il cuore in gola, per vedere una di queste fantomatiche donne orribilmente meravigliose, ma non ne vedemmo alcuna. Forse era troppo presto, forse non era il luogo giusto e dovemmo tornare con le pive nel sacco.
Ma almeno io avevo saputo che non ero una puttana e questo mi consolava.....
Ogni tanto, quando ero molto piccola, tra i tre e i quattro anni, andavo a trascorrere qualche giorno dalla zia Esterina, che aveva problemi di udito e non aveva figli. Abitava con lo zio Bruno, fratello maggiore di mia madre, in una casettina al limitare della città. Ora quel quartiere è uno dei più belli, allora sembrava invece campagna, infatti a me piaceva tanto perché c'era un giardino e di fronte una vasta distesa di campi di grano dove d'estate vedevo le lucciole.
Che meraviglia stare tra il grano ancora verde che mi arrivava oltre la cintola e farmi danzare attorno tutte quelle piccole luci intermittenti!!
La zia una volta ne catturò qualcuna, le chiuse in un vasetto e me lo mise sul comodino, così che potessi vederle. Ma al mattino i piccoli meraviglioso insetti/lampadina erano solo mucchietti grigi di qualcosa d spento e morto. Quanto piansi!
E quanto piansi quando scoprii che la gatta Muci aveva mangiato la mia lucertola!
Muci, che era una gatta "siamese", come il mio Bainjo, e forse è da allora che ho imparato ad amare particolarmente i gatti di questa specie, che sono piuttosto speciali. Lei era l'amore di mia zia che trascorreva tante ore in cucina a cucire con la Singer semi automatica, azionata da una pedivella. Ora quella cara zia è morta da tantissimi anni, forse venti, ma io sento ancora quel rumore così particolare di quei piedi che azionavano quel meccanismo a volano che faceva entrare ed uscire l'ago dalla stoffa. Lei era velocissima con i piedi e le mani che guidavano il cucito e sembravano un tutt'uno con la macchina. Io stavo ad ammirarla incantata, mentre lei lavorava e la gatta dormiva sul suo cuscino posto proprio lì, sul tavolo da lavoro della zia, sotto alla finestra, vicino ai cestini con rocchetti di filo di tutti i colori, pezzi di stoffa, il metro da sarta, un paio di forbicioni giganteschi e i gessetti per segnare dove tagliare e poi cucire.
La zia cuciva gli abiti per le vicine e le amiche: era molto brava e si faceva pagare poco da loro. Così era sempre indaffarata. Non che avesse bisogno di denaro, loro erano i più ricchi di tutti.
Ma lo zio era fuori per lavoro per giorni e giorni, in giro per l'Italia a comprare e rivendere frutta e verdura all'ingrosso, e lei rimaneva sola con la sua gatta. Così cucire per le altre le piaceva e la teneva occupata. Anche per quella ragione io venivo mandata spesso da lei per qualche giorno, conoscevo bene quel posto e giocavo sulla la stradina non asfaltata che correva lungo quella fila di casette basse, uscendo dalla città ed inoltrandosi nelle campagne. Lì vi erano un sacco di animaletti che io osservavo con grande interesse e che spesso catturavo. Avevo imparato a prendere le lucertole senza fare loro del male e avevo scoperto che accarezzandole piano col dito in un punto preciso sotto la gola s'immobilizzavano e restavano ferme a farsi guardare, sul palmo aperto della mano. Nessuno me lo aveva insegnato, lo facevo a basta. Strappavo quei lunghi fili d'erba piuttosto resistenti anche se flessibili e, legandone due o tre, creavo una specie di guinzaglio che passavo attorno alle zampe anteriori dell'animaletto. Così lo rimettevo per terra e quello camminava ed io lo seguivo. Ogni giorno catturavo una di quelle lucertolone e la portavo al guinzaglio in quel modo per un po', poi quando la zia mi chiamava per rientrare, la scioglievo e la lasciavo andare. Ma quella volta avevo trovato un grosso ramarro tutto verde e azzurro. La zia mi chiamò per la merenda e io, che non volevo lasciare andare la bestiola perché mi piaceva troppo, le chiesi di poterla portare con me in cucina. Lei aveva paura di quelle bestioline e mi disse di legarla nel cortile alla gamba di una sedia, in modo da ritrovarla finita la merenda, ero davvero piccola e così feci quello che mi era stato consigliato.
Divorai la merenda e corsi subito fuori dalla mia amica tutta colorata, ma una volta fuori di lei trovai solo qualche pezzetto sanguinolento un rimasuglio del troppo facile pasto della ferina Muci, che si era ritrovata con un regalo così inatteso e non se l'era fatto assolutamente scappare!
Fui triste, inconsolabile, per giorni. Mi sentivo fortemente in colpa per la fine della mia amica lucertola. Sgridai Muci ma mi resi conto che lei era del tutto contenta di quanto aveva fatto. Ero furiosa con lei ma non potevo non volerle bene. Così la perdonai, capivo che dal suo punto di vista non era stata una cattiveria ma una cosa del tutto normale.
Dopo quel giorno, non misi più il guinzaglio alle lucertole e mi limitai a prenderle, "incantarle" guardarle e poi liberarle intatte.
C'era anche un altro animaletto che mi offriva un gioco bellissimo: il maggiolino.
A quei tempi ce n'erano a bizzeffe sulle rose fiorite dalla zia, che amava molto quei fiori e ne aveva diverse piante lungo la recinzione del piccolo giardino. Erano di tutti i colori: gialle, rosa, bianche, rosse e tute assai profumate, non come quelle di ora, che non sanno più di nulla.
Dentro i calici, sul bottone della corolla e tra gli stami, si trovavano con facilità quei grossi coleotteri verdi, la cetonia dorata appunto, che noi chiamavamo "maggiolini" perchè le rose fiorivano a maggio. Era facile catturarli, erano molto lenti nello spiccare il volo e quindi io, con delicatezza, ne prendevo uno con le dita di una mano, lo appoggiavo sul palmo e quando l'insetto apriva le elitre per spiccare il volo, io gli passavo sotto un pezzo del robusto filo di cotone da cucire della zia, in modo che gli passasse attorno al torace, a cappio. Succedeva così che il maggiolino spiccasse il volo, usando la mia mano come pista di lancio ma, restando impigliato al filo, non potesse fare altro che girare in tondo: io reggevo l'altro capo del filo e lo guardavo per un po', volare ronzando come un grosso cacciabombardiere a quattro motori, finché l'insetto si posava di nuovo sulla mia mano, magari si riposava un po' e poi spiccava il volo un'altra volta. Glielo facevo ripetere qualche volta, quel bel gioco, poi lo liberavo, per non spaventarlo troppo.
Il mio rapporto con gli insetti ed altri animaletti ebbe diversi episodi, lo racconto qui di seguito in due capitoli di "Io non sono di qui."
Le formiche
Nel bordo di un muretto che correva lungo la discesa dei garage del condominio, c’era un fazzoletto di terra con un po’ d’erba e qualche
vaso.
Lì avevo scoperto un formicaio.
Un piccolo nido di formicuzze nere che scendeva lungo una sottile crepa tra il cemento e la terra.
Restavo ore a guardare le delicate bestiole affaccendate nella loro organizzata e industriosa esistenza.
Portavo briciole della mia merenda e seguivo
le operazioni di smaltimento lungo i loro segreti magazzini interni, immaginando inesistenti voci e richiami.
Un bimbo più piccolo di me che abitava al quinto piano scoprì il mio appassionato interesse e un giorno distrusse il formicaio, per sfregio, per il semplice gusto di farmi soffrire.
Quando arrivai all’appuntamento quotidiano con le mie amiche e trovai solo lutti e devastazioni, rimasi impietrita.
Cadaveri ovunque. L’ingresso ordinato e quasi invisibile della casa sotterranea era ora una buca e un cumulo di terra smossa.
Tutto distrutto.
M'invase una collera violenta.
Piangendo e urlando corsi a cercare il malcapitato autore dello sterminio e trovatolo poco lontano, del tutto impreparato alla mia reazione,
lo picchiai selvaggiamente.
Gli feci male, tanto che fu costretto a letto qualche giorno. Ma era un monello avvezzo a mettersi nei pasticci e non rivelò mai chi l’aveva ridotto in quel modo. Così non fui rimproverata da
nessuno.
Ritornai piangendo e tremando di rabbia al mio formicaio e rimasi a lungo a singhiozzare con la testa tra le mani.
In giro non c’era nessuno.
Ma a un certo punto vidi una formica far capolino tra le macerie del suo palazzo e poi, guardando meglio, asciugandomi gli occhi con il dorso delle mani sporche di terra, un’altra e un’altra
ancora.
Le superstiti non si stavano affatto disperando.
A due a due prendevano i cadaveri delle compagne morte e li portavano giù, trascinandoli a fatica, lungo i corridoi distrutti della loro casa.
Altre, invece, con un progetto a me sconosciuto ben chiaro nella piccola grande mente, spostavano o toglievano granelli di terra e detriti.
Lavoravano alacremente, ma senza affanno, come comandate da un sereno e invisibile capomastro che le istruiva su cosa dovevano fare, sul come e che infondeva loro forza e coraggio.
Presi allora un sottile bastoncino e cominciai ad aiutarle come potevo, avvicinando i cadaveri all’imboccatura del formicaio, per alleviare almeno un poco la loro fatica. Sminuzzavo cautamente i
grumi di terra più grossi, attenta a non provocare smottamenti lungo la voragine ancora aperta, in modo da facilitare la loro metodica e tenace opera di ricostruzione.
Rimasi presso il nido distrutto fino che mia madre, spazientita, non mi chiamò per la cena. Era quasi calata la notte.
Naturalmente la mattina dopo andai a scuola e solo il pomeriggio potei scendere a controllare la situazione.
Il lavoro eseguito dalle formiche era straordinario. Non dico che tutto fosse tornato come prima, ma sicuramente l’ordine e la pace regnavano di nuovo nel formicaio silenzioso.
Guardavo i piccoli esseri con ammirazione. Senza strepiti e pianti, avevano ritrovato la loro dignità.
Però, in fondo, non so perché, mi sembrava di sentire un sottile dolcissimo canto, come una tenue nenia funebre.
Tutto rimase tranquillo per diversi giorni e io alternavo i miei giochi chiassosi e spensierati alle visite quasi mistiche al formicaio.
Un giorno però, trovai tutto bruciato, raso al suolo come si suol dire, "delenda Cartago" come mi avrebbero insegnato a scuola.
Nessuna era sopravvissuta e una larga chiazza di erba e terra annerita restò per moltissimo tempo a testimoniare la fine dell’Impero delle Formiche.
Non vi furono né lacrime né vendetta, questa volta, perché quel fuoco aveva bruciato anche un poco di me.
Topi, scorpioni e ragni
Nella grande casa settecentesca dove sono nata, il giardino sul retro era ampio e popolato di fiori.
Iris violacei che erano chiamati le «scoregge del diavolo». Grandi margherite gialle. Bordature di trifoglio dai fiori violetti. Roseti profumati di ogni colore. Due svettanti palmizi di
coloniale memoria e sedili di pietra levigata per stare all’ombra.
In fondo, la lavanderia coperta di edera e la casina.
Al piano terreno erano stati ricavati due appartamenti.
In uno viveva la famiglia di Massimo, il mio carissimo Massimo, che il padre, a cui mancava un braccio e che a noi incuteva un sacro terrore, picchiava ogni giorno con la cinghia e poi chiudeva
nella cantina scura. Massimo non piangeva più, ma io mi rannicchiavo vicino alla porta chiusa e gli parlavo singhiozzando, perché non avesse paura.
Ma lui non aveva paura. Lui era coraggioso.
Quando le rose erano in fiore e il loro profumo nei caldi pomeriggi di maggio stordiva lievemente, mentre tutti dormivano, noi rubavamo dalla cantina due bottiglie vuote di vino, una per uno, le
riempivamo di petali strappati dai rami carichi dei roseti e vi versavamo un po’ di acqua azionando la pompa a braccio dipinta di rosso che cigolava sinistramente.
E poi, con i ferri da calza sottratti dal cestino da lavoro di mia madre, riducevamo in poltiglia quei petali profumati, traendone un fluido dolciastro e stucchevole che ci spruzzavamo addosso
come fosse Chanel numero 5.
Era il profumo della fantasia del nostro giardino.
Ma nella cantina c’erano ragni, scorpioni e topi. Io ne avevo paura.
La zia di mio padre, un’anziana maestra nubile che viveva in una vecchissima casa cadente all’inizio della medesima via, era zoppa.
Aveva avuto la poliomielite, ma a me qualcuno aveva raccontato che era rimasta così perché era stata punta da uno scorpione velenoso proprio nella nostra cantina.
Questo dava alle nostre discese laggiù il sapore di imprese pericolosissime e si facevano le scale di corsa, ben attenti a non toccare il muro.
Giacomino, il mio gatto, era il padrone incontrastato della cantina.
Di pelo rosso striato, gli era permesso qualche volta di entrare nella cucina annerita dal fumo del camino e con l’acquaio di pietra, per ricevere qualche avanzo dalla nostra tavola.
Ma il suo cibo se lo doveva procacciare da solo.
Era un ottimo cacciatore di topi. Ma un giorno protestò, a modo suo.
Mia madre si toglieva le scarpe quando rientrava in casa e indossava un paio di ciabatte.
Le scarpe venivano riposte in un angolo del muro, tra la cucina e la porta della cantina. Un giorno che doveva uscire, come di consueto andò a indossarle.
Un urlo disumano ci scosse tutti.
Ci precipitammo da lei spaventati e la trovammo che osservava terrorizzata un topo morto che il gatto, da vero sadico, aveva deposto dentro una delle due scarpe. In segno di sdegno e di
dispregio.
Povero Giacomino!
Qualche tempo dopo, una notte, scivolò lungo l’orlo rotondo di pietra del pozzo dei vicini, che era aperto e senza coperchio e cadde nell’acqua gelata.
Era inverno.
Io dormivo nella mia camera, sotto la coperta coi "Bambi" e mi svegliai sentendo i suoi miagolii terrorizzati e disperati.
Corsi in camera di mamma e papà, piangendo, pregando e implorando per la salvezza del mio micio, ma mi risposero che tanto non c’era più niente da fare, mi rispedirono a letto e si rimisero a
dormire.
Io accompagnai con i miei singhiozzi la lunga e terribile agonia del mio amico…
Nella vecchia casa non c’era riscaldamento, né vasca da bagno, i pavimenti erano di pietra lucidata con la cera rossa.
Quando mia madre ci doveva lavare, una volta alla settimana, metteva un’ampia tinozza di latta davanti alla cucina economica con il fuoco prigioniero dentro anelli concentrici di ghisa.
Stendeva delle lenzuola lungo alcune corde per ottenere un minimo di privacy, scaldava l’acqua sulla stufa e ci lavava e strofinava vigorosamente lì.
D’inverno faceva molto freddo e mio padre, che lo soffriva in maniera particolare, prima di andare a letto vestiva pesanti pigiami di lana e fustagno e si metteva in testa una lunga papalina
beige con un piccolo pon pon in fondo.
L’aveva confezionata mia madre con i ferri da calza, come tutta la maglieria che indossavamo.
Il nuovo appartamento sarebbe stato moderno e dotato di tutti i comfort.
Ma io ricordo ancora il vecchio portone pesante di legno scuro dietro alle nostre spalle…
Mentre il condominio era in costruzione, ci trasferimmo nella casa della vecchia prozia. Una dimora più cadente e scomoda della nostra, ma l’anziana signora stava per morire e aveva bisogno di
assistenza.
Era stata maestra elementare e aveva dedicato all’insegnamento tutta la sua vita. Si mormorava che da giovane fosse stata amata da un uomo misterioso: ma lui era emigrato in Africa e lei si era
rifiutata di seguirlo, rimanendo così zitella per tutta la vita.
Era una signorina brutta e taciturna, goffa, zoppa e con un gran naso.
Non si lasciò mai fotografare in vita sua e nella sua casa non c’erano specchi.
Sulla sua lapide figura unicamente il suo nome, senza nemmeno la data.
Io le facevo visita quotidianamente.
Aveva vecchi libri di testo del tempo fascista e quaderni dalla copertina nera, con i bordi delle pagine dipinti di rosso. C’erano anche cannucce e pennini per scrivere, lapis rossi e blu per
correggere i compiti e inchiostro nero in vecchie boccette incrostate.
Io le chiedevo di farmi fare i compiti e lei mi assegnava lavori da eseguire che poi correggeva coscienziosamente e ai quali dava il voto.
Tornava indietro ai suoi anni migliori tra i banchi.
A me piaceva fare i compiti che mi assegnava.
Lei mi prendeva molto sul serio e non si stancava delle mie chiacchiere.
Penso di avere reso un po’ meno tristi i suoi ultimi giorni di vita.
Se ne andò in fretta e ricordo che i miei fecero un inventario delle sue povere cose. A parte un po’ di fine biancheria ricamata e tela da lenzuola intessuta a mano, vestigia del suo corredo mai
terminato né sfruttato, le sue erano poche e semplici cose di tutti i giorni.
E pensare che era stata una donna ricca. Proprietaria di case e di un teatro in città, dato che suo padre era un imprenditore edile, ma il fratello, incallito donnaiolo, giocatore d’azzardo e
altrettanto fannullone impenitente, le aveva mangiato tutto il capitale, lasciandole solo la vecchia casa cadente nella quale aveva finito i suoi giorni.
Io chiesi in regalo le sue chincaglierie e nessuno trovò niente da dire.
Così continuai a frequentare le sue stanze ormai vuote.
Avevo steso una vecchia coperta imbottita per terra e recitavo il ruolo della padroncina di casa con le sue tazzine e i suoi piattini, scrivevo nei suoi quaderni neri e mi davo i voti da
sola.
Ho ancora un paio di quei quaderni, zeppi dei miei diari adolescenziali, in una vecchia scatola di legno, silenziosi ricordi di un silenzioso passato.
Di sopra non avevamo il gabinetto, per cui si utilizzava quello della zia di sotto.
Anche quel servizio era stato ricavato in un secondo tempo all’esterno della casa ed era coperto da una centenaria edera rampicante che nascondeva la facciata interna di tutta la casa.
All’interno si trovavano un lavandino e un water.
Una sera scesi per fare la pipì, mi sedetti sulla tavoletta e alzando gli occhi vidi un enorme ragno nero che pendeva appeso al suo filo di bava sopra la mia testa.
Scappai su per le scale urlando in preda al terrore, senza neppure tirarmi su le mutandine.
Da quel giorno mi sono sempre recata in quel bagno aprendo per precauzione il mio ombrellino verde e sedendomi solo dopo una lunga e accurata ispezione…

CAPITOLO SETTIMO
Altri ricordi della mia infanzia. Iris,
Viola, La contessina e il Mio mostro.
Quante cose dovrei scrivere, tante, troppe. Cercherò di mettere le più importanti.
Ho ricordi che risalgono a quando ero davvero piccola.
Il primo febbraio prossimo compirò cinquantotto anni ma ho chiare immagini nella mente che giungono a rammentarmi fino ai primissimi tempi della mia esistenza: ricordi di cui ho poi controllato l'esattezza e la veridicità confrontandoli con quelli di mia madre, che pure ha una memoria sviluppatissima e che corre fino ai primordi della sua lunga vita.
A parte il fatto che ricordo la mia nascita e risento ancora quegli sculaccioni, se torno indietro con il pensiero rivedo perfettamente la grande casa "vecchia", che lasciammo quando avevo tre anni e Massimo e sua sorellina Cristina, che nacque poco dopo di lui e alla quale avevano regalato un cavalluccio a dondolo. Io e Massimo lo volevamo cavalcare ma sua madre ce lo vietava e venivamo aspramente sgridati, perché noi eravamo "grandi" . Però, appena possibile, quando nessuno guardava, noi ugualmente ci salivamo sopra... quanto ci piaceva quel cavalluccio proibito...
Attorno a me, piccola piccola, si apre l'immagine che ha i suoni colori e profumi del grande giardino e di quelle due palme, mi sembra di esserci ancora sotto ora: come erano alte, che bello stormire e che sussurri traeva il vento tra quelle strane foglie che sembravano uno strumento musicale.
Così come rivivo la mia prima grande paura, l'ho già raccontata, quel forte sconvolgimento lo sento risalire in me, avevo sicuramente meno di tre anni, il mio lettino ancora con le sponde e la copertina con "Bambi" disegnato sopra, al mattino mi sveglio, mi metto seduta e chiamo la mamma.
Ma la mamma non arriva.
Allora la chiamo più forte, ma la mamma non risponde....
Quindi comincio a piangere, prima lagnosamente, poi sempre più forte, ansimando, senza riuscire più a respirare, scossa da singhiozzi convulsi e feroci che mi strappano polmoni, gola, stomaco, continuando ad urlare: mamma, mamma, mamma.... e sentendo solo attorno a me il completo silenzio della casa.
Il tempo non passa ed io so che la mamma non verrà più: lo temo follemente, ne sono sicura ed ho una paura così terribile contro la quale non posso fare assolutamente niente.
Finalmente, e non so quanto tempo sia in realtà passato, magari furono solo pochi minuti, odo il rumore del portone d'ingresso al piano di sotto che rintrona il suo vecchio cardine lungo l'androne.
La sua voce, amata, agognata, attesa, creduta persa per sempre, mi grida:
"SMETTILA DI PIANGERE!!! PIANGI SEMPRE.... NON TI SOPPORTO PIU'!!!!"
Poi sento i suoi passi che salgono di fretta i gradini ed il suo viso adirato mi appare attraverso l'uscio, le sue braccia mi sollevano, tenendomi lontana da sé e la sua voce che continua a recriminare, a lamentarsi della mia stupidità nell'avere paura di star sola, che non mi sopporta più.. che non ce la fa più.....
Quante volte mia madre mi ha detto quelle parole.. dovevo essere una figlia assai impegnativa già da piccolissima.
Ricordo assai bene anche la prima volta che entrai in chiesa: quanto ero piccola? Non lo so, sicuramente molto. C'era una vetrata colorata ed io vedo ancora quella luce, così bianca che cancellava tutto intorno, così forte che cancellava tutto dentro di me.
A tre anni, poi, cominciai a frequentare la scuola materna. Quanto segue in corsivo è una delle novelle del mio secondo libro edito in cartaceo "Kaiki ed altre novelle".
IRIS
Il cortile della scuola materna era vasto e rettangolare e a me sembrava immenso, orlato di alte robinie dalle foglie ovali di un verde tenero e acceso, che a primavera si rivestivano di grappoli di fiori bianchi e fragranti, dolcemente ricurvi e chiusi in loro stessi, come a celare un tenero segreto.
Ne succhiavo il nettare, dopo aver raccolto a manciate quelli ormai maturi, caduti al suolo.
Al centro del grande spiazzo c’era un palcoscenico che fungeva anche da teatrino: era costruito di mattoni e cemento, poggiato su tre alti gradini e coperto da un tetto a forma di pagoda e lì noi bimbi, guidati dalle nostre maestre, recitavamo lo spettacolo di fine anno, intonando canzoncine ripetute all’infinito per tutta la durata delle lezioni e inscenando piccole storie, vestiti di costumi di carta crespa colorata e variopinta, che con pazienza, tanta pazienza, confezionavamo con le nostre inesperte e piccole mani, sotto l’occhio attento delle nostre educatrici.
Amavo andare alla scuola materna: l’adoravo! Dentro le stanze dalle volte altissime e dalle enormi porte a vetri con le cornici in legno dipinte di grigio chiaro, i muri avevano zoccoli di vernice lavabile gialli e verdini, sui quali erano allineate le fila dei nostri armadietti e degli attaccapanni, affissi bassi al muro in modo tale che noi potessimo arrivarci senza fatica.
Su ogni armadietto era incollata una figurina rappresentante un oggetto coloratissimo, un frutto oppure un fiore, in modo che noi riconoscessimo il nostro posto, dato che non sapevamo ancora leggere il nostro nome.
Il mio era un folletto col cappello verde dai sonagli dorati e i calzoni corti rossi, i piedi scalzi e uno scanzonato sorriso malizioso.
Le mie maestre avevano intuito subito con quale soggetto avrebbero avuto a che fare.
Nelle aule spaziose dalle ampie vetrate, dove filtrava la luce del sole o si rifletteva il rincorrersi delle nuvole accompagnato dal picchiettare della pioggia, spiccavano piccoli tavoli rossi e verdi con seggioline dello stesso colore, raggruppate come macchie circolari di funghetti su un prato. Disponevamo di giochi svariati e ogni giorno si cantava, imparando note e parole nuove.
I grossi barattoli colmi di pastelli ci invitavano al disegno e i nostri lavoretti venivano appesi ad asticelle di legno con puntine dalle capocchie colorate.
Avrei voluto disegnare tutte le forme che si affollavano nella mia mente, ma la mia mano malferma riusciva a tratteggiare solo arzigogoli contorti.
Nell’apprendere l’alfabeto invece ero risultata precocissima: già sapevo scrivere il mio nome e leggevo con facilità le lettere e le parole che campeggiavano sui cartelloni appesi in alto lungo le pareti: A come albero, E come elefante e così via.
A quattro anni scrivevo e leggevo senza fatica tutte le parole che incontravo a passeggio per strada, purché formate da caratteri grandi.
La merenda, a base di pane, burro e marmellata o latte e biscotti, era un gioioso appuntamento a metà mattina, quando, affamata dopo aver consumato tante energie nel gioco e nel disegno, regolarmente me ne spalmavo un po’ sul grembiulino bianco: una marachella che ossessionava mia madre, indaffarata ogni volta a ripristinare il suo colore originale.
All’ora di pranzo i profumi provenienti dalle cucine lievitavano stuzzicanti fino a noi, diffondendosi attraverso i corridoi: le pietanze che ci venivano servite in ciotoline decorate di bachelite erano appetitose e saporite.
Impossibile non richiederne una seconda porzione, che mi veniva concessa con parsimonia a causa della mia leggera pinguedine: ma la mia fame era impellente!
Ogni mattina, stringendo nella piccola mano il cestino di plastica rosa dove erano riposti il cambio e il tovagliolo pulito, sgambettavo allegra dietro le lunghe falcate di mia madre, che già pensava alle sue quotidiane faccende domestiche e mi accompagnava a passo di marcia, pregustando quelle ore di pace che la mia assenza da casa le consentivano.
Io assaporavo invece l’allegria che avrei condiviso con gli altri bambini e soprattutto pensavo già ad Iris.
Iris era la mia maestra.
A me sembrava incredibilmente alta, ma lei si accomodava sorridente sulle nostre seggioline per poterci accogliere meglio.
Quando, puntualissima, entravo in aula, Iris scandiva il mio nome come un rintocco festoso e io volavo tra le sue braccia, salutando frettolosamente mia madre, che già girava l’angolo del corridoio, assorta dall’assillo dei lavori che l’attendevano a casa.
Mi lasciavo avvolgere dalle lunghe braccia invitanti della mia maestra, che mi stringevano a lei facendomi aderire alle sue forme morbide e lievemente generose.
Il suo profumo di viole o di rose quasi m'inebriava, trasportandomi per valli fiorite e un sorriso spontaneo e solare affiorava su quelle labbra delicate e prive di rossetto.
Iris per me incarnava quello spicchio della luna che a volte vedevo sorgere lentamente sui tetti, più luminoso dell’argento: in quei momenti un tremito misterioso mi scuoteva il fondo del cuore, mescolando dolcezza e languore dentro di me.
Il suo nome riecheggiava tra le mie labbra come un’antica nenia muliebre di donne al lavoro nei campi e il fiore da cui aveva rubato le parvenze aggraziate decorava i balconi dei miei occhi.
La chiamavo mille volte al giorno e sempre il mio sguardo la seguiva mentre giocavo, scrivevo o disegnavo.
Appena potevo, mi rifugiavo tra quelle braccia sempre disponibili.
Era Iris che correva a risollevarmi quando cadevo e mi sbucciavo un ginocchio sul ghiaietto del cortile, lei che mi asciugava le lacrime con il suo morbido fazzoletto tranquillizzandomi con la sua voce carezzevole.
Mi capitava spesso di cadere, perché soffrivo di problemi di vista sin dalla primissima età e altre volte picchiavo la testa contro ogni genere di ostacolo, dato che non sapevo valutare bene le distanze. Ogni volta che questo mi succedeva a casa, mia madre non faceva altro che sgridarmi, ritenendomi solo sbadata e troppo vivace.
Iris, invece, mi teneva abbracciata al suo collo, dove io, cercando il morbido incavo, nascondevo il viso inondato di lacrime.
Scossa dai singhiozzi, mi lasciavo calmare dalla sua voce suadente, fino a quando, passati il dolore e lo spavento, lei mi lavava e disinfettava la ferita, sulla quale poi applicava un
fazzoletto pulito piegato a triangolo e annodato per le becche, in modo che non sanguinassi più. Rasserenata, potevo così tornare ai miei giochi e io, che mi sentivo letteralmente miracolata dalle sue cure amorevoli, ostentavo con fierezza quel bendaggio artigianale, come se mi avessero decorata con la medaglia d’oro.
C’erano poi quei giorni terribili nei quali stavo male,
perché il mio intestino mi torturava con dolori lancinanti: me ne stavo in disparte, col viso corrucciato e triste e cercavo un angolo solitario del cortile in cui rintanarmi assieme al mio dolore, che non era solo fisico, ma anche intensamente mentale.
Iris se ne accorgeva subito, si avvicinava e mi faceva sedere sulle sue ginocchia, accarezzandomi delicatamente il pancino dolente, dopo aver chiesto alla cuoca di prepararmi una camomilla calda.
Senza dire nulla, come se già sapesse tutto di me e del mio dolore, come se i suoi occhi fossero in grado di leggere l’odissea del mio animo malato, mi cantava sottovoce una canzone tutta per me e, mentre sorseggiavo la mia camomilla, mi cullava con una cadenza così rasserenante da farmi assopire in pochi minuti.
Poi mi adagiava sulla mia brandina e mi copriva, canticchiando ancora sottovoce e dondolandomi lievemente, come su un’amaca scossa da una tiepida brezza primaverile.
Forse sognavo cose che ancora non conoscevo e non capivo,ma che già percepivo distintamente…
Venne Natale e fu tutto un avvicendarsi di decorazioni ritagliate da noi, con carte variopinte e lucenti, con le statuine del presepe ricavate da turaccioli di sughero e da stuzzicadenti, con la capanna di cartone, l’erba secca del giardino e il muschio degli alberi spogli.
Festoni intrecciati pendevano da ogni angolo e una miriade di palline di svariate forme e colori decoravano un abete vero, nel centro del grande salone.
Anche noi, a casa, preparammo l’albero e il presepe: quest’ultimo era compito di mio padre e di mio fratello, dato che io ero ritenuta ancora troppo piccola per maneggiare oggetti fragili e costosi.
La decorazione dell’albero era invece affidata a mia madre, che la eseguiva a regola d’arte, collocando con cura in mezzo ai rami le sfere policrome di vetro soffiato: c’erano i nanetti, i funghi con la capocchia rossa a puntini bianchi, una mongolfiera verde brillante con fili colorati che reggevano un minuscolo cestello, Babbo Natale sulla slitta, stelline di ogni dimensione, candeline rosse con un supporto fatto a molla, capelli d’angelo argentati, festoni lucenti di tutte le sfumature e piccole falde di cotone idrofilo a simulare la neve.
Infine, come in una specie di prodigio, si spegneva la luce e tanti piccoli lampioncini di ogni foggia rilucevano grazie alle minuscole lampadine intermittenti racchiuse al loro interno: l’albero diventava un tripudio di bagliori che mi faceva battere le mani, pazza di gioia.
Ma a scuola le lucine non c’erano e mi rattristava che Iris non potesse vedere quello spettacolo incantevole: avrei voluto renderla partecipe della mia contentezza, vederla risplendere con me tra quelle luci da favola.
Così, la notte prima delle vacanze natalizie, quando
tutti dormivano e l’albero era stato spento (e per fortuna era staccato anche il cavo elettrico dalla spina), io rubai le forbici dal cassetto della cucina, scesi silenziosa a piedi scalzi lungo le scale del piano superiore dove erano situate le camere da letto, presi il cestino di scuola e tagliai, con pazienza e tanta fatica, ogni lampioncino, nascondendoli accuratamente tra i miei panni in modo che non si vedessero né si rompessero, fino a che ne fu pieno.
Volevo farne dono alla mia amata Iris, immaginandola circondata da quelle luci fantasmagoriche e godendo in anticipo della sua felicità nel ricevere un regalo così inatteso.
Poi, con le piccole dita affaticate dallo sforzo e gli arti indolenziti per essere stata a lungo in piedi su una sedia, tornai a letto, silenziosa come ne ero uscita e mi addormentai di botto.
Al mattino, al primo richiamo della mamma, mi destai subito, smaniosa di raggiungere la scuola; ma mia madre mi sembrava lenta e indolente, rendendo interminabile il tempo che mi separava dalla mia audace sorpresa.
Uno strano languore, misto di impazienza e di dolcezza, mi lievitava nello stomaco.
Quando finalmente arrivammo a scuola e mia madre se ne fu andata, attesi, con malcelata impazienza, il momento adatto.
Appena ci fu una pausa nelle attività ricreative, attirai Iris in un angolo e le dissi che avevo una sorpresa per lei.
Poi la condussi nel corridoio vuoto, nel segreto del mio armadietto e aprii il cestino, mettendole tra le mani i lampioncini.
«Presto si illumineranno!» le dissi pregustando la gioia immensa che le avrebbero donato.
Il volto di Iris fu rischiarato da un dolcissimo sorriso, venato da una punta di muta malinconia, come una lacrima solitaria che scende su una gota. Era una luce ancora più splendente di quella dei miei lampioncini, ma più intima e soffusa, una luce che si diffuse in tutto il mio essere, fino a una radice nascosta che neppure sapevo esistesse in me.
Poi, con infinita tenerezza, Iris mi abbracciò stretta stretta e mi spiegò che, privati del filo che li collegava tra loro, i miei favolosi lampioncini sarebbero rimasti spenti per sempre.
E mentre mi parlava mi fissava negli occhi così intensamente da rapirli.
Iris mi aveva rivelato il segreto della luce elettrica: non avrebbe mai visto il bagliore di cui io volevo circondarla, per donare una degna cornice alla sua bellezza.
Delusa e triste, presi a piangere e a singhiozzare: non avrei potuto mostrarle quanto io la vedessi bella.
Ci volle molto tempo perché riuscisse a calmarmi.
Rimasi sconsolata per tutto il giorno, nonostante Iris cercasse con discrezione di farmi capire che aveva comunque apprezzato tantissimo il mio gesto e che, nonostante la mancata accensione dei lampioncini, si era sentita più bella che mai.
Quando venne mia madre a prendermi, fu svelato il mistero casalingo dei lampioncini spariti e le due donne ci risero sopra entrambe, divertite dalla mia ingenuità.
Ma io invece mi adombrai ancora di più.
Imploravo di lasciare i lampioncini a Iris, ma la maestra, intuendo la disapprovazione di mia madre, si schernì così fermamente che il mio tenero sogno incompiuto fu incartato in un giornale e prese la strada di casa, tra il mio profondo sconforto e la palese irritazione di mia madre, che già si preoccupava di come raccontare l’accaduto a mio padre…
Non fui sgridata aspramente, quella volta, ma solamente rimproverata e ammonita sul rischio che avevo corso: se il filo non fosse stato staccato, avrei potuto restare folgorata.
Inoltre mi fu spiegato altrettanto chiaramente che gli oggetti di casa nostra appartenevano a mamma e papà e che io dovevo sempre chiedere il permesso a loro prima di prenderne uno.
Mio fratello, invece, la prese malissimo: visibilmente incollerito, mi investì di cattive parole. Come mi ero permessa di rubare le luci del suo albero di Natale?
Da ultimo, ci fu la desolazione del buio profondo nel quale era sprofondato l’albero a causa della mia malaccorta birichinata…
Ai lampioncini furono tolte le lampadine e attaccati ganci di fil di ferro, trasformandoli così in comuni decorazioni prive di illuminazione.
Ma Iris mi amò in modo particolare, da quel giorno fino a quando ci separammo al termine del ciclo di scuola materna: io non tralasciai mai di regalarle un fiore colto da una siepe o una coccinella che mi si era posata addosso.
E quell’amore profondo, celato in quella radice segreta, non mi abbandonò mai.
Qualche lampioncino esiste ancora tra le mie decorazioni natalizie e ogni anno, mentre le estraggo dalla scatola impolverata, li osservo con intensa commozione e con infinita tenerezza.
Non rividi più Iris da quando si trasferì in un’altra città, ma un giorno mia madre mi disse che si era sposata e aspettava un bambino.
In quel momento mi sembrò di stabilire un contatto telepatico con lei, una specie di corrispondenza interiore con la sua anima, e pensai che quel bambino, forse, un pochino apparteneva anche a me.
Alla scuola materna mi accompagnava mamma ma già dalla prima elementare cominciai ad andare a scuola da sola. Abitavamo nella parrocchia di San Pietro, nella casa dell'amico del babbo. Il tragitto fino alla mia scuola era all'incirca di un chilometro, forse un po' di più, tutto sullo stesso lato della strada e quindi non c'era ragione che io passassi dall'altra parte. In realtà dovevo attraversare diverse strade che s'immettevano nel viale principale che io stavo percorrendo ma il traffico era assai scarso a quei tempi. Così andavo sola.
Anche per questo ricordo così bene la mia città, era molto piccola ed a sette otto anni l'avevo già girata in lungo ed in largo. Avevo una totale libertà di movimento e andavo ovunque. All'inizio mi fu il permesso di giocare nella stradina dietro casa, ma poi ne uscii, vagando per il viale, fino al giardino della palestra ex GIL, dove la domenica mattina si tenevano le partite delle squadre cittadine maschili di pallavolo e pallacanestro, sostenute dal nostro sparuto ma convintissimo tifo, che aveva in me una colonna vocale portante.
Era quello il mio giardino. Piantumato ad alti ippocastani che in autunno lasciavano cadere dai ricci senza spine castagne non eduli ma così lustre, lisce e profumate. Io ne tenevo alcune sempre in tasca, ne facevo collane forandole con un ago da lana ed un filo di lana grossa rubati alla mamma.
In quel giardino ero sempre seduta a terra o sdraiata sull'erba: lì mi prendevo tutto il mio contatto con la natura e quel Dio Giardiniere che amavo tanto. Guardavo gli insetti, i fiori spontanei, i fili d'erba, le piante officinali.
La palestra aveva altissimi soffitti e vetrate e vi abitava un custode che chiudeva i cancelli, ma io avevo fatto amicizia con i suoi figlie e con la moglie, che mi accoglieva sempre volentieri, perché in qualche modo tenevo a bada il suo figlio piccolo, Walter, che era la sua disperazione. Il povero bambino era veramente poco intelligente, quasi subnormale anche nel modo di esprimersi, mentre il fratello maggiore Riccardo, era intelligentissimo e si stava laureando. Ebbi una simpatia per lui e forse lui per me, ma tutto restò inespresso. Io giocavo sempre con Walter, che riconosceva la mia superiorità, guadagnata e ribadita sul campo con continue lotte, spintoni e contrasti fisici. Per quello ero l'unica che riusciva a convincerlo a fare alcune cose, tra cui studiare, occupazione che lui assolutamente detestava. Così la madre, disperata ed incapace di imporsi a quel povero figlio disadattato, mi usava per tenerlo un po "in riga".
Io gli facevo fare i compiti e cercavo di spiegargli quello che a scuola non aveva capito. Lui aveva un paio di anni meno di me. Ci sedevamo al tavolo della cucina e ci mettevamo ore a fare cose che io avrei fatto in pochi minuti, ma non perdevo mai la pazienza. Anche alle medie davo lezione a questo ragazzo, d'inglese soprattutto, gli era troppo ostico, anche pechè a malapena aveva imparato a parlare in italiano. In quel giardino portai anche la mia gattina, nel cestino della mia bicicletta, quando ero già adolescente, quella micetta siamese che nacque a casa di Carlo, il mio primo morosino poi diventato mio primo marito, e che successivamente mia madre mi costrinse a rendere, dato che a mio fratello dava fastidio.
La portavo con me e lei mi stava sempre in braccio.
I gatti "siamesi" amano particolarmente il contatto con l'essere umano e vi si rapportano quasi come fanno i cani. Un giorno Riccardo mi disse: "Tu cerchi in questa gattina l'amore che non hai ricevuto mai."
Come aveva ragione.
Per tutta l'infanzia ho giocato per strada, nei giardini pubblici e nei campetti della mia città: e soprattutto cercavo compagnia per giocare a pallone come un maschiaccio e decisamente a quei tempi era davvero una cosa fuori del normale una bambina che giocasse a pallone. Stavo in porta. Mi piaceva tantissimo e passavo le ore con qualcuno dei mie vari amichetti che mi facevano "i tiri", cioè calci piazzati, che io cercavo di parare tuffandomi. Era un divertimento che non mi veniva mai a noia.
Ma poi ugualmente mi scatenavo in scorribande in bici o partite a "Nascondino", a "Pum", a "Palla prigioniera", a "Strega impalata", a "Chi arriva prima a Roma", a "Fazzoletto", a "Le belle statuine", a "figurine", a "tappi", coperchietti di metallo a corona che appiattivamo con un sasso, oppure a biglie di vetro o quelle di plastica con la figurina del ciclista dentro. Si giocava facendo la pista nella sabbia prendendo uno dei giocatori seduto a terra per i piedi e trascinandolo in modo che il suo sedere segnasse nella sabbia il solco della pista. Poi, con sabbia più bagnata si rinforzavano le sponde da cui si "ciccava" la pallina come anche si giocava senza pista a "Cicca e spanna" e cioè: gettate le palline, una per ogni partecipante, in una spianata di cemento in qualche cortile, chi cominciava si avvicinava con la mano di una spanna alla pallina da colpire, "ciccandola" con la propria posta tra pollice e indice della mano destra e sparandola violentemente.
Facevamo sempre "La conta" per vedere a chi toccava stare sotto o partire per primo, in ogni gioco: le filastrocche della "conta" erano svariate. La più classica faceva così:
"Ambarabacciccicoccò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore le sgridò, ambarabacciccicoccò.."
Oppure era anche molto gettonata:
"Sotto il ponte di Baracca c'è un bambin che fa la cacca. La fa dura, dura, dura, il dottore la misura, la misura a trentatrè, a contare tocca a te...."
Ma la più stramba e quella che mi piaceva di più era:
"Pimpiripettenise, pimpiripette pa.." ed ad ogni sillaba chi faceva la "conta" batteva in modo cadenzato la mano aperta sul pugno chiuso che ognuno degli altri partecipanti teneva fissa davanti a sé: chi si beccava l'ultimo schiaffetto, veniva eliminato e l'ultimo che restava era il prescelto.
Me ne ricordo una che mi insegnò la mia mamma e che gli altri bambini di solito non conoscevano:
"Unzi dunzi trinzi, quaraquarinzi, mirimirinzi, pan del fora...."
Erano filastrocche venute chissà da dove, che i bimbi si insegnavano l'un l'altro in un mondo parallelo a quello degli adulti, i quali ne rimanevano del tutto fuori.
Stare fuori casa era per me pura gioia e libertà.
Anche quando facevo a botte, cosa che capitava spesso, io stavo bene fuori casa.
Giocavo delle partite interminabili a "Settimana" con la mia amica Viola, disegnando con dei sassi che lasciavano il bianco e che si trovavano comunemente allora nella ghiaia della stradina, un reticolato sul cemento del cortile sotto il condominio. Era un reticolato fatto di rettangoli appaiati e allineati l'uno sopra l'altro, nei quali disegnavamo i numeri 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, poi il 7 che aveva la grandezza di due, al quale seguiva il segno di un arco finale senza numero. Fatta "la conta", chi cominciava per prima gettava un sassetto piatto a partire dal rettangolo con il numero uno e il sasso non doveva toccare la riga, altrimenti si perdeva il turno. Quindi su di una gamba sola si saltellava di casella in casella sempre senza toccare le righee chinandosi senza posare l'altro piede per terra per raccogliere il sassetto. Quando si arrivava nell'area delimitata dall'arco si posava il piede, si faceva un volteggio per girarsi e di nuovo su di una gamba sola, si ripercorreva in senso inverso all'andata il reticolato.
Che gioco di destrezza e precisione! Viola era assai più brava di me ed io perdevo sempre!
Anche quando il tempo era brutto uscivo ugualmente di casa ed andavo a bussare all'appartamento di sotto da Viola e giocavamo con suo fratello, il mio e a volte altri bambini, con i soldatini o il Monopoli o alle carte.
Lei era la mia amica speciale.
Quanto segue in corsivo è un'altra delle storie di "Kaiki ed altre novelle".
VIOLA
Avevamo la stessa età, nove anni, io qualche mese di più.
I nostri genitori erano amici e ci conoscevamo da sempre, ma arrivò un giorno che il grattacielo fatto costruire da mio padre fu finito: noi andammo ad abitare nell’appartamento grande del secondo piano e loro esattamente sotto di noi, al primo piano.
Non andavamo a scuola insieme, perché lei continuò a frequentare le elementari del quartiere dove aveva vissuto fino ad allora, ma ora eravamo vicinissime e la nostra lunga amicizia cominciò a crescere.
Appena più bassa di me ed un poco pingue, come erano quasi tutte le bambine romagnole di quel periodo, figlie della guerra durante la quale i nostri genitori avevano patito la fame e, quindi, ci nutrivano in abbondanza, Viola era bella.
Il viso di un ovale perfetto, con la carnagione diafana e trasparente delle creature che richiamano affetto, portava magnifici capelli castano scuro lunghi sino alla vita ed oltre, perché non le erano mai stati tagliati.
Sua madre ne andava molto orgogliosa e glieli curava continuamente, tenendoglieli quasi sempre intrecciati come un fascio di giunchi in una treccia grossa e morbida che, partendole dalla base del collo, le scendeva sinuosa, accompagnando ogni suo movimento con guizzi o lente danze come onde.
Era lucido e cangiante, quel fascio di brune alghe marine abbandonate alla corrente e il confronto con la mia corta zazzera rossa, scompigliata e ogni giorno atteggiata ad una nuova autonoma foggia, lo rendeva ancora più muliebre, incorniciante queste tenere gote opalescenti e i grandi occhi verdi.
Come me portava gli occhiali e dello stesso colore avevamo le iridi ma, mentre io ero miope e le mie grosse lenti a fondo di bicchiere infossavano e spegnevano il mio sguardo, rendendolo simile ad una lumaca che si rintanava nel suo guscio, lei era astigmatica e le sue lenti, più sottili e di diversa curvatura, aumentavano a dismisura la grandezza dei suoi occhi lustri, rendendoli come due laghi di montagna nei quali specchiarsi.
Gli abiti che indossava, seppure di foggia casalinga, le cadevano addosso eleganti come fosse sempre vestita a festa ed ogni suo movimento per aggiustarsi la gonna o sollevare il colletto della camicetta, suggeriva un frusciare di sete d’altri tempi, mentre sedeva sul divano di casa che subito si trasformava in una esotica ottomana damascata.
Le lunghe gambe sottili, con i calzini sempre bianchissimi ed attillati, si atteggiavano naturalmente ad una composto e pudico abbandono, lievemente ripiegate sotto di sé, unite tra loro come in un abbraccio malizioso e innocente, mentre io non sapevo trattenermi dall'allargare le mie, facendoci scivolare nel mezzo l’ampia gonna a pieghe, che odiavo, per nascondere ciò che di una signorina per bene non si doveva vedere, come diceva mia madre.
Viola non correva mai, non sudava mai, a volte giocava con me alla "settimana", disegnando col gesso per terra i quadrati lungo i quali saltellava leggera e precisa, oppure ci lanciavamo la
palla, usando il cancello come rete da volley, senza però raggiungere grandi risultati, perché, mentre io mi affannavo a correre dietro ai suoi lanci bislacchi in ogni direzione per cercare di
rimandargliela indietro, lei il massimo sforzo che compiva era allungare il braccio: se la palla non la raggiungeva come di sua propria volontà, la lasciava correre via, seguendola con uno
sguardo corrucciato, come si sarebbe usato per redarguire un paggio sbadato.
Era molto più abile a giocare ai "dieci fratelli" lanciando la palla contro il muro una volta, poi due e tre, fino a dieci, eseguendo ogni volta un movimento diverso con le mani o le gambe, o piroettando come una ballerina nel plicèt.
Spesse volte suo fratello Giacomo, coetaneo di mio fratello, coi riccioli biondi scomposti e crudeli e bellissimi occhi azzurri, si intrometteva tra noi, rubandoci la palla ed invitandomi a riprendermela, dribblando come fanno i calciatori.
Io m'infuriavo immediatamente e ingaggiavo con lui, così più grande di me, un corpo a corpo dal quale uscivo perdente ogni volta, accompagnata dagli sberleffi di quel maligno viso d’angelo; colpita nel mio amor proprio allora lo sfidavo alla boxe ed incrociavamo i pugni, anche se lui aveva le braccia forti di un ragazzo e assai più lunghe delle mie, io ero talmente impavida ed orgogliosa che tante ne prendevo quante ne davo, incurante del dolore che mi faceva sulle spalle, le braccia e lo stomaco e, pur uscendo anche allora sconfitta, riuscivo ad allontanarlo e a riprendere la palla sequestrata ingiustamente, cosa che lui fingeva di concederci per la sua magnanimità, mentre invece il suo viso era acceso d’ira nel l’impossibilità di riuscire a domarmi e a ridurmi alla ritirata.
Viola allora mi guardava grata e stupita, un poco scandalizzata dal mio osare, ma un luccichio di ammirazione animava i suoi occhi da bambola e io mi sentivo un piccolo fiero soldato, degno di una decorazione al valore.
Nelle giornate di pioggia o di freddo lei, che era cagionevole di salute e soffriva di tossi violente, non poteva uscire, così io scendevo nel suo appartamento, dopo aver fatto i compiti come un fulmine e giocavamo in casa: se c’erano i nostri fratelli o i cugini si giocava a "Monopoli " o a "tappo", oppure a briscola o scopa, come ci insegnava la vecchia nonna ormai fusa in un tutt’uno con la sua poltroncina ed il suo scialle dal colore indistinto.
Altrimenti c’era il "Gioco dell’oca" o la ‘"Tombola" ed io ero sempre sfortunatissima e mi rabbuiavo alquanto quando perdevo, permalosa all’eccesso, anche perché perdevo quasi sempre.
Se però eravamo in casa da sole e la nonna se ne stava sulla poltrona vicino alla finestra, agucchiando e dormicchiando, noi ci rifugiavamo in camera sua e giocavamo a "Babbo e Mamma".
Sul tappeto che fungeva da scendiletto apparecchiavamo una minuscola cucina fatta di piattini e piccolissimi bicchieri di bachelite e lei aveva pure le tazzine di porcellana vera con la teiera e la zuccheriera, con la quale mi serviva un aromatico inesistente tea.
A fianco i nostri bambini, bambolotti vestiti dalle mani esperte di nonna dei ritagli più estrosi e inutili, dormivano o giacevano malati, con la febbre alta tanto da dover chiamare il dottore.
Io ero sempre il "Babbo", e non mi ricordo di essere stata mai la "Mamma", mai una volta, tornavo la sera stanco dal lavoro e trovavo la tavola apparecchiata e una profumata cena a rifocillarmi dalle fatiche della lunga giornata di lavoro, allora lei mi chiamava affettuosamente "Caro" e io le dicevo "Grazie Tesoro" mentre mi serviva trasparenti e succulente pietanze, accompagnate da mezzo bicchiere di un mai imbottigliato vino rosso generoso.
Se i bimbi poi stavano male, ecco che mi trasformavo nel "Dottore" che con saggia maestria , dopo aver constatato la gravità di quella malattia, li guarivo con una puntura eseguita alla perfezione mimandola con le dita sul sederino di plastica del malcapitato bambolotto, mentre lei fingeva un terrore e una apprensione degna di una grande attrice.
Alla fine di tutto il trambusto, rigovernati e riposti i piatti della cena ed ogni altra cosa fosse rimasta nel mezzo, ecco giungeva il momento più intimo, quello che io aspettavo con impazienza dall’inizio del gioco: era giunta l’ora di andare a dormire, perché il giorno seguente sarebbe sorto presto e faticoso.
Così ci sdraiavamo l’una accanto all’altra sul tappeto morbido, coprendoci con una copertina di quando lei era neonata, che la madre le aveva regalato per i suoi giochi e lei faceva finta di addormentarsi subito, dopo avermi detto "Buonanotte, Caro!"
Ma io allora la cingevo tra le mie braccia, stringendola a me in silenzio, senza proferire neppure un sospiro e lei si abbandonava al mio abbraccio, con gli occhi chiusi e il viso illuminato come da uno spicchio di luna che sembrava origliasse dalla finestra.
E con la mano leggera e un poco tremante, le accarezzavo la lunga treccia, riempiendomene la mano, affondando il mio viso nell’incavo del suo collo per respirare l’intimo odore che le saliva dalla pelle delle braccia e delle ascelle, per poi passare a percorrerle il viso con carezze lunghe e leggerissime, mentre con una gamba la imprigionavo e, appoggiandola tra le sue leggermente separate, sentivo il calore delle sue cosce e del suo ventre farmi vibrare ogni fibra.
Poi le percorrevo tutto il corpo, con tocchi setosi e aderenti, soffermandomi sul piccolissimo seno che appena appena stava per spuntare, mentre lei continuava a fingere di dormire, pur tradendosi ogni tanto con sospiri e fremiti…
Ed io non avrei voluto mai staccarmi da lei, ogni volta ascoltando una parte diversa del suo ingenuo infantile corpo abbandonato e desiderando fortemente di esserle dentro con ogni mia parte, con ogni mio respiro, con ogni mio sconosciuto piacere.
Poi la nonna ci chiamava e lei si scuoteva come da un torpore, come da un sonno vero e un po’ imbarazzata, senza guardarmi in faccia, si riassettava i vestiti, rianimava il tono della voce che aveva squillante da soprano e correvamo a fare la merenda, oppure io risalivo nel mio appartamento per la vera cena, tornando il chiassoso ragazzaccio di sempre..
A notte fonda, mentre tutti dormivano e io ascoltavo il ritmico russare di mio padre, che soffriva di sinusite e il leggero sospiro allungato di mia madre, dopo aver letto per ore, spegnevo la piccola lampada del mio comodino e mi adagiavo, con l’orsacchiotto stretto al mio infantile petto, risentendo quel profumo e quell’ardore che mi avevano così scaldato il sangue mentre la stringevo a me e mi addormentavo, finalmente stanca, sognando di essere un principe con un bianco destriero che giungeva da paesi remoti e sconosciuti a prostrarsi a quella nera lucida treccia.
Anche con un'altra mia compagna delle elementari e poi pure delle medie ebbi un rapporto assai speciale ed intenso. Lo racconto nella seguente novella, essa pure tratta dal mio "Kaiki".
LA CONTESSINA
Che fosse migliore di noi non era messo in dubbio da nessuno.
Il padre era un conte che trascorreva la sua vita a Milano, frequentando i salotti bene e il mondo della lirica.
Ogni tanto tornava e lasciava alla moglie, altera, severa e tristissima, un altro frutto del suo prezioso seme, da crescere perché il mondo avesse poi in regalo la prosecuzione della sua altisonante specie.
A loro non faceva mancare nulla se non la sua presenza e il suo amore.
Proprietario di vigneti e terreni che producevano ricche messi, condotte e guidate dal suo fattore, un uomo alto e duro come il legno, aveva adagiato la sua numerosa prole con la moglie e la servitù in una villa alla sommità di una collina ricoperta e circondata da un fitto bosco, dove i suoi fidi potevano cacciare e procurargli le prede a cui lui ambiva quando tornava alla ricca ma rustica magione, ornata e definita da una torretta centrale con gli smerli che si distingueva in ogni parte di tutta l’ ubertosa pianura circostante, tenuta a frutteti e vigneti.
Il giardino era ben curato e fiorito in ogni stagione dell’anno e nelle scuderie ancora un cavallo di rango conduceva una vita d’ozio dorato, ultimo esemplare di una lunga schiatta di cavalcature che per generazioni si erano distinte dalle giumente e dalle carrozze dei mercanti e degli uomini d’affari; cavalli e fattrici ricordati a lungo da tutta la cittadinanza per la loro purezza, estrema eleganza e portamento e per la perizia nel montarli e portarli che l’intera casata sembrava tramandarsi geneticamente.
Le stanze di quella enorme villa, che io non visitai mai per intero, avevano soffitti altissimi ed in alcune di esse giacevano mobili e immensi lampadari pendenti, accuratamente ricoperti da bianchi panni e tenuti lustri e puliti come fossero di uso quotidiano, mentre il tempo delle feste e della musica risonante lungo le basse colline circostanti e le dolci valli, era finito da un pezzo.
Ricordo una grandissima cucina con un camino di marmo che occupava quasi tutta la lunga parete e vasellami fini, stoviglie decorate con scene di caccia, bicchieri eleganti dal lungo stelo, riposare nelle grandi credenze di noce dalle vetrine scintillanti come accese di luce propria.
La madre della mia amica contessina viveva in quel regno decaduto con una dignità degna di Penelope, dirigendo la servitù come se nulla fosse cambiato dai fasti che erano ormai niente più che un ricordo corale. E sempre nei forni cuocevano carni odorose, con verdure fresche di stagione, frutta appena colta dagli alberi e dolci preparati con cura che riempivano l’aria della nostra merenda di una magica atmosfera quando, a metà pomeriggio, richiamate dalle passeggiate nel parco o dalle letture nella camera da letto della contessina, ci venivano servite su lini immacolati con posate di lucido argento, frutto del lavoro di quelle semplici e generose fantesche che vezzeggiavano la loro preferita e le sue amiche in visita.
Lei era la primogenita.
Fu mia compagna alle scuole elementari e medie.
Aveva un incedere come di giunco flessuoso, nonostante l’alterigia le sostenesse le larghe spalle e le ergesse la testa sopra tutte noi: era alta e forte ma aggraziata, elegante e vivamente volitiva.
Il viso era puro come l’avorio, il naso tagliato netto e affilato, gli zigomi alti traevano a se le labbra sottili ma ben disegnate in un atteggiato sorriso, imparato negli anni dell’infanzia, che non si accompagnava quasi mai a quello degli occhi che, scurissimi e allungati, imprimevano tutta la propria risolutezza e coscienza di sé già a quella giovane età.
I capelli, anche loro molto scuri e lucidi di cosmetici alla seta, emanavano un profumo lieve e penetrante, scendendo come una fitta cortina impenetrabile e immota ben oltre le scapole, a volte scossi da un colpo di quel grazioso capo che imprimeva loro un fremito che li attraversava tutti come un’onda marina ma senza scomporli minimamente.
Le mani erano curate, con dita lunghe e sottili, energiche per gli esercizi al pianoforte che ogni giorno ella eseguiva per volere paterno e non per propria volontà, ma l’attitudine, anche se riluttante, era così evidente che le note fluivano da quelle corde scosse dai piccoli martelletti del grande nero pianoforte a coda del salone, come fughe canore di usignoli, finalmente liberati da lunghe prigionie, oppure scuotevano i silenziosi corridoi come galoppi di cavalli in una invisibile quanto eccitante caccia alla volpe.
Io l’ammiravo e sentivo la sua bellezza sovrastarmi e rendermi schiava.
Tutto quello che ella mi comandava, io eseguivo: se richiamata allo studio, inforcata la mia bicicletta e percorrendo a perdifiato diversi chilometri, arrivavo puntuale all’appuntamento ed insieme sedevamo alla sua scrivania di prezioso legno intarsiato, dove alternavamo i compiti di scuola allo sfogliare di libri assai antichi che parlavano di allevamento di cavalli e ne mostravano tutti i particolari, anche quelli anatomici meno pudici che lei mi indicava con un falso ma ben simulato distacco.
Oppure mi chiedeva gentilmente di aiutarla a raccogliere dei fiori per ornarne la casa ed io, lasciando a lei la scelta ed il taglio, mi prestavo come paniere vivente, incurante delle spine delle rose, facendomi graffiare le braccia come fossi accarezzata dalle sue mani.
A volte mi portava per forre e segreti nascondigli che lei diceva essere di sua esclusiva proprietà e ci sedevamo tra tappeti di viole dal profumo stordente o sotto centenarie querce avvolte da liane di edera, in silenzio, oppure parlando dei nostri progetti futuri.
Scendendo per passaggi scoscesi io sempre la precedevo porgendole la mia mano forte e salda dove, come una bianca colomba che si abbeverasse dopo un lungo volo, ella appoggiava la sua, indugiando nel contatto, con gli occhi frementi che mi scuotevano ovunque io esistessi.
C’era una distanza tra noi che non fu mai colmata in abbracci più intimi o in cameratismo di amanti di cavalli, ma io ero l’unica che aveva imparato a memoria le arie sue preferite dell’Aida e del Rigoletto e a me affidava la sua musica, alla mia voce potente e ancora purissima, avvezza al canto nei lunghi anni della chiesa, così che le sue mani sembrava suonassero direttamente le mie labbra.
La rividi dopo tanti anni, dato che il padre l’aveva voluta con sé a Milano alla fine delle scuole medie, per farle proseguire gli studi in scuole di élite più adatte alla sua viva intelligenza e al suo rango ed ella era diventata una donna bellissima, mentre io ero ormai ingrassata e fiaccata dalle sofferenze e dai parti, ma nei suoi occhi, che mi guardavano ardenti, mi rividi, fiera e indomita nei miei dieci anni.
Non parlammo molto, lei era di fretta e l’incontro fu del tutto casuale per le vie della nostra cittadina, un giorno in cui era tornata a trovare la madre, ma la sua mano corse come quella colomba, ora mansueta, alla mia mano, accogliendola, come l’avesse aspettata troppo a lungo e finalmente ritrovata, anche se, ahimè, troppo tardi.
Le sue labbra allora sorrisero accompagnate dai suoi occhi ,accesi di un fuoco inestinguibile e dopo avermi salutato, si voltò alcune volte a guardarmi con una lenta nostalgia mentre io, impietrita dall’emozione, ascoltavo il mio cuore divorare di battiti il mio petto.
Qualche anno dopo la rovina si abbatté sul suo casato: il padre, avendo sperperato nel lusso tutto il suo patrimonio, si sparò un colpo di pistola alla tempia.
La villa e i terreni furono contesi dai creditori e seppi che la contessina per vivere insegnava musica ai bambini di Milano.
Ma il suo cavallo nitriva ancora nel nostro sangue, che si mescolò allora e mai si divise, stretto nel ricordo e nell’amore mai pronunciato.
La mia infanzia finì a undici anni e mezzo, quell'agosto 1966 in cui mio padre pose l'ultimo giorno della sua vita.
Di certo quella data ne sancisce l'inderogabile limite.
Ma ben prima il tempo della serenità e della purezza infantile era stato valicato ed infranto.
Ciò che segue in corsivo è un capitolo di ' Io non sono di qui '
DON EMIDIO
IL MIO MOSTRO
Oggi sono l’abbandono
La voce aspra della tua coscienza
Il buco del tuo calzino
Il dente cariato che cerchi di dimenticare ma che subdolo lavora di nascosto
Oggi sono un tumore celato nella speranza.
Una breccia nel sorriso di un sistema perfetto
L’afonia in un coro angelico
Oggi sono il sasso che galleggia
Il fiore che alimenta un brulichio di insetti immondi
Oggi io sono l’amore che divora
La calura che toglie le forze
Il miasma asfissiante da cui corre lontano chi ho amato e chi amo
Oggi nego di esistere e di morire
Oggi vivo per una stupida causalità che mi vuole matrice del mio stesso infinito dolore. Che mi trasforma in un vuoto silenzioso, in un palcoscenico deserto su cui è calato il sipario
Done, così lo chiamavamo tutti.
Era il parroco più amato dai bambini.
Tutti gli correvamo incontro come al richiamo del flauto magico.
Era alto e dal bel viso solenne. La lunga tonaca nera ne snelliva la figura pingue. Sembrava non finire mai.
Ci tendeva le braccia come Gesù: sinite parvulos… E noi volavamo tra quelle braccia.
La sua voce tuonava dal pulpito.
Fine parlatore e pensatore, ammaliava. Le sue omelie erano racconti che ti penetravano nel cuore.
Egli parlava a ognuno di noi in prima persona.
Ma a me sembrava che guardasse solo me. Amasse solo me. Vedesse solo me.
La parrocchia era la mia casa.
Lì si trovavano attività, svaghi, giochi, canti, studio, qualcuno che mi ascoltava, qualcuno che mi parlava, qualcuno a cui importava di me.
Tutti i miei pomeriggi dai sei agli undici anni, eccetto i mesi estivi, io li ho passati, almeno in parte,in parrocchia.
Il catechismo, poi il ping pong, il biliardo, il biliardino. Era il paese dei balocchi.
C’era sempre qualcuno che passava di lì con cui giocare, parlare o anche litigare.
Le favole di quel dio erano stupende. Io studiavo e ricordavo ogni cosa. I nomi, i volti…
La chiesa era ben tenuta e riscaldata d’inverno, adorna della statua della Madonna che schiacciava il serpente, del grande quadro del Santo martire sulla graticola, delle candele accese, dell’altare con il tabernacolo sfavillante d’oro, di lini bianchissimi e di gigli.
Ovunque aleggiava l’odore acre dell’incenso.
Mi perdevo tra le navate, fra le panche di legno con le targhette dei defunti ai quali erano state dedicate, fra i libretti delle preghiere, distribuiti ognuno al loro posto.
Done suonava la pianola od organetto: non conosco il vero nome di quello strumento dai cento suoni diversi, che aveva un motore ma non le canne e che lui adoperava con maestria, senza bisogno di uno spartito.
Io avevo una voce che incantava: forte, pura, intonata e altissima. Una voce bianca, la principale del coro. Se fossi stata un maschio, il ruolo di chierichetto mi sarebbe calzato a pennello.
Li invidiavo tantissimo, i chierichetti. Le loro tonache bianche fino a terra. I ricami di filo dorato. Le pianete, i calici, le ampolle. L’acqua e il vino, simboli di vita eterna. Peccato non poter diventare prete… le monache invece quasi le detestavo.
La domenica pomeriggio, alle due e mezzo, si andava al cinema. Filmoni mitici che ci trasportavano fra i ghiacci dell’Alaska o in mezzo ai flutti degli oceani, sulla luna o all’inferno, nell’antica Roma o nella Parigi ottocentesca, nel gelo innevato di Mosca o nelle praterie sconfinate del Far West.
Viaggiavamo ovunque, a piedi, a cavallo, vedeva mo tutto, scoprivamo tutto. Per una settimana intera rivivevo dentro di me il film visto, in attesa del prossimo.
Cosa avrei vissuto? Dove sarei stata?
La sala era sempre gremita e si entrava con le liquirizie, le brustoline, i lupini.
E poi c’era l’Operetta, che si metteva in scena ogni anno, nel Cineteatro dietro la chiesa: noi bambini guidati da lui e una serie di ragazzi grandi che curavano tutta la messa in scena. Con i costumi e gli scenari, con l’orchestra vera che suonava nella
sua fossa. Le prove duravano tutto l’inverno. Il sabato pomeriggio dopo il catechismo e ancora il mercoledì.
Io ero nel coro. Non sapevo assolutamente recitare e non ho mai ottenuto ruoli da protagonista.
Solo qualche impacciata comparsa. Ma nel coro ero la colonna. Dopo la prima prova già sapevo a memoria quasi tutte le parole. E lui ci insegnava cantando con noi. Niente da leggere, né da studiare.
Ma io mi facevo dare il libretto e me lo leggevo avidamente. Alla seconda prova lo sapevo già a memoria.
Le rappresentazioni venivano replicate due o tre volte. L’eccitazione era altissima. E gli applausi scroscianti. Le caramelle gettate sul palco a noi che ci inchinavamo davanti al pubblico. Tutta quella festa per noi, attorno a noi.
Solo ai miei sembrava non interessare per niente. Mi sa che non vennero mai a vedermi. Io non lo ricordo. Anzi, mia madre mi zittiva quando in casa intonavo a gran voce i cori e le parti soliste di canto per allenarmi. Così uscivo fuori e andavo a cantare dove non davo fastidio a nessuno…
Done non era una persona pulita.
La tonaca si rivelava, a un occhio attento, lisa in molti punti e l’odore che emanava era vagamente rancido.
I capelli neri, lustri di brillantina, sicuramente non erano lavati troppo spesso. E l’odore che si percepiva dentro le stanze private dei preti e delle loro perpetue era forte, quasi opprimente.
Loro erano sepolcri imbiancati.
Non ricordo quando lo fece la prima volta. So che lo fece molte volte. Moltissime.
E io pensavo: ' Sì, sì, sono qui. '
La sua era una violenza sottile. Proprio perché entrava in me nel nome di Dio e dell’amore.
Le sue mani erano dappertutto in me. La sua voce era dovunque.
Il suo respiro era l’aria che respiravo.
Si fermava lì, non fece mai altro che toccarmi.
Ma anche se avesse fatto tutto quanto era in suo potere, non sarebbe stato diverso…
Lui succhiava il mio sangue…
Lui beveva la mia vita…
Lui rubava la mia luce…
Durante le confessioni, Done, chiuso nel confessionale, mi chiedeva sempre se mi fossi toccata e cos’altro avessi fatto, se avessi toccato qualcuno dei miei amichetti o dei miei cuginetti.
Anzi, fu lui a insegnarmi come procurarmi piacere da sola o con altri.
Fu lui a spiegarmi come nascevano i bambini, non mia madre o mio padre e lo fece che io avevo sei o sette anni.
Col viso appoggiato contro la grata, la voce bassa ed emozionata, gli raccontavo le mie prime avventure erotiche con i miei coetanei, cosa avevo fatto e quante volte, cosa avevo provato io e cosa avevano provato i bambini che giocavano con me a quei giochi carnali.
Lui mi faceva domande molto specifiche, anatomiche e io rispondevo con precisione.
Sentivo il suo desiderio passare attraverso i buchi della grata.
Sentivo i suoi occhi forare il buio.
Sentivo una mano malvagia che si impossessava di me.
Da allora, il piacere e il dolore si sono mescolati dentro di me. Per sempre.
Lì, alla mensa di quel pane amaro e guasto, ho imparato cosa vale la mia vita.
Piacere e dolore.
I miei scoprirono tutto, tramite la confessione della mia amica Sandra, che viveva quello che stavo vivendo io, come penso tutte le altre bambine della parrocchia.
I genitori di Sandra erano i migliori amici dei miei genitori e vivevano nell’appartamento sotto di noi.
Ma non fecero niente. Ci fu solo un po’ di tensione. A me non chiesero nulla. Seppi tutto da lei, i loro discorsi e la loro decisione di non agire in nessuna maniera. A me, nessuno rivolse una parola. Confermando così quello che mi era stato insegnato e cioè che la mia vita valeva solo come piacere e dolore.
Continuammo a frequentare la chiesa. Avevo undici anni.
Lui non mi molestò più.
Poi mio padre morì.
E qualche anno dopo mi allontanai dalla parrocchia e dalla religione cattolica.
Troppi conti non tornavano nella mia mente.
Quanto scritto finora su quella terribile esperienza è il frutto di una rielaborazione profonda avvenuta nell'estate del 2008 mentre ero nel centro di accoglienza.
Scrissi ancora, sempre su ' Io non sono di qui ':
' Troppo presto la mia innocenza è stata profanata da mani scaturite dall’ombra.
Mi chiedo quanta forza io possegga veramente per vivere con questa ferita dentro.
Per riuscire a continuare ad amare, nonostante questo.
Per avere il coraggio di guardare questo. Ora. Qui.
Ho cinquantatre anni. Ma sono ancora quella bambina abbandonata e violata. Sono una piccola geisha venduta per paura.
È un miracolo che io sia viva. Che io non faccia la prostituta. Che io non sia un’assassina. Che io non sia pervertita o pedofila.
Che io non sia completamente folle, ma solo tanto, tanto. Senza arrivare fino in fondo.
Oggi penso che lui ha sbagliato, così come hanno sbagliato i miei genitori. Che non è stata colpa mia. Che io sono altro, molto altro.
Non so se riuscirò a dare un altro valore alla mia vita.
Lo faccio con il pensiero, ma i binari segnati a fuoco dentro di me, nel profondo, dove la mente non ha dominio, sono quelli. '
In effetti io ho vissuto sino a quel momento ignorando volutamente quanto mi era accaduto.
Non che lo avessi dimenticato, assolutamente. Ricordavo perfettamente tutto, anche il peso di quelle mani e quel piacere che io sapevo ingiusto ma che non potevo non provare.
La domenica al cinema, nel buio della sala, lui si aggirava tra di noi, controllando, facendo tacere i più vivaci, spiegando e rispondendo alle domande, ma soprattutto, ogni tanto, si avvicinava ad una di noi, ci faceva alzare, si sedeva sulla nostra sedia e ci faceva accoccolare sulle sue gambe.
Così, mentre tutti guardavano il film, le sue mani si inserivano sotto le gonne ed ci accarezzava lentamente voluttuosamente.
Io ricordo chiaramente il mio pensiero in quei momenti: sapevo che lui stava facendo qualcosa di brutto, ma mi dicevo dentro di me: ' Toccami, toccami... '
Ed ero un doloroso piacere perverso.
Poi ci fu il giorno in cui Sandra confessò ai suoi genitori che il prete le disse di averla sognata e chiese a loro cosa significasse quando un uomo sognava una bambina. Loro fecero domande e si scoprì tutto ed io scoprii, perché non lo sapevo, che lui faceva lo stesso anche a lei.
Io non lo sapevo, ma lo trovai dl tutto naturale. Ricordo che ci chiedemmo spaventate se lui sarebbe stato arrestato, mandato via. Eravamo perfettamente consce che lui ci stava violando, eppure noi allora non capivamo quale dolore ci stesse scavando dentro. Eravamo come anestetizzate.
E così, anestetizzato, quel ricordo visse dentro di me fino a quel caldo pomeriggio di luglio 2008 in cui esplose con tutta la sua nera virulenza, in quella stanzuccia assolata son le persiane chiuse, dove io mi sedetti al mio pc e scrissi quanto sopra ho riportato e poi, leggendolo a Dana e Sara, piansi tutte le mie lacrime e tutto in una volta sentii cosa avesse veramente fatto, quale guasto fosse stato scavato dentro di me.
Di una cosa non mi do pace, però.
Successe che un giorno, eravamo già ragazzi, io e Carlo entrammo all'improvviso in una delle stanze della parrocchia, cercando qualcuno probabilmente e scoprimmo il prete che, seduto alla sua scrivania, aveva fatto stendere una bimba su quella, con le gambe aperte e penzoloni, le aveva sollevato la gonna e la stava accarezzando con il volto vicinissimo alla sua carne infantile.
Io e Carlo restammo un attimo interdetti, lui, il prete, ci rivolse uno sguardo duro ed interrogativo, noi ci sentimmo spauriti come neonati e senza una parola richiudemmo e ce ne andammo.
Non ne parlammo mai neppure tra noi, ma io ricordo come fosse ora, che sono passati almeno quarant'anni, il viso pallido di quella creatura, i suoi occhi chiusi che non si aprirono neppure al rumore della posta che si schiudeva, ricordo il rosa delle sue cosce innocenti ed il bianco di quelle sue mutandine.
Non ho mai parlato a nessuno, di questo, né mai ho avuto il coraggio di scriverlo.
Ma dentro di me, questo non me lo perdono.
Avrei dovuto intervenire, fare qualcosa, eppure non feci nulla.
Nessuno fece mai nulla.
Il prete morì piuttosto anziano, dopo essere andato in pensione, di malattia. Nessuno mai lo fermò e chissà quante centinaia di bambine ha rovinato.
E non feci nulla neppure io.
Guardando dentro di me so che quello è un grande il peso che porto, perché allora avrò avuto tredici, massimo quattordici anni e SAPEVO cosa avrei dovuto fare, ma non lo feci per paura.
Perché il dominio che quel prete ha esercitato su di me era di natura psicologica ed era completo. Lui mi ha profondamente plagiato.
Mi dico questo anche per far tacere il senso di colpa nei confronti di quella bambina
ma forse se quella sconosciuta creatura fosse qui, ora, di fronte a me, forse mi direbbe che quello è una colpa perenne che non ha mai fine.
Altre due avventure di molestie sessuali ho vissuto.
Un giorno, avrò avuto sette anni, mi stavo recando a piedi in parrocchia, era primissimo pomeriggio. C'era il sole. Un'auto, allora il traffico era assai scarso, accostò di fianco a me ed un uomo si sporse, aprendo la portiera dalla mia parte e chiedendomi dove fosse una certa via.
Io, che la conoscevo bene, glielo spiegai, ma lui, fingendo di non aver capito, mi chiese se lo avessi potuto accompagnare.
Io d'istinto acconsentii e salii sull'auto.
Ecco, qui il ricordo si interrompe e c'è un vuoto nero, come una interruzione, un salto molto profondo.
Poi il ricordo riprende con me che scendo precipitosamente da quell'auto, rammentando ad un tratto assai spaventata che mio padre mi aveva raccomandato di non salire mai con nessuno sconosciuto.
Rivedo poi quell'uomo chiudere rumorosamente la portiera e fuggirsene via,
sgommando.
Un mese fa una cartomante sensitiva mi disse, dopo aver ascoltato il racconto dei miei innumerevoli tentativi di suicido, che io non potevo morire dato che ero morta all'età di sette anni.
A quelle parole mi sono messa a piangere in modo straziato, improvvisamente, come improvvisamente mi è salito alla memoria quel fatto, al quale non avevo assolutamente più pensato.
Dentro di me una voce mi dice che in quel vuoto temporale, in quello scatto, c'è qualcosa di molto brutto e violento.
Qualche anno dopo, mio padre era morto da poco, era autunno e quindi io avevo undici anni e mezzo, altro mi accadde, rincasando che era già sera, nel viale alberato dove sorgeva la mia casa che era assai buio e pochissimo trafficato. Da un albero sbucò fuori all'improvviso un uomo, di cui non ricordo assolutamente nessun particolare, solo che era giovane e più alto di me ed indossava un ampio cappotto. Lui mi fu accanto in un attimo e mi avvolse con il suo abbraccio molto forte.
Mi tirò a sé violentemente e, con il viso sul mio, tanto che sentii l'odore di fumo del suo fiato, mi chiese: ' Ma ce l'hai tu il pelo? '
Io allora ero molto forte e senza neppure pensarci sopra, così, di puro istinto, mi divincolai e gli rifilai una ginocchiata in pancia, probabilmente sui genitali. L'uomo quindi mi lasciò portandosi le mani sulla zona colpita emettendo un sbuffo di fiato, come ne fosse rimasto senza e io fuggii velocemente fino a entrare nell'ingresso di casa mia, che era a pochi passi di distanza, aprire il portone di alluminio e vetro con mani tremanti e rifugiarmi in camera mia.
Quell'uomo era molto cattivo: in quel suo fiato io respirai morte e corruzione malvagia.
Non ne parlai mai con nessuno. Anche di questo è la prima volta che lo faccio, come dell'uomo della macchina.
Mai ad amica amico innamorato ragazzo marito amante innamorata ragazza amica amante. Mai.
I giochi a sfondo sessuale dettati dalla curiosità dell'altro e dal nascere dei primi stimoli sono una cosa normalissima in ogni bambino.
Il mio primo contatto del genere avvenne con uno dei miei cuginetti più piccoli quando ancora si abitava nella grande casa poi demolita. Ricordo bene che venimmo sorpresi in bagno insieme a fare pipì e sgridati, cosa che mi lasciò piuttosto colpita e stranita.
Ma quanti anni avevo quando il mio amatissimo amico Giorgio, figlio di un altro compagno di studi di mio padre, che abitava di fronte a dove si costruì il condominio, mi chiese se avessi voluto giocare ad un gioco bellissimo che facevano all'asilo? Non ricordo con precisione se andavo io stessa ancora alla scuola materna oppure già alle elementari, ma di certo la mia età non superava i sei anni, periodo che segnò l'inizio delle molestie sessuali del prete, con l'avvento della scuola di catechismo. Io accettai con grande curiosità, cogliendo nella sua voce una eccitazione strana e forte. Fu così che mi portò in cantina, dove era certo non saremmo stati visti e tirò fuori dai pantaloni il suo piselletto, facendomelo vedere tutto orgoglioso e chiedendomi di chinarmi come per fare la pipì, permettendogli di guardarmi.
Io gli diedi retta e fu così che provai il mio primo conscio piacere sessuale.
Da quel giorno feci molti giochi di quel genere con molti dei maschietti che mi giravano intorno, anche con un paio di cuginetti, quando eravamo più grandicelli e già sapevo che era ' peccato '. Ma lo facevo lo stesso, perché l'attrazione per quel gioco era più forte di ogni cosa. Ma quando feci la prima confessione, il sabato precedente la mia Prima Comunione, non ebbi il coraggio di confessare quel mio gravissimo peccato a quel prete che ne stava commettendo uno vero e decisamente più grave con me: non me la sentii, così, alla sua domanda se avessi mai fatto atti impuri risposi di no e il giorno dopo ricevetti così la mia Prima Comunione.
Io avevo un fede spontanea, mistica.
Restavo le ore in chiesa a vivere la presenza e la vicinanza di quel Dio che mi sentivo dentro. Io sapevo tutto di lui, cos'era, com'era, ma quello che mi veniva insegnato non corrispondeva a ciò che sentivo.
Io sapevo che quello che facevo non era peccato.
Era peccato dire bugie, imbrogliare al gioco, disubbidire alla mamma, non fare il proprio dovere ed io, quei peccati, non li commettevo.
Ma quello, che era considerato il più grave, non mi sembrava un peccato.
Cosa facevo di male in quel gioco così eccitante? Eppure il senso di colpa, ogni sera, mentre recitavo le preghiere prima di entrare nel mio lettino, lacrime cocenti scendevano giù per le mie guance: chiedevo perdono a Gesù, gli chiedevo perdono con tutto il mio cuore, ma non riuscivo a non fare quei giochi e neppure a confessarli al parroco.
L'anno dopo feci la mia Santa Cresima.
Già la Prima Comunione fu una cosa bellissima, con la grande festa in mio onore, l'abito bianco da sposa, il velo e tutto il resto, la Santa Cresima si prospettava ugualmente eccezionale.
Neppure in quel frangente riuscii a confessare il mio peccato e fui ' punita ' .
Quando fummo tutti in chiesa, i bambini schierati su di un fianco lungo le navate e noi bambine di fronte, ci fu dato un cero da tenere in mano, simbolo della luce che stavamo per ricevere e questo cero fu acceso. Mentre seguivamo con gli occhi e il cuore palpitante l'avvicinarsi del vescovo che dava ad ognuno l'olio santo sulla fronte – e girava una voce che invece ci sarebbe stato fatto un buco con un chiodo e poi coperto con la benda! - e lo schiaffetto del memento mori, la bambina che era di fianco a me appiccò involontariamente il fuoco al mio velo.
Io non mi accorsi di nulla, solo come in un sogno sentii grida e poi qualcuno che mi avvolgeva la testa con della stoffa strappandomi il velo e ciuffi di capelli. Il padre di quella bambina con grande sangue freddo si era tolta la giacca ed aveva spento il fuoco, che stava rapidamente spargendosi ai miei capelli ed alle maniche del vestito.
Fui salva per miracolo, ma io sapevo che era Dio che mi aveva punito, indignato del mio comportamento.
La notte seguente, finalmente sola, piansi tutte le mie lacrime di pentimento, eppure ciò non bastò a farmi confessare il mio peccato. Non potevo dire a quel prete che avevo commesso il sacrilegio così immenso di aver ricevuto la Prima Comunione e la Santa Cresima e di essermi comunicata tutte quelle domeniche, - dato che io andavo a messa ogni domenica, in modo categorico, - con il cuore non puro.
E mi rodevo di dolore e di pentimento senza trovare una soluzione, una via d'uscita
Per fortuna quella stessa estate trovai la mia pace.
Fui mandata in una colonia montana a Verghereto, una località balneare molto amena, sui nostri appennini.
Restai lì quindici giorni: io amavo moltissimo andare in colonia, a differenza di tutti gli altri, perché si stava in compagnia, si giocava, c'erano le signorine che si prendevano cura di me ed ogni anno, con grande sollievo della mia mamma che finalmente poteva riposare un po', andavo in una di quelle, sempre la stessa, a Pinarella di Cervia, sotto una bellissima pineta in riva al mare. Ma quell'anno mi chiesero se avessi voluto andare ance in una in montagna ed io ne fui felicissima.
Infatti mi divertii molto: ogni giorno lunghe passeggiate nei boschi che lì sono assai verdi fioriti e profumati e tanti giochi in un clima più fresco, a me molto gradito, dato che da sempre soffro molto il caldo. Il cibo ottimo come i canti e i giochi: fu tutto perfetto; ma due fatti segnarono quei quindici giorni.
La prima domenica un prete venne a dire messa. Durante l'omelia ci fece un sermone piuttosto violento sulla necessità di non peccare mai e di confessare i propri peccati con grande umiltà. Egli gridava dal pulpito descrivendo le eterne fiamme dell'inferno che avrebbe arso vivo, senza mai estinguersi colui che sarebbe morto in odor di peccato mortale.
Io rimasi profondamente colpita. La notte, in quel lettuccio dentro la camerata, mentre tutti gli altri bambini e la nostra signorina dormivano, io restavo a fissare il buio, con gli occhi sbarrati dal terrore.
Fu così che decisi di confessarmi il sabato seguente.
Con il cuore che palpitava forte forte raccontai a mezza voce il mio enorme peccato, spettando i tuoni ed i fulmini di quel prete. Invece lui mi disse che Dio mi perdonava e mi inflisse come punizione l'obbligo di recitare alcune orazioni in aggiunta alle solite.
Davvero con che cuore leggero uscii da quella chiesa!
Da quel giorno mai più feci qualcosa che la mia voce interiore mi ammoniva come non giusto.
Un altro accadimento restò segno indelebile in me, accaduto in quei giorni di colonia montana: un pomeriggio, mentre eravamo in camerata, reggendomi in equilibrio con una mano su di una sponda di un lettino e l'altra su quella del lettino accanto, mi dondolavo. Persi l'equilibrio e caddi viso a terra. Il colpo fu notevole. La signorina corse attratta dalle mie grida. Il sangue scorreva perché mi ero spaccata il labbro. Mi portarono allora al lavandino e mi lavarono con l'acqua fredda finché il sangue si fermò. Ma io continuavo a singhiozzare. ' Perché piangi? ' mi ammonì severa l'assistente, forse timorosa di ricevere una lavata di capo per averci lasciate senza assistenza in camerata, ' Non dirmi che ti fa così male! ' ed io le risposi: ' Non piango per il dolore, ma per il mio dentino che si è spezzato. '
Infatti allora si accorsero che il mio incisivo superiore destro era troncato di netto in orizzontale per due terzi. Solo ai diciotto anni fu ricostruito con una nuova tecnologia. Da quel giorno ebbi un sorriso di cui mi vergognai assai, imparando a sorridere con le labbra chiuse, cosa che faccio tutt'ora.
Ma un'altra volta mi recai a chiedere il perdono di Dio.
Avevo trentatrè anni ed avevo avuto il mio primo rapporto sessuale con una donna, dopo tanto spasimare e tanta incertezza. Lo racconterò più avanti.
Avevo allora abbandonato la Chiesa cattolica da anni ormai, esattamente dai miei tredici anni, ma spesso continuavo a recarmi in chiesa per pregare al ' mio' Dio, per respirare quell'aria mistica che tanto amavo.
Quel rapporto carnale fatto senza amore e ' contro natura ', mi pesava nel cuore. Dentro di me sapevo che non era quella la mia via e sentii il bisogno di chiederne perdono a colui che forse si era sentito offeso.
Allora non seppi cosa mi spinse, dopo tanti anni di lontananza, ad affrontare una confessione: ora invece sono certa che il mio cuore non in pace con sé stesso cercò allora, come tante altre volte, di ricevere una perdono esterno che avesse potuto perdonare quello che io non riuscivo a rimettermi e cioè, ora lo vedo chiaramente, di aver sporcato con un rapporto di sesso quello che dentro di me è uno dei sentimenti più alti: l'amore per le donne.
Mi recai così nella cattedrale della mia città, dove vi era un prete confessore che ogni pomeriggio si metteva a disposizione dei fedeli in cerca di perdono. Era un prete che non conoscevo e si diceva di lui che fosse un sant'uomo ispirato. Per quello lo scelsi. Ma quando gli ebbi raccontato tutto lui mi domandò: ' Hai tu intenzione di non avere mai più un rapporto carnale con un'altra donna? ' . Io quella volta fui sincera, come lo ero stata fino ad allora, dopo la fatidica confessione nella colonia, tanto che, quando mi accorsi che non ero affatto pentita dei peccati di ' fornicazione ' che stavo commettendo e che anzi, non li ritenevo affatto peccati, mi allontanai totalmente dalla chiesa, e gli risposi che non ne ero affatto sicura, che sentivo il mio cuore ed il mio corpo portati a quel genere d'amore.
E fu così che il prete ' santo ' mi negò l'assoluzione ed il perdono di Dio.
Io uscii dalla chiesa in lacrime, ma sapevo che quelle lacrime non erano per me, bensì per lui.

CAPITOLO OTTAVO
Malattie, paure e fissazioni della mia
infanzia. Primo tentativo di suicidio
Ci si può stupire di quanto io sia così forte nonostante tutte le malattie che hanno minato la mia salute, nella mia infanzia, diverse delle quali congenite.
Ho già narrato della forte gatroenterite che fu curata con l'acqua seconda di calce. Mi è sempre stato detto che a procurarla fu il latte di mia madre, ma di certo io non potei bere il latte per molti anni, fino alla mia giovinezza ed anche oltre perché mi provocava dissenteria.
Ma la dissenteria fu una costante della mia infanzia.
Ogni tanto e la causa precisa non si individuò mai, veniva assalita da scariche di diarrea fortissima con dolori da contorcermi.
Rimase famosa la volta che mi accadde sui nove dieci anni, prima comunque della morte del babbo,
Quella volta che io e mia madre, cosa del tutto inedita, partecipammo ad una gita organizzata da non so quale parroco della mia città, amico di una delle mie zie. La meta fu Napoli e stemmo via credo tre giorni, comunque ci furono un paio di pernottamenti fuori.
Io ricordo molto bene la gita alla Grotta Azzurra, - come dimenticare quell'acqua incandescente di un azzurro che sembrava vivo????? - ai Faraglioni, mastodonti di pietra in mezzo al mare, ai vicoli con la famosa biancheria stesa ad asciugare e la vociante umanità tutta per strada, alla pizzeria con la pizza più buona che io avessi fino ad allora mai mangiato – e forse anche dopo, - al Castel dell'Ovo, - che avevo sempre sentito nominare dal babbo perché vi aveva passato il richiamo sotto le armi, - e gli scugnizzi che si buttavano nell'acqua del molo, allora ancora pulita, per raccogliere molto lestamente le monete che noi, gitanti ricchi, gettavamo in acqua. Mi stupì molto la loro forza ed allegria, il loro vociare: ' Ancora signò … ancora!!! '
Ma ricordo che chiesi dove fosse la loro mamma e come mai permettesse loro quel bagno così pericoloso......
Visitammo poi, la grande Reggia di Caserta con i giardini, le fontane e le immensa sale affrescate di ori e di stucchi e arredate con mobili rococò.
Percorremmo tutta la statale Amalfitana per ammirare il paesaggio che era davvero stupendo, tra scogliere, mare azzurrissimo, bellissime ville e palmizi, ma evidentemente qualcosa del pranzo, che consumammo in un ristorantino, mi aveva dato fastidio, - ricordo che ci scandalizzammo alquanto per l'insalata piena di terra. Quindi fui assalita dai miei soliti dolori, eravamo sul pullman e la mia autonomia non era molta: chiesi a mia madre di poterci fermare, ma l'autista non voleva farlo, perché non vi era un'area apposita nei paraggi e così mi fu chiesto di tenere duro. Io ci provai e ricordo i lacrimoni cocenti che alla fine convinsero il conducente del nostro mezzo ad arrestarlo sul ciglio di quella strada così stretta a tutta curve, permettendomi di evacuare sul ciglio di un fosso, piena di vergogna e con la paura di essere vista, ma davvero non ne potevo più! Beh, non fu divertente per nulla, tanto è vero che me lo ricordo ancora perfettamente.
Quindi questi improvvisi e terribili mal di pancia che mi disturbarono per tutta la mia infanzia e la giovinezza, - ma ancora oggi, ogni tanto, soprattutto se prendo freddo ai pedi, tornano a trovarmi – erano di certo il ricordo di quella enterite neonatale, ma anche della infestazione di parassiti intestinali di cui soffrii ripetutamente, cosa di cui ho un ricordo piuttosto vivo.
Ma la lista dei mie problemi infantili è piuttosto lunga.
A tre anni fui operata di tonsille ed adenoidi perché le tonsille erano sane ma ipertrofiche, così come le adenoidi ed io non respiravo bene ma lo facevo solo e sempre a bocca aperta e la notte non riuscivo a stare sdraiata e ' mi arrampicavo su per il muro ' come mi ha sempre raccontato mia madre.
Perciò una mattina venne mio zio Bruno, l'unico che fra di noi aveva un auto, mi avvolsero in una coperta, mi fecero entrare nell'abitacolo di pelle nera, - credo fosse la prima volta che io salivo su di un auto e ne rivedo ora i finestrini piccoli e le strade della città che fuggivano via al mio sguardo, - e mi trasportarono in ospedale. In quella stanza così grande e così alta fui fatta sedere su di una specie di poltrona da dentista, ma poiché non stavo ferma, una infermiera si sedette al posto mio, mi prese in braccio e mi strinse così forte da impedirmi di muovermi mentre un medico con il camice bianco, -e come era alto e magro quel medico e che brutta faccia che aveva... - mi applicò la maschera ad etere per praticarmi quella rudimentale anestesia. Quel liquido freddo che mi entrò in gola nel naso, beh, campassi cent'anni, non lo dimenticherei e, vi giuro, ricordo perfettamente tutte le manovre che vennero fatte nella mia gola, il divaricatore che mi fu messo, il taglio, il raschiamento, il sangue che mi soffocava e quelle braccia che mi imprigionavano.
Poi, come Dio volle, mi addormentai, ma mi svegliai non so quanto tempo dopo vomitando sangue, che il cuscino era tutto rosso e per diversi giorni ebbi così tanto dolore da non poter inghiottire che gelati, che però mi piacevano tantissimo.
Ebbi tutte le malattie infantili: morbillo, varicella – che prurito!! - orecchioni piuttosto forti con febbre alta e dolore alla parte gonfia ma non fui molto soggetta a malattie da raffreddamento, per quello ero piuttosto forte, esattamente come ora.
Invece la mia miopia congenita mi procurò sempre molti problemi, esattamente come ora.
Fu la mia maestra quando andai in prima elementare, - e cioè a cinque anni e mezzo, - che si accorse che non vedevo bene e disse ai miei di portarmi a fare una visita oculistica: infatti scrivevo con la testa appoggiata sull'avambraccio destro.
Di certo avrebbero potuto pensarci prima, dato che da sempre, anche alla scuola materna, io mi mettevo in quella posizione e sbattevo molto facilmente contro ogni genere di ostacolo, mobili ed altro, come pure inciampavo facilmente dovunque, ma mia madre non faceva altro che dire che ero sbadata, disattenta e che avevo ogni sorta di difetti e vizi.
Invece l'oculista mi trovò una miopia che era già sui cinque gradi dall'occhio destro e sui tre al sinistro, quindi un difetto già piuttosto accentuato.
Ma l'abitudine di sgridarmi quando inciampavo o cozzavo contro qualcosa non cambiò, come pure quella del susseguente scappellotto come monito al fatto che, se proprio dovevo piangere, piangessi pure per qualcosa.
Mi misero quindi il mio primo paio di occhiali, con la montatura scura e grossa e con queste lenti a culo di bicchiere: ricominciai a vedere, riscoprendo tutta una realtà che non conoscevo, ma anche cominciai il tormento delle stanghette che ferivano dietro le orecchie, oppure la montatura che segnava sul naso e le lenti che si sporcavano, si appannavano e ogni volta che cadevo, - ed io cadevo sempre, - mi ruzzolavano via, rompendosi molto spesso e costringendomi a sopportare una serie di rimbrotti e raccomandazioni infinite.
Di certo gli occhiali sono una tortura, poi di quella fatta ed addosso ad una scalmanata come me, ve li raccomando.
Ma senza non vedevo davvero nulla, tanto che d'estate al mare, quando me li levavo per andare a fare il bagno, poi avevo grandi difficoltà a ritrovare il mio ombrellone e lo stabilimento balneare e diverse volte i miei furono richiamati dagli altoparlanti dei bagni vicini che gridavano il mio nome, dicendo che li stavo aspettando al Nettuno oppure al Rivabella.....
Ho sempre letto tantissimo, soprattutto la sera e la notte, ma leggevo con la mano sull'occhio destro, perché altrimenti vedevo doppio, inoltre in ogni classe dove io sono stata sono stata messa sempre in prima fila, dato che altrimenti non leggevo alla lavagna, venendo così classificata ' secchiona ', anche se io non lo ero davvero. Comunque Balena Quattrocchi era il mio secondo nome.
Ogni anno gli occhiali erano da cambiare perché la mia miopia progrediva e a dieci anni era già meno sette e meno cinque gradi.
Infatti quell'anno, mentre mio padre era in ospedale, mia zia mi portò da un altro oculista a Forlì, che facevano assai bravo, per un consulto extra, ma costui non diede speranze, dicendo che a trent'anni, massimo, sarei stata cieca. E su questo nessuno ebbe nulla da ridire, con buona pace di tutti e nessuno si preoccupò mai di fare qualcosa, cercare qualcosa per vedere se si fosse potuto ovviare a questo destino infame che mi se prospettava.
Per fortuna inventarono le lenti a contatto........
Poi vi fu il problema alle anche.
Appena cominciai a camminare, zoppicavo.
Era una zoppia accentuata sulla parte destra ed anche i piedi venivano buttati assai male.
Fui portata dal medico, che era amico di mio padre e fui sottoposta a radiografie alle anche.
Risultò che avevo una parziale lussazione e che avevo una gamba più corta, di quasi un centimetro, la destra.
A quei tempi non vi erano molti rimedi per quel problema: io continuai a zoppicare fino a tra anni e mezzo, poi smisi. Evidentemente il mio organismo si riequilibrò da solo.
Ricordo però di aver ingurgitato grandi quantità di olio di fegato di merluzzo, che era a dire di tutti nauseabondo ma che a me, che volete che vi dica, piaceva tanto, forse perché mia madre mi dava quello al sapore di arancio... misteri dei bambini.
Comunque il dolore alle anche era una abitudine, per me, anche quando non zoppicavo più.
Durante il soggiorno a otto anni in quella colonia estiva a Verghereto, di cui ho già raccontato, dato che facevamo lunghissime camminate quotidiane, accusai un forte dolore ai talloni che non passò neppure tornata a casa.
Di nuovo mi fecero radiografie e risultò che avevo delle cisti ad ambedue la anche, ma soprattutto a quella destra. I medici dissero che se queste non si fossero riassorbite da sole avrei dovuto essere sottoposta ad un delicato e difficile intervento chirurgico ed avrei dovuto venire ingessata per tutto il tronco e le gambe in una totale immobilità per diversi mesi. Raccomandarono quindi di non farmi fare ginnastica a scuola, - e questo durò fino al penultimo anno del liceo - e di tenermi ferma il più possibile.
E questo fu il tormento numero due: il dolore fisso alle anche ed ai talloni, il continuo dirmi: ' Ari stai ferma, Ari non correre, Ari non camminare.'
Per fortuna nuotare mi era permesso: davvero per fortuna, altrimenti davvero non so come avrei potuto resistere; almeno d'estate potevo sfogarmi in acqua.
Ma di certo io ferma non stavo, non mi era proprio possibile: io ero una cavallina, una bestiolina che ferma non sapeva stare, che aveva il fuoco dentro, che era forte ed agile che non aveva paura di nulla, che aveva bisogno di correre, di camminare, di andare in bicicletta.
L'altra mia fortuna fu il fatto di vivere in uno stato di totale libertà e, alla fine, facevo quello che mi pareva, anche perché, quando non mi facevano uscire ero come un leone in gabbia e talmente rumorosi i miei giochi che davvero, per disperazione, all'ennesimo: ' Posso andare a giocare mamma? ', la risposta era un si.. con, immagino, sospiro di sollievo appena chiudevo la porta.
Io non ricordo se i miei mi chiedessero cosa facevo quando ero fuori casa e dove andavo, so solo che andavo ovunque, spingendomi fino a qualche chilometro da casa, con la bici o con i pattini a rotelle, giravo senza meta, per guardare le case, i giardini, per seguire le rive del fiume, le massicciate della ferrovia, i viali, le strade, stradine e vicoli della mia città, il grande Parco delle Rimembranze che noi chiamavamo la Rocca, lo sferisterio per il gioco della pallacorda che era dietro di questo, ogni chiesa o campetto da gioco, ogni oratorio, ogni luogo di ritrovo per bambini. Se vi era un'altalena, se vi era uno scivolo, e quelli vennero solo dopo il compimento dei miei dieci anni, io li trovavo e ci trascorrevo le ore. La mia città era un continuo contenitore di sorprese, le case dei miei compagni di scuola erano sempre aperte per me ed io avevo sempre qualcuno da andare a trovare, a salutare, ad aiutare nei compiti.
Stare sola non mi piaceva molto, solo alcune volte sentivo il bisogno di isolarmi e comunque c'era l'appuntamento fisso a casa di zia Teresina per la merenda, dove nessuno mi contava il cibo ed anzi, dove lei, la mia zia preferita, si preoccupava che mangiassi e mi faceva ' l'ovino ', sbattendo in una grande tazza un uovo di giornata con il frullino a mano fino a montare le chiare a neve, alle quali poi accludeva il tuorlo e lo zucchero, servendomi poi questa leccornia dolce e spumosa che io ingollavo con grandi cucchiaiate, oppure lavorando solo il tuorlo con lo zucchero fino a farlo diventare una crema densa e morbida, quasi bianca, con la quale farmi baffi appiccicaticci. Altrimenti tirava fuori dalla credenza odorosa di buono grandi trecce di pane comune biscottato fuori e morbido dentro, ne tagliava pezzi abbondanti per ognuno di noi, tra i quattro cinque affamati di turno che sempre aveva al richiamo delle quattro del pomeriggio, - io i mie cugini più piccoli e qualche bimbo dl vicinato, tanto per mia zia, sempre tutte creature eravamo, uccellini da nido per quel grande cuore di madre e si che danaro a casa sua ne girava ben poco! - e, aperto il cartoccio di carta oleata, estraeva grandi fette di rosea e profumatissima mortadella per farcire i nostri panini che, come tanti pollicini, andavamo a divorare in giro per casa, il terrazzo, il cortile.
Come poteva il male alle anche fermare tutto questo?
E così me lo tenevo, senza lamentarmi, anzi, nascondendolo, per paura di venire segregata in casa.
Però, niente ginnastica alle medie e al ginnasio e niente campeggi estivi con le coccinelle e le guide, cosa che fu uno dei mie più grandi dispiaceri.
Io davvero non ricordo di aver vissuto un giorno senza un qualche dolore.
Perché non è finita qui.
A sette anni mi venne una infezione sulla gamba destra, a metà della tibia. Mio padre, come ho già raccontato, me la spremeva ogni giorno e la cosa durò mesi. Mi ci metteva poi una pomata nera con uno strano odore che si chiamava ' Ittiolo ' e che veniva conservata in una scatolina rotonda di legno leggero. Questa pomata serviva per fare maturare l'infezione e ricordo benissimo quando un giorno venne fuori da questa ' spremitura ' che lui faceva della mia ferita, una specie di vermicello bianco, che lui rimossa accuratamente, dicendomi che quello era ' il nonno ' dell'infezione stessa. Infatti, poi, guarii. Non so altro, di quella, che fu una strana cosa, ma mi resta una vistose cicatrice a ricordo e conferma di non aver inventato o sognato tutto.
Poi venne il dolore alla milza.
All'improvviso mi sorgeva un forte dolore al fianco sinistro, tale che mi impediva di restare persino seduta. Mi successe diverse volte, decine di volte, anche in classe, alle elementari ed alle medie: mi dovevano allora mandare in infermeria e farmi sdraiare. Di solito mi addormentavo, dopo un po', quando il dolore forte calava, ma rimanevo stanca e stranita per tutto il giorno.
Nessuno seppe mai da dove venisse quel dolore: dissero che mi faceva male la milza, anche se questo non mi accadeva quando io facevo sforzi, ma di solito quando stavo seduta per parecchio tempo.
Ricordo che anche al liceo ebbi un paio di quelle crisi e fui accompagnata a casa da un professore. Quella cosa restò e resta un mistero della mia vita.
Ma il disastro più disastroso della mia infanzia ed adolescenza fu l'enuresi notturna, la famosa ' pipì a letto '.
L'ultima volta che io ho fatto pipì a letto avevo 21 anni ed ero madre da tre.
Fu una cosa tragica, per me, una colpa mia che ogni volta che si avvicinava la sera, mi attanagliava: ' Ari, non bere, che sennò fai pipì a letto.... non mangiare il cocomero, il melone, il gelato, che se no fai pipì a letto.... '.
Ma io la facevo lo stesso. E ogni volta erano tragedie di mia madre che doveva mettere a lavare le lenzuola e stare attenta al materasso, che era di crine, cioè di fieno – come si dormiva bene in quel materasso di fieno!!! -comprato appositamente per me perché quello di lana induceva ancor di più il fenomeno. Ma il mio materasso aveva sempre aloni giallastri di pipì uscite fuori dalla ' telincerata ' che si spostava sempre.
Io non mi accorgevo di fare pipì a letto. Qualche volta sognavo che mi scappasse e di farla da qualche parte, ma il più delle volte ero ignara di tutto. So solo che, ad un certo punto della notte mi svegliavo, mettevo una mano sotto il mio fianco e sentivo il famigerato bagnato.
Appena fui grande abbastanza imparai ad alzarmi da sola, a cambiarmi il pigiama e la biancheria e a mettere degli asciugamani sulle lenzuola, in modo da poter continuare a dormire senza svegliare la mamma. Almeno così limitavo i rimbrotti e le sgridate.
Poi cominciai a non volermi addormentare e a leggere fino alle due e le tre di notte, proprio perché così, quando non ce la facevo più, mi alzavo per andare in bagno ed affrontavo una notte assai più breve: infatti il mattino dopo mi svegliavo che avevo un urgentissimo bisogno di urinare, ma almeno il letto e tutto il resto era asciutto.
E quando accadeva che io dovessi dormire fuori per un qualche ragione, da una zia, un'amica o altro praticamente non dormivo, ma rimanevo semi assopita, impedendomi di sprofondare nel sonno, per accorgermi del bisogno impellente che sempre, due o tre volte per notte io avvertivo e potermi alzare ed andare in bagno.
Alle medie scoprii che vi era una branca della medicina chiamata ' psicologia ' e cominciai a leggere qualche libro, continuando per tutto il liceo. Allora imparai che il disturbo del quale soffrivo era un evidente stato di sofferenza psicologica e non una azione di cattiva volontà o di cattiveria, come affermava mia madre.
Fu la mia professoressa di lettere delle media, l'amata signora Dionigi, che mi fese scoprire la psicologia, in seconda media.
Io mi domando e dico, va beh che lei era professoressa e suo marito medico e che mi madre aveva si e no la seconda elementare, ma mio padre era semi-laureato e sua sorella era laureata in farmacia.
Possibile che a nessuno sia passato mai per la testa che io stessi soffrendo di e per qualcosa e che non fossi solo cattiva e cattiva e cattiva?
Io li ricordo bene gli sguardi cupi, i continui rimbrotti, le continue sgridate.
Un giorno chiesi a mia madre:' Perché mio fratello non lo sgridi mai?' e lei mi rispose: ' Perché lui è bravo e buono e non fa mai nulla di sbagliato, cosa lo dovrei sgridare a fare?'
E così è stato tutta la vita: io non ho mai fatto nulla di giusto e lui mai nulla di sbagliato e quello che mi chiedo è: possibile che lui non abbia sbagliato mai, per mia madre ed io invece sempre, dato che non ricordo un volta in cui mi abbia detto, al mio annunciarle una qualsiasi cosa: ' Hai fatto bene!! '
Io sono sempre stata quella che faceva e diceva disastri, quella del famoso detto di mio padre, esasperato dalle sue continue lamentele: ' L'hai voluta? Goditela! '
E allora anche io ora mi chiedo: ma mio padre, mi ha amato davvero o aveva ragione mia madre quando mi disse che io l'avevo mitizzato troppo che lui non era quello che gli altri vedevano?
E ancora mi chiedo: ' Se neppure da bambina, quando si è innocenti e spontanei, io ho saputo farmi amare da chi mi ha messo al mondo e da chi avevo intorno, se neppure allora ho saputo comportarmi in modo grazioso o bello da venire apprezzata, come potrò fare ora, che non so più davvero che pesci pigliare perché ho un groviglio nella testa che mai più potrò più dipanare?
Eppure ero una bambina dalle grandi qualità e poi sono stata una donna dalle grandi qualità, ma se nessuno mi sopporta, mi sa che queste qualità le vedo solo io.
Le mie notti, comunque, erano assai tormentane non solo per la questione dell'enuresi ma perché c'era qualcos'altro di ancora più terribile che non mi faceva dormire fino alle due le tre di notte dai sette otto nove anni e seguenti, fino a … sempre, perché anche ora io raramente mi addormento prima dell'una di notte, anche se sono stanchissima o sveglia dal mattino presto.
Quella cosa terribile che io vivevo senza averne mai parlato con nessuno era la paura del buio.
Appena spegnevo la luce mi irrigidivo in un terrore folle ed aspettavo che mani gelide e vischiose uscissero da sotto il letto e mi afferrassero per portarmi via.
Il terrore mi paralizzava così tanto che io non riuscivo a muovere un muscolo, neppure per riaccendere la luce, neppure per chiamare la mamma o il babbo, che certamente mi avrebbero sgridato, come di sicuro è avvenuto, dicendomi che tanto non vi era nulla e nessuno che potesse e volesse farmi del male e che i miei erano solo i soliti capricci.
Finché fui bambina dovetti sottostare al volere dei miei di spegnere la luce, perché era obbligatorio, così che quando ogni altra luce era spenta ed il buio totale io precipitavo in quel baratro di attesa gelata e folle, senza remissione né sollievo fino a quando, vinta dalla stanchezza, non mi addormentavo.
Non so quanto tempo io passassi in quello stato, ma a me sembrava lunghissimo, perché si dilatava di attimi di furibondo terrore.
Non credo di avere le parole per poterlo descrivere. Solo posso dire che io SAPEVO che quelle mani erano lì, pronte a ghermirmi, che appartenevano a qualcuno che era male puro, che era tortura infinita, tormento, non tanto morte, ma dolore e terrore senza fine.
Poi, appena ebbi una mia capacità di gestire le mie cose, non spensi più la luce.
Ero già madre da diversi anni ma se mi capitava di dormire da sola, perché Carlo si recava da qualche parte per lavoro, io tenevo tutte le luci di casa accese.
Ora non posso dire di avere ancora quella paura, no di certo, ma non amo il buio e comunque dormo sempre con qualche luce accesa.
Solo Carlo seppe, in qualche modo, di questo mio problema, ma non ne parlai mai con nessun altro, neppure io ricordo di averne trattato neppure con i medici della mente che mi ebbero in cura da grande.
I miei genitori non si curarono di questi miei disturbi, eppure sapevano che vi fosse qualcosa che non andava.
Non solo il buio mi terrorizzava, ma anche film o telefilm e documentari che trattassero di qualcosa di vagamente pauroso. Persino il Tenente Maigret, trasmissione allora assai in voga e che mio padre seguiva, mi gettava nella più irragionevole paura: bastava che solo la musica, accennando a qualcosa che stava per avvenire, salisse un attimo di tono per la suspance, che io me ne fuggivo in camera mia a leggere, chiudendomi le orecchie con le mani per non udire: era qualcosa più forte di me.
Quindi ogni sera andavo a letto dopo carosello ma leggevo, con la mia lampada da comodino accesa che mi rassicurava. Poi i miei si coricavano e mi dicevano di spegnere. Io rispondevo: ' Ancora un minuto, finisco il capitolo! ' e speravo si addormentassero. Se questo avveniva io non spegnevo la luce. Ma se non avveniva dovevo farlo e quindi venivo rapita da questo mondo terrifico entro in quale ogni rumore esterno, che so, il russare di mio padre, un cigolio di un letto, qualcuno che si alzava per andare in bagno o in cucina, diventava la preparazione, l'annuncio a quello che stava di certo, di sicuro per accadere, ma che non accadeva mai, lasciandomi a soffrire quello che io solo posso sapere, ogni notte, ogni sacrosanta notte.
Questa mia paura non mi venne quando ero piccola piccola, no, io ricordo che abitavamo già nell'appartamento nel condomino quando vivevo quegli incubi notturni, quindi dopo gli otto anni di età, quindi dopo che cominciarono le molestie da parte del sacerdote ed anche di quell'accadimento così avvolto in un vuoto e quello strano salto mnemonico che fu l'incontro con l'uomo della macchina.
Anche senza voler per forza di cose tirar fuori forze paranormali, quelle mani erano il male in persona e venivano proprio ad afferrare me.
I miei giorni però furono segnati anche da altre mie strane idiosincrasie.
Nessuno voleva mai dividere il letto con me perché, oltre il problema della pipì, io muovevo in continuazione la gamba destra.
Era un movimento ritmico che io non riuscivo a fermare in nessun modo, così forte che scuoteva il materasso e faceva dondolare tutto il letto.
Ricordo perfettamente come partiva, pochissimi minuti dopo io toccassi il letto, di giorno e di notte, cominciava con una flessione della caviglia, in modo regolare circa, una al secondo, forse più veloce, per poi passare ad un dondolio di tutta la gamba fino al ginocchio, sempre con flessione della caviglia. Questo movimento durava anche quando dormivo, senza interruzione.
Quando dovevo coricarmi con qualche cuginetto, che so al mare o a casa di qualche zia, questo fatto rappresentava un problema grande perché io non potevo impedirlo e così facendo non permettevo agli altri di dormire.
Ricordo che mia madre mi disse che secondo lei quel mio movimento era un modo per cullarli nel letto fino ad addormentarmi, dato che lei non mi cullava e questo io ripetevo a chi mi chiedesse il perché di quel mio strano movimento.
Solo quando mi sposai e cominciai a dormire con Carlo, questo fenomeno si acquietò un poco, ma senza sparire. Cercavo di mantenere la mia oscillazione in modo tale che il risultato fosse solo un dolce dondolio e lui si abituò ben presto a questo mio fare e questo successe poi anche con Antonio.
Solo dopo che mi separai da Antonio e ricomincia a dormire da sola questa cosa riprese forza, ma poi si trasformò in una smania che mi impediva di trovare riposo sdraiata e che mi obbligava a camminare per ore per casa, finché non riuscissi finalmente a rilassarmi e ad addormentarmi.
In uno dei mi ricoveri a Villa Azzurra, quella clinica per malati di mente nella quale fui accolta tre volte, un neurologo mi visitò, dato che il disturbo aveva raggiunto una cadenza regolare e continua e mi disse che soffrivo certamente della ' Sindrome delle gambe senza riposo', mettendomi in terapia con un farmaco che curava il morbo di Parkinson. Il sollievo fu immediato e da allora io sono dipendente da questo farmaco, perché senza di quello sia sdraiata che le mie gambe vengono scossi da movimenti e contrazioni in parte spontanei, in parte procurati da me per alleviare la tensione ed il fastidiosissimo spasmo che provo. Ora questo mi accade anche da seduta ed interessa anche le braccia, quindi senza quel farmaco io non posso vivere.
Ma comunque le mie gambe ferme non lo sono state mai, neppure da sveglia.
Ricordo perfettamente che la mia maestra delle elementari, la fatidica amata-odiata signora Spinelli, si lamentasse sempre del mio continuo agitare le ginocchia, aprendo e chiudendo le gambe con il fruscio delle gonne e del grembiulino scolastico: mi sgridava sempre, ammonendomi di smettere, poi lasciandomi vivere, dato che si rese conto che io, davvero, ferma non ci potevo stare.
La Sindrome delle gambe senza riposo è un malattia ancora piuttosto sconosciuta, pur se colpisce una discreta area della popolazione femminile europea. Alcuni anni fa feci delle ricerche su internet, ora no sono più così sicura di quello che sto per dire, ma allora lessi che non vi erano cure certe. Ho incontrato altre donne che come me soffrivano di questo disturbo che, credetemi, regala un malessere assurdo e mi sono accorta che diverse di esse neppure sapessero che il loro mal stare avesse un nome.
Parlando ultimamente con le mie figliole mi hanno detto che anche loro cominciano a soffrire di quegli inequivocabili sintomi e mi dispiace tanto per loro.
Io, finché non sono approdata a quelle benedette ma altrettanto velenose pastigliette, ho davvero tribolato molto, anche perché è impossibile dormire e, per assurdo, più ero stanca, più le mie gambe, una volta che provavo a coricarmi, ballavano. Intere notti ho passato a vagare per casa, semi addormentata e furente ed ora davvero senza quelle medicine non potrei sopravvivere, perché le ultime volte che per un motivo preciso ne ho dovuto sospendere la somministrazione, il sintomo durava giorno e notte e si era esteso anche alle braccia ed alle spalle. Nessun essere umano merita una tortura così e se, per una qualche ragione, dovessi rimanere senza la mia cura sono certa che cercherei la morte fino a quando, per quanto lei potesse ancora sfuggirmi, l'avrei definitivamente afferrata.
Continuando a parlare delle mie paure, ricordo le altre due piuttosto importanti di cui ho già narrato: la paura dei ragni e quella degli scorpioni.
Il terrore per i ragni durò a lungo, fin ben oltre il mio divenire adulta poi, piano piano si ridimensionò, aiutato anche dal fatto di andare a vivere in campagna: divenne ribrezzo, poi fastidio poi si trasformò in amore, quello che provo per tutte la creature animali e vegetali e quindi, ragni inclusi. Anzi, quando ebbi il negozio di animali e decisi di tenere anche i rettili e simili, acquistai una grossa tarantola, ma proprio grossa e la studiai con l'esatto rispetto ed amore che nutrivo per tutti gli altri. Devo dire che pure lei, a modo suo, dimostrava di riconoscermi e di accettarmi, a modo suo si può dire che mi voleva bene. Semplicemente andava ascoltata e capita.
Gli esseri umani si credono superiori a tutti gli animali e i vegetali, ma non è così.
Io ritengo che tra tutti gli esseri viventi che popolano questo povero pianeta, l'essere umano sia di gran lunga quello inferiore: basti a dirsi che tutti gli altri esseri vivono in equilibrio naturale tra loro e l'ambiente e nessuno, lasciato libero di vivere una vita non manipolata da noi ma gestita dai propri ritmi biologici, ha creato danni al pianeta. Mentre noi in cinquanta anni, e dico cinquanta anni, che sono davvero un'inezia nel confronto della vita di questo mondo, -se non vogliamo addirittura rapportarci all'universo - lo abbiamo praticamente avvelenato.
E penso che questo la dica tutta.
Il mio terrore per i ragni diventato poi amore mi ha portato persino a versare lacrime per uno di questi.
Quando vivevo nella mia roulotte, nell'estate 2007, proprio mentre stavo scrivendo quel diario che poi è diventato il mio libro Io non sono di qui, dato che passavo molte ora al computer, un giorno mi accorsi che all'angolo in alto a sinistra dello schermo, che era uno di quei vecchi scatoloni catodici, aveva attaccato il capo del suo filo di bava un minuscolo ragnetto, grosso meno di una capocchia di spillo, dalle zampette corte e di colore chiaro. Feci per scacciarlo od ucciderlo, in un gesto che purtroppo è naturale per moltissimi e che lo era anche per me, ma mi fermai in tempo. Mi immaginai in lui, così piccolo ed indifeso, immaginai il suo terrore nel vedere questa enorme cosa che si abbatteva su di lui, schiacciandolo miseramente. Sentii il suo grido di morte nel mio cuore e capii la mia inutile e crudele violenza. Pensai allora di metterlo fuori aiutandomi con un foglietto di carta, ma, guardandolo meglio, vidi che mi fissava.
Lo so che voi penserete a questo punto che io sono pazza, ma non mi importa.
Il ragnetto mi fissava, come a volermi dire: ' Buongiorno signora, desidera? ' e di nuovo lo immaginai modello casalinga, con il grembiulino e la scopa in mano, tutto intento a mettere a posto la sua casa.
Ma che diritto avevo io allora a spostarlo, a costringerlo a vivere in un altro luogo se lui proprio quello aveva eletto come sua abitazione? Non avevo nessun diritto e quindi decisi di lasciarlo stare, di permettergli di vivere dove aveva scelto e dove a lui, o lei, piaceva.
Gli misi anche un nome, lo chiamai: Picì, dato che proprio il mio pc gli era piaciuto così tanto.
Cominciò allora una lunga frequentazione: io e Picì divenimmo ottime amiche. Quando mi mettevo al pc, lei, perché io avevo deciso che era una lei, usciva dal minuscolo buchetto che era il suo nido, si spenzolava ad uno dei suoi fili di bava e stava lì, a guardare con me i colori dei miei giochi di bolle, palline e ranocchie, oppure si dondolava al suono della musica che sempre io ascoltavo, seguendone persino il ritmo con il suo sballonzolare sue e giù come un elastico vivente. Io le parlavo e le raccontavo delle mie ultime novità e devo dire che Picì era una ottima ascoltatrice.
Quando facevo le pulizie giornaliere stavo sempre molto attenta a non rompere la minuscola sua ragnatela e a non farle del male, così che i giorni passavano e la nostra amicizia diveniva sempre più intima: come mi sedevo al computer Picì correva fori a salutarmi e restava in mia compagnia finché io mi trattenevo vicino allo schermo. Ma tutte le cose belle hanno una fine ed io un brutto giorno, facendo un movimento improvviso, la schiacciai senza volerlo. Rimasi li, guardando quel minuscolo cadaverino ormai inanimato, divenuto fermo e spento per sempre, dispiaciuta e desolata di essere stata proprio io la causa della morte della mia piccola amica e ancora una volta ammaliata e spaventata dal mistero della morte e della vita: un attimo prima lei ' era ', un attimo dopo, contro il volere suo e mio, ma per un accadimento di quello che l'umana impotenza chiama fato, non era più. E silenziose lacrime scendevano dai miei occhi a causa della netta sensazione di aver perduto una amica. Infatti molto spesso mi sorpresi, nei giorni successivi, a cercare con gli occhi ma invano la piccola sagoma dondolante.
Si può amare un ragnetto? si.. si può amare tutto, in effetti nulla è così difficile né impossibile, a volerlo: sono riuscita ad amare oltre alle persone, animali piante e cose.
Forse, l'unica che non sono riuscita mai ad amare sono proprio io.....
La serie delle mie difficoltà, come ben vedo, è assai lunga anche se sto parlando dei problemi inerenti alla mia infanzia. Successivamente, come vi narrerò, si allungherà notevolmente di più. Ma ancora vorrei raccontare due particolari piuttosto importanti riguardo le mie manie e le mie paure, anche se sono certa che tornerò altre volte su questo.
Dato che avevo il terrore del buio e delle creature occulte della notte, dei film gialli e violenti in generale, spesso io e Carlo ci trovavamo in disaccordo sui film da andare a vedere.
Era nostra abitudine andare al cinema almeno una volta alla settimana e ogni tanto lui mi proponeva di scegliere un qualche film del terrore o simili, ma io mi rifiutavo categoricamente.
D'estate poi il problema aumentava perché, dato che nella nostra città c'erano diverse arene all'aperto, gradivamo assai tornare a vedere i film che più ci erano piaciuti durante gli anni precedenti o a vederne qualcuno che per caso ci fosse sfuggito e quindi, non dico tutte le sere ma quasi, eravamo nel grande spiazzo tra le case, che di certo una volta era stato un immenso giardino, dove erano disposte file di sedie di legno con la seduta reclinabile, - un po' scassate a dire il vero, - e ancora girava l'ometto con la cassettina dei dolciumi e dei gelati che noi, ovviamente, acquistavamo in gran quantità: andare al cinema senza sgranocchiare semi e succhiare ghiaccioli o liquirizia non era davvero la stessa cosa.
Quindi capitava assai spesso che, ripescate dal fondo si qualche baule di quinte - seste visioni, saltassero fuori film di pessimo gusto e tra loro qualche film del terrore, che allora era un filone che cominciava a farsi notare dal grande pubblico.
Ogni volta con lui erano discussioni. Stanca allora di negarmi sempre quando venne quella fatidica volta che mi trovai di fronte ad un suo interesse ancora maggiore del solito, cedetti ed acconsentii. Il film in questione era ' Le amanti di Dracula ' ed io feci dei patti molto chiari con Carlo: avrei guardato le parti tranquille della pellicola, per poi chiudere gli occhi quando ci fossero state le scene violente e cruente. Lui promise che così avremmo fatto e finalmente andammo.
Avevo 14 o 15 anni. Ci sedemmo a metà dall'arena, come nostra abitudine, nella fila distanziata da quella successiva per permettere il passaggio, in modo da non trovarci qualcuno troppo alto di fronte a noi e cominciò il film. Io già tremavo solo a guardare la presentazione e le pubblicità dei film che sarebbero andati in visione le sere successive, poi iniziò la narrazione vera e propria, - assai stupida ed insipida, a dire il vero – ma io stavo pronta a rintanarmi contro l'incavo della spalla di Carlo, nascondendo il volto tra le mani e cercando di tapparmi anche le orecchie, perché persino le grida e la musica che enfatizzava lo stato di paura mi disturbavano moltissimo. Seguendo infatti la musica ed il suo aumentare di tono e vibrazione mi accorsi che stava per iniziare di certo una scena cruenta e appena fui sicura che sarebbe stato proprio così, mi rifugiai tra le sue braccia, seppellendomi tutta per non vedere né sentire, le mani premute contro occhi ed orecchie e solo quando Carlo mi disse che la scena terrificante era finita rialzai la testa.
Guardai allora un altro spezzone e di nuovo l'aumentare della musica mi indicò che si stava avvicinando un altro punto cruciale: quindi mi rintanai di nuovo, tremando vistosamente, contro la sua capiente spalla. Ad un certo punto mi sembrò che il silenzio fosse tornato e che la quiete avesse ripreso a regnare e così chiesi a Carlo: ' E' finita, posso guardare? ' e lui mi rispose in modo affermativo. Alzai allora la testa ed aprii gli occhi proprio nel momento in cui sul grande schermo dell'arena, lui in persona, Dracula, il signore e padre di tutti i vampiri e di tutti i miei terrori, con la terribili fauci spalancate, i canini aguzzi gocciolanti sangue, ancora stava per gettarsi sul suo ferino pasto, mordendo la candida gola di una discinta e morente fanciulla.
Lì per lì la mia reazione non fu poi così violenta, mi limitai a gridare e a richiudere gli occhi, ma poi, ritornando a casa nel buio, mi sembrava di sentire passi dietro di noi e l'inquietudine e la paura stavano salendo di tono.
Inutile dirvi che feci una litigata memorabile con Carlo dandogli del vigliacco e affibbiandogli tutti i nomacci e gli improperi del mio vocabolario ma lui, quell'insensibile, era tutto contento ed orgoglioso della sua bravata e se la rideva spudoratamente.
Ci vollero molti mesi, quasi un anno o forse più perché io riuscissi a ritrovare un po' di serenità: nelle mie notti e nei momenti silenziosi quel viso orribile e quelle grida mi invadevano anima e corpo, gelandomi di un terrore paralizzante e solo dopo che ci sposammo e che cominciammo a dormire assieme riuscii a spegnere la luce.
Infatti stavo così sempre in uno tale stato di nervosismo e di agitazione che una volta, non so con precisione quando, ma credo la stessa estate del famigerato film, una notte che stavamo rientrando in casa, proprio mente gli giravo le spalle per aprire con la chiave il portone di ingresso del condominio, lui, silenziosamente, mi mise all'improvviso una mano sulla spalla sinistra, stringendola forte e mimò il gesto di mordermi sul collo.
Io sentii il sangue liquefarsi in tutte le mie vene, poi rapprendersi, vidi tutto nero, piegai le ginocchia e sarei di certo caduta, se non fosse stato che lui mi afferrò al volo.
E anche quella volta non so quanto piansi e quanto poi giacqui incapace di prendere sonno fin quando proprio non ero sfinita e naturalmente dormendo con la luce accesa.
Ma sopra tutto e tutti vi era una cosa che era la mia totale completa inalienabile fissazione.
Nella mia cameretta nel condominio, dove io stavo così bene e che era il mio regno, vi erano due luci: una al soffitto ed una lampadina sul comodino. La luce al soffitto, un lampadario in perfetto stile Modernariato come il resto dei mobili, acquistati nuovi nuovi quando ci recammo ad abitare lì, si accendeva da due punti con due scatole elettriche a levetta, uno all'ingresso della camera, sullo stipite della porta e l'altro sulla parete lungo la quale era appoggiato il mio letto. Erano due placche con due levette, messe probabilmente per accendere due serie di lampadine ed azionavano entrambe l'unica lampadina che invece aveva il lampadario. Accadeva così che se qualcun altro accendesse la luce in camera mia, - dato che io quando lo facevo stavo ben attenta - , che si potesse sfalsare l'ordine delle due levette e che quindi si trovassero una su ed una giù mentre io esigevo che con la luce spenta esse si trovassero tutte e quattro esattamente nella posizione di riposo. Quindi ogni qual volta che entravo in camera mia controllavo la situazione e, se trovavo le levette sfalsate, le azionavo accendendo la luce da un interruttore e spegnendola dall'altro finché l'equilibrio da me desiderato non si fosse ristabilito. E a volte accadeva che mi alzassi anche dal letto se mi accorgevo che ciò non era.
Io non parlai mai a nessuno di quella mia mania, devo dire che neppure ne ero cosciente. La ricordo perfettamente ma a me sembrava, allora, una cosa normalissima: quelle due levette dovevano stare così e basta.
Pochi anni fa, parlando con mia madre dei miei problemi psichici e psichiatrici, una volta lei ammise che forse avrebbero dovuto accorgersi che qualche cosa non andava in me perché mi disse che erano preoccupati della mia fissa per le levette in ordine.
Io restai di stucco: avevo creduto che nessuno se ne fosse mai accorto, anzi, non ci avevo neppure pensato più. Solo allora mi resi conto di quanti segnali di sofferenza io avessi dato e di come davvero non furono mai raccolti da nessuno, ad eccezione della cara professoressa delle medie.
E questo, oggi, mi procura ancora tanta tanta tristezza.
Quindi, anche in parte per quanto sopra descritto, io soffrivo intensamente di solitudine. Non riuscivo ad avere un rapporto soddisfacente con nessuno. Odiavo il mondo e la sua crudeltà
A dodici anni ingerii una intera confezione di Tavor di mia madre.
Mia madre stava malissimo, era dimagrita in modo notevole, dopo la recentissima morte di mio padre e faticava a dormire. Piangeva sempre e non vedeva più uno scopo della sua vita. Perciò si recò da un medico che le prescrisse quelle pillole.
Io ricordo che quel pomeriggio ero sola in casa e giunsi ad aprire il cassetto del suo comodino come in uno stato di trance. Non avevo le idee chiare ma sapevo solo che volevo andarmene da li. Così ingollai tutto il flacone. Poi, spaventata, chiamai proprio quella mia professoressa di italiano delle medie, che in quei giorni sentivo come l'unica persona che mi prestasse attenzione. Capì immediatamente cosa fosse successo ed arrivò di corsa. Mi fece del caffè e mi tenne sveglia per cui ne venni fuori. Lei non disse nulla a mia madre, nell'immediato. Provò ad accennarle, durante una udienza, dei mie problemi e sofferenze ma mia madre si ribellò. Le disse che aveva idee strane in testa e a me comandò di non frequentarla ed ascoltarla, che mi stava montando la testa.

CAPITOLO DECIMO
L'adolescenza: Carlo, il liceo la moto, il lavoro estivo, il collegio.
A dodici anni conobbi quello che divenne il mio primo ragazzo e poi il primo marito.
Non ero innamorata di lui ma lui lo era di me ed io mi sentivo tanto sola.
Quindi mi misi con lui.
Lui era molto presente ed affettuoso.. io avevo assolutamente bisogno di lui.
Ma la sua presenza non mi riempiva.
Fin da bambina piccolissima avevo sentito una forte attrazione per le donne, come vi ho raccontato.
Durante quegli anni avevo una vita onirica ad occhi aperti intensissima. Passavo ore ed ore, soprattutto la notte, vivendo storie, vite che mi narravo nella mente con tutti i particolari. In quelle vite io non ero una donna ma un uomo anche se di natura assai diversa dagli uomini che avevo incontrato. Ero io ma non ero la bambina o la giovinetta. Ero un essere assai più complesso che incentrava in se stesso sia la figura femminile che quella maschile dei miei sogni. Per fare un esempio rivivevo intensamente più volte una scena in cui, su di una carrozza aperta - tipo troica -tirata da cavalli, sotto la neve, io ero una bellissima fanciulla con accanto a me un aggraziato e dolcissimo cavaliere. Ma, nel momento preciso in cui colui si chinava su di me per darmi il primo agognato bacio, ecco che io diventavo lui ed ero io a baciare la bellissima fanciulla.
Ma questo pensiero non giunse mai a farsi consapevolezza.
È ben vero che fin da assai piccola di nascosto da tutti mi radevo il viso usando il pennello e la schiuma di mio padre e mimando nello specchio i suoi gesti.
E anche che molto spesso urinavo in piedi a cavalcioni del wc cercando di comportarmi come se avessi un pene, come è vero che ero un maschiaccio nel mio modo di comportarmi, chiassoso, poco elegante e scomposto – cosa che faceva impazzire mia madre - ma ciò non mi ha mai portato a non sentirmi donna. A non desiderare da sempre di avere bambini, di avere il seno, di essere amata come una donna.
Quindi il mio stato d'animo era assai confuso.
Vissi perciò con quel mio primo uomo tutte le tappe dell'emancipazione sessuale di una giovane donna, anche se alle spalle avevo una lunga serie di giochi erotici praticati con compagni di gioco e cugini.
Con lui ebbi il mio primo bacio, – a dodici anni - il primo petting - pochi mesi dopo - il primo rapporto completo – a quindici anni - ma le emozioni che provai furono assai blande ed incolori. Erano praticamente atti di autoerotismo.
Questa mancanza di un vero trasporto mi portò a lasciare quel ragazzo diverse volte, però il suo dolore e la mia acre solitudine mi riportarono sempre a cercarlo e riprenderlo con me.
Nel frattempo frequentai con grande facilità e successo le scuole medie, vivendole come una esperienza bellissima. Comincia a spaziare nelle mie letture e dai libri per ragazzi, che avevo letto e stra - letto nei suoi classici, passai a romanzi e soprattutto poesie. Alle medie lessi tutta l'opera di Quasimodo, Montale ed Ungaretti per poi accedere a Lorca e Jimenez.
Comincia anche il volontariato, andando tutti i giorni dalle orfanelle per aiutarle a fare i compiti. Volevo loro molto bene e regalai loro tutti i miei libri più infantili ed i miei balocchi, bambole ed altro.
Poi la domenica mattina andavo all'ospizio a trovare qualche vecchietta. Lo feci per anni.
Presi anche parte ad un gruppo di aiuto per ragazzi spastici, che aveva sede a Parma, creato da frati Saveriani. Mi recavo là in treno la domenica mattina e ne tornavo la sera.
Ma Carlo si sentiva messo da parte e questo mi portò poi ad abbandonare queste attività verso i sedici anni.
Mi allontanai dalla chiesa cattolica perché non ammetteva la vita sessuale fuori dal matrimonio e perchè non operava la povertà.
L'intenso amore mistico per Dio Padre e Gesù Cristo vissuto fin da piccolissima, assidua alle celebrazioni con profonda partecipazione emotiva, non implicò che non avessi un mio metro di giudizio totalmente personale. Non riuscii a ritenere che la vita sessuale di una persona fosse un peccato, in nessun momento della vita, anche prima del matrimonio.
Probabilmente l'esperienza atroce vissuta con il mio parroco e confessore mi aveva portato a pensare in quel modo, probabilmente era un mio modo per alleviare lui e me dai sensi di colpa. Ma anche sono certa che il mio personale codice morale sia stato sempre piuttosto chiaro e preciso in me: l'amore e quindi anche quello dei corpi, non era un peccato.
Inoltre le azioni e le parole del prete fecero in modo che si creasse in me un bisogno giornaliero di soddisfare le mie pulsioni, che da naturali divennero imperiose, perché il desiderio di quell'uomo era così marcio e profondo che mi aveva invaso e contagiato totalmente. E sempre avevo cercato i coetanei ed i cuginetti.
Quindi il conflitto tra il mio desiderio sessuale, che era impellente ed i veti della chiesa mi portarono ad allontanarmene definitivamente, quando entrai in quarta ginnasio.
Quanto segue in corsivo è un capitolo del mio terzo romanzo: ' Quello che non dico a nessuno'.
- Mi scuso se alcuni concetti o fatti vengono di nuovo ripresi nella narrazione ma ciò che state per leggere è stato scritto prima di questa biografia e con intenzioni diverse. Quindi spero che capirete e perdonerete alcune ripetizioni. -
IL PRIMO
Avevo 15 anni quando permisi a Carlo di entrare per la prima volta dentro di me.
Non era la passione che mi spingeva verso di lui, era un affetto molto profondo, ma fraterno, era il legame di sangue che ci inseguiva vita dopo vita lungo i secoli.
Io questo allora non lo avevo ben chiaro e mi era più comodo chiamarlo amore, ma in fondo sapevo benissimo che quello che provavo per lui era un'altra sensazione.
Però c'era la mia vita che mi spingeva tra le sue braccia, c'era la mia infanzia contrastata a contrastante, che sbocciava in un corpo di donna che mi andava così tanto stretto da cercare di allargarlo mangiando enormi quantità di dolciumi, sperando di addomesticare tutto quell'amaro con lo zucchero che mi si scioglieva voluttuosamente in bocca.
Le mani di un uomo adulto avevano colto i miei primi impulsi e avevano guidato le mie fantasie veloci e per nulla sopite verso vie dolorose e oscure.
Io sentivo qualcosa che non si atteneva a ciò che ci si aspettava da me: non ero una bambina come venivano dipinte le bambine nei bellissimi libri che leggevo, la notte, mentre tutti in casa dormivano.
Io mi sentivo un angelo con la carne, un angelo di amore per corpo, il mio corpo che viveva già, nonostante nessuno lo pensasse: scrissi più o meno questo in un mio diario dei dodici anni, un quaderno con la copertina ricoperta di cacofonici colori. Lo conservo ancora, quel quaderno, come molti altri dei miei anni passati, anche se purtroppo diversi li ho gettati via, misconoscendo persino a me stessa quello che io provavo, che era così diverso da quanto mi veniva raccontato in tale bella e compiuta forma e che era completamente dissimile da quanto mia madre cercava nei miei modi di fare senza trovarlo assolutamente.
Avevo poco più di tre anni il giorno che mi sorpresero a sbirciare curiosa nei pantaloni corti di un mio cuginetto più piccolo e fui redarguita aspramente che' quelle cose ' una bambina per bene non le avrebbe nemmeno dovuto pensare.
Io mi sentivo in tutto e per tutto una bambina per bene, non dicevo mai bugie ed obbedivo sempre, anche se spesso a malincuore: non facevo mai e poi mai una cosa che mi era stata vietata.
Ma quello che provavo, che cosa c'entrava quel sottile solletico in una parte di me che conoscevo assai poco, con le bugie? Con disubbidire alla mamma o al babbo?
Perché poi mi avevano sgridata con un'aria così preoccupata?
Ero troppo piccola per dare una risposta a questi enormi interrogativi, e reagii assecondando un'istintiva voce che mi era dentro da sempre: staccai il pensiero e il ricordo dalle azioni, creai due piani, due realtà che non comunicavano tra di loro, per dare la possibilità alla vita di crescere dentro di me e alla bambina di vivere con il sorriso delle persone a cui voleva bene.
Niente di più sbagliato.
Così accettai le carezze blasfeme del sacerdote che sporcò irrimediabilmente gli anni che dovevano essere i più belli della mia vita, i più spensierati e mi caricai di un dolore assai più grande delle mie piccole forze.
Ma la vita, nonostante tutto, ha i suoi sentieri che non vengono tracciati da nessuna mano umana e continuò a scavare dentro di me, portandomi avanti con lei
Mi venne insegnato che il mio corpo provava un desiderio così bello che però era chiamato: 'peccato'.
Come potevo non provarlo?
Non ci riuscivo.
Inoltre proprio l'amore era legato a quelle sensazioni, io lo sapevo già, perché quando guardavo alla televisione un bacio, allora assai casto, tra un uomo ed una donna, o uno sguardo intenso e passionale, io sentivo accendersi in me le medesime emozioni che venivano chiamate con quel brutto nome: peccato mortale.
Amare è uguale a morire?
Chiudere l'amore in stalli per bestiame era la via giusta? Solo tra un uomo e una donna, solo dopo una certa età, solo nel sacro vincolo del matrimonio, solo per mettere al mondo un figlio.
E io allora era preda di quel demonio, di quel serpente che vedevo schiacciato sotto il tallone scalzo della madre del figlio di quel dDo che mi veniva contrabbandato per buono e giusto?
Aveva dunque egli creato in me un mostro?
Quando io guardavo i due bellissimi attori che si baciavano sullo schermo della tivù o del cinemascope, io ero sempre lui che baciava lei, io ero quella mano che la prendeva alla nuca allargando le dita tra i suoi capelli, che la attraeva a sé guardandola intensamente, io ero quelle labbra che conducevano quella danza che non avevo mai provato ma che sentivo di conoscere fino in fondo.
La notte abbracciavo il mio orso di pezza a immaginavo, sognavo ad occhi aperti, di baciare una bellissima principessa mentre su di una slitta tirata da cavalli fumanti nello sforzo, come nel film ' Il dottor Zivago ', la neve cadeva lenta e intensa su di noi; sentivo il corpo di lei abbandonarsi e fremere tra le mie braccia, sentivo il suo respiro profumato invadermi i polmoni in fiamme.
Poi mi scuotevo dal mio sogno e mi dicevo che stavo sbagliando, che io ero lei. Riprendevo allora il filo della mia fantasia e mi perdevo nei particolari della foresta incantata che correva attorno a me, nel rumore degli zoccoli che battevano contro il ghiaccio indurito, nel suonare dei piccoli campanelli attaccati agli odorosi finimenti, per poi scivolare di nuovo nella estatica sensazione di guardare quel volto pallido ed acceso, il mio volto pallido ed acceso, come se mi staccassi da me e guardassi me stessa attrice ed attore nei due personaggi.
Premevo le labbra sul cuscino e sentivo la stoffa di cotone riscaldata dal mio fiato aggredire l'interno delle mie labbra, così sensibile e sempre avido di contatti, sentivo una mano entrare nelle mie viscere, afferrarle e stringerle forte, attorcigliarle su loro stesse e tentare di strapparle da me.
Quello era l'amore, lo sapevo, lo conoscevo, ma ugualmente sentivo che il cuore, il famoso cuore con cui faceva rima, non c'entrava nulla con esso.
Si, il cuore accelerava i suoi battiti fino a farmi male, ma l'amore si depositava altrove e svegliava altri muscoli di me, quelli che erano celati nel profondo, tra le mie gambe.
Fu sempre il sacerdote a suggerirmi i movimenti da fare con la mano e me li descrisse così bene perché io capissi fino in fondo cosa NON dovevo fare, quei movimenti che soli riuscivano a portare a compimento quello strano struggimento di carne, che soli dissetavano, anche se per poche ore, quella forte arsura che era sete di acqua creata dal fuoco, proprio lì, dove non si doveva guardare, dove non si doveva toccare, nel luogo di noi di cui non di doveva parlare, che non si doveva neppure sentire.
Ma, oh, quando sentii per la prima volta quell'acuto brivido di diapason sotto le mie dita incerte ma sicure, incontrai il bene più bello che avessi assaggiato fino ad allora.
Avevo sette o forse otto anni, non di più, ero uno scalmanato ragazzaccio con gli occhi tristi, con addosso un vestito ed un golfino che non erano i suoi, ma sembravano presi in prestito da qualcuno totalmente diverso da lui, un vestito sollevato su due gambe forti e muscolose imprigionate in calzini bianchi traforati che scendevano alle caviglie nei movimenti del gioco e si sporcavano di terra ed erba.
Era il bello più bello che avessi mai visto quel buio coloratissimo e luminoso dietro alle mie palpebre serrate con forza su occhi che non distinguevano nulla ma portavano ugualmente alla mente visioni prive di una forma conosciuta.
Vidi per la prima volta il viso del piacere ed era così lucente da non poterlo descrivere ed era così sbagliato da non poterlo capire.
Tristissima di essere così felice, di sentirmi così completa, portai le mie dita un po' umide alle mie labbra ed assaggiai il mio sapore, ascoltai quell'odore che già riconoscevo in maniera istintiva come radice unica di un piacere che era veicolo di forze molto maggiori di quelle della mia volontà.
Quel gesto misterioso divenne un rito sotterraneo e talmente privato che neppure lo confessavo a me stessa, divenne un appuntamento con una parte di me che non doveva neppure esistere.
Fu quel piacere a portarmi a maturare la prima scelta effettiva della mia vita: mi chiesi se potevo io provare in modo così imperioso una emozione sbagliata e decisi che erano le regole imposte ad essere sbagliate.
Amavo così tanto quel Dio che non potevo più sentirmi la traditrice di quel forte amore nel non seguire i suoi dettami: così decisi che quel Dio non esisteva affatto, lasciandomi orfana dell'unico padre che mi era rimasto.
Avevo quattordici anni e, dopo aver passato intere notti ad arrovellarmi sulla mia mancanza di onestà nei confronti di colui che io sentivo degno di ogni rettitudine, dopo aver vissuto il giorno della confessione e della comunione in chiesa con la certezza di offendere la stessa matrice della mia esistenza con il mio comportamento peccaminoso, divisa tra la mia realtà e una legge che mi veniva imposta, scelsi la mia realtà ed abbandonai la religione cattolica, che era stata fonte di intensa meraviglia e di forte impulso spirituale.
Frequentare di già il ginnasio permetteva di cominciare ad affermare la propria volontà.
Avevo letto tanti libri che parlavano dell'amore, della poesia dell'amore, dell'intensità dell'amore. Avevo studiato versi in cui quello che io provavo tra le gambe veniva traslato in una dimensione totalmente incorporea.
Avevo ascoltato parole che narravano di brividi assolutamente non corrispondenti ai miei: io non riuscivo ad amare fuori dal mio corpo, solo nella mia mente, non potevo neppure immaginare come si facesse.
E allo stesso modo non mi riusciva di provare quel trasporto guardando il viso di un ragazzo o un uomo, ma sempre e comunque erano i volti delle mie amiche a sciogliermi il sangue e ad accelerare il mio respiro.
Ma come potevo riconoscere quello che sentivo se in nessun libro era narrato, in nessun verso cantato?
L'amore era solo tra un uomo ed una donna.
Carlo si innamorò di me, eravamo due adolescenti soli, forse due bambini soli.
Io sentivo uno spasimo continuo di contatti, di carezze ed abbracci, sentivo un vuoto che non aveva mai fondo.
Il suo sguardo ingenuo ed aperto esprimeva in parte quell'ardore che io avevo visto negli occhi degli attori innamorati o sulle pagine dei fotoromanzi rosa che leggeva mia zia. Mia madre non voleva che io li leggessi, ma spesso la zia li dimenticava aperti sul tavolo della cucina, così io scorrevo alcune pagine di quelle storie melense e stupide, nelle quali uomini e donne si rincorrevano come mosche attratte dal miele.
Veramente a me Carlo sembrava più un pesce lesso e non aveva certo il fascino sornione di Clarck Gable, ma comunque era lì, era per me ed io sentivo una profonda tenerezza per lui.
Avevo dodici anni quando mi baciò per la prima volta. Stavamo ballando in una festa estiva di paese e l'orchestrina sul palco rialzato ci dava dentro con i fiati le chitarre e la batteria, per divertire tutta quella gente a cui le gambe fremevano.
Io indossavo un fresco abito di cotone lungo fino ai piedi, secondo la moda di allora, bianco con piccoli disegni blu, come un arabesco.
La mia zazzera corta e voluminosa era ramata e lucida, gli occhi dietro le spesse lenti, accesi.
Sentivo che quella sarebbe stata una serata speciale per me ed ero molto emozionata. Mi sembrava di aver un appuntamento importante col mio destino e non mi sbagliavo: Carlo divenne poi il mio primo marito.
Ballammo qualche svelto, così, lui era goffo, ma cercava di fare il disinvolto, io mi divertivo a provocarlo. Ero ancora snella, ero bella, molto e quella sera lo sapevo, nonostante di solito non me ne accorgessi mai.
Sentivo i suoi occhi sorridenti passare dal mio viso al mio seno, ai miei fianchi.
Quella fu la prima volta che pensai di essere desiderabile. Il ragazzaccio scarmigliato quella sera dormiva e al suo posto una ragazzina maliziosa si godeva la festa, la musica e il fresco della sera di giugno. Era il 1967.
All'improvviso il ritmo di twist si spense e le note rallentarono.
Alcuni abbandonarono la pista, andandosi a sedere sulle sedie disposte ai bordi ma tutte le coppie si allacciarono e presero a dondolarsi al ritmo lento.
Io non avevo mai ballato un cheeck to cheeck fino ad allora e penso neppure Carlo: ci guardammo un attimo sospesi, poi lui fece un cenno ed io volai tra le sue braccia. Attorno a noi i ragazzi già si stringevano alle loro ballerine e qualche coppia si baciava già.
Era usanza che la pista da ballo fosse una specie di zona franca, nella quale era permesso scambiarsi le effusioni che allora per strada erano del tutto non abituali, così i fidanzatini e i morosini approfittavano largamente dell'occasione, incollando le bocche sulle bocche come volessero mangiarsi.
Mi guardai in giro e sentii tutte quelle bocche sulla mia.
Avevo favoleggiato a lungo sul mio primo bacio, lo avevo girato in filmoni mitici dell'immaginazione, con scene di interminabili rallentì.
Il tempo nel quale le labbra di lui si avvicinavano alle mie per poi sfiorarle era immenso e mentre io attendevo quel tocco magico e prezioso, che mai più si sarebbe ripresentato in tutta la mia vita, assaporavo una vasta serie di emozioni e pensieri contrastanti tra il desiderio, la paura, l'eccitazione, la tenerezza, la voglia di fuggire, la curiosità.
Quando Carlo mi cinse la vita io gli allacciai le braccia dietro il collo, con una studiata mossa cinematografica. I nostri corpi però erano ancora lontani.
Ballammo su di una sola mattonella, con piccoli passi brevi, dondolando i fianchi.
Lui mi strinse a sé, facendosi coraggio: entrambi guardavamo le altre coppie che, vicinissime, tutte ormai si baciavano con passione. Sentivamo i loro respiri un po' affannosi ed i rumori sordi e un poco liquidi di quelle bocche fuse insieme.
Carlo mi strinse più decisamente a sé ed io mi appoggiai interamente a lui. Anche quella era una mia prima volta, non avevo mai assaggiato con le mie forme il corpo di un ragazzo.
Appoggiò la sua guancia contro la mia: era una guancia non più imberbe ma non certamente virile e la sua carnagione chiarissima coperta di efelidi lo rendeva un eterno lattante. Gli occhi azzurri cerulei erano tondi come quelli di un gatto.
Sentivo l'odore del suo dopobarba, probabilmente sottratto al padre, di cui si era abbondantemente annaffiato.
Erano già diversi mesi che ci vedevamo tutti i pomeriggi dopo la scuola: ci trovavamo in parrocchia dove ci eravamo conosciuti e giocavamo a ping pong o o bigliardino. Io parlavo tanto e Carlo mi ascoltava attentamente, lui guidava la sua vespa rossa - aveva tre anni più di me e già il patentino - ed io mi allacciavo alla sua vita con le braccia.
La nostra piccola città non aveva segreti per noi ed ogni via, ogni angolo si colorava del nostro passaggio chiassoso. Lui aveva una nuvola di capelli rosso carota, io un aspetto da maschiaccio: chi poteva non ricordarsi di noi?
E pensare che all'inizio a me piaceva il suo amico Ferruccio e lui faceva una discreta corte alla mia amica Sandra
Con il pretesto di farli conoscere meglio, io conducevo Sandra nei luoghi dove sapevo si sarebbero incontrati e lui portava sempre con sé Ferruccio perché desiderava ricambiarmi il favore. Ma ud un certo momento mi accorsi che la presenza dei nostri amici non ci era più necessaria. Carlo prese a guardarmi in uno strano modo, a divenire un po' più riservato e timido, ad arrossire facilmente, io cominciai a sentirmi sola senza di lui, a desiderare di vederlo, di parlargli, di specchiarmi nel suo sorriso immediato.
Per Caro io ero una gemma luminosa: gli piaceva tutto quello che dicevo o facevo, mi accondiscendeva in tutto, mi viziava, portandomi piccoli ingenui regali.
Io non ero abituata a tanto apprezzamento, anzi, piuttosto era il contrario, mi sentivo sempre contrastata e inadeguata.
Carlo cominciò a scrivermi bigliettini con cuori trafitti e stelle, io mi sentivo in dovere di raccontargli ogni mio pensiero, o quasi. Restava sempre il pensare sotterraneo che scorreva in modo parallelo al flusso superficiale delle parole.
Sapevo che si era innamorato di me, anche se non me lo aveva detto apertamente: allora la parola amore era rivestita ancora di un alone di mistero e di rispetto, era un cappello da mago del quale non si conosceva la capienza.
Quella sera mentre ballavamo lui diventò padrone dei suoi sentimenti e li depose sulla mia guancia con un piccolo bacio a labbra chiuse.
Chissà, mi chiedevo con il fiato sospeso, se i suoi compagni più grandi di gioco o di scuola gli avevano insegnato come muovere la bocca per baciare, gli avevano raccontato i segreti del bacio alla francese, gli avevano spiegato come fare per toccarmi il seno senza che io gli mollassi uno schiaffo.
Ma Carlo non seguì alcuna regola e lo sentii sprofondare nel pieno delle sue forti emozioni. Io restavo a guardarlo al balcone dell'attesa del mio primo bacio, che sapevo sarebbe arrivato proprio quella sera.
Dopo avermi posato altri piccoli baci sulle guance e vicino alle orecchie sentii che stava cercando il coraggio per osare di più e in preda alla mia impazienza voltai verso di lui il viso proprio mentre lui muoveva le sue labbra verso le mie e fu così che esse si sfiorarono per un attimo, prima che lui si ritraesse e mi stringesse forte a sé.
Avevo ricevuto il mio primo bacio e non avrei mai più e mai più ricevuto un secondo primo bacio. Ma la musica dei violini che sentivo nei sogni ad occhi aperti lì era sostituita da quella della fisarmonica, non ci fu nessuno sguardo intenso e prolungato né alcun sospensione interminabile del tempo.
Ancora una volta quello che io provavo non aveva trovato riscontro nella realtà.
Passarono tre anni durante i quali i nostri baci divennero profondi e lunghi, le nostre mani smaniose e sfrontate e scoprimmo tra i nostri vestiti, in piedi contro qualche porta o muro compiacente, il piacere di darci il piacere, pensando l'una al corpo dell'altro.
Era un bel modo di amarsi, immediato e impulsivo, facile e poco compromettente.
Sempre, lui mi si appoggiava addosso ed io sentivo il rigonfio del suo maschietto che premeva contro il mio basso ventre.
La primavera risvegliava i nostri desideri ormai sicuri di loro stessi.
Eravamo un gruppo di amici di scuola e, anche se Carlo frequentava un istituto, era però ben accetto da noi ginnasiali. Eravamo ancora tutti vergini. Correva il 1970 e la rivolta studentesca infuriava, vedendoci impegnati entrambi in prima linea.
La parola ' amore libero ' era di uso comune e a ping pong non si giocava più in parrocchia ma nella piccola sede dell'associazione Italia - Cina, dove un bel tavolo sportivo era messo a disposizione di chi, come noi, avesse voluto restringere i confini di questo pianeta.
Anche i miei amici erano in coppia e si parlava di baci, di rivoluzione, si cantava suonando la chitarra, si stampavano ciclostilati, si favoleggiava di metodi anticoncezionali.
Io e Carlo eravamo l'avanguardia della libertà sessuale con le nostre pratiche più disinvolte, mentre gli altri si erano fino a quel momento limitati ai baci.
Egli cominciò a dirmi che avessi voluto fare l'amore ' sul serio ' con lui, ne sarebbe stato felice.
Io ero scossa da un desiderio continuo di provare e riprovare quel brivido di piacere che mi dava gioia: non era il corpo di lui che mi risvegliava, ma il mio che risvegliava se stesso.
Sapevo che volevo provare quella emozione di cui parlavano tutti e mi batteva il cuore nell'immaginarla: ma ai sogni romantici che avevo fatto sul mio primo bacio, ora l'avvicinarsi al primo rapporto completo era come un distintivo rivoluzionario, esattamente come fumare sigarette, che io trovavo solamente sgradevoli e puzzolenti, o bere whisky di marca scadente.
I genitori di Carlo avevano una casetta in collina, abitata da una famiglia di piccoli contadini che tenevano qualche gallina e una vigna di vino rosso. Nella stanza riservata alle mangiate pantagrueliche di piadina e maiale ai ferri, annaffiate da abbondanti libagioni, c'era un camino rustico e un vecchio divano di fianco al tavolo molto semplice al quale stavano appoggiate sedie impagliate. Era maggio, ma quel pomeriggio pioveva. Noi, incuranti, sulla fedele vespa arrivammo fin lassù e ci facemmo accendere il fuoco dalla contadina, che era nostra amica e nostra complice: i suoi occhi ammiccavano maliziosi, come se leggesse apertamente le nostre intenzioni.
Dopo averci servito una merenda di pane prosciutto e vino, se ne andò adducendo la scusa di certi suoi mestieri e, mentre usciva dalla stanza tirandosi dietro la porta, cogliemmo il suo sorriso complice e tenero: sicuramente stava ricordando la ' sua ' prima volta.
Non ci furono grandi discorsi tra noi, né dichiarazioni: il vino mi faceva girare la testa, il resto lo fece la primavera.
Quando, sdraiati su delle coperte stese davanti alla fiamma ardente, tolti i vestiti bagnati e rischiarati solo dalla luce del fuoco, Carlo mi fu sopra e spinse il suo membro eretto contro di me, io allargai le gambe e chiusi ancora di più gli occhi: la mia verginità era come un peso di cui liberarsi prima possibile, era come il retaggio di una società ormai superata e vinta; sconfiggerla sarebbe stato come liberarci da vincoli ancestrali.
Io volevo, ma la magia dei sogni non era neppure entrata con me in quella stanza oscurata.
La sua erezione si ammorbidì un po' mentre, emozionato, cercava di penetrare una donna per la prima volta nella sua vita: egli mi aveva precedentemente toccato sul bottoncino sapiente ed io stavo desiderando quella pace che mi portava sempre il culmine del piacere ma quando, dopo un po' di tentativi maldestri ,riuscì a penetrarmi con la prima parte del suo membro, l'eccitazione che sentivo sparì completamente.
Percepivo il suo corpo pesare sul mio, capivo che lui stava vivendo una forte e magica emozione, ma io non provavo nulla, ma nulla dentro di me, neppure il tanto proclamato dolore della deflorazione. Non una goccia di sangue, non una goccia di fluidi dalle mie mucose interne secche e immobili: ascoltavo il suo respiro concitato aspettando il suo orgasmo che venne in poco tempo.
Lui gemette lievemente, si fermò, si rilassò e si staccò da me: ecco, avevo fatto l'amore per la mia prima volta. Lui si sollevò un po' per guardarmi e commosso e raggiante mi chiese se mi fosse piaciuto: io gli risposi sorridendo, con la più grande delusione stretta nella mia gola: ' Sì, tantissimo, amore. '
L'ingresso alle scuole superiori fu bellissimo. Adoravo andare a scuola: era tutta la mia vita. Entrai immediatamente a far parte del movimento studentesco diventandone un leader. Questo durò per tutti i cinque anni di frequenza al liceo classico. Vicepresidente dell'assemblea, relatrice sempre in primo piano in oggi occasione, organizzatrice di manifestazioni, occupazioni ed attività varie, militai nel Manifesto per un po' ed andavo a giocare a ping pong, abbandonato l'oratorio, all'associazione Italia Cina
Cercai di imparare a fumare, come facevano tutti, ma vomitavo e tossivo. Non ci riuscii mai e neppure potevo bere, per la stessa ragione: il mio stomaco non accettava nulla di simile. Ma mangiavo moltissimo, soprattutto dolci, dato che avevo denaro mio. - Fin dalla prima elementare, infatti, ho ricevuto una paghetta settimanale che ho usato per comprarmi libri e dolci, il mio cibo.. -
Con il mio ragazzo ogni giorno erano abbuffate, lui pure piuttosto goloso ed assai più pingue di me. Così cominciai ad ingrassare: allora pesavo circa 65 / 70 chili per un'altezza di 165 centimetri ma ero assai muscolosa. Il mio sviluppo era stato piuttosto precoce e a dodici anni ero già formata. Non potevo di certo venir definita ' grassa ' ma mia madre mi torturava continuamente, vedendomi obesa.
Il nostro rapporto era sempre più teso e difficile. Allora più che mai nulla di quanto io facessi le andava bene e ogni cosa la dovevo strappare con lunghe insistenze.
A quindici anni cominciai a cucinare io: detestavo i lavori domestici e così lei, oberata dall'impegno del negozio, mi consegnò la conduzione della cucina, tenendo per sé le pulizie. Cucinare mi piacque subito e mi rivelai un'ottima cuoca, non avendo bisogno di sue dirette lezioni ma solo di indicazioni per le dosi. L'avevo guardata per anni tirare la sfoglia, preparare il soffritto, il ragù, la crema pasticciera, l'arrosto, le frittate, il minestrone di verdura e tutto il resto, non avevo bisogno che mi spiegasse come fare: le regole della buona cucina romagnola le avevo assorbite insieme all'aria ed all'acqua, crescendo.
A quattordici anni, dopo lunghissime insistenze, ebbi il mio primo motorino: un Guzzi Dingo a tre marce a mano; Carlo aveva la sua Vespa ed altri amici miei più grandi d'età avevano già ricevuto il loro primo mezzo a due ruote. Io smaniavo in un modo incredibile per averne uno tutto mio e tanto dissi e feci che alla fine mia madre acconsentì e mi anticipò il denaro di quel fantasmagorico regalo di compleanno: costava quarantacinquemila lire ed io glieli restituii con lo stipendio della mia prima estate lavorativa, prestando la mia opera per due mesi, dopo la chiusura della scuola, in un magazzino per lo smistamento della frutta. L'economia era fiorente e si trovava lavoro facilmente.
Lavorai ogni estate della mia gioventù e percepii anche per tutti i miei anni scolastici una borsa di studio, ottenuta con le mie alte votazioni. Il denaro venne dato sempre a mia madre che però, ripeto, non me ne fece mai mancare per le mie spese personali, che gestivo autonomamente.
E a proposito delle mie estati lavorative di seguito, in corsivo, potrete leggere una delle novelle di Kaiki che racconta una particolare esperienza.
LA COLONIA AL MARE
Da ragazza, ho lavorato per due estati n una colonia di una cittadina del mare Adriatico, un’accoglienza per bimbi della piccola borghesia padana e che a volte ne prendeva presso di sé, gratuitamente, con pretta pietosa mancanza di pietà, alcuni bimbi poveri provenienti dal sud Italia, molti dei quali già lavoravano come braccianti agricoli nei campi dei grandi proprietari terrieri, che non avevano scrupoli ad impiegarli nonostante la loro tenera età, oppure negli orti di genitori e parenti che, essi stessi, conducevano una esistenza assai dura..
Erano gli anni’71 e ’72..
Allora la differenza tra il sud e il nord del nostro paese era più profonda e palpabile di ora ed io, che non conoscevo nulla di persona su questo problema se non quello che avevo letto sul ‘Manifesto’ o sui bollettini vari degli scioperi della rivolta studentesca, quando venni in contatto con quei bimbi, mi resi conto, stupita, di quanto davvero la loro vita fosse assai diversa dalla nostra..
Anzi, ripensandoci proprio oggi, dopo chissà quanto tempo che non lo facevo, sepolta dalle macerie di tutto quello che è crollato dopo, sopra questo mio vissuto, ricordo bene la colonia in questione, che aveva un anonimo nome tipo ‘ Stella marina ‘, - o qualcosa del genere - ed era una struttura che ospitava bambini di ceto medio - povero, ma ancora dignitoso, provenienti dalle cittadine della bassa padana lontane dal mare, come Parma o Reggio Emilia e aveva dedicato del grande edificio un po’ scrostato dalla salsedine, di colore giallino e circondato da un cortile ghiaioso punteggiato e ombreggiato di alti pini marittimi dal largo frondoso e odoroso ombrello, una dependance più piccola e bassa ai bambini poveri, ma poveri davvero, di un paesino interno del nostro profondo sud, di cui proprio ora non riesco più a rammentare il nome.
Io passai il primo turno del primo anno di questa mia esperienza lavorativa, con un gruppo di bimbetti maschi emiliani, coi quali mi sentivo più in sintonia nel dividere giochi ed interessi rispetto alle loro coetanee femminucce, ma li trovavo viziati, annoiati, incontentabili e meditavo di andarmene, perché quel lavoro non mi piaceva, mi annoiava e, inoltre, la cucina lasciava alquanto a desiderare.
C’era poi anche da dire che io, spirito libero e ribelle, poco mi adattavo a ‘ mantenere la ' disciplina’, imponendogliela, a quei poverelli già pieni di complessi e di difficoltà personali e quindi, dato che non riuscivo a trovare nessun dialogo con loro e neppure ad imporre la mia autorità, che non sentivo affatto di possedere sui loro visetti impertinenti ma in un certo qual modo sofferenti e disadattati, questo faceva del mio gruppo il peggiore di tutta la colonia, così che la direttrice mi chiamava spesso nel suo grande ufficio di fianco al refettorio, che sembrava tanto un’aula scolastica deserta, per redarguirmi o spronarmi a fare meglio, cosa che inevitabilmente non mi riusciva.
All’inizio del secondo turno mente il primo, fatte su le poche cose, magliette, calzetti e ciabattine o zoccoletti, se ne tornava pieno di giubilo tra le braccia amorose o meno dei loro ‘ mamma e papà’, arrivò questo nutrito gruppetto di ragazzacci e femminucce chiassosi ed esuberanti, che parlavano con un accento a noi assai straniero: anzi alcuni di loro non parlavano neppure italiano ma soltanto il loro idioma dialettale..
Arrivarono, scendendo dallo scalcinato pullman di linea che li aveva trasportati sin lì nel loro primo, unico lunghissimo viaggio intrapreso fino ad allora e scesero come una torma rumorosa e frullante d’ali che si stiracchiavano, tutti compatti, occhi scuri lucidissimi, pelli scure e ambrate dal sole con, come bagaglio, i soli abiti che portavano addosso, in una confusionaria, stinta, stropicciata macchia semovente multicolore.
Ma di un particolare, inatteso, erano colmi!
I pidocchi pullulavano tra i loro neri riccetti e le scure trecce femminili, lunghe fino ai fianchi, di capelli che mai erano stati tagliati dalla nascita.
L’allarme scoppiò come una bomba in tutta la struttura, tra esclamazioni a stento soffocate, piene di disgusto, del personale scelto per accoglierli e così, in un attimo, quei piccoli merli diventarono sparuti passerotti, chiusi tutti insieme, - che se avessero potuto li avrebbero ‘legati’ tutti insieme, - dentro il refettorio sprangato della dependance, soli.
Fuori il resto delle ’signorine‘ accoglieva i nuovi gruppi di urbani bambini, zittiti e spauriti, alcuni già piangenti, che chiamavano la mamma.
Signorine venivamo chiamate allora noi assistenti, scelte esclusivamente per il nostro aver accettato paghe esigue e trattamento senza pause e diritti, perché ci veniva chiesto di trascorrere tutta l’estate senza mai un po’ di riposo, notte e giorno, ad eccetto di uno solo dì tra un turno e l’altro, dormendo nelle camerate dei bimbi, divise e protette esclusivamente da una tendina di cotone e condividendo i – poveri - pasti con loro, senza che nessuna di noi avesse una preparazione specifica alla pedagogia, ma tutte affidandoci alla nostra buona volontà e inventiva, che alla fine diventava puro spirito di sopravvivenza.
Invece il gruppo delle addette a risolvere l’inatteso quanto fastidioso problema degli ‘altri’ bambini, era animato da accese discussioni.
Io allora, guardai il grappolo di femminucce che mi era stato assegnato, graziose nelle loro nuove magliette multicolori, prima di venir unificate nella ‘divisa’ che avremmo poi loro assegnato: vedendole chiacchierare a bassa voce, guardandosi intorno con occhi già pieni di ancora non inespresse pretese, sentii il mio cuore volare tra quegli occhi scuri, selvatici, pulsanti, che erano stati rinchiusi senza colpa e già reietti, dal resto della loro temporanea comunità..
Così mi recai di corsa dalla direttrice, affidando alla collega più vicina le ‘mie’ bimbe in attesa di salire in camerata per disfare le loro valigette di plastica con Minnie e Paperina dipinte sopra, chiedendole di assegnarmi un gruppo di quei ‘ maschi’ pidocchiosi e vivacissimi.
Ella mi guardò, scura in volto, per un attimo stupita, poi nella sua scaltra mente fece due più due, capì tutto e mi spedì col il resto del personale che già stava indossando cuffie e guanti, pronto, se pur assolutamente controvoglia, ad affrontare il POBLEMA vivente di quel bimbi ‘ alati’….
Diedero anche a me un camice bianco, cuffia, guanti e una tosatrice elettrica per capelli con l’ordine di: “ Andare, tosare a zero tutti, maschi e femmine, spogliarli dei loro abiti che ammucchiati, sarebbero poi stati bruciati, lavarli ovunque energicamente con spazzole non proprio delicate, rivestirli con le divise usate del turno precedente e portarli finalmente a mangiare e bere, poi a dormire nelle loro camerate, una per tutti i maschi, quasi una trentina, una per le femmine, assai di meno di numero.”
Entrammo allora, così armate e paludate come dottoresse ignote ed estranee, nel refettorio-lager e fummo accolte da esclamazioni di stupore e diffidenza da quegli occhi mobili ed attenti, diventati torvi e introversi.
La fase dalla tosatura fu la più difficile, soprattutto per le bambine che mai avevano ricevuto quell’onta e che, sentendosi private dell’immagine della loro femminilità, piangevano disperatamente, arrabbiate, snocciolando lunghe serie di anatemi a noi incomprensibili, tra le crisi di prurito isterico che sconvolgevano l’una dopo l’altra le ben nutrite ed educate signorine della mia età, non avvezze a quel contatto ‘impuro’.
Io, amante di tutti gli animali, delle formiche e delle api, dei maggiolini e delle coccinelle, delle lucertole, dei topolini, delle piccole serpi dei nostri fossi, non nutrivo alcun problema verso quelle bestioline, si fastidiose ma sicuramente desinate al genocidio e quindi mi prodigavo alacremente per tosare più testoline possibile, cercando facezie ed imparando subito le loro esclamazioni dialettali, chiamandoli a me con quelle stesse loro parole rinfrancanti, finché non mi trovai circondata da una frotta di uccellini che mi dicevano: “ Signurì, ammè, ammè!” sorridendo, alcuni sdentati nel cambio dei dentini da latte, altri, i più grandi, con già l’innata deferenza verso la figura femminile mista al sentimento di comando, che orgoglioso reprimeva paura e smarrimento in frasi sboccate e parole ‘da grandi’, delle quali io non capivo l’esatto significato ma intuivo la sostanza a sfondo sessuale e malizioso.
Finita la tosatura di quel gregge a due gambe, le femminucce ,tremanti e ancora sotto shock che si passavano la mano incredula sulla rasa piccola rotondità del proprio cranio, lanciando sguardi colmi di sofferenza e rimpianto per le loro belle trecce corvine e crespe gettate a terra come un mucchio di scalpi, furono portate in un bagno a parte e lavate da altre due mie colleghe che continuavano a disperarsi per la loro propria capigliatura, programmando immediate e prolungate abluzioni con aceto caldo o shampoo antiparassitario di farmacia, mentre io accompagnai, insieme ad una delle cuoche, una donna robusta e taciturna di origini meridionali anch’essa, nel bagno più grande la ‘mia’ torma ridacchiante, nuda come piccoli vermini bruni di terra, magri, alcuni addirittura ossuti, ma forti ed avvezzi alla fatica, dei quali nessuno copriva con le mani le proprie parti intime, come mi sarei aspettata, ma reagendo con infantili quanto già consce erezioni spontanee, che venivano esibite con orgoglio prettamente maschilista di una prematura ma già dichiarata supremazia del loro apparato genitale, il tutto accompagnato da risa, motti sguaiati e spalle dritte di dignità ed orgoglio.
La pelle delle loro infantili membra, abituate di certo più all’acqua piovana o di fossi e torrenti che a quella della doccia e di quel sapone forte e maleodorante, disinfettante ed antiparassitario, si arrossava al contatto di quella poco gentile brusca, ma nessuno protestava e si giravano docilmente, alzando braccia e gambe, impudici, sfidandomi ad affrontare le loro orgogliose nudità per poi arrendersi ai dolci massaggi delle mie mani che, abbandonato lo sgraziato violento strumento, ammorbidiva lo sporco incrostato dall’abitudine di vite selvatiche ma vive e dignitose, che era la loro protezione naturale al sole troppo caldo delle loro pianure assetate e all’aggressione degli insetti ematofagi, come pulci, zecche e zanzare.
Alla fine di un faticoso quanto inedito pomeriggio di lavoro, con le loro risa e sgomenti mascherati da orgoglio, rivestiti tutti, maschi e femmine, di magliette bianche e calzoncini blu recanti i segni del passato turno, fu data loro una cena, abbondante per fortuna, che, ormai stanchissimi ma affamati, spolverarono in fretta, usando velocemente le mani.
Spezzavano il pane con gesti antichi di ammirazione e rispetto che credevano nella sua divina gratificante natura e annaffiavano la loro sete e arsura provocata dall’infame sapone che li aveva grattati in profondità, con caraffe di acqua dolce e fresca, lievemente ferruginosa e sterilizzata col cloro del nostro ‘civile’ acquedotto, che così differiva da quell’acqua naturale alla quale loro erano abituati, ma che fu da tutti comunque immensamente gradita.
Poi, richiamati attorno a me, accorrenti, assonnati ma ancora attivi e attenti, li accompagnai nella ‘ nostra’ camerata, circondata dai loro” Resti cun noi, signurì?”, affidandoli uno per uno ai loro lettini vestiti di lenzuola candide che forse mai avevano provato, su materassi comodi e morbidi guanciali, dove sprofondarono in pochissimo tempo in un sonno profondo, che si accendeva nei loro corpi sfiniti, sfumandosi sulle loro labbra in spontanei “ Notte, signurì!”, ai quali rispondevo con il cuore emozionato e stranito, prendendo ad uno la mano, all’altro passando la mia sulla testolina rapata e pungente o donando ai pulcini più piccoli uno schioccante bacetto sulla guancia ormai addormentata.
Mi aggirai fra di loro finché non restai sola con il silenzio dei loro lievi regolari respiri di sonno, interrotti ogni tanto da qualche incomprensibile distorta parola che sfuggiva alle loro labbra e menti addormentate.
Poi, sfinita, mi accucciai nella mia branda, paludata dalla tenda lasciata socchiusa, dopo aver risciacquato l’abbondante sudore del lungo pomeriggio con una doccia fresca e ristoratrice e mi addormentai con loro, sentendo ancora il corale vociare – signurì…signurì..
Sono passati tanti anni da allora, ma io ricordo ancora i visi, le canzoni da taverna, - Ohi Marì', ‘ Cun sta pioggia e cun ‘sto vento chi è che bussa al mio convento' e 'Attacate astuccordone ' - che mi insegnarono, tra le chiare sabbie di giochi comuni con i sassi e le biglie, i noccioli di pesca seccati al sole, le capriole, le mani sulle spalle e a volte sul mio seno adolescenziale, mente la loro lingua dialettale diventava velocemente la mia, nella sua spontanea arguzia e ricchezza di naturalità.
Erano bimbi-adulti, che non erano quasi mai stati a scuola e che già da sempre lavoravano negli orti e nei campi, a contatto con galline ed armenti: della vita sapevano già tutto, imparato dagli accoppiamenti degli animali nei cortili delle povere case e nell’ombra ronzante delle stalle.
Ne sapevano più di me, che studiavo il greco e il latino al liceo classico e che guidavo la rivoluzione culturale studentesca e me lo insegnarono con racconti di abitudini antiche, da me mai conosciute e forse ormai sparite per sempre, seguendomi per anni a venire con lunghe teorie di cartoline postali inviatemi a Natale e Pasqua, recanti con la malferma calligrafia, i loro nomi, Nicò, Mattè, Rocco, Antò, Giusè, Vituzzo…. e la dicitura “ tanti auguri e ossequi, Signurì!” , che sempre facevano scorrere lacrime di amore e nostalgia per quelle lucenti vite esuberanti e sincere, nate e forgiate da una terra faticosa e ingrata quanto orgogliosa e vitale.
Per tutto il turno di un intero mese fummo lasciati a noi stessi, comunità a parte, con regole accordate tra noi e mai disattese da nessuno, fiorite dalla mia comprensione e amore che sfociava e fioriva nei loro amore e comprensione.
Oggi essi sono giovani uomini e qualcuno di loro forse non è già più, perché allora già minato ai polmoni o al cuore da nascite predestinate a morti precoci.
Ma, come io ricordo di ognuna di quelle ‘cocce pelate’, gli occhi e l’atteggiamento tumido delle labbra, passionali per genesi, così, sono sicura, essi ricordano di me le carezze, i lazzi, le canzoni urlate a squarciagola lungo le obbligatorie marce serali sotto l’ombra del viale orlato dai pini:
Ohi Marì, ohi Marì, famme ddurmì unanuotte bbracciata cuttè …e Togliteacmmisella…a cammisella, gnornò,gnornò………………..
Il motore fu una immensa passione: passavo tutti i pomeriggi in sella, facendo lunghi giri per le colline od andando al mare; ero del tutto spericolata. L'anno successivo vendetti quel motorino, che era troppo lento e ne comprai un altro: uno Speed-way Morini nero e giallo, a quattro marce a pedale, che faceva quasi i novanta e, dato che per quanta velocità raggiungesse il mio ' bolide ' tanta io ne sprigionavo, andando sempre ed ovunque con il gas a manetta, ebbi due incidenti – che non confessai mai a mia madre – . Nel più grave di questi mi feci una ferita profonda su di uno stinco che impiegò diversi mesi a guarire. Dissi a lei, che mi vide zoppicare, che ero caduta ed avevo sbattuto contro un marciapiede mentre invece avevo cozzato contro una macchina ferma ad uno stop, immettendomi nella strada su cui essa si trovava e avendo allargato troppo la curva a causa della eccessiva velocità. Il botto fu notevole e mi trovai dalla parte opposta della piccola utilitaria, con la testa vicinissima allo spigolo del marciapiede, che per fortuna non toccai, dato che, come sempre, non indossavo il casco, allora retaggio esclusivo di chi aveva le moto di cilindrata maggiore, come se noi ' piccoli ' non meritassimo di salvare la pelle. Fu la pedivella della mia moto a procurarmi la ferita ma, poiché miracolosamente nessuno dei due mezzi aveva riportato danni di una certa entità e dato che i tempi erano assai diversi, quando mi alzai da terra e mostrai al conducente dell'auto - terrorizzato - che stavo benissimo, lui, che magari non aveva neppure l'assicurazione, fu ben felice di chiudere tutto lì. E io, per paura che mia madre mi sequestrasse il mio mezzo a due ruote, nascosi il tutto, raccontando la bugia. Ma d'altronde mia madre non aveva tempo di badare a me e neppure la voglia e non guardò il buco nella gamba, che se lo avesse fatto di certo mi avrebbe accompagnato al pronto soccorso. Io lo curai da me e alla fine si rimarginò, lasciandomi un'altra vistosa cicatrice esattamente sotto a quella della infezione avuta da bambina. - Decisamente quella mia gamba destra non è stata mai fortunata, dato che ora riporta, sopra ai due segni dell'età giovanile, la stimmate della maturità: la grossa chiazza scura ricordo del colpo ricevuto cadendo dalla scala, dicembre 2009. -
Godevo allora di una libertà ancora più totale ed assoluta.: mia madre non era mai in casa., fuori tutto il giorno per lavoro ed uscendo spessissimo anche la sera.
Negli anni successiva ebbe una relazione con un altro uomo, - di cui si innamorò- che mi raccontava come ci si racconta ad una amica. Questo mi faceva soffrire ma nello stesso tempo ero contenta per lei: vederla sola e sofferente era per me intollerabile. D'altronde il mio modo di essere era così adulto anche da bambino che nessuno mai ha provato per me tenerezza e senso di protezione, mentre sono sempre stata io quella che lo esercitava sugli altri, su tutti gli altri, amici e parenti, madre compresa.
Mi presi cura, durante la mia adolescenza, di tutte le mie zie o altri parenti ed amici quando si recavano in ospedale per una qualche operazione o parto o altro, facendo le notti o recandomi quotidianamente a trovarli per le bisogne. Capitò più volte e, come già narrato per la mia nonna materna, io avevo tempo ed attitudine né mai mi tirai indietro. Mentre invece rifiutai ogni volta ogni aiuto, ad eccezione delle visite per la biancheria pulita e le altre piccole necessità, tanto che trascorsi ogni notte di tutti i miei svariati post operatori rigorosamente da sola.
Credo che faccia parte del mio non ritenermi degna, il rifiutare l'aiuto, quando ne ho bisogno.
I primi tre mesi della quinta ginnasio li trascorsi in collegio, come già accennato.
La nostra casa era così sola e vuota e desolata e triste che l'idea mi piacque persino, quando mamma me la propose.
Era un collegio retto da suore, in Viale Michelangelo, a Firenze. Fu un'esperienza molto bella quanto tristissima.
La vita in collegio era lenta e monotona e, dato che abitavo così lontano da lì, vi trascorrevo anche le domeniche, quando il collegio si svuotava, praticamente. Ma, dato che ero assai brava negli studi e molto fervente di fede, soprattutto per i canti sacri, mi feci amica di alcune suore, soprattutto due, che mi permisero di sentirmi meno sola. Una lavorava nella sezione della scuola materna e mi coinvolgeva sempre nelle sue attività per i piccoli. Le altre convittrici erano impegnate ore ed ore nello studio, io in pochi minuti eseguivo tutti i compiti con ottime votazioni. Questo mi fece esonerare dallo stare rinchiusa nella sala da studio e mi fu permesso di passeggiare nel parco o recarmi appunto a fare altre attività. Anche, pattinavo lungo i corridoi infiniti di quella antichissima costruzione: le suore mi volevano davvero bene.
L'altra invece era una delle decane e non lavorava più, perché piuttosto malandata ma sempre riceveva qualcuna di noi per parlarci di arte, poesia, letteratura e dei nostri piccoli – grandi problemi. Io la trovavo meravigliosa: la sua cultura era infinita, conosceva tutto, aveva letto tutto. Mi diede diversi testi da leggere, di poesia e filosofia. Insieme poi ne parlavamo e ne discutevamo e lei sembrava apprezzare molto il discorrere con me. Era un essere superiore, aveva gli occhi azzurri su di un volto pallido e molto rugoso, cosa che però non ne celava affatto la profonda ed eterea bellezza. Ho sempre pensato che avrei voluto raggiungere la sua serenità, diventare come lei, che emanava gioia e purezza. Mi aiutò molto, in quei lunghi mesi ed io la ringrazio oggi, di quello, se allora non lo feci.
Altre attività, poi, animavano le giornate: la domenica mattina c'erano sempre biglietti per i matineè di musica classica al Teatro Comunale di Firenze. Nessuna voleva mai andare ma io l'adoravo e così ogni domenica assistetti a spettacoli memorabile. Ascoltai Muti quando era agli esordi ed anche Abbado. Ricordo il soffitto ricoperto di velluto blu con incastonate tante lucette, come stelle. Le file di poltrone assai comode, l'atmosfera di bellezza, l'ingresso dei musicisti con i loro meravigliosi e lucenti strumenti, il frinire ed il gracidare degli stessi nell'accordarli, prima di iniziare, l'applauso quando entrava il Direttore, con il frac scuro, i capelli mossi e la lunga bacchetta magica, lo zittire quando l'orchestra finalmente, prendendo spunto da quel concitato ed improvviso movimento di polso del direttore, esalava le prime incredibili note.
Poi, alla fine dell'uragano musicale, lo scroscio delle mani battute fino a spellarle, che era troppo stato bello, troppo bello..
Invece la domenica pomeriggio mi recavo nella vicina parrocchia a tenere lezione di religione ai bambini.
Io ero triste, si certo ma il parco era così bello, in collina, così intenso nella sua veste autunnale, che passeggiare per quei vialetti mi rinfrancava.
Poi in pochissimi giorni strinsi due amicizie speciali con due ragazzine, di cui una era siciliana e quindi trascorreva le domeniche come me, reclusa. Fu proprio per quella ragione che legammo subito. Lei, Dodo, era figlia di un industriale dell'isola ed era molto ricca ma altrettanto abbandonata. Tutti i convittori di quel collegio, dato che vi era anche una nutrita ed appartata sezione dedicata ai ragazzi, erano figli di gente ricca: io ero di gran lunga la più povera. Infatti gli altri prendevano regolarmente lezione di tennis e di pianoforte, che mia madre non poté mai permettersi di pagarmi, nonostante io l'avessi molto desiderato: già era un impegno notevole, per lei, pagare la retta.
Quello che si racconta sui collegi è vero, che vi sono affidati ragazzi che ricevono una istruzione in cambio di molto denaro ma che sentono molto il distacco dalle famiglie, ricche di beni materiali ma povere di quelli affettivi. Le mie compagne erano tutte tristi come me e tra noi ci si dava più amore possibile, più compagnia, comprensione. Poi c'era un notevole spirito di cameratismo che ci spingeva a fare piccole infrazioni e coprendoci l'un l'altra: c'era chi fumava in bagno, mentre altre stavano di guardia, chi portava piccoli oggetti preziosi da casa, tipo cosmetici o giornaletti, che erano vietati e venivano celati e nascosti un po' a turno per sviare l'attenzione e la guardia delle monache. Poi c'era chi già piangeva per amori non corrisposti ed allora il consolarsi era d'obbligo.
Di giorno vivevamo tra l'aula, il refettorio, la sala ricreazione e quella di studio, con due appuntamenti alla chiesetta, uno la mattina, per una preghiera e l'altro la sera, per la messa ed i canti.
Dopo la cena ci venivano concesse un'ora di maggiore libertà nella sala di ricreazione, perché le suore avevano il loro ritiro spirituale e noi venivamo lasciate sotto la guardia più blanda di qualcuna delle ragazze più grandi, quelle che frequentavano l'università. Allora potevamo anche ascoltare qualche disco sul mangiadischi e sempre salvava fuori il famigerato ' Je t'aime 'che proprio in quei mesi aveva visto sorgere e crescere a dismisura la sua esplosiva popolarità. Che sospiri... li cantava lei, Jane Birkin ma anche li esalavamo noi, ascoltandola con occhi sognanti!
Poi veniva l'ora di andare a dormite.
La camerata, ubicata al piano superiore, era vastissima e non era stata divisa in camerette: noi dormivamo ognuna un separé dalle pareti di legno, chiusi sul davanti con una tenda di stoffa. Dentro c'era il letto, un piccolo armadio, un lavandino, in bidè, un piccolo tavolo con la lampada e una sedia. Alle ventuno eravamo già tutte in camerata, ci veniva concessa mezz'ora per leggere o scrivere e poi ogni luce veniva spenta.
In fondo alla camerata, vicino alla porta d'ingresso, vi era il separé della suora nostra guardiana, una baffuta Cerbero di origini meridionali che a malapena parlava l'italiano. Era assai severa, o almeno ci provava ma, tolti i paludamenti neri del giorno e indossati quelli candidi della notte, spente le luci, sicuramente stanca da una lunga giornata di lavoro, dato che erano le monache stesse ad eseguire ogni compito nel collegio: pulizie, lavanderia, cucina, orto e frutteto, crollava tragicamente, per lei, in un sonno profondissimo, russando sonoramente. Così allora noi tre o quattro più monelle sgusciavamo in silenzio dalle nostre cellette e ci infilavamo in quella della mia amica Dodo, che ara la cameretta più vasta ed aveva due lettini, invece che uno. Ci sedavamo l'una vicina all'altra ed andavamo via così, di chiacchiere a bassissima voce, fitte fitte, per buona parte della notte. Non fummo mai scoperte...
Ma io, evidentemente, soffrivo molto, mi venne una forte anemia, di certo mangiavamo pochissima carne, svenni un paio di volte ed ebbi diverse epistassi, di cui una richiese l'intervento di un medico per cauterizzare il capillare sanguinante.
Così, quando tornai a casa per le vacanze di Natale, mia madre decise di non farmi tornare più. Io accettai la sua decisione così come avevo accettato quella di andarvi ma devo dire che mi dispiacque anche parecchio, di non tornare, tanto, sola lo ero anche a casa, forse di più.
Per parecchi mesi mi scrissi con le amiche lasciate là, poi.. beh, si sa com'è la vita: ciò che sembra eterno non lo è mai.
Ripresi allora a frequentare la mia classe al ginnasio e tornai con il mio Carlo, con buona pace di tutti gli zii impiccioni. Per qualche mese conservai la pronuncia aspirata fiorentina e quell'aria un po' spocchiosa che mi si era attaccata addosso, frequentando ragazze così ricche. Mi feci comprare anche da mia madre dei vestiti assai femminili e belli, di certo per emulare le bellissime donne viste a teatro e per le vie smaglianti di quella favolosa metropoli. Ma ciò durò pochi mesi ancora.
A primavera era già sulla sella della mia moto a correre come una pazza per le mie amate e profumate colline.

CAPITOLO UNDICESIMO
Il professore, Tati, un'estate
indimenticabile e la Guzzi 500.
' Riempire le mie giornate': ecco la parola d'ordine, che se non potevo riempire quella voragine interiore potevo almeno cercare di non vederla né ascoltarla.
Quindi davvero in quegli anni, dalla infanzia al mio matrimonio, ho fatto di tutto.
Ho sempre amato la vita di gruppo.
Da bambina negli scout, le coccinelle, poi nelle guide, durante le superiori.. peccato solo che non potevo partecipare ai campeggi per il mio problema alle anche.
Cantavo. Adoravo cantare ed ero apprezzata per la mia voce intonata e potente.
Oltre al coro della chiesa, negli scout, nelle operette, alle elementari fui scelta per cantare nel teatro comunale della mia città, davanti al vescovo, in uno spettacolo di canzoni in suo onore. Io, coadiuvata in quella scelta da mia madre, che amava molto quella canzone, scelsi di cantare Milord, che di certo non era propriamente adatta e scandalizzai tutti.
Poi dalla quinta ginnasio presi parte ad un gruppo teatrale di canto politico ed anarchico e cantai molte volte in pubblico. Due sere alla settimana c'erano le prove, alle quali partecipavo con grande entusiasmo. Presi anche lezione di dizione, in quell'ambito, da uno di noi che era un attore professionista, anche se non di grandissima fama, però nella nostra cittadina era piuttosto conosciuto. Fu lui ad insegnarmi a recitare, almeno un po'...
In casa continuavo a sentirmi molto sola e desideravo tenere un animaletto con me. Quando a Carlo nacque una cucciolata di gattini siamesi, convinsi mia madre a farmene tenere una, una femmina, a cui diedi il nome di Bimba. A parte quando ero a scuola lei stava sempre con me, era adorabile ed io ero davvero felice di poterla tenere in braccio. Dormivamo abbracciate ma la cassetta con la segatura dove lei faceva i suoi bisogni, che stava in terrazzo, dato che abitavamo al secondo piano, emanava un odore che a mio fratello dava fastidio. E così, nonostante le mie lacrime, mia madre mi costrinse di rendere la gattina alla madre di Carlo.
I tentativi di vincere questo ostracismo furono diversi: un po' di tempo dopo incontrai per strada un accalappiacani che aveva catturato un cagnolino. Era un piccolo volpino nero e fulvo, dal pelo semi lungo e la coda portata alta e festosa, ornata da una bella frangia. Chiesi all'uomo che fine avrebbe fatto quel grazioso cagnolino e lui mi rispose che se nessuno lo avesse reclamato, dato che non aveva collare e medaglietta, dopo tre giorni sarebbe stato soppresso. Corsi da mia madre in negozio, piangendo e le raccontai tutti e tanto feci che la convinsi a farmelo andare a prendere e tenerlo in casa. Quelli del canile lo avevano chiamato Billy ed anche se era un nome che non mi piaceva non volli cambiarglielo, dato che lui a quello già rispondeva.
Con i miei risparmi pagai la tassa della medaglietta, che costava diecimila lire, se non ricordo male, gli acquistai collare guinzaglio ciotole cibo, poi la spazzola e lo shampoo secco in polvere che ogni giorno gli aspergevo abbondantemente nel pelo, spazzolandolo vigorosamente in modo che fosse più profumato possibile. Era una bestiolina molto giovane, poco più che un cucciolo e giocosamente si fece fare tutto, felice di ogni carezza e di ogni parola che gli rivolgevo. Io ero al settimo cielo. Si dimostrò tranquillo, in casa, ubbidiente e pulitissimo. Mi alzavo per tempo, prima di andare a scuola e lo portavo fuori, poi, appena ritornavo, la stessa cosa. Nel pomeriggio e alla sera, dovunque andassi lo presi con me, evitando luoghi dove non potesse entrare. Anche Carlo era contentissimo di quel cagnolino. Ma a scuola dovevo pur andare e dopo non troppi giorni mio fratello si lamentò del fatto che Billy, quando io ero via, cercasse di entrare in camera da lui, affacciandosi alla porta, entrando anche dentro e mettendosi a dormire sdraiato sul tappeto, sotto alla sua grande scrivania. Non dava alcun fastidio, secondo me, dato che non abbaiava né faceva altro, ma a mio fratello quella presenza non garbava e così fui di nuovo costretta a riportare il mio cucciolo al canile. I pianti quella volta furono centuplicati, cercai davvero in tutti i modi di convincerli a recedere dalla loro decisione ma furono irremovibili. Lo riportai al canile, con tutte le sue cose e pregai piangendo il custodi di non sopprimerlo, di affidarlo a qualcun altro, di fare qualsiasi cosa perché il mio Billy non dovesse morire. L'uomo mi sorrise e cercò di tranquillizzarmi, dicendo che avrebbe fatto il possibile. Prese il guinzaglio di cuoio rosso che gli tendevo ed io mi allontanai singhiozzando, mentre Billy mi guardava stupito ma scodinzolando, come se pensasse che sicuramente sarei tornata a riprenderlo, cosa che purtroppo non potei fare. Non ebbi mai più cuore di recarmi al canile e chiedere di lui.
Provai allora con animaletti più piccoli: un giorno un conoscente mi regalò una taccola di nido, un corvo molto comune nelle nostre colline. Lo chiamai Mao e gli insegnai a stare sulla mia spalla. Quando ero via stava in una gabbia molto grande in camera mia ma, appena possibile, lo tenevo con me. Ma Mao gracchiava, quando io non c'ero e quella fu la ragione per la quale dovetti separarmene, regalandolo ad un amico. Comprai allora un criceto color albicocca, un animaletto assai docile e curioso, che chiamai Speedy e che tenevo sempre in qualche tasca. A lui piaceva addormentarsi lì, oppure camminarmi addosso, salendomi sulle spalle e la testa. Ma, prima la ruota nella quale lui faceva ginnastica emetteva un rumore che mio fratello non tollerava, poi, tolta la ruota, dava fastidio l'odore. Allora lo portai in cantina e lì visse, nella sua gabbietta, finché un giorno lo trovai morto. Certo, averlo in camera mi avrebbe permesso di godere assai di più e meglio della sua compagnia. Ma non vi fu nulla da fare, ogni tentativo fu un disastro e separarmi dai miei amici animali fu una grande sofferenza, per me.
D'altronde mio fratello dettava legge in tutto: si mangiava persino solo quello che voleva lui. Maccheroni in bianco, fettina cucinata molto e sottilette, questo era il suo menù. Inutile dire che io detestavo quel cibo e me ne lagnavo a lungo con mia madre ma, dato che lui non mangiava altro, perché era ed era stato sempre assai noioso, il cibo in tavola ogni giorno era quello, con buona pace dei miei desideri, perchè io ero grassa e cosa importava se anche mangiavo poco. Così il pomeriggio mi rifacevo abbondantemente.
Tanto, tutto quello che lui faceva o diceva lui era giusto e bello, mentre tutto quello che facevo o dicevo io, brutto e sbagliato.
Io ero sempre e comunque cattiva. Una cattiva bambina.
Andai in prima liceo, continuando fervidamente l'attivismo politico.
In quegli anni lessi veramente di tutto. Marx, Mao Tsze Tung, Jung, Freud, Backunin, Schopenauer, Catullo, Calvino, Morante, Pavese, Cassola, Moravia, Marquez, Hesse, Emingway... e poi tutto tutto tutto: Ho letto centinaia di libri, tutti i poeti e pure di tutto quello che studiavamo a scuola io leggevo in opera omnia. In latino in greco ed in italiano. E molto anche in inglese, fino alla quinta ginnasio.
Il pomeriggio, poi, spessissimo mi recavo nella più rinomata libreria , in centro, con i soliti due tre amici e passavamo in rassegna i banchi zeppi di volumi, acquistandone sempre dei nuovi. Poi ce li si scambiava, ce li si prestava, altri si prendevano in prestito dalla biblioteca della scuola. Ma io, come ho già detto, amavo troppo comprare libri e la mia personale biblioteca stava diventando davvero ingente, compresi i fumetti, di cui ne lessi e comprai una quantità notevolissima. Mi piacevano soprattutto i fumetti tipo Penuauts, Mafalda, Blondie and Dagoberto, Andy Capp, Asterix e simili: sono troppi perché io possa scriverli qui. I miei figli ora hanno ereditato una grande parte di tutti i miei libri.
Ascoltavo anche tantissima musica. Soprattutto i Beatles, Behethoven, de Andrè Guccini ma anche tutto il resto, Mia Martini... Mina... tutto amavo ed amo della musica.
Avevo un piccolo giradischi tutto mio e vi suonavo sopra i miei LP e quelli di mio fratello, ovviamente senza che lui se ne accorgesse, e se i dischi tacevano, la radiolina era sempre accesa.
Ma la musica era parte attiva delle mie giornate anche perché eravamo un gruppo di amici che cantavamo sempre, insieme. Sandro, il mio inseparabile amico fraterno, suonava divinamente la chitarra ed aveva una voce stupenda: passavamo le ore a cantare insieme. Comprai io pure una chitarra, quell'anno, me la scelse lui, che conosceva assai bene quello strumento poiché era figlio e nipote di musicisti. Mi fece comprare una Yamaha acustica che aveva un suono notevole. La pagai cinquanta mila lire, che non erano poche, a quei tempi. E mi insegnò a suonarla. Divenni discreta ma mai raggiunsi il suo livello e questo mi inibiva parecchio: era giusto che fosse lui a suonare per tutti noi.
Passavamo i pomeriggi e le sere insieme, anche con Cristina, la sua ragazza e Nadia, che fu mia sorella dal tempo delle medie. Sapevamo tutto gli uni degli altri, eravamo totalmente solidali e non litigammo mai. Anche con gli altri compagni di scuola io andavo assai d'accordo, pur se si erano creati tre schieramenti piuttosto netti, all'interno della classe. Eravamo ventisette in tutto: una decina – tra cui Nadia - faceva parte del gruppo religioso di Comunione e liberazione, poi c'eravamo io, Sandro, Cristina e Tati che eravamo nel gruppo dei rivoluzionari, gli altri erano i qualunquisti.
Ma io uscivo con tutti, ero amica di tutti e partecipai sempre alle attività comuni, tipo gite, bigiate di classe, al cinema tutti insieme, vedere gli incontri di boxe, andare a giocare al bigliardo al bar Roma, interminabili partite notturne di poker e dovunque si potesse stare insieme e in compagnia.
Perché mi sentivo sempre terribilmente triste e sola.
Fin da bambina mi sono chiesta se la vita onirica fosse la vera vita e anche mi chiedevo perché io fossi proprio io. Riuscivo a vedermi dentro un'altra persona, riuscivo a sentire negli altri i loro sentimenti, anche quelli che poi non esprimevano o addirittura negavano: questo mi fece sempre andare allo sbaraglio dentro di me, così come il dire sempre ciò che pensavo e il non mentire mai. Ciò mi ha portato ad avere grossi problemi con tutti ma in quegli anni vissi delle amicizie intense e sincere, forti e profonde, non avendo problemi mai con nessuno dei miei amici. Eppure mi sentivo sola lo stesso.
In prima liceo conobbi il professore.
Aveva 42 anni, io 16: mi innamorai perdutamente di lui. Lasciai il mio ragazzo.
Vi racconto di lui attraverso una delle mie novelle di Kaiki, qui sotto, in corsivo.
IL PROFESSORE
Frequentare la Prima Liceo per me significava fare ingresso nell’età adulta: i ginnasiali, ospiti di vetuste aule al piano di sotto, erano sempre e solo delle matricole, anche nell’ultimo giorno della quinta ginnasio, in ricordo dei tempi in cui, per passare al liceo vero e proprio, bisognava affrontare e superare un esame assai duro.
Quando giunsi io, l’esame era stato abolito da non molto tempo e noi eravamo ancora considerati come studenti delle medie, solo di un grado superiore.
Passare in prima era un salto di valore, tutto aumentava: il rispetto degli insegnanti, quello dei compagni, sia più grandi che più piccoli, la comodità delle aule, il numero dei professori, la specializzazione e la difficoltà delle materie studiate, l’autostima e l’autodeterminazione di chi ci arrivava.
Infatti, anche se non c’era più l’esame, alla fine della quinta ginnasio era avvenuta una falcidiata tra i nostri ranghi e diversi dei miei compagni non erano riusciti a oltrepassare quella fatidica soglia.
Ci fu chi si arrese e cambiò scuola; chi l’abbandonò definitivamente per il mondo del lavoro, che allora era immenso e offriva ogni possibilità; chi invece rimase sulla strada intrapresa ripetendo l’anno.
Io passai a pieni voti e fui molto delusa dal calo delle mie quotazioni nei primi compiti e nelle prime interrogazioni del nuovo anno scolastico.
Non mi ci volle molto per capire che era stato impresso un giro di vite e che ci veniva richiesto molto di più e così mi adeguai.
Ma quello che mi diede più soddisfazione fu conoscere i professori nuovi, che mi sembrarono subito interessanti, più preparati, più profondi, più esigenti, - poiché eravamo abituati ad averne uno solo che ci insegnasse le cinque materie principali, riempiendo così di monotonia le nostre mattinate. Egli era un docente molto colto e preparato, ma del tutto privo di genio e di originalità, che banalizzava qualsiasi nozione tentasse di trasmetterci.
Ma lui fu una folgorazione.
Entrò in classe la prima volta indossando il suo trench dal taglio moderno ed elegante, anche se sobrio, sopra un accurato vestito grigio chiaro con una cravatta vivace, la camicia bianca immacolata, stringendo tra i denti il bocchino in cui innestava, come uno stendardo di riconoscimento, una sigaretta di marca straniera dall’aroma accattivante.
Alto e distinto, ci ispirò subito soggezione: zittiti tutti all’unisono, al suo ingresso ci alzammo in piedi in segno di rispetto come si faceva allora, affascinati da quell’entrata da attore consumato, da quel talento istrionico che subito ci catturò tutti.
La sua voce risuonò chiara, con un tono caldo ma distaccato, anche se gentile e assai curato nella scelta dei vocaboli, con una erre arrotata che gli conferiva un’impronta signorile.
Si rivolse a noi così, quasi in mezzo alla classe, dopo averci fatto rimettere seduti e, nel silenzio più assoluto, ci diede il benvenuto e delineò a grandi linee il suo metodo di insegnamento: un compito in classe alla settimana, alternando il latino al greco, tre interrogazioni a testa per materia al trimestre, tante ore di grammatica e sintassi e altrettante di letteratura, in parte estrapolata direttamente dagli scritti nella lingua originale, indicandoci quali opere aggiuntive avremmo dovuto procurarci al più presto.
Ci anticipò che le avremmo tradotte insieme a lui ed emise, stentoreo, il suo dictat:
«Avrete da me quello che mi darete voi».
Poi si tolse il trench, lo appese con cura all’attaccapanni a lui riservato e si accomodò sulla sua sedia, dietro alla cattedra, rialzata rispetto a noi da una pedana di legno, a sottolineare la sua indiscussa e indiscutibile autorità.
Cominciò immediatamente la sua lezione, indagando con domande varie quale fosse il grado di preparazione al quale eravamo giunti ed entrando senza indugi nel vivo del suo programma didattico.
Io rimasi rapita.
Il profumo di talco e di tabacco dolce che emanava mi avvolse come un’aura, la sua carnagione olivastra e i suoi occhi scurissimi, mobili e acuti come lame affilate che ci scrutavano, entrandoci dentro la mente e l’anima, carpendo la mostra essenza interiore con una sola occhiata, trovarono che le mie porte non opponevano nessuna resistenza al suo tocco leggero ma deciso.
Le sue mani lunghe e scarne, eleganti e curatissime, che gesticolavano leggermente, sottolineando come un direttore d’orchestra tutte le parole che uscivano dalle sue labbra, erano in perfetta sintonia con la sua figura slanciata ma forte, lievemente rigida, coronata da una non celata chierica di capelli nerissimi, fini e lucidi, che
gli conferiva il senso di appartenenza a una età ancora giovane ma già matura: poco oltre la quarantina.
Io lo ascoltavo attentamente e tutti questi particolari, congiunti alle sue parole colte, chiare, scelte, originali ma estremamente semplici e comprensibili, scavarono un solco nel mio cuore dove piantai immediatamente il seme della mia ammirazione e del mio subitaneo amore per lui.
I giorni passavano ed io non aspettavo altro che le sue ore di lezione, trepidante ed emozionata, mescolando Euripide, l’aoristo, le volute di fumo delle sue instancabili sigarette con un sentimento palpitante che cresceva ogni giorno di più, mentre non gli staccavo gli occhi di dosso quando spiegava qualche argomento, girando tra i banchi.
Cercavo di incontrare il più spesso possibile il suo sguardo, che spesso si fondeva col mio, soffermandosi un attimo, per poi fuggire verso altri occhi, assorto in quello che diceva, pur rimanendo vigile e indagatore.
Io cominciai a fare il confronto tra la dolce semplicità di Carlo, il mio spasimante di allora e la sua scarsa capacità fabulatoria, con la ricchezza e la variabilità delle vivide espressioni del professore, a volte serie e assorte, a volte pungenti e taglienti, spesso ironiche e severamente divertenti.
Il mondo dei greci e dei latini, la tragedia, il teatro, l’epica, la poesia, la difficile sintassi e la musicalità delle lingue che egli leggeva con una fluidità e una espressività straordinarie, si fondevano in un tutt’uno alla mia voglia di imparare, al desiderio di penetrare la cultura.
E davano sollievo alla solitudine interiore che continuamente insidiava la mia evoluzione psichica, dovuta al dolore mai sopito della mancanza di mio padre, che mi aveva abbandonato troppo presto, passando nell’Ade di cui spesso si parlava in quegli antichi, verosimili e modernissimi classici letterari.
E davano corpo al mio desiderio di un amore puro ed eletto, destinato a pochi mortali, fatto di intenzioni e di fremiti interiori più che di abbracci e di baci.
I miei occhi lo frugavano e lo accarezzavano, la mia memoria incamerava ogni sua parola e ogni suo gesto, per poi ricordarlo e riviverlo nel silenzio della notte, mentre io vegliavo nella casa addormentata, ascoltando il respiro di mia madre, appesantito dalla sua cronica stanchezza, proveniente dalla porta adiacente alla mia.
Tra un cambio d’ora e l’altro e durante la ricreazione, egli si tratteneva con noi ed io ero sempre nel gruppetto di coloro che gli si stringevano attorno per porgli domande, chiedere chiarimenti, pianificare interrogazioni; ma il mio sguardo era troppo intenso e trasparente per sfuggire alla sagacia dei miei compagni di studi, che presto mi fecero confessare la mia passione segreta per il bel professore.
Fu così che subito la voce si sparse in tutto l’istituto ed io divenni «quella che era innamorata del professor Venturi ».
Inoltre i miei sguardi erano così intensi e trasparenti che presto pure lui se ne accorse.
Lo capii perché la sua voce vibrava di una nuova trattenuta tenerezza quando si rivolgeva a me e dagli sguardi lievemente più intensi e frequenti che rispondevano, solerti e disarmati, per un attimo solo, ai miei silenziosi doni d’amore, con sorrisi appena accennati e una misurata affabilità durante le interrogazioni e gli scambi di opinione.
Io lasciai il povero Carlo, che si soffermava a piangere sotto la mia finestra, ma quella dolcezza che dilagava in tutta me stessa quando pensavo al mio professore era un sentimento che non avevo mai provato per lui e mi rivelava che non era lui che desideravo, nonostante gli volessi tanto bene e lui mi amasse fino all’adorazione.
Così, nel pomeriggio, con tutto il tempo che avevo di nuovo a disposizione, facevo lunghe pedalate in bici e finivo sempre per passare davanti alla casa del professore, spiando di sfuggita attraverso la finestra, che sapevo essere quella del suo studio, col desiderio, la speranza e il timore di vederlo, di incontrarlo solo un attimo e con la necessità impellente di stare vicina a lui, di condividere con lui almeno il luogo e l’ora, anche solo per i pochi secondi che impiegavo nel superare la sua casa e
svoltare bruscamente, tornando a girovagare altrove, timorosa di dare troppo nell’occhio.
Ad un certo punto dell’anno scolastico egli ci invitò a casa sua, per approfondire i nostri rapporti ed io convinsi prima Tati e poi Sandro a recarci insieme a trovarlo.
Finalmente potevo entrare in quella casa, una villetta indipendente con un bel giardino curato e ornato di fiori primaverili appena sbocciati.
Lui ci accolse in veste da camera, meno austero e ieratico che in classe, più rilassato e disposto allo scherzo e da quella volta ci trattenemmo diverse volte con lui, a parlare di politica, di grafologia, dei problemi che vedevamo nel presente e dei nostri progetti per il futuro.
Durante quelle visite, che a volte si prolungavano parecchio, io lo bevevo come un’assetata nel deserto e mi riempivo dell’indugiare caldo e sereno dei suoi occhi dentro i miei, del suo rivolgermi la parola a bassa voce, come se fossimo stati da soli in quella stanza, incuranti della presenza degli altri ragazzi e ragazze.
Il nostro era un dialogo silenzioso e sotterraneo, ad un livello così profondo che nessun altro poteva raggiungerci, dove le nostre anime si scambiavano parole che neppure noi conoscevamo, si fondevano in abbracci che neppure osavamo sperare, si allacciavano sempre di più in nodi indissolubili come quelli marinareschi…
Un giorno maledetto, una terribile sciagura colpì la famiglia della nostra compagna Nadia: suo padre morì, folgorato dall’alta tensione nel cantiere in cui lavorava.
Dopo il funerale, io e Sandro, entrambi orfani di padre, le regalammo un criceto in una gabbietta tutta colorata e piena di passatempi: Nadia desiderava tanto un cagnolino, ma la madre era contraria, per cui si era dovuto ripiegare su una bestiola più piccola.
Forse quel simpatico animaletto avrebbe alleviato la sua solitudine…
Mentre si avvicinava l’estate, prendemmo l’abitudine di recarci da lei per sederci al fresco del suo giardino che profumava di rose, seduti in tre sul suo dondolo, per cantare sottovoce alcuni malinconici blues, dando così espressione e sfogo, lei al suo dolore e noi alla nostra affettuosa solidarietà.
Fu il professore che una sera ci chiese di potersi unire a noi, per partecipare a queste meste ma feconde riunioni dei suoi allievi preferiti e poiché ignorava il percorso per giungere da Nadia, mi offrii di fargli da guida nel corso del tragitto.
La sua automobile gli somigliava in modo straordinario: sportiva ma non chiassosa, scattante ma silenziosa ed era permeata del suo profumo.
Appena presi posto sul sedile accanto a lui, mi colse una specie di vertigine: mi sentivo già tra le sue braccia, travolta dall’amore che ora poteva assaporare un’intima vicinanza.
Fu una serata dolce, intrisa di malinconia e lui seppe confortare con tatto e delicatezza la mia amica, che era la migliore della classe, specialmente nelle sue materie.
I nostri blues quasi sussurrati come per non profanare il lutto di quella casa, lo colpirono e lo commossero vivamente: Nadia e Sandro suonavano divinamente la chitarra, dialogando tra loro con arpeggi e fioriture spontanee e le nostre tre voci riunite assieme, quella baritonale di Sandro, quella da soprano leggero di Nadia e la mia da soprano lirico, fuse perfettamente insieme da un prolungato sodalizio, gli suscitarono un’intensa emozione.
L’aria era gradevole, il vento ci accarezzava e sembrava che il tempo si fosse fermato lì, su quella soglia, con tre adolescenti e un loro professore che vivevano una comunione estranea alle consuetudini scolastiche.
Ma il tempo era volato via: si era fatto tardi e il professore mi riaccompagnò a casa.
Abituato a una guida spigliata, quella sera stranamente non pigiava sull’acceleratore e discorreva tranquillamente con me, tenendo una mano sul cambio e una sul volante.
Le strade erano vuote e silenziose e le ombre di quella notte primaverile ammantavano come un velo oscuro la città addormentata.
Io gli lanciavo occhiate furtive per non apparire troppo sfacciata, col cuore che mi rimbalzava in gola: non eravamo mai stati così soli e vicini.
Il resto era sparito e io mi sentivo isolata, galleggianre accanto a lui dentro una bolla di sapone.
Ad un tratto i nostri sguardi si incrociarono, restando incatenati a vicenda.
Tutto scomparve all’istante, tutto fuggì dileguandosi in silenzio, liquefacendosi in una atmosfera di totale sospensione: lui accostò, senza distogliere gli occhi dai miei e spense il motore; il silenzio della notte ci era complice, ci accoglieva come un nido.
Smise di parlare e continuò a guardarmi intensamente, poi alzò una mano per scorrere lievemente col dorso la morbidezza ancora infantile della mia guancia e lo fece con un gesto così lento, assorto nei suoi insondabili pensieri, che la sentii tremare leggermente.
Io mi posai su quella innocente e sensuale carezza e tutta la mia spontanea ingenuità lo sommerse di intensa tenerezza, attirandolo inesorabilmente verso di me, fino a che il suo viso non fu così vicino al mio che le sue labbra appena dischiuse, caste e nello stesso tempo infuocate, condivisero con me il sapore dell’estasi in un contatto fremente.
Lui trattenne a stento la violenza dell’amore che ci premeva nelle vene pulsanti, sbriciolandola in una dolcezza infinita che solo un uomo adulto e puro può provare per una donna-bambina innamorata e indifesa.
Fu un attimo o un’eternità, non lo sapemmo mai, né ci importò mai di saperlo.
In quel bacio egli versò tutta la sua vita ed io gli offrii tutto il mio futuro.
Ma il presente fu più forte di tutto e prevalse nel conflitto tra il cuore e la mente che si agitava furioso dentro di lui.
Lentamente si staccò da me e si appoggiò al sedile, come sfinito da un’aspra lotta dall’esito ancora incerto.
«Lo sai che non possiamo», mi sussurrò e la sua voce era un’isola lontana.
«Ma noi ci amiamo», mormorai io, sentendo un gelo mortale artigliarmi il cuore.
Allora nei suoi occhi ancora fissi nei miei scintillò il bagliore di una lacrima trattenuta, mentre mi ripeteva che, pur se il nostro amore era travolgente come un fiume in piena, la vita aveva deciso per noi, togliendoci ogni possibilità e ogni diritto di poterci amare.
Poi distolse gli occhi dai miei e staccò la sua mano dalla mia guancia rigata di lacrime.
Senza più dire una parola, si rimise alla guida fino a fermarsi sotto casa mia: sentivo che la sua era una sentenza senza appello e io l’accettai, perché l’amavo troppo per mettere in discussione l’amara verità che era sorta su quelle labbra che un attimo prima avevano spalancato il mio futuro alla più agognata delle felicità.
Ci guardammo ancora a lungo e i nostri occhi vissero in quegli attimi tutto quello che i nostri corpi non avrebbero provato mai.
Lui si staccò da me e io sentii nettamente la corda del violino che si recideva dal ricciolo di legno levigato e lucido che l’aveva trattenuta fino ad allora e poiché non ero Paganini, ma una ragazza che non poteva fare altro che obbedire al suo maestro d’amore, scesi dalla macchina e, senza voltarmi indietro, varcai la soglia del portone di casa, entrai nel mio alloggio e chiusi la porta dietro le mie spalle.
Da quel giorno piangemmo insieme tutte le nostre lacrime silenziose e invisibili, amandoci disperatamente nelle ore di scuola, donandoci completamente l’una all’altro senza un gesto o una parola.
Ma Catullo sulle sue labbra: Dammi cento baci e ancora mille, poi cento e mille ancora… fu il suo regalo per le nostre nozze segrete e mai consumate, mentre tutto spariva intorno a noi e le nostre emozioni si dispiegavano libere in un Eden parallelo dove un uomo può amare un’adolescente ed esserne riamato senza che nessuno lo possa giudicare sporco o immorale.
Furono tre anni di paradisi incontaminati, stillanti di note e di cupi abissi infernali, formati da vulcani in eruzione, che tutto bruciavano e fondevano, lasciando solo una crosta vitrea fredda e indurita.
Io accettai di nuovo l’amore di Carlo, perché la solitudine mi avvelenava il sangue così violentemente da non permettermi neppure di respirare…
Frequentavo la Terza Liceo quando a maggio rimasi incinta.
Non appena lo seppe, il professore mi lanciò uno sguardo incandescente di dolore e di nostalgia: i suoi occhi mi gridavano in silenzio che quel bambino avrebbe potuto essere suo.
Lui amava moltissimo i bambini ma non ne ebbe mai uno.
Quando nacque la mia piccola era il mese di marzo e io, appena ristabilita dal parto, in una bellissima giornata di sole, la adagiai nella sua carrozzina, col suo abitino più bello, tutta bianca, rosa e profumata e varcai di nuovo, per l’ultima volta nella mia vita, il grande portone di quel tetro santuario della cultura che era il Liceo, al suono della prima campanella.
Subito tutti quelli che mi conoscevano si raccolsero intorno a me, festeggiandomi e sommergendo di complimenti la mia piccola e deliziosa creatura, che con gli occhi sgranati guardava un po’ interdetta tutti quei visi sorridenti.
Accalcandosi intorno a noi, mi accompagnarono di sopra per mostrarla a tutti i professori che mi accolsero con affetto e calore.
Solo lui trasalì da lontano, quando mi vide e aspettò qualche attimo prima di avvicinarsi a me.
Ci salutammo cordialmente, reprimendo a stento le nostre telluriche emozioni. Lui allungò le braccia ed io gli porsi il frutto di un amore che non era il suo, per donarglielo comunque, come gli avevo donato tutta me stessa, rinunciando al nostro amore senza lottare.
La piccola gli strinse il dito che lui aveva fatto scivolare dolcemente sulla sua perfetta miniatura di mano e gli strappò un mesto e tenero sorriso che mise a nudo per un attimo il suo animo solitario e straziato.
Poi, mormorando parole di circostanza in mezzo al clamore della gente attorno a noi, me la ripose delicatamente tra le braccia e, con il pretesto dell’imminente lezione si allontanò, senza più voltarsi indietro.
Questa storia ha un seguito, che ora scrivo di getto per la prima volta.
L'anno prima della mia partenza per la Sardegna, un giorno che ero tornata nella mia cittadina per stare qualche giorno con i miei figli e mia madre, recandomi in un negozio, incontrai un mio ex compagno di liceo che lavorava lì.
Ci salutammo con gioia e, come sempre succede in quei frangenti, ci raccontammo un po'.
Erano anni che non ci vedevamo.
Parlammo di un po' di tutto e naturalmente dei vecchi compagni.
Lui li frequentava ancora.
Ma io, che avevo vissuto venti anni in un'altra città, poco dopo il mio matrimonio e che poi mi ero allontanata definitivamente già da qualche anno, non avevo rivisto che pochi di loro.
Ma il mio pensiero ero andato immediatamente al mio amato professore.
Avevo seguitato ad amarlo sempre, senza interruzione di tempo e di intensità, fino a quel giorno, nonostante la mia vita avesse conosciuto altri amori.
Ma lui, lui aveva mantenuto il suo posto speciale, tutto a lui dedicato.
Così non resistetti e chiesi al mio compagno di studi se avesse notizie del nostro insegnante.
Il sorrisetto che spuntò sulle labbra del mio amico fu molto eloquente, però non disse nulla.
Mi racconto che il professore stava bene di salute, nonostante avesse passato già gli ottanta da un po', ma che era diventato molto triste e solitario. Che si era ritirato da tutte le molteplici attività che comunque lo avevano visto protagonista della vita della nostra cittadina, che aveva smesso di scrivere e pubblicare.
Insomma il quadro che mi fece fu assai preoccupato e preoccupante.
Ci salutammo dopo qualche minuto ed io mi recai a casa dei miei ragazzi, quella casa che era stata mia e che ora sentivo aliena e ostile.
Ma il pensiero della tristezza di quell'uomo così amato mi travolgeva, portandomi via ogni altro pensiero.
Fu così che presi carta e penna e gli scrissi una lettera.
Non gli parlai d'amore, ma gli ricordai quello che era stato per noi, gli dissi che il compagno mi aveva detto della sua tristezza e gli chiesi di accettare il mio affetto e la mia compagnia epistolare.
Lui mi rispose con la sua bella calligrafia fine e originale e si schermì.
Negò di essere triste, adducendo una naturale riottosità, mi redarguì dicendomi che ero stata esagerata come quando ero ragazzina nel descrivere la sua importanza per tutti noi suoi allievi e mi disse che ormai era troppo vecchio.
Mi offesi.
Quelle sue parole mi fecero male.
Ma come aveva potuto pensare che io gli stessi chiedendo ora quel rapporto che non gli avevo mai domandato?
Così gli risposi assai piccata che io volevo solo donargli il mio affetto e fargli un po' di compagnia epistolare, che lui aveva frainteso il mio intento e che io ero omosessuale, che l'avevo finalmente scoperto ed accettato e che, quindi, il mio interesse per lui era scevro di qualsiasi altra cosa che non fosse il desiderio di poter alleviare in qualche modo le sue sofferenze.
Terminai la mia lettera dicendogli che se il mio affetto era una cosa a cui voleva rinunciare, sfacesse pure.
Imbucai la lettera pensando che non mi avrebbe risposto.
Mentre invece lo fece.
Seguirono così diverse lettere nelle quali lui si raccontò a me, dei suoi problemi famigliari e delle sue malinconie, mentre io gli raccontai un po' delle mie tante disavventure.
Poi un giorno non mi rispose più.
Né io lo sollecitai ulteriormente, travolta dai mie tragici eventi dei tentativi di suicidio che accompagnarono la mia storia d'amore di allora con Dana, la protagonista del mio primo romanzo, IO NON SONO DI QUI.
Subito prima di partire perla Sardegna passai ancora due o tre giorni a casa dei miei.
E un pomeriggio, passando per una strada del centro, lo incontrai.
Io ero in bicicletta e lui mi camminava davanti.
Fu un colpo allo stomaco da kappaò.
Riconobbi immediatamente la sua sagoma, pur se ingobbita e pur se stava camminando a testa bassa.
Nella frazione di un attimo milioni di pensieri accorsero alla mia mente, come un immenso stormo di uccelli che si levasse in volo all'unisono, spaventati all'improvviso dal colpo di un cannone.
Mi fermo, lo fermo lo saluto gli parlo lo abbraccio.
No.
Sono vecchia sono grassa, non voglio che mi veda così.
Lui è vecchio e stanco, non vorrebbe che io lo vedessi così.
Per la frazione di qualche secondo la mia bici gli scivolò accanto e poi lo superò.
Lui non si accorse di nulla.
Pedalai il più velocemente possibile fino a togliermi dalla sua visuale e poi mi fermai, ansante.
Tremavo dalla testa ai piedi.
Era lui, avevo visto il suo volto e tutto di lui in quell'infinito secondo in cui gli ero stata a fianco: era lui e pur nella vecchiaia dei suoi 84 anni, era ancora bellissimo.
Ma tanta tanta tristezza emanava il suo viso.
Mi appoggiai al muro e piansi, incurante di chi, passando, mi guardava.
Piansi e lo ami ancora come allora.
Poi la vita di nuovo mi travolse.
Non so nulla di lui, né se ancora viva o..............
ma non lo voglio sapere.
No mi importa...che importa saperlo?
Io e lui siamo ancora là:
' Da mihi basia mile, deinde centum, dein altera mille...'
Lui fu il mio primo amore maturo. E mi respinse anch'egli. Mi amò davvero? Fui certa di si ma in realtà non lo seppi mai, come non lo so neppure ora.
Sandro, divenuto adulto e a sua volta professore, cominciò a scrivere romanzi e il primo che scrisse fu proprio su quegli anni. È davvero un bel romanzo: lui è uno scrittore di buon successo dato che è molto bravo. In quel suo primo libro raccontò di me e del professore e nel suo racconto noi allora ci amavamo, lui mi aveva accettato, aveva avuto una storia con me.
Quando lessi quel libro, a trent'anni passati, piansi tutte le mie lacrime...
Quell'anno fu così denso di avvenimenti.. avevo sedici anni, stavo malissimo ma ero così piena di vita e di ogni forza vitale che attirai a me altrettante forze vitali.
Infatti mi innamorai anche di una mia compagna di classe, Tati e fui per mesi e mesi il suo cavalier servente in modo così totale, perché, nonostante piangessi d'amore per il professore, sapevo che amavo anche lei, anzi, che amavo lei in modo assai più viscerale di quanto non amassi lui. Ma non lo capii né ammisi mai fino in fondo.
Vi parlo di lei attraverso un passo di ' Quella che non dico a nessuno '.
Dal capitolo LABBRA
Io e Tati avevamo sedici anni.
Lei era piccola, molto magra, di carnagione scura e capelli lunghi inanellati e corvini.
Gli zigomi sporgenti da sioux portavano a due occhi di castagna, lucidi e sgranati, in una eterna spaventata domanda.
Le sue labbra marcate erano sporte in fuori senza che lei le atteggiasse, sempre dischiuse su denti regolari e bianchissimi.
Tutto il suo corpo sottilissimo emanava fragilità e forza miscelate come sale e pepe.
Io la proteggevo col mio portamento sicuro e spavaldo, allargando ancora di più le spalle già molto larghe e orgogliose.
Correvo da lei ogni giorno, pronta ad assecondarla in tutto, come i suoi desideri fossero il fine ultimo delle mie ore.
L'amore per il bel professore di latino e greco mi trasportava con prepotenza lungo salite e discese tra un giorno e quello seguente.
Carlo era stato allontanato, con dispiacere ma fermamente: come era possibile amare due persone contemporaneamente?
Tati ascoltava i miei sogni d'amore, circoscriveva le mie sofferenze, arginava le mie lunghissime attese.
E io stavo lì, ai suoi piedi, offrendomi come fermo gradino al suo passo lieve.
Mangiavamo insieme, dormivamo nella stessa camera, sul lettino a castello, io al piano di sotto ad ascoltare il suo respiro che dormiva, i movimenti delle sue gambe tra le lenzuola.
Andavamo in bagno insieme: le prime volte io mi vergognavo perché ero stata abituata ad una rigorosa privacy, ma lei scardinò il mio pudore con una naturale disinvoltura. Guardavo i suoi fianchi stretti sgusciare fuori dai perenni jeans della nostra adolescenza e sedersi senza essere infastiditi dai miei occhi che si concentravano sul pube ricco di riccioli neri.
Lo scroscio sulla bianca ceramica si mescolava alle nostre voci allegre, mai stanche.
Mi sentivo orfana se per un giorno non potevo vederla e stare con lei, mi sentivo triste quando lei lo era, incredibilmente felice quando lei sorrideva.
Quando ci salutavamo perché io dovevo tornare a casa mia, Tati mi accompagnava per il lunghissimo corridoio rivestito di parquet morbido e caldo, apriva il catenaccio di ferro del pesante portone di scuro legno massiccio e mi salutava ogni volta con un bacio, che io ricambiavo leggera ed estatica.
Quella sera d'inverno fredda e scura di pioggia, le sue labbra si posarono sulle mie.
Non bastò la superficie di tutti i pianeti delle galassie e di tutti i corpi celesti lontanissimi per accogliere le mie labbra contro le sue.
Poi chiuse la porta.
Io rimasi fulminata. Impietrita. Non feci nulla.
Non ne parlammo neppure più ma il contatto di quella pelle era fuoco. Non l'ho mai più dimenticato.
Finita la scuola ci recammo, io e lei sole, in vacanza quindici giorni nel paesino di montagna da dove provenivano i suoi e dove ancora vivevano suoi nonni e zii. Uno di questi zii aveva appena acquistato una bellissima villa stile liberty, subito fuori il paese, per trasferirvisi con la famiglia. Ma ancora non l'aveva fatto e la casa era vuota, così che ci invitò a trascorrere un po' di giorni lassù. Mia madre acconsentì.
Io e Tati mettemmo qualche maglietta, dei jeans e un po' di biancheria in una borsa, un po' di soldi in tasca e prendemmo un autobus di linea che ci portò su.
La villa era bellissima, completamente ammobiliata con un ampio giardino recintato ma tutto il paesino era straordinario, a picco sul ruscello, con case di antichi massi e le montagne tutte intorno, alte e fitte di boschi di castagni.
Ogni giorno io e lei, sole o con lo zio, che si rivelò una persona davvero simpatica, facevamo lunghissime camminate, raccogliendo funghi, di cui lui era esperto. Loro cercavano i porcini ma io, che non avevo mai raccolto funghi in vita mia, inebriata da quei profumi e quei colori, mi accontentavo di raccogliere gialletti e balute, che erano più comuni e quindi meno preziosi. La mia amica e lo zio ogni giorno facevano a gara di chi avrebbe trovato il porcino più bello e grosso ma il destino volle che fossi io a vincerla, quella gara, in modo del tutto incosciente e clownesco, secondo il mio stile. Infatti scivolai sul denso fogliame secco che ricopriva il terreno e che lo rendeva un po' insidioso, proprio in un piccolo boschetto di cornioli e cadendo col sedere a terra, dando una botta notevole, rivelai la presenza, divellendolo dal terreno, di un grosso porcino edule, che era poi dato dalla fusione di due, come due gemelli siamesi.
Allora loro due si arrabbiarono scherzosamente ma in modo veemente contro di me e me ne dissero di tutti i colori ed io risi fino a svenire e tutto il paese poi mi conobbe come ' quella che aveva un gran culo nel trovare funghi '.
Ma nella nostra cittadina successe un fatto davvero grave e doloroso: tre ragazzi della classe superiore, che io ovviamente conoscevo benissimo, ebbero un orribile incidente in auto, che prese fuoco. Uno di loro rimase intrappolato e morì per le ustioni riportate, diverse ore dopo.
Ci scrisse di questo il nostro e ' mio ' professore che, sapendoci lassù, aveva voluto avvertirci. Io e lui ci scambiammo un paio di lettere molto emozionate, in quel frangente, che io rilessi innumerevoli volte.
Ma la vita, a sedici anni, è più forte di tutto e riprendemmo camminate, bagni nel ruscello, chiacchiere, canzoni: furono quindici giorni esaltanti, bellissimi. Io e lei trascorremmo sempre ogni giornata in perfetta simbiosi, io cucinavo per lei e mi sentivo così felice di averla sempre accanto. Dormimmo insieme, nello stesso letto matrimoniale ma per non fare impazzire la zia con le lenzuola, avevamo preso due sacchi a pelo che avevamo trovato là: la notte faceva piuttosto freschino. Quindi, giunta l'ora, salivamo al piano di sopra con una candela, perché in quella parte della casa mancavano i lampadari, ci infilavamo ognuna nel nostro sacco a pelo, lei si avvicinava a me, si appoggiava contro di me, io l'abbracciavo e ci addormentavamo così, esauste.
Non ebbi il coraggio di toccarla mai in modo diverso, era come se dentro qualcosa di fortissimo paralizzasse l'altrettanto forte desiderio che sentivo di amarla in modo completo.
Forse lei pensò di non piacermi, non so, non ne parlammo mai.
Quando tornammo a casa, poco tempo dopo Tati si fece un ragazzo e mi allontanò, dato che Mù, così si chiamava lui, non mi aveva tanto in simpatia – cosa che era reciproca - e, ovviamente, voleva stare solo con lei.
Ma quello fu un anno davvero intenso: ad agosto Cristina mi invitò nella villetta che avevano i suoi a Vieste, sul Gargano. Anche quella volta mia madre acconsentì ed io trascorsi in quel luogo i giorni che ricordo come tra i più belli in assoluto della mia vita: praticamente sempre in spiaggia, in acqua, in barca, con quel mare meraviglioso e blu cobalto, l'isoletta spoglia che sembrava il dorso di una balena spiaggiata, a mezzo chilometro dalla riva, alla quale arrivavo a nuoto, che era ricca di grotte e spiaggette fatte di conchiglie piccolissime, scogli per i tuffi e le immersioni ad ammirare una natura subacquea quasi da barriera corallina, tanto era varia e variopinta.
Cristina aveva fratelli, sorelle e cugini e quindi noi eravamo un gruppetto già molto nutrito. Poi diversi ragazze e ragazzi campeggiavano sulla spiaggia che era di fronte la villetta e con loro il gruppo nostro si fuse e si allargò: ci furono falò notturni, canti, mangiate e bevute, con la mia prima memorabile sbronza, mescolando insieme il forte vino rosso e quello bianco di quei luoghi con le salsicce secche sottolio.
Stetti malissimo, fino a svenire e vomitai per una notte intera. Il giorno dopo ebbi persino la febbre e ciò mi impedì di toccare ancora un goccio di vino per anni a venire fin dopo i ventitre.
Tornai a casa, il tempo della scuola si avvicinava, avevo amici, una vita pienissima, la moto.. ma mi sentivo disperatamente sola. Allora tornai con lui, Carlo, che ancora mi amava e mi stava aspettando, - dato che aveva lavorato duramente tutta l'estate - e da quel giorno diventammo inseparabili.
Vendette la Vespa e comprò una vecchia Guzzi cinquecento: lui aveva i capelli rossi – con ulteriore dispetto di mia madre - ed era assai sovrappeso, tutti mi dicevano che era brutto, che io ero assai più bella di lui ma a me faceva tenerezza.
Eravamo conosciuti da tutti: per le strade della nostra cittadina e delle colline circostanti, il tum tum tum di quel potente e grosso motore a quattro tempi rimbombava ovunque. perfettamente riconoscibile. Io imparai subito a guidarlo, non avevo la patente ma allora erano tempi diversi ed io lo guidavo spesso. Nessun vigile mi fermò mai, forse perché mi conoscevano e sapevano di chi fossi la figlia, non so. Quando avevamo la Vespa spesso vigili e carabinieri ci fermavano, rimanendo con un palmo di naso, perché era un novanta di cilindrata e ci si poteva salire in due ma nell'aspetto era del tutto identica alla cinquanta, che poteva trasportare un solo occupante. I documenti quindi erano in ordine e dovevano lasciarci andare senza altro aggiungere, molto ben diversamente da quanto sarebbe accaduto se mi avessero fermato quando io ero io alla guida della grossa Guzzi, di cui non avevo neppure l'età giusta per condurla.
Ma tutto andò sempre liscio: non cademmo neppure mai, non avemmo mai un incidente. Certo non era una moto velocissima: pesava diversi quintali ed era lunga assai più di una cinquecento moderna, aveva ruote assai larghe e grandi, però raggiungeva una velocità poco superiore ai centodieci chilometri all'ora e questo la rendeva assai sicura.
Ma certo dovevamo essere assai peculiari, entrami: quando guidavo io e lui sedeva sul sellino di dietro, dato che lui era un metro e ottanta e che il sellino si trovava di suo già più alto, perché era stato collocato sul parafango posteriore, lui era una immensa montagna lassù in cima ad una moto che sembrava guidata da un nano.
Ma a me piaceva così tanto guidare quella grossa potenza motore, mi faceva sentire forte, mi dava un senso di calma e di sicurezza e del resto non mi importavo di nulla.
Quindi, in gruppo con altri amici motorizzati o da soli, ogni santo giorno che Dio mandò allora sulla terra, con qualsiasi tempo, io e lui andavamo a fare un giro da qualche parte, a fare una merenda di piadina e sangiovese in qualcuna delle osterie che ci erano care, oppure al mare e fare il bagno, oppure gite più lunghe per visitare qualcuna delle belle cittadine di contorno: San Marino, Gradara, la Rocca delle Camminate ed altri, oppure anche solo per il piacere di guidare.
E, mentre viaggiavamo e le colline sfilavano via, mentre le vie ci mandavano il loro suono e i luoghi si avvicinavano o allontanavano, noi cantavamo.
Ad alta voce, entrambi perfettamente all'unisono, avevamo tutto il nostro repertorio di canzoni preferite.
La moto viaggiava, ci faceva da accompagnamento musicale e noi cantavamo.
Poteva dirsi felicità?

CAPITOLO DODICESIMO
La madre di Carlo, Bertino, Nuvola..
Io frequentavo regolarmente la casa di Carlo, dato che, abitando loro di fronte alla chiesa, conoscevo i suoi da sempre.
All'inizio mi accolsero con tutti gli onori: anche se molto giovane ero però assai carina, di ottima famiglia, molto brava a scuola e famosa, per quello. Inoltre c'era anche un po' di capitale, che di certo non guastava.
Lui era particolarmente attaccato alla madre e le faceva continuamente piccoli o grandi regali e sempre si piegava ai suoi voleri: era il mediano di tre figli maschi e praticamente, dato il suo buon carattere, la madre gli aveva insegnato a fare tutti i mestieri di casa e, secondo me, abusava della sua disponibilità, facendoli fare più o meno tutte le pulizie.
Abitavano in affitto un vastissimo appartamento sontuosamente arredato e stracolmo di ninnoli.
Decisamente la mia futura suocera era tutto quanto io aborrivo: parrucchiera, trucco, vestiti, feste con gli amici... aveva una vita sociale intensissima e la sua casa era sempre piena di gente per giocare a carte, mangiare oppure ballare. Sempre mi invitavano ed io andavo, anche perché Carlo si dispiaceva molto se io mi negavo.
Ma ci si accorse molto presto che eravamo piuttosto incompatibili: loro erano di destra, addirittura nostalgici, io di estrema sinistra. Ovviamente Carlo, dopo qualche discussione, decise che sarebbe stato di sinistra pure lui e questo ai suoi ovviamente non piacque. Inoltre lui a scuola non era un fulmine a ciel sereno e, poiché passava tantissimo tempo con me, non studiava mai, nonostante io lo cazziassi continuamente, per quello, dato che io ritenevo la scuola una priorità essenziale. Ma a lui piaceva ben poco e fu per tre volte rimandato a settembre con quattro materie. Il terzo anno lo ripeté, cosa che gli costò anche una sonora dose di busse, gli altri riuscì a farsi promuovere all'esame di riparazione.
Ma sua madre incolpò sempre me di essere la causa degli insuccessi scolastici del figlio.
Altri erano anche i punti di attrito con il comportamento dei suoi: non gli davano mai denaro e tenevano per sé tutto quello che lui guadagnava, lavorando duramente nei mesi estivi. Praticamente il cinema, la pizza, le merende, la miscela per la moto era tutto a carico mio, se volevo che lui stesse con me. Non che a me importasse spendere per lui il mio denaro, tutt'altro ma mi sembrava ingiusto per lui, che si vergognava molto di quella sua condizione di perenne squattrinato. La madre acquistava in continuazione vestiti ed altro abbigliamento per sé ed io trovavo questo molto egoista: ne comprasse uno in meno, che tanto era assai brutta ed aveva un gusto molto pacchiano e facesse fare al figlio la vita che conducevano gli altri suoi coetanei.
Forse avevo ragione, forse torto, mi sono poi accorta che i figli sono assai egoisti nei confronti dei genitori e pieni di pretese. Io vedevo che mia madre, nonostante fosse sempre in rincorsa di denaro, però non mi privava della possibilità di vivere la mia giovinezza. Se non ci fossero stati i miei soldi il povero Carlo avrebbe avuto molte meno possibilità di divertimento. Allora l'economia girava e tutti si era portati allo spendere e, nonostante io fossi contraria al lusso e vestissi come si usava tra i sessantottini, con jeans magliette, scarpe da tennis e il fatidico eskimo; nonostante non mi truccassi e non spendessi il mio denaro in beni così futili, però non mi facevo scrupolo nell'impegnare i miei soldi in ciò che ho altrove descritto.
E poi, su tutto, una cosa non potevo assolutamente perdonare a quella donna così frivola, e cioè di vestire il figlio sempre cercando di risparmiare, acquistando a prezzi stracciati scampoli di stoffa, per fargli cucire da una sua amica pantaloni e giacche, ad onta del risultato visivo: lui era molto sovrappeso ed aveva i capelli rossi: camicie viola o verde pisello e pantaloni e giacche giallo oro o verdone operato, tipo stoffa da divano, gli stavano veramente da cani. Il fatto è che lui non se ne rendeva conto ed era sempre tutto fiero quando la madre gli faceva cucire qualcosa, venendo poi da me a far bella mostra delle sue novità. Quando me lo vedevo apparire davanti così conciato io mi arrabbiavo moltissimo, chiedendogli se si fosse guardato nello specchio. Ogni volta litigavamo, per quello, noi che litigammo sempre pochissimo nei lunghi e numerosi anni che abbiamo condiviso. Davvero sembrava che ogni cosa che dicesse o facesse la sua mamma fosse sopra di ogni dubbio e giudizio negativo.
Comunque, alla fine di quelle discussioni, io gli dicevo che se avesse voluto continuare ad uscire con me, avrebbe dovuto vestire in modo consono. E finì che, ogni volta che mi recavo con mia madre a fare acquisti per il negozio e compravo per me indumenti, altrettanti ne compravo per lui: neppure mia mamma poteva vederlo girare con il verde pisello o il giallino addosso. quella fu una delle pochissime cose in cui io e lei ci trovavamo completamente d'accordo, in quei tempi.
Lui, però, difese sempre la madre ed i suoi e non prese mai le mie parti quando accaddero tensioni e poi veri e propri scontri. E questo mi pesò sempre molto.
Ma d'altronde anche mia madre non ci andava leggera, con lui, che non piaceva neppure a mio fratello ed allo zio.
Quindi i nostri ci osteggiarono sempre ma a noi non importava.
Sognavamo di andare ad abitare in campagna di avere centinaia di animali e dieci figli.
Lui mi amava, ero una dea, per lui.
Io amavo il professore e Tati mi portava a stare lunghe ore lontano da Carlo ma, alla fine, loro non mi avevano voluto ed io dovevo amare per vivere: ne avevo assolutamente bisogno. Sapevo che non amavo veramente Carlo ma era troppo difficile per me, era impossibile affrontare tutto quello che si nascondeva nel mio subconscio. Era molto più semplice mentire a me stessa, convincendomi di amarlo e di desiderare di vivere tutta la mia vita con lui.
Infatti così feci.
Alla fine di quella estate straordinaria ebbe inizio una delle attività più straordinarie della mia vita stessa.
Lungo la statale che correva tra la ferrovia ed il mare, appena fuori della cittadina balneare di cui sempre parlo, c'era una specie di baretto - chiosco in cui una rubiconda signora, la famosissima signora Dina, ' Regina della piadina' serviva ai turisti e ai lavoratori affamati, delle fantastiche piadine farcite con salumi di ottima qualità, annaffiando il tutto con vino genuino – anche se io allora bevevo solo birra o coca cola-.
Era un posto un bel po' strambo, costruito con tavelloni di cemento vibrato e con il tetto ondulato, il tutto dipinto con vernici lavabili dai colori molto accesi, verde rosso e bianco. Davvero un pugno in un occhio ma la piadina era davvero da primato, i prezzi contenutissimi e la signora assai simpatica. A noi, sempre alla ricerca di merende e luoghi dove trascorrere qualche ora fuori dalla città, non ce lo eravamo fatto scappare di certo. Ma un giorno che ci recammo là vedemmo che due ragazzi stavano piantando pali per fare una palizzata. Poco più indietro, sotto il piccolo pioppeto che gettava la sua ombra su di un rettangolo di terra sabbiosa, avevano costruito una tettoia e dentro vi erano legati tre cavalli. Naturalmente andammo a vedere cosa stessero facendo e fu così che conoscemmo Paolo, figlio della signora Dina e Marinella, la sua fidanzata. Avevano un paio di anni più di noi ed avevano deciso di aprire un piccolo maneggio, approfittando di quella area ombrosa e ventilata rin iva al mare, della posizione piuttosto favorevole, poiché il passaggio delle auto era notevole, sulla statale che conduceva a Rimini e, non per ultimo in fatto di importanza, il fatto che la madre avesse una vasta ed affezionata clientela che poteva essere interessata alla cosa esattamente come avrebbe offerto un ristoro a coloro che si fossero fermati per cavalcare.
Insomma, una attività avrebbe aiutato ed integrato l'altra.
Inutile dirvi che io fui la loro prima cliente, dato che quel giorno stesso presi a noleggio uno dei loro cavalli, pur se il recinto del maneggio non era ancora finito.
Non era la prima volta che andavo a cavallo, c'ero salita un'altra volta con mia cugina, l'anno precedente che ci recammo io e lei in tandem in un'altra cittadina balneare limitrofa, in cui esisteva un maneggio. Ma lì l'ambiente era assai chic, dato che era un vero e proprio centro ippico con vaste stalle ed impianti per il salto agli ostacoli. Nel maneggio dove ci misero al passo con le nostre due cavalcature, c'erano altri ragazzini e ragazzine, vestiti di tutto punto con stivali, pantaloni da equitazione e cap.
Il maestro, quindi, ci trattò con molto distacco ed io e mia cugina ci sentimmo così a disagio che non tornammo più, pur sentendo entrambe il desiderio di cavalcare.
Ma l'anno seguente io ebbi una bellissima esperienza con i cavalli, proprio nell'estate stessa in cui morì mio padre e poi per diversi mesi successivi.
La zia che mi aveva ospitato mentre lui era in fin di vita, sapendo la mia grande passione per quei meravigliosi animali, un giorno condusse me e mio cugino a fare una passeggiata dentro l'ippodromo di corse al trotto che era nella nostra cittadina, dove lei conosceva uno degli stallieri, che fu gentilissimo con noi e ci fece salire sul suo calessino per farci provare quell'ebbrezza.
Quando poi, dopo la scomparsa del babbo, tornai a casa con mia madre e mio fratello, nei lunghi pomeriggi seguenti, così tristi e solitari, io mi recai di nuovo all'ippodromo, spinta del grande amore e dal desiderio di stare tra i cavalli e gli uomini di cavalli.
Lo stalliere si affezionò subito a me e cominciò ad insegnarmi tutto quello che bisognava sapere per accudire un cavallo.
Risultò che ero decisamente portata e che quegli animali assai insanguati e nervosi, perché alimentati in modo assai energetico per farli correre con prestazioni il migliore possibile, mi accettavano con docilità, divenendo consenzienti assai più del solito a farsi accudire. Inoltre, come ho già detto più volte, ero davvero forte e sviluppata, era grande come adesso e muscolosa, per il tanto nuoto di ogni estate e la bici il pallone i pattini e tutto il resto. Quindi imparai tutto subito con grande facilità. Appena finito di mangiare, ogni giorno correvo all'ippodromo: non avevo detto a nessuno, che ci andavo, per paura che me lo vietassero, cosa assai probabile, se non certa. Ma il fatto che io uscissi e stessi fuori casa era una cosa normalissima. Così passavo ore nella lunga scuderia, dove Bertino, il vecchio capo stalliere ed ex fantino, coadiuvato da un altro soggetto un po' male in arnese e un po' tonto, del quale ora non ricordo il nome, si prendeva cura di una trentina di bellissimi animali di pura razza, tra cui alcuni erano soggetti che già gareggiavano, altri, puledri che stava domando ed allenando, poi c'era uno stallone di rango e qualche giumenta da riproduzione con i puledrini piccoli che ancora allattavano.
Lo so che sembra una favola, che un vecchio uomo di cavalli possa aver affidato alle cure di una ragazzina di undici anni animali così preziosi ma questo accadde: in breve tempo ero diventata autonoma, sapevo cosa dovevo fare e come: pulivo qualche box dagli escrementi, aggiungendo paglia pulita e fresca, mettevo in tutti le razioni di fieno e d'avena, poi andavo a prendere le giumente dal recinto grande e le riportavo nelle loro abitazioni, tenendole con la lunghina alla cavezza, seguite dai loro puledrini che trottavano loro al fianco, nitrendo. Prima di farle rientrare nei loro box, le legavo nello spazio apposito e davo loro una bella strigliata, pulendo persino gli zoccoli con l'apposito ferro, prendendoli in mano come mi aveva insegnato lo stalliere.
Intanto lui allenava i puledri di due anni che avrebbero debuttato presto nelle gare. Io lo aiutavo ad attaccare il sulky, lui da una parte ed io da quell'altra del cavallo, in modo da fare prima e, quando rientrava dopo i giri di pista, con il cavallo sudato fradicio, lo staccavo dal sulky, gli passavo la stecca con l'alcool denaturato per fare uscire il sudore dal mantello e lo passeggiavo, sempre con lunghina alla cavezza, finché non fosse stato asciutti, mentre lui ne allenava un altro. Poi lo strigliavo e lo spazzolavo alla perfezione e lo riconducevo nel box, dove lo attendeva il suo pasto.
Molto spesso accadeva che invece del sulky si attaccasse un calesse più pesante che serviva per allenamenti intesi a dare resistenza e ad aumentare la muscolatura dell'animale. Allora Bertino mi faceva salire con lui, mettendomi tra le sue gambe, mi faceva afferrare le redini e mi insegnava a guidare il cavallo, cosa che non era poi così semplice perché quegli animali erano davvero bizzarri.
Però stavo imparando assai bene e lui già parlava di venire a chiedere a mia madre il permesso di farmi fare l'iscrizione ai driver e prendere il patentino con l'assicurazione, perché diceva che voleva fare di me una campionessa.
Io ero al settimo cielo.
Tutto quello duro diversi mesi, fino alla primavera successiva, quando, un giorno, Bertino mi chiamò nella stanza dei finimenti, mi mise in mano una rivista e mi disse di sfogliarla. Non avevo mai visto nulla di simile: foto e foto di donne nude oppure vestite in modo piuttosto provocante che si accoppiavano con uomini altrettanto nudi, in posizioni piuttosto esplicite.
Io non ero capace di staccare gli occhi da quelle immagini, come ipnotizzata, mentre l'uomo mi guardava senza dire una parola.
Fu Carlo a salvarmi, quella volta, dato che lo avevo conosciuto da un po' e proprio quel pomeriggio lo avevo invitato a venire lì per vedere i ' miei ' cavalli.
Quando riuscii a scuotermi da quella lettura strabiliante ma di cui sentivo fortemente la pericolosità, resi senza commenti la rivista allo stalliere e gli dissi che stavo aspettando il mio amico, che sarebbe giunto da lì a poco. L'uomo sembrò riscuotersi lui pure, prese il giornale e mormorando come tra sé e sé, uscì dalla stanza dei finimenti e si rimise al lavoro.
Carlo giunse davvero, pochissimi minuti dopo.
Nei giorni seguenti io mi recai ancora un paio di volte all'ippodromo ma sentii chiaramente che qualcosa era cambiato, come se l'incantesimo si fosse rotto e così non tornai più.
Era molto molto tempo che non ripensavo a questo fatto che vi ho appena raccontato.
Ed oggi mi chiedo due cose: la prima è come poté mia madre non accorgersi di nulla, non sentire l'odore di cavallo che avevo addosso e sui vestiti, dato che lei aveva un olfatto piuttosto sviluppato e piuttosto noioso e se ne stava sempre con il naso all'aria in caccia di ogni cattivo odore da debellare in casa ed addosso a me. Di certo in quei mesi stava malissimo, ma....
La seconda è un semplice perché. Perché tutti da me hanno sempre e solo chiesto sesso?
E questa è una domanda che resterà senza risposta.
Quanto avevo imparato da Bertino mi risultò davvero utile e ben presto io mi offrii come aiutante a vasto raggio, nel maneggio di Paolo e Marinella, prendendomi cura dei cavalli, della loro pulizia, delle stalle, del cibo, dei secchi d'acqua, dato che non vi era l'impianto di acqua corrente.
Poi, imparando prestissimo a cavalcare assai bene e con totale assenza di ogni paura e difficoltà, comincia ad accompagnare la clientela in passeggiata lungo i campi, fuori dal maneggio, che c'era una carraia assai lunga sulla quale si poteva galoppare in libertà, oppure la mattina prestissimo, all'alba, in spiaggia, cosa che era assolutamente meravigliosa.
Acquistai anche un paio di manuali sulla monta con la sella inglese ed insieme noi tre – Carlo non montò mai a cavallo, restando a guardare me, tutto il tempo - cercammo di migliorare il nostro stile e la nostra tecnica, per poterla poi insegnare a chi veniva ad affittare i cavalli e non era aveva ancora imparato a montarli.
Infatti uno dei miei compiti principali divenne poi quello di insegnare i primi rudimenti a chi giungeva senza aver nessuna esperienza, facendo camminare e trottare il cavallo con il cavaliere, trattenendolo per la capezza con una lunghina di una ventina di metri, e facendolo muovere in tondo intorno a me: la mia pazienza e la mia predisposizione ai rapporti interpersonali mi resero molto adatta a ciò.
Quel sodalizio durò fin dopo la nascita della nostra prima figlia, fin quando io e Carlo non ci trasferimmo a Ravenna. Anzi, ricordo benissimo che andai a cavallo fino a gravidanza inoltrata.
Vissi tante avventure con quei ragazzi ed i loro cavalli, che in parte vendevano alla fine della stagione per poi comprarne altri alla primavera successiva.
Il mio primo amore fu Nuvola, una piccola cavalla sarda dal mantello sauro.
Fu lei che mi insegnò a cavalcare, fu lei che mi parlò, raccontandomi tutti i segreti dell'amore tra uomini e cavalli.
Era piccola di statura, come tutti gli esemplari della sua razza e come quasi tutti gli abitanti di quest'isola, ma fortissima, caparbia, generosa se presa per il verso giusto, riottosa e indomabile se presa per il verso sbagliato, tanto che non la si potava dare a tutti, perché se prendeva qualcuno in antipatia, lo tirava presto o tardi per terra.
Per quella ragione divenne ben presto la ' mia cavalla ', dato che anche Marinella a Paolo ebbero qualche problema con lei. Io glielo dicevo: ' Il segreto, con lei, è non andare contro al sua volontà, è assecondarla, lasciandole la possibilità di galoppare e sfogarsi un po', prima di cominciare a lavorare. '
Era troppo nevrile ed aveva bisogno di correre. Loro avevano paura della sua velocità e cercavano di frenarla, trattenendola con le briglie, cosa che la faceva arrabbiare tantissimo e quindi scalciare e sgroppare, facendoli poi cadere di sella. Io, invece, non avevo paura: le lasciavo le briglie appoggiate, tese ma non tirate, come avevo letto nel manuale, abbandonandomi completamente a lei ed al suo velocissimo galoppo, tanto che si abbassava persino di parecchio, allungandosi nelle falcate, sentendomi un tutt'uno con lei. Pesava tre quintali e mezzo ed io già ottanta chili, era piccola assai, rispetto a me ma eravamo davvero un corpo ed un'anima sola quando, sul bagnasciuga, al mattino prestissimo, lasciavo che frangesse la risacca delle onde con i suoi piccoli e fortissimi zoccoli, sentendo solo gli schizzi dell'acqua marina, il vento, il suo respiro ed il mio cuore, inebriandomi.
Purtroppo Paolo e Marinella la vendettero, a metà della seconda stagione, ad un signore che se ne era innamorato e che offrì loro una bella sommetta. Io non potei impedirlo e ne fui così addolorata da rimanere inconsolabile.
Al suo posto acquistarono Andromeda, una cavalla russa della razza del Don, saura anch'essa, ma molto alta ed esile e piuttosto nevrastenica, con la quale non legai mai, preferendo allora Pedro un grigio pomellato pacioso e pigro ma forte ed instancabile, se spronato a puntino, o Dea, una vecchia gentildonna baia, che fu poi la prima che montai, quel giorno famoso del nostro incontro. Era così mansueta che era assai affidabile e poteva portare in groppa chiunque, anche bambini piccolissimi.
Ma Nuvola aveva il vento, nel sangue, il profumo del mare e fu quello che mi fece innamorare di lei.
Anche a questi accadimenti della mia vita era molto tempo che non pensavo più e devo dire che oggi rimango alquanto shoccata rendendomi conto che il mio primo amore equino fu una irriducibile femmina sarda da cui fui separata, cosa che mi spezzò il cuore.
Sa quasi dell'incredibile, dato che, come vi racconterò, una irriducibile femmina sarda, umana, questa volta, è stata il mio ultimo amore terreno, separandosi da me e spezzandomi il cuore.
Solo ora mi rendo conto di questo, non vi avevo mai pensato.
E se avessi avuto ancora qualche dubbio sul mio vero nome di battesimo ora non l'ho davvero più.
Perché io mi chiamo ' Destino ', figlia e vittima sacrificale di questa legge incomprensibile che tutto muove e che ha mosso le mie fila con una precisione chirurgica ed una vena di, per me incomprensibile, sottile intelligente ed fantasioso sadismo.
termino questo capitolo con il testo della canzone: ' Mediterraneo sentimento ', scritto da me quaranta giorni fa, ascoltando una musica del valente musicista Giacomo
Gilio.
Sono parole scritte per la Sardegna e per tutti i suoi figli, cavalli compresi.
Ciao Nuvola, grazie.
MEDITERRANEO SENTIMENTO
musiche di Giacomo Gilio
E' il vento che porta quel colore
l'odore
l'amore delle nubi
le forre
il mirto delle dune
Il mare è come un aquilone
e vola
calando negli abissi
di sabbia
e rapide maree
Io apro il volto
alla tua voce
respiro
e credo di tornare
là dove
l'isola è il tuo corpo
E il mio è solo
il maestrale
che va
e torna profumando
rapisce il succo
delle labbra
e rompe in fretta
quel restare
M'innalzo
e vago nel ricordo
vibrando
lacrime e parole
bevendo
il cielo del tuo sguardo
Se il vento ti rincorre
son io che porgo
la mia mano
cercandoti
nell'aria della notte
Le labbra
contro le tue labbra
pregando
il sogno del creare
un mondo
nuovo per amare
Mediterraneo sentimento
di viaggi
cosmici e interiori
ricordi e vivide visioni
mi perdo e
non voglio ritornare..

CAPITOLO TREDICESIMO
Una gravidanza inattesa. L'esame di maturità.
Il matrimonio. Arriva Angela.
Durante il mio ultimo anno di liceo mio fratello mise incinta la sua giovanissima ragazza e naturalmente si sposarono.
Fu una festa bellissima, lui vestito di bianco con i capelli e la barba lunga, biondo: sembrava Gesù, tanto era bello. Fuori dalla chiesa e al pranzo di nozze ci furono grandi festeggiamenti ed acclamazioni, regali da parte dei parenti e degli amici.
Dato che lui ancora studiava ed era vicino alla laurea, vennero a vivere da noi perchè mia madre si prese come punto di impegno che lui arrivasse a quel traguardo, che si vedeva assolutamente indispensabile per la sua vita.
Io ero contenta.. andavo d'accordo con mia cognata, che era più giovane di me, parlavamo sempre, ero felice che a tavola, a pranzo, ci fosse una atmosfera serena, che ci fosse lei che aveva di nuovo portato il parlare in quel silenzio micidiale che erano i nostri pasti. Altresì mi dava molta gioia sapere che prestissimo un bimbo avrebbe portato la nostra famiglia a riaccendersi con la sua nuova vita.
Ma a maggio mi accorsi di essere io pure in attesa.
I metodi anticoncezionali che avevamo usato nei tre anni precedenti e che ci avevano fino ad allora protetto, ci tradirono.
A quei tempo era molto diverso rispetto a ciò che è poi venuto: mia madre non sapeva che io avessi rapporti con il mio ragazzo, quindi non avevo potuto prendere la pillola e gli altri metodi basati sul conteggio dei giorni fecondi, gli spermicidi locali e la famosissima ' retromarcia ', erano sistemi che presentavano una casistica di insuccesso più ampia. Infatti così accadde che il ritardo del ciclo, che mi allarmò immediatamente, dato che io sono sempre stata molto puntuale, si trasformò in una certezza quando feci uno di quei test comprati in farmacia.
Il cerchietto nella mia urina era del colore di una nuova vita.
Io, però, fui felice di quello e Carlo pure: ci saremmo sposati, avremmo avuto finalmente una vita nostra, con regole nostre, dato che le regole che gli adulti ci imponevano ci stavano piuttosto strette.
Lo comunicai subito a mia madre, senza por tempo in mezzo e lo feci con una grande tranquillità. Lei rimase alquanto sorpresa e si rabbuiò notevolmente. Mi disse che non aveva denaro per il mio matrimonio, che aveva speso tutto quello che le era stato possibile per le nozze di mio fratello e che quindi io non avrei avuto una festa.
Le risposi che non mi importava, che semplicemente ero felice di aspettare un bambino e di sposarmi. Mia madre, dato che aveva appena accettato di buon grado e senza tante tragedie il matrimonio di mio fratello, in qualche modo assorbì anche quel colpo: d'altronde ero sua figlia e lei sapeva benissimo di essere l'unica mia risorsa.
Infatti, come da preavviso e previsione, la famiglia di lui si oppose al nostro matrimonio.
La madre di Carlo ne fece una tragedia e quando lui, alquanto tremebondo, le comunicò che io aspettavo un bambino, disse cose assai pesanti sulla mia moralità e gli impose di non sposarmi, avvertendolo che se lo avesse fatto lo avrebbe disconosciuto come figlio e cacciato di casa.
Io non fui presente a quella discussione, per fortuna, avevo detto a lui che avrebbe dovuto affrontare i suoi da solo, perché intanto sapevo benissimo come sarebbero andate le cose.
Carlo in famiglia era quello che faceva tutti i mestieri di casa e portava denaro con il suo lavoro estivo: di certo per lui veniva speso assai meno di quanto guadagnasse d'estate in segheria e allo zuccherificio, dato che nel frattempo aveva preso il diploma ed era stato assunto in quella campagna stagionale che però assicurava introiti economici paragonabili quasi ad un intero anno di lavoro. Inoltre aveva ottenuto anche la borsa di studio per l'università, alla quale si era iscritto al primo anno l'ottobre precedente.
Carlo ha tre anni più di me ma, essendo io andata a scuola un anno prima ed avendo lui ripetuto la terza superiore, praticamente dal punto di vista scolastico era solo un anno avanti a me.
Avrebbe compiuto ventun anni a settembre.
Furono mesi difficili: mia madre arrabbiata con me, con lui e furibonda con i suoi, i suoi che ne dicevano di tutti i colori su di me, che io l'avevo fatto apposta proprio per sottrargli il figlio, che si era dimostrato così bravo a scuola da riuscire a prendere il diploma – cosa che al fratello maggiore non era fino a quel punto riuscito e che era mostrata, insieme alla frequenza positiva all'università, come fiore all'occhiello, con grande orgoglio al vasto entourage festaiolo e mondano di mia suocera. -
Io mi ero resa conto benissimo di quanto fosse avida ed egoista quella donna e non mi sorprese il suo comportamento, però mi ferì alquanto.
Carlo non volle ascoltare ragioni e disse loro che mi avrebbe sposato lo stesso.
Visse i mesi che lo separavano dal nostro matrimonio come in una specie di limbo, andando a dormire a casa sua, sì, ma trascorrendo il resto del tempo fuori, come fosse un profugo. Spesso veniva a pranzo da me, altrimenti stava a casa di un amico carissimo.
In quell'anno mi aspettava un altro appuntamento importantissimo: l'esame di maturità, che di certo rappresentava una pietra miliare nella vita di una giovane donna. Ero sempre stata promossa con ottimi voti, a parte in prima liceo che il ' mio ' professore mi aveva rimandato in greco, dato che allo scritto avevo avuto delle difficoltà. La grammatica e la sintassi greca non è cosa che si possa inventare né assimilare solo ascoltando le spiegazioni: per raggiungerne la padronanza che lui ci chiedeva era necessario impegnarsi in lunghi e costanti esercizi, cosa che io quell'anno non avevo fatto, travolta da tutto quello che era successo proprio con lui. Così mi rimandò.
Io subii il colpo come mi avesse picchiato, mi avesse fucilato lui stesso con le sue mani e, nonostante avessi vissuto tutte le avventure estive che vi ho raccontato, ugualmente studiai così tanto, in compagnia di altri due che avevano subito la stessa punizione, che all'esame di riparazione superai brillantemente la prova, sia scritta che orale, venendo promossa con sette.
Quello studio indefesso ed approfondito mi permise di vivere poi di rendita per tutta la seconda e la terza liceo, in modo che arrivai ad essere ammessa all'esame di maturità con la media del sette abbondante, quasi otto. Quello che mi abbassava la valutazione era il sette in condotta ed il sei in matematica, che il professore di quella materia mi affibbiò a tradimento. Dico questo perché quegli anni furono assai peculiari, dato il fermento del movimento studentesco. Alcuni professori continuarono ad insegnare seguendo il loro metodo prestabilito dalla precedente lunga consuetudine, altri cercarono nuovi metodi e nuovi contenuti ma altri ancora, tra cui il mio professore di matematica e fisica, presero il tutto con faciloneria. Infatti lui entrava in classe e ci chiedeva: 'Volete fare lezione, ragazzi? ' ed ovviamente a quella sua stupida ed inutile domanda seguiva un nutrito coro di no. Quindi avveniva che un gruppetto di noi si recasse intorno alla cattedra, trascorrendo l'ora a parlare con il prof, mentre altri studiavano le materie delle ore successive o, peggio ancora, giocavano a carte, dato che l'unica cosa che lui ci chiedeva era di non fare chiasso. Era il professore del bengodi, amato per quello da tutti. Io non ero d'accordo su questo modo di gestire quel tempo scolastico e dissi al professore ed ai compagni, d'accordo con il fraterno Sandro ed altri ragazzi impegnati nel movimento, che avremmo dovuto trovare modi alternativi e non nozionistici di affrontare lo studio di quelle materie ma, ovviamente, essendo in netta minoranza, fummo zittiti e così si trascorsero i tre anni del liceo senza aprire un libro né di matematica né di fisica, senza far un esercizio né un compito in classe, con la soluzione del sei politico a fine anno.
Per l'ammissione all'esame di maturità il professore propose interrogazioni volontarie su argomenti a scelta che io pure affrontai con un risultato accettabile, dato che quelle materie non mi piacevano affatto e che lui non spiegava mai ma la votazione finale che mi assegnò, il sette in fisica e il sei in matematica, furono un handicap che io davvero non meritavo: se lui avesse fatto il suo lavoro come gli altri professori, io di certo avrei ottenuto votazioni migliori.
Ma era giugno e noi eravamo in pieno marasma per la mia gravidanza e l'esame diventò una priorità minore.
Ugualmente io sentivo l'emozione per quel traguardo, perché, anche se avevo deciso che l'anno seguente non mi sarei iscritta all'università, dato che il bambino sarebbe nato a febbraio, però la mia intenzione era quella di iscrivermi poi e di laurearmi lo stesso. Quindi la maturità e la votazione riportata restavano assai importanti.
Studiai a lungo tutto l'anno, preparandomi coscienziosamente.
All'esame, nello scritto di greco mi aiutò un po' la mia cara Nadia che, essendo bravissima, venne contro alle sue convinzioni e mi passò un foglietto con la traduzione, eseguita da lei in tempo record proprio per poter aiutare qualche amico. Infatti io avevo fatto alcuni errori, dato che il compito era assai difficile: ci avevano dato una versione complessa e fumosa che falcidiò le fila degli esaminandi. Quello fu il primo anno di purga dopo i precedenti, che avevano visto uno sbando totale, rivoluzionando il consueto metro di giudizio. Quindi, dalle votazioni altissime si passò a quelle penalizzanti di quell'anno e di quelli a seguire. In particolare nella nostra classe vi fu la richiesta di moltissime bocciature ed il nostro commissario interno, il professore di filosofia, ebbe il suo da fare per salvare la pelle a molti. Comunque, ugualmente, sette furono i respinti e chi aveva un punteggio basso in condotta, che quasi sempre dipendeva dall'impegno politico e dalle lotte sostenute contro il preside per ottenere gli spazi decisionali per gli studenti, se non fu bocciato fu promosso però con una votazione finale molto più bassa.
Infatti io, che ero candidata per un 60 o un cinquantotto, dato che ero stata ammessa con nove in italiano scritto ed orale, otto in storia e filosofia, latino e greco orale e geografia astronomica, sette in latino e greco scritto, otto in filosofia, sette in fisica, sei in matematica, otto in ginnastica e religione e sette in condotta, adducendo come pretesto che ero andata fuori tema nel compito di italiano, fui promossa con trentasette.
Quando affissero le votazioni eravamo tutti lì fuori e rimanemmo gelati: sette respinti, un solo sessanta, - quello di Nadia, che era assolutamente fuori di discussione, sia perché lo meritasse in assoluto ma anche perchè faceva parte di Comunione e liberazione, - il cinquantasei di Sandro, che stupì molto dato il suo sette in condotta, qualche altro cinquanta a ragazzi appartenenti al medesimo confessionale ed il resto di noi tra il trentasei e il quarantadue.
Il mio trentasette fu quindi uno scandalo. Addirittura alcuni miei compagni che avevano vivacchiato sulla sufficienza scarsa tutti i cinque anni di liceo ebbero votazioni superiori a quaranta, tra cui la stessa Tati, che di certo non si era mai distinta, né per voglia di studiare né per impegno, dato che poi si sarebbe iscritta all'ISEF, per diventare insegnante di ginnastica.
Ma io ero incinta: avevo infranto un muro che mi collocava in una particolare dimensione.
Alle mie lacrime incredule e deluse il professore di filosofia mi disse che aveva dovuto lottare per salvare tanti e che qualcuno aveva dovuto pagare per quello sforzo. Praticamente fui punita per aver osato essere una ragazza impegnata pubblicamente in politica e poi aver avuto rapporti sessuali prima del matrimonio.
Me ne andai ad occhi bassi, senza salutare nessuno, parlare con nessuno. Quel mondo, il mondo della scuola e della giovinezza era ormai definitivamente finito per me.
Giorni dopo ricevetti un telefonata dal mio professore di italiano che si scusò a nome di tutti. Il titolo della prova di italiano ci chiedeva di spiegare la poetica di Giacomo Leopardi alla luce degli accadimenti della sua vita. Amavo Giacomo leopardi. Avevo letto, oltre alla maggior parte delle poesie, tutto il suo ' Zibaldone ', trovando in quella sequela di pensieri riflessioni e spunti poetici una vastissima eco del mio cuore. Avevo studiato la storia della sua vita seguendo come ogni accadimento fosse nello stesso tempo frutto e motore di esplosioni poetiche: il dolore di vivere che diventava poesia.
Per quel componimento avevo scritto sei fogli protocollo in poco più di un'ora ed avevo consegnato per prima, uscendo dall'aula magna dove eravamo tutti riuniti per sostenere la prova, seguita dagli sguardi di invidia di molti. Avevo trattato approfonditamente gli accadimenti della vita del poeta e li avevo collegati alla sua poetica con il grande trasporto che provavo per lui e fu proprio il narrare la sua avventura umana che mi fu imputato come fuori tema.
Il professore mi disse che il mio era il più bel tema che mai avesse letto nella sua carriera e che l'accusa di essere uscita dal postulato era assolutamente falsa e fuorviante. Inoltre mi chiese, a nome di tutti, di partecipare alla cena di festeggiamento, dato che avevo detto, amareggiata, che non sarei andata.
Accettai.
Al lungo tavolo, come per caso, mi trovai seduta quasi difronte al ' mio' professore. Ci guardammo lungamente, perfettamente consci che quello sarebbe stato il nostro commiato, cosa che effettivamente fu, dato che, come ho già anticipato, ci rivedemmo poi solo quella volta, la primavera successiva, quando gli portai la mia bambina e, quarant'anni dopo, quando io sola vidi lui, per le strade della nostra città.
Quanto loquaci ed espressivi possono essere sguardi silenziosi. Quanto amore ci si può dare senza sfiorarsi, in un solo attimo. Fino a riempire ere geologiche di parole e di baci.
Ma la mia vita aveva deciso per me.
Io e Carlo ci sposammo i primi di ottobre, in comune.
Al matrimonio vennero poche persone: della sua famiglia solo i fratelli. Anche pochi amici corsero a festeggiarci in quella mattina brumosa che piovigginava.
Io ero vestita con un abito premaman color carta da zucchero, i soliti capelli corti ramati ed indomabili e già evidentemente futura madre, che al quinto mese di gravidanza la pancia era notevolmente aumentata. Lui indossava un paio di pantaloni marroni ed un maglione nero che aveva acquistato mia madre . Non volle giacca non volle camicia e cravatta. Io mi sarei sposata volentieri in jeans ma non mi andavano più e acconsentii alle insistenze di mia madre ad optare per un vestito. Lo odiai, quel vestito, che non misi mai più, dal primo momento che lo indossai fino a quando non riuscii a toglierlo, la sera, per indossare i miei pantaloni della tuta.
Nella bella e vasta sala consigliare un assessore con la fascia del comune della nostra città ci fece dire le frasi di rito, poi ci porse le sue congratulazioni, stringendoci la mano e mettendomi tra le braccia un mazzo di fiori con il nastro recante i colori di quella fascia.
Non sono mai stata imbarazzata nella mia vita come quel giorno.
Scendemmo le antiche scale ed uscimmo dal palazzo del comune. Qualcuno gridò auguri, partì un piccolo applauso, volò un po' di riso. Mi misero in mano il bouquet che io gettai verso quel piccolo gruppetto che ci stava di fronte. Non ricordo chi lo prese, ricordo solo che pensai che Tati non era venuta, che era il matrimonio più triste che avessi mai visto. Carlo era come inesistente, di certo rattristato dall'assenza dei suoi.
Tagliai corto, allora, accusando una stanchezza che provavo davvero, salutammo velocemente gli amici e ci incamminammo a piedi, con lo sparuto gruppetto dei miei cucini e di qualche zio, verso la casa di zia Teresina, che abitava a mezzo chilometro da lì. Niente auto, niente fiori, niente baci, niente di niente.
La zia, poveretta, aveva cucinato per tutti un semplice pranzo di festa, come fosse una domenica qualunque, con i cappelletti in brodo ed il lesso. La torta venne tolta dalla sua custodia di polistirolo ed io la feci tagliare direttamente in cucina: eravamo tanti per il salottino, meno di una ventina comunque, ma tanti per un tavolo ed un divano di famiglia. Ci furono brindisi? Non li ricordo. Qualche zio mi consegnò una busta con dentro un po' di denaro. Dopo un paio d'ore eravamo già a casa mia: mio fratello e sua moglie, che avrebbe partorito di lì ad un mese, già dal giorno del loro matrimonio dormivano nella camera che era stata di babbo e mamma, mia madre si era trasferita nella mia cameretta, che era la più piccola e noi alloggiammo in quella che era stata di mio fratello, dove fu aggiunta una rete al mio lettino. Carlo aveva con sé una valigia con un po' di biancheria, un paio di jeans, due maglioni, un paio di scarpe e un portafoglio, souvenir di Venezia, con diecimila lire dentro: i suoi si erano tenuti persino la borsa di studio del secondo anno dell'università, che erano arrivati da poco.
Ma eravamo giovani.
Io non so veramente cosa ho provato quel giorno.
Vedete che ho ricordi precisi di tutto ma il giorno del mio matrimonio con Carlo è avvolto in una strana nebbia che scolora e nasconde tutto. Ricordo solo che mi sentivo triste, che mi dicevo quanto io valessi poco per tutti quanti. Eppure avevo accudito tanti in ospedale, durante quegli anni: svariate zie, il fratello stesso di Carlo, che ebbe un incidente con la moto, persino Tati, quando tentò di suicidasi ingollando un po' di pillole. Eppure io sentivo di aver amato tanto tutti, quei compagni di scuola che non erano venuti neppure a salutarmi, quei parenti che non si erano preoccupati di rendere più allegra quella festa così dimessa.
Mi vergognai di loro, mi vergognai del mondo intero. E non fu affatto bello.
Un mese dopo il matrimonio, per strada sotto casa di Carlo, di fronte al negozio di mia madre, incontrai sua madre che, vedendomi a qualche passo da lei, allargò le braccia verso di me, chiamandomi per nome. Mi abbracciò e mi fece una gran festa, dicendomi che ero diventata proprio una bella ragazza e chiedendomi di andare a pranzo da loro, la domenica prossima. Io rimasi impietrita dallo stupore e non seppi fare altro che ricambiare tiepidamente quell'abbraccio di Giuda ed accettare l'invito, mormorando poche prole di circostanza. Quando mia suocera si allontanò, accomiatandosi, attraversai la strada ed entrai nel negozio. Mia madre aveva seguito tutta la scena da dietro la vetrina e mi disse, asciutta, che ora, dato che soldi da spendere non ce n'erano più, ecco che erano risaltati fuori.
Io pensai, tra me e me che avrei dovuto mandare tutti a quel paese ma sapevo quanto Carlo amasse la madre e quanto avesse sofferto di doversi sposare così. Non che ne avesse parlato molto: lui era uno che non parlava mai di sé, di ciò che provava, ma io sapevo che aveva sofferto e stava male per l'assenza dei suoi.
Diciamo che il nostro rapporto era profondo nel campo dell'affetto, anche da parte mia ma piuttosto superficiale. Vivevamo lo giornate insieme, facevamo cose decidendole insieme ma di quello che provavamo non parlavamo mai. Fu così per tutto il nostro tempo comune.
Ripristinati il rapporti con i suoi ci recammo a novembre da una sua zia che abitava a Venezia e vi trascorremmo un mese. La città lagunare nella nebbia era bellissima. La girammo in lungo ed in largo, a piedi e per ogni calle e ponte, Carlo mi fece fotografie con la sua Konica che aveva acquistato l'estate precedente: lui amava fotografare e soprattutto amava fotografare me ma io mi vedevo sempre bruttissima, in quelle foto e gli chiedevo ogni volta cosa ci trovasse in me. Lui mi rispondeva dicendomi che ero sciocca, che io ero molto bella: era molto innamorato di me, era affettuoso, mi affibbiava nomignoli strambi e buffi, tipo ' Talpona ingenua ' dato che non vedevo nulla e che ero talmente ingenua da cadere in ogni trabocchetto che lui mi tendesse. Io mi fidavo ciecamente di lui e qualsiasi cosa mi dicesse per me era verità. Più volte mi fece credere cose strambe ed io rimanevo come una scema quando mi accorgevo che mi aveva preso in giro, spesso tra i risolini di tutti gli amici. Era anche piuttosto dispotico, si faceva sempre quello che voleva lui ed era un vero bastian contrario, rispondendo di no a tutte le mie richieste e proposte. Esattamente come mia madre. D'altronde Carlo è del segno della Vergine, come lei, come fu mio padre e come accadrà negli anni a venire con l'ultima donna della mia vita. Io sono un acquario ma ho l'ascendente in vergine: decisamente con quel segno zodiacale ho un conto aperto.
Quindi, ogni volta che volevo fare qualcosa avevo di fronte a me due o tre giorni di discussioni, dopo di cui lui si convinceva ed acconsentiva. E questo fu, dal primo giorno fino all'ultimo, per ogni cosa.
In quei giorni a Venezia io credo che lui fosse assai felice: i suoi si erano riconciliati, mi amava e ci eravamo sposati, la città era emozionante. Mi baciava e mi diceva ti amo, in continuazione, mi teneva sempre abbracciata: io avevo un estremo bisogno di quel contatto, avevo bisogno di quella presenza: stare sola era per me una sofferenza incredibile, una paura profonda. Lui era allegro, cantavamo sempre. Facevamo progetti per la nostra futura casa in campagna ed i prossimi nove figli dopo quello che avrebbe visto di lì a poco la luce.
A tutti sembravo felice, tutti mi invidiavano. Ma io so che non lo ero.
Di una cosa però ero di certo felice ed emozionata: del bimbo che stava per nascere, e dico bimbo perché, dato che nella famiglia di Carlo erano nati solo maschi da tre generazioni, si supponeva che fosse un maschio egli pure.
Comprai libri di pedagogia e puericultura che lessi avidamente. Mi preparai ad accogliere la mia creatura con tutto l'amore che era in me. Gli scrissi poesie.
La prima poesia venne scritta da me a cinque anni e mezzo, in prima elementare, per il mio orsetto. Da allora la poesia non mi ha mai abbandonato. Magari ha latitato per lunghi periodi, ma ogni volta che mi sono risvegliata all'amore è sempre stata con me ed in me. Avevo scritto poesie per il professore, per il mare i tramonti per gli alberi. La natura mi emozionava in modo potente. E quella creatura che era in me e che sentivo muovere imperiosamente, era una fonte di magia.
La gravidanza fu buona ma ingrassai molto, giungendo alla fine di essa ad oltrepassare i cento chili per la prima volta nella mia vita.
Io mi sentivo molto appesantita e stanca, avevo la pressione bassa e mi davano fastidio tutti gli odori, soprattutto quelli di cucina. Nel mese di settembre un amico dei miei, quel famoso farmacista che mi aveva salvato la vita, dato che possedeva una piccola azienda di trasformazione di frutta, mi assunse per quel poco tempo che mi separava dal compimento del settimo mese e questo perché dello stipendio avevamo assolutamente bisogno ed inoltre avrei potuto godere dell'indennità della maternità. Ma dopo due o tre giorni svenni sul lavoro. Davvero non potevo stare in piedi tutte quelle ore, con la pressione così bassa. Allora il farmacista si comportò da vero gentiluomo e mi disse di non preoccuparmi per nulla, che mi avrebbe ugualmente pagato e tenuto in regola per accedere alle convenzioni ma che stessi pure tranquillamente a casa e pensassi solo al mio bambino. Devo dire che devo molto a quell'uomo. Se ne è andato da tempo...... lo ringrazio con tutto il mio cuore di quello che ha fatto per me.
Quel denaro fu prezioso: acquistammo dal figlio di una vicina di casa, per centodieci mila lire - una vecchissima auto, un Maggiolino Wolksfwagen di sedici anni: era un vecchio bidone sfiatato ma almeno potevamo muoverci: in moto con la pancia era assai scomodo e pericoloso e portare il bimbo con noi, poi, impensabile. Da un po' avevamo venduto la vecchia Guzzi perché aveva un difetto meccanico alla frizione che ci lasciò spesso a piedi. Trovare ogni volta i pezzi di ricambio era un'impresa notevole, da svolgere tra i ferrivecchi di tutta la Romagna. Trovammo uno che lo pagò bene e con quei soldi acquistammo un Aermacchi duecentocinquanta Ala d'ora, un po' assettato da corsa, con il manubrio stretto e le gomme a semi-pera per piegare meglio le curve. Raggiungeva i centoquaranta all'ora, di velocità e noi andavamo sempre sparati dappertutto. Ma ora era tutto cambiato. E così comprammo al nostra prima auto.
Poi acquistammo tutto il necessario per il bimbo: lettino, carrozzina, box e mia madre mi regalò tutto il corredino.
A novembre era nato il primo bimbo di casa: ero diventata zia di un bellissimo maschietto biondo. Lo tenevo in braccio e pensavo a quando avrei stretto a me il mio piccolo. Desideravo moltissimo che nascesse ma i giorni sembravano non passare mai.
Finalmente venne il momento della scadenza del tempo ma non accadde nulla. Mi recai a fare un controllo ed il ginecologo mi disse che il bambino non era girato bene e mi fece fare una lastra con la quale si vide che veniva giù di spalle, con la nuca piegata. Ma il medico mi esortò a non preoccuparmi, che di certo al momento giusto si sarebbe girato. Guardando quella lastra, che era come una vera e propria fotografia al negativo del mio bambino, mi commossi moltissimo, anche perché ci accorgemmo che si stava succhiando il dito nella mia pancia. Si vedeva molto chiaramente.
Qualche giorno dopo sentii dei dolori e una forte tensione al basso ventre: la pancia, che fino a quel momento era altissima tanto da rendermi difficile anche il respirare, mi si era abbassata all'improvviso. Mi recai in ospedale e mentre mi visitavano mi si ruppero le acque: era sera, una sera di febbraio dell'anno millenovecento settantaquattro. Avevo da pochissimi giorni compiuto diciannove anni.
Mi ricoverarono. Non subentrando altre doglie per tutta la notte mi tennero a digiuno e alle sei del mattino mi prepararono per un parto pilotato, mettendomi una flebo con un medicinale per l'induzione delle contrazioni.
Ero sola, ero stata sola tutta la notte. Alle 8 del mattino cominciai ad avere le doglie espulsive e cominciai a spingere. Ma nulla accadeva.
I dolori crescevano di intensità e io spingevo sempre più forte.
Partorimmo in dodici, quella mattina, io fui la prima ad entrare e l'ultima ad uscire. Tutte le altre future mamme arrivavano alla sala parto, - che era adiacente a quella travaglio dove io mi contorcevo in quel lettino dalle lenzuola sudate, in preda ad un caldo terribile seguito da un altrettanto terribile freddo - cacciavano due grida ed il bambino usciva. Io: spingevo e spingevo, ma nulla.
Cominciai a piangere, stavo malissimo. Le ostetriche mi sgridarono ammonendomi che stavo spaventando le altre partorienti. Io chiesi loro aiuto, le implorai di fare qualcosa, qualsiasi cosa, anche di farmi morire ma che facessero cessare quell'atroce dolore: le doglie, indotte dal medicinale, erano vicinissime ed impietose, ad ognuna avevo conati di vomito e le viscere mi si rivoltavano ma loro mi comandarono di smettere di lamentarmi, accusandomi di essere noiosa, di non spingere bene, nel modo giusto. Io mi impegnavo sempre di più ma ormai ero sfinita..
Mi lasciarono lì ore, fino a mezzogiorno, da sola. Loro erano attorno alle altre oppure preparavano i letti ed il resto, parlando fra di loro di quello che avevano fatto la sera prima. Ricordo ancora molto bene i discorsi di una che si lamentava di un litigio avuto con il marito a causa della suocera. Il tempo trascorreva e di me non si curavano. Venne un paio di volte la capo ostetrica a visitarmi, mi disse che ero al massimo della dilatazione, che se mi fossi impegnata, con poche spinte lo avrei fatto, il bambino. Io davvero stavo spingendo con tutte le mie forze ma il bambino non nasceva affatto.
A mezzogiorno arrivò il primario che si arrabbiò furiosamente con tutti, dicendo che erano tutte pazze: ' Ma me la volete far morire, questa povera bambina!!!!!??? ' gridava ed alludeva a me. ' Perché non mi avete chiamato prima??? ' Era da lui che mi ero sempre recata ogni mese per i controlli, lui mi conosceva bene, era anche amico di mio padre.
Mi fece immediatamente portare in sala parto: io ero sfinita. Il battito del bambino stava diventando sempre più fievole. Mi applicarono la ventosa tre volte, gonfiandomi come una mongolfiera. Nulla.
Poi mi fecero la manovra di spingere a monte della pancia assecondando la doglia. Fu terribile. Mi sembrò di sentirmi scappare fuori gli occhi dalle orbite. Tre volte anche quella. Nulla. Allora il primario mi tagliò.
Non mi fece anestesia, mi disse il motivo ma non me lo ricordo. Sentii perfettamente il taglio ma qualsiasi cosa, che facesse qualsiasi cosa: anche la morte era meglio di quel dolore che era pazzesco. Mi tagliò la vagina e l'utero a T, ebbi ancora due doglie e finalmente la bambina uscì: pesava quasi quattro chili.
Aveva la fontanella già calcificata e quindi la testa non aveva cambiato la sua forma allungandosi e seguendo il canale del parto. Era grossa, aveva due spalle da gigante, non sarebbe passata mai. Aveva sofferto tantissimo, la mia bambina, forse come me: avrebbero dovuto praticarmi un cesareo ore ed ore prima. Il suo nasino era tutta ammaccato e livido e così restò per qualche mese. Quando me la fecero vedere sembrava un mostro, così livida e gonfia.
Io ero volata via: sentendola uscire da ma avevo sentito il più immenso sollievo mai provato e che mai più avrei provato, poi, quasi svenni.
Mi cucirono, più di quaranta punti, nella semi incoscienza sentivo i fori dell'ago nella mia carne e pensavo che mai e poi mai avrei potuto affrontare di nuovo una cosa così.
Mi portarono in camera..
Lì ad aspettarmi c'era Carlo che fece le foto alla piccola: era molto emozionato. Mia madre era arrivata dopo la chiusura del negozio.
Io ero così stanca e mi sentii disperatamente sola. Raccontai la terribile esperienza che avevo appena vissuto ma questo non sembrò toccarli particolarmente.
Anche se lui lui fu affettuoso il mio dolore restava comunque semplicemente una cosa mia. Mia madre disse che davvero la piccola aveva un pessimo aspetto.
Dato che non avevamo pensato a nomi per una femmina, rimanemmo un po' incerti, poi decidemmo di chiamarla Angela. Carlo mi disse che era felice e mi abbracciò. Io sono certa che lui lo fosse. Io pure lo sarei stata, desideravo quel figlio ma avevo sofferto troppo. Dentro sentivo una rabbia feroce, avrei voluto urlare ma non dissi nulla.
Dopo un po', finito l'orario di visita, andarono via e rimasi sola con la bambina che dormiva nella culla accanto al mio letto, sfinita anch'essa. Mi alzai per andare in bagno senza chiamare nessuno e mi guardai nello specchio: avevo tutti i capillari del viso e degli occhi scoppiati, ero un mostro.
Mi sentivo una bestia da macello perché così ero stata trattata, forse peggio.
Fu davvero terribile. Ma non ebbi tempo di riposare.
La piccola, il giorno dopo che fui dimessa, cominciò a stare male: rigurgitava tutto il latte artificiale che beveva dal biberon. Infatti, a causa della mia elevata miopia, non ho potuto allattare nessuno de miei figli. Ogni volta ebbi montate lattee abbondantissime e piansi, su quel dono di Dio che andava sprecato. Inoltre avevo un gran dispiacere di non poter provare la dolcezza dell'allattamento, del sentire che la mia vita stava dando la vita alla mia bambina. Più volte ho provato la tentazione di offrire loro il mio seno comunque, almeno per una volta ma poi, pensando che si sarebbero potuto stranire per il ritorno al biberon, non lo feci mai.
La piccola succhiava avidamente ma poi rigurgitava quasi tutto. Ci allarmammo e la portammo da un pediatra di fronte a casa, amico di famiglia: lui ci disse che andava tutto bene, che era normale quello che stava accadendo ma il giorno dopo Angela peggiorò: era quasi letargica ed aveva diarrea.
Decidemmo allora di portarla in ospedale.
Fu immediatamente ricoverata e messa sotto flebo. Ci dissero che molto probabilmente sarebbe morta: aveva una gastroenterite grave ed era molto disidratata. La temperatura si era alzata ed era passata a febbre, c'era il rischio di convulsioni. Io, con i punti ancora non assolutamente rimarginati, perché da sempre riparo le mie ferite, anche quelle del corpo, in modo lentissimo, stetti giorni seduta su di una sedia, accanto alla mia creatura, controllando il flusso della flebo, vegliandola, cambiandola, cantandole piano canzoncine, chiedendole di non morire, di rimanere con noi. Carlo stava con noi appena poteva: eravamo annichiliti.
Per fortuna Angela si salvò, ricominciò a mangiare, succhiando i pochi grammi del nuovo latte che le porgevo con il biberon e cominciando a piangere.
Io avevo tantissimo latte, il seno mi faceva male, mi diedero pillole per mandarlo via: era una follia.. La mia bambina moriva a causa del latte artificiale ed io dovevo subire quella grave onta.
Piansi tanto: quel cibo d'amore era di nuovo un cibo di morte.
Per fortuna lei sopravvisse perché era molto forte, solo che stette male per anni. Fu sempre sotto peso e, dai zero ai tre anni subì tredici ricoveri. Ebbe anche più volte le convulsioni.
Una volta ero sola in casa quando lei stette male ed uscii per strada - allora eravamo già in campagna – e cercai di fermare le macchine che passavano. Lei era tramortita svenuta tra le mie braccia. Diversi corsero via.. fu molto brutto.
Ogni volta che la piccola stava male e veniva ricoverata in ospedale io passavo giorni e notti accanto a lei, su di una sedia, colta dall'angoscia, dalla paura e da un senso di impotenza che faceva più male di tutto.
Comunque quella prima volta si salvò e dopo un paio di settimane fummo dimesse. Tornai nella casa di mia madre ed iniziai il ritmo della vita di una madre.
All'improvviso mi sentii cambiare: fu come si aprisse una porta e il sole entrasse a rischiarare una parte della stanza che prima non era visibile. Capii ad un tratto e tutto in una volta cosa volesse dire essere genitori, cosa significhi la parola abnegazione. Pensai a mia madre, al suo punto di vista, alla sua vita dall'altra parte della barricata.
Una porta si era aperta ma altrettanto chiaramente ne sentii un'altra chiudersi: non ero più una figlia ma una madre.
La mia vita era radicalmente cambiata.


CAPITOLO QUINDICESIMO
Avventure equestri
Fu proprio Nuvola a fermi provare il brivido di volar via di sella.
Nel primo inverno, dopo la tardiva apertura del maneggio, Paolo e Marinella avevano tenuto le due cavalle, Dea e Nuvola, vendendo il vecchio maschio baio di cui ora non ricordo il nome. Ogni tanto noi andavamo a trovarli a casa loro e io e Marinella facevamo una passeggiata a cavallo, anche perché le due fanciulle equine avevano bisogno di muoversi, soprattutto Nuvola, che era più giovane e inquieta.
I nostri due amici vivevano con la madre di lui, la famosa Dina, regina della piadina, in una grande casa nelle campagne dell'entroterra riminese, tra campi di insalata, patate fragole e verdure varie. C'erano perciò le carraie, che formavano una dedalo di percorsi da un podere all'altro sui quali si poteva cavalcare abbastanza tranquillamente, senza trovare traffico, attraversare strade asfaltate ed altro che infastidisse le nostre cavalcature. Però, dato che eravamo ancora assai inesperte entrambe, i nostri rispettivi ragazzi ci raccomandavano sempre di non galoppare ma di restare al trotto, che era una andatura più facile da tenere sotto controllo. E noi così facemmo, almeno per quasi tutta la durata della prima di quelle numerose passeggiate. Certo, trottare è bellissimo, ci si gode il panorama di ciò che si attraversa, si può tranquillamente chiacchierare con chi ti cavalca a fianco ed è di certo una andatura poco pericolosa, dato che si può fermare con molta facilità in pochissimi istanti.
Quel giorno era una bellissima domenica di dicembre, con il sole piuttosto lucente ed il cielo azzurro e non faceva affatto freddo: io montavo Nuvola e Marinella aveva preferito Dea, che era molto più tranquilla. Infatti all'inizio Nuvola ebbe qualche riottosità, cacciò una sgroppata, dato che da diversi giorni non veniva mossa ma era stata chiusa nella sua stalla. Io però riuscii a calmarla e poi, mettendola ad un bel trotto veloce, la impegnai a fondo fisicamente, in modo che si stancasse. La passeggiata filò via liscia senza problemi: nessun cane aggressivo ci corse dietro, come succedeva spesso, né ci trovammo motorini rombanti o altre pericolose situazioni improvvise. Trottammo per una mezz'ora buona poi decidemmo, essendoci allontanate parecchio da casa, di girare le cavalle e tornare verso casa. Facemmo qualche minuto di passo per riprendere un attimo fiato e poi ripartimmo al trotto, che la strada da percorrere era ancora lunga. Ma io avevo voglia di galoppare. È inutile, per me andare a cavallo vuol dire galoppare, non c'è verso, fin dall'inizio è sempre stato così. Allora dissi a Marinella: ' Senti, che ne dici se facciamo qualche minuto di galoppo? Abbiamo visto che qui intorno è tutto tranquillo... così ci divertiamo un po'. Poi mettiamo le cavalle al passo ed arriviamo a casa che sono già asciutte. '
La mia amica, che non era spericolata come me, mi guardò un po' dubbiosa, poi, forse per non passare da fifona e dato che comunque, in teoria, la più esperta era lei, acconsentì. Fu un attimo, appena toccammo con i talloni il costato delle nostre cavalle, essendo ancora piuttosto piene di energie, partirono al galoppo.
Ma una cosa non sapevamo, noi due, amazzoni ancora piuttosto ingenue e senza esperienza e cioè che il cavallo è sempre assai contento di tornare a casa, alla sua stalla, dove sa che lo attende la biada e l'acqua fresca. Così, Nuvola e Dea da un galoppo un po' trattenuto passarono ad uno alquanto più disteso, aumentando la velocità e quando Marinella mi gridò di fermarmi, io assolutamente non riuscii a convincere la velocissima cavallina saura a rallentare: anzi, sentendo la stalla avvicinarsi, lei cominciò a galoppare ancora più forte. Dea, che se pur vecchia aveva il suo orgoglio, abbassò il collo, sottraendosi un po' alla forza del morso e ci si mise di impegno per raggiungerci. E lì Marinella fece il più fatale degli errori, cominciò a gridare: ' Aiuto, Ferma.. Cado!! ' cosa che non fece altro che gasare di più le nostre amiche a quattro zampe che, se possibile, si lanciarono ancora più a pancia a terra. Non era possibile fare nulla, io non riuscii neppure a pensare, tanto fu tutto così veloce: qualche centinaio di metri prima della casa dei miei amici la stradina sterrata faceva una stretta curva a gomito, nascosta da una alta siepe verde che iniziava poco prima. Le cavalle si trovarono ad affrontare quel cambiamento di direzione lanciate alla loro massima velocità e si comportarono seguendo la loro natura e cioè abbassandosi ancora di più e scartando di lato velocissime. La scena fu bellissima: Marinella, che era dietro, vide Nuvola scomparire alla sua vista in uno scarto repentino e me, scaraventata esattamente dalla parte opposta, centrando in pieno la siepe, allora gridò ancor più forte ed io sentii, mentre, stordita dalla gran botta cercavo di mettermi a sedere, incastrata tra i rami, per fortuna abbastanza accoglienti di quella siepe, l'inequivocabile tonfo che mi segnalava l'atterraggio della mia amica assai poco distante da me. La fila di arbusti si dimostrò provvidenziale, dato che ci accolse molto più morbidamente di quanto avrebbe fatto il fossetto che vi era dietro, per giunta con un po' di acqua dentro, nel quale saremmo di certo cadute se la siepe non ci fosse stata. Sentii la mia amica gemere e lamentarsi e la chiamai per nome, chiedendole se stessa bene. Io, nel frattempo ero riuscita ad alzarmi e, vedendo le gambe di lei fuori della verzura a due passi da me, mi precipitai lì per rendermi conto del suo stato di salute ed aiutarla a rialzarsi. Ci andò bene, ce la cavammo con qualche ammaccatura che ci fece camminare tutte sbilenche per diversi giorni e una collezione di vistosi quanto innocui graffi sulle mani e le braccia. Quando anche lei si fu rimessa in piedi, ancora tremante e spaventatissima, decidemmo comunque di incamminarci verso casa, che era non proprio vicinissima ed io le passai un braccio sotto una ascella per sostenerla un po' ed aiutarla a camminare, dato che le faceva male una gamba, che di certo aveva sbattuto malamente contro il terreno. E fu così che Carlo e Paolo ci videro spuntare dal viale che portava al cancello dell'aia, dopo che, prese al volo le due cavalle scosse che erano giunte fin lì di gran carriera, aver tolto loro velocemente i finimenti ed averle messe nella stalla, si stavano precipitando di corsa a cercarci, preoccupatissimi che ci fossimo fatte del male.
I giovani sono belli per quello, poiché sanno trovare il lato umoristico in ogni cosa.
Infatti fu la loro risata sonora che ci accolse e ci contagiò e, inutile dirlo, tutto finì con piada prosciutto e sangiovese.
Ma un altro volo al galoppo spiegato mi attendeva, qualche anno dopo. Questa volta la protagonista fu Tuba.
Tuba mi fece cadere da cavallo innumerevoli volte, nei primi tempi, dato che aveva paura dei rametti che si potevano incontrare gettati sul terreno. Cercammo di capire da cosa venisse questa sua fobia e il maestro mi suggerì che forse lei era stata morsa da qualche serpente e quindi aveva paura di tutto quanto fosse simile e le si parasse di fronte. Fatto sta che in pineta ed in campagna, potete perfettamente capire, che i ramoscelli sono all'ordine del giorno, se non del minuto. Quindi per diversi mesi io toccai terra col sedere più o meno tutte le volte che mi recavo con la mia cavalla a passeggiare fuori dal recinto del maneggio, perché lei faceva uno scarto così repentino, di fronte a quegli innocui ramoscelli spezzati e gettati a terra, che proprio io non riuscivo a contrastare. Anzi, imparai presto che mi conveniva assecondarlo e volare giù, tanto ero comunque ben fornita di naturali ammortizzatori e non mi feci mai male.
Ma quella volta non fu un rametto a tradirmi, perchè che lei, dopo un po' di mesi, riuscì a tranquillizzarsi e smise di comportarsi a quel modo, diventando assai docile ed ubbidiente. Davvero io e lei eravamo riuscite a fonderci ed io la guidavo con il pensiero, senza dover usare se non lievemente le mani e le gambe.
Avevo un modo di montare a cavallo piuttosto avvolgente, trovandomi bene solo con la staffa piuttosto lunga ed abbracciando con tutta la gamba il costato dell'animale. Stavo quindi ben a contato con la sella e raccoglievo naturalmente il baricentro della cavalcatura sotto di me, creando una situazione di equilibrio ed armonia. Anche al trotto avevo imparato ad eseguire quello che veniva chiamato ' di scuola ' e non battevo la sella, assecondando il movimento del cavallo con un naturale rollio del mio bacino. Nonostante fossi una ragazza robusta ero assai più leggera di altri molto più magri di me perché non andavo mai a contrastare con i miei movimenti quelli del cavallo.
Così, quel pomeriggio io e Tuba ci eravamo spinte dopo il Fossatone, che era, come da manuale, un largo fosso a carattere però torrentizio e che quindi permetteva un facile guado in un punto specifico dove era stato elevato un terrapieno a massicciata; nei periodi di minore afflusso di acqua lì se ne trovava qualche spanna, permettendo quindi di passare all'altra sponda A me piaceva tanto andare dall'altra parte di quel baluardo naturale alle nostre passeggiate, perché vi erano un paio di radure assai grandi e piane, assolutamente deserte, nelle quali potevo galoppare a mio piacimento ed anche perché l'intero sentiero che si percorreva in quella parte di pineta era assai rettilineo ed altresì permetteva di aumentare la velocità del galoppo.
Arrivavamo a percorrere una decina di chilometri, forse dodici, poi tornavamo indietro e di certo coprivamo al galoppo la maggior parte dell'intera distanza.
Tuba non era una cavalla velocissima: la sua qualità maggiore era la resistenza: io le avevo insegnato ad assumere l'andatura di galoppo che in gergo viene chiamato ' galoppino ' oppure ' canter ' e con quella percorrevamo lunghe distanze, trattenendoci fuori anche per tre ore, in passeggiata libera e totale solitudine: io lei e la pineta.
Quel giorno però avevo voglia di volare e chiesi alla mia amica equina di spingere sulle sue fortissime zampe e di donarmi tutta la massima velocità che potesse raggiungere. Così la incitavo, a briglia lenta e i talloni affondati nel costato, spingendola sempre più forte: il terreno era perfetto, asciutto e senza pozzanghere, il sentiero era sgombro e rettilineo, non c'era nessun pericolo.
Ma l'insondabile è sempre all'erta: ad un certo punto, mentre io e lei eravamo distese in un galoppo piuttosto veloce, si udì uno schiocco secco, io mi sentii lanciare violentemente a terra e altrettanto nettamente sentii la mia cavalcatura che andava dalla parte opposta, come quella volta con Nuvola. Atterrai e per fortuna il fondo della pineta è sabbioso, quindo piuttosto elastico ma la botta fu notevole: ma che dirvi, evidentemente avevo dei notevoli ammortizzatori perché non mi feci assolutamente nulla neppure quella volta. Mi alzai quindi in fretta, chiamando la mia cavalla a gran voce, temendo che si allontanasse. Per fortuna lei si era fermata una decina di passi più in là e stava brucando di già una verde erbetta che aveva trovato assai interessante sotto un albero. Il pericolo, quando il cavaliere cade con il cavallo lanciato al galoppo è che le redini volino superando la testa dell'animale fino a formare una specie di cappio nel quale può impigliarsi una zampa e far cadere anch'esso, causandogli ferite anche serie. Avevo assistito una volta ad una cosa del genere e quindi la mia preoccupazione era anche quella. Ma le redini erano si appoggiate davanti a lei, a terra, però le sue zampe erano libere.
Guardandola bene, però, ancora distante alcuni passi da lei, mi accorsi che una cosa molto importante mancava all'appello: la sella. Infatti Tuba era ' nuda '.
Capii allora che quello schiocco che avevo sentito era il rumore del sottopancia, - la striscia di cuoio che passando appunto sotto la pancia del cavallo tiene stretta la sella, - che aveva ceduto di netto facendomi cosi cadere.
Presi le redini, allora e, tenendo la cavalla vicino a me, comincia a perlustrare il terreno attorno al punto del mio atterraggio per cercare la sella, che trovai infatti non troppo lontano, sotto un cespuglio, tutta insabbiata e con la cinghia scucita di netto.
A quel punto cosa potevo fare?
Impossibile riallacciare la sella alla cavalla come impossibile tornare a casa a piedi, che i chilometri erano almeno sei o sette, la sera incombeva e camminare con gli alti stivali da cavallerizza non è poi molto comodo. I cellulari non erano ancora stati inventati oppure non erano di uso comune, - più o meno l'anno di cui parlo è il millenovecento settantanove – e poi in quel luogo dove mi trovavo non ci si poteva accedere che a piedi o a cavallo, quindi, dovevo per forza di cose salire su la cavalla a pelo e tornare al circolo in quel modo.
Ma c'era un altro scoglio da superare.
Per issarsi sulla groppa di un cavallo vi sono principalmente tre modi, il primo, che viene chiamato ' in appoggio ', consiste nel farsi forza sulle braccia e volteggiare fino a disporre una gamba da ogni lato dell'animale, il secondo, più banale e meno elegante, è quello di infilare la punta di un piede, - per l'esattezza quello sinistro, nella staffa e facendo forza su quella, dopo aver afferrato con le due mani i quartieri della sella, issarsi su. Il terzo, soprattutto praticato dalle donne è che qualcuno, di solito un forte e gentile giovanotto, offra la sua mano sulla quale posare con disinvoltura il ginocchio, flettendo ad elle la gamba sinistra e facendosi issare dalle nerborute braccia di colui.
Bene, per quanto agile e molto forte io fossi, in gioventù, però l'elevazione dal suolo non è mai stata la mia specialità: ci ho provato innumerevoli volte ma non sono mai riuscita a salire a cavallo in appoggio.
Volentieri, se ci fosse stato qualcuno lì attorno avrei accettato di ' dargli la gamba ', come si dice tra la gente di cavalli, anche se di solito mi schernivo e l'evitavo, per cercare di risparmiare strappi muscolari alle schiene dello stalliere e del maestro che si offrivano cavallerescamente di aiutarmi. Quindi io sempre salivo sull'arcione issandomi sulla staffa.
E lì, quel giorno, cascava l'asino, dato che chi, come me, non è capace di salire con disinvoltura sul proprio cavallo è di certo un asino.
Provai e riprovai ma non ci fu nulla da fare. Ero poi anche assai indolenzita per la gran botta data, cosa che non mi aiutava di certo.
Ma io non sono tipo da disperarmi per nulla e cercai lì attorno se ci fosse che so, una grossa pietra, un tronco caduto o altro che mi potesse elevare e mi permettesse di issarmi sulla groppa di Tuba. - A mia lievissima scusante devo però dire che lei era piuttosto alta e che la sua altezza al garrese sopravanzava di due centimetri la mia, quindi la mia faccia si trovava proprio a livello della famigerata zona dove avrebbe in quel momento dovuto trovarsi una sella. -
Cerca cerca tra erbe alte e cespugli ma nulla, lì in giro non vi era proprio nulla che potesse servire alla bisogna e così mi incamminai piuttosto mestamente a piedi, dato che il tempo stava trascorrendo ed essendo inverno le giornate erano ancora assai corte.
Ma madre natura volle in qualche modo aiutarmi e qualche centinaio di metri più in là trovai un fossetto naturale, - formato di certo dalla controtendenza del terreno e dalle piogge, - che era profondo un buon mezzo metro. Con grande respiro di sollievo allora feci scendere la mia povera cavalla nel fosso, che inizialmente oppose qualche resistenza ma poi si arrese docilmente al mio volere e, chiedendole di portare un po' di pazienza pur se in una posizione assai scomoda dato che l'incavo del terreno era assai stretto, riuscii abbastanza facilmente ad issarmi su.
Fu proprio tramite quella avventura che scoprii le gioie e la bellezza del montare a pelo. Certo il trotto era alquanto difficile da sostenere, poiché il sobbalzo causato dal movimento del cavallo lancia in alto il cavaliere ma il galoppo era una meraviglia, ancora più bello che con la sella, con le gambe completamente libere dalle corregge delle staffe, che potevano abbracciare il costato dell'animale e reggersi ad esso e con esso, sfruttando anche la sua velocità ed il suo movimento.
Fu così che io e Tuba percorremmo al galoppo tutta la lunga strada del ritorno e riuscimmo ad arrivare al circolo con le ultime luci del giorno. Mi videro scendere dalla discesa ghiaiata che portava dalla stradina all'aia attorno la scuderia, stanca trafelata e sudata ma incolume, così come era la mia cavalla. Il maestro, che era già in allarme da un po', abituato anche da altre mie bravate che vi racconterò e stava già organizzando con motorini e trattore una battuta di ricerca nella pineta ormai notturna, per ritrovarci, temendo il peggio, mi venne incontro chiamando il mio nome ad alta voce con tono evidente di rimprovero ma la sua preoccupata rabbia si smorzò quando mi vide senza sella . Si ammutolì all'istante e rimase a guardarmi a bocca aperta per qualche secondo poi scoppiò lui pure in una grassa sonora risata.
Che non era la prima e non fu l'ultima che io gli feci fare.
Da quel giorno per due mesi, il tempo che ci volle per aggiustare dal sellaio di Bologna il mio finimento rotto, cavalcai ogni giorno a pelo ma anche dopo aver recuperato l'arcione, più volte evitavo di usarlo: il dolce calore di Tuba era il sedile più comodo e aggraziato dell'universo intero e gli indiani d'America lo sapevano bene, che per millenni hanno cavalcato i loro pony senza bisognio di assolutamente null'altro che la bellezza dell'unione tra due creature così complementari come sono il cavallo e l'essere umano.
La prima sonora risata che regalai al mio istruttore fu poco dopo l'acquisto di Tuba che avvenne l'anno dopo dell'inizio della nostra frequentazione equestre.
Prima di allora montai i cavalli della scuola e lui mi chiese più volte di aiutarlo a risolvere qualche problema che presentasse qualcuno di loro: per esempio, ce n'era uno troppo riottoso e quindi difficile da cavalcare per chi avesse poca esperienza. Il suo nome era Tombolo ed era un giovanissimo cavallotto morello, che, essendo assai dispettoso ed irriducibile, mi gettò a terra ogni volta lo montassi, per diversi mesi. Fu l'unico che riuscì a procurami una ferita, cadendo, una volta che, sfuggendo alla lunga frusta che il maestro gli sventolava dietro per spronarlo a saltare un piccolo ostacolo che lui non voleva saltare affatto, fuggì a rotta di collo andando a sbattere contro un albero e facendomi ruzzolare giù come la solita pera cotta. Quella volta mi fratturai il mignolo della mano sinistra che reca tutt'ora il segno di quella avventura, dato che si è saldato piuttosto storto. Mi convinsero ad andare al pronto soccorso: il dito era gonfio e mi faceva molto male. La frattura all'ultima falange fu rivelata dalla radiografia e mi steccarono dito e mano. Ma Angela a quei tempi era piccolina, erano proprio i primi mesi del nostro soggiorno lì e quindi la dovevo vestire lavare, cambiare. Gettai al stecca meno di tre ore dopo....
Tombolo divenne poi un bravo cavallo da scuola, imparò anche a saltare e a non sgroppare violentemente ad ogni piccolo rumore, come invece faceva quando mi gettava giù.
Ripensandoci ora ero davvero spericolata. Io non avevo nessuna paura, ve lo assicuro: quando cadevo mi rialzavo immediatamente, mi spolveravo i pantaloni e la giacca, riacchiappavo la mia cavalcatura e poi su, di nuovo in sella. Perché quando si va a cavallo o sui pattini o in bici, si cade, è assolutamente normale, fa parte del gioco e forse, anzi di certo già da allora sapevo benissimo che altre cadute sono quelle da temere, nella vita.
Oltre Tombolo montai un altro puledro, che però era assai più tranquillo. E che fu quindi affidato presto ad altri allievi più giovani ed inesperti di me.
Anche montai per qualche tempo un grosso irlandese che a causa di un incidente si era fatto male ad una gamba e non voleva più girare a destra. La sua muscolatura si era tutta irrigidita e quindi sia al trotto che e al galoppo faceva resistenza, tirando dritto, cosa che non andava assolutamente bene. Guidata dal maestro, lo ginnasticai per qualche settimana, dato che ero piuttosto determinata e piano piano il cavallo si sciolse e riprese a muoversi normalmente.
Inoltre l'istruttore mi chiedeva spesso di accompagnare sia gli altri allievi che qualche cliente di passaggio, in passeggiata in pineta. Quelle volte mi faceva montare una cavalla assai bella e forte che però era diventata cieca. Nel maneggio era facile da usare più o meno per chiunque, perché ormai aveva si era creata i suoi riferimenti e si muoveva piuttosto con disinvoltura ma fuori all'aperto ella aveva bisogno di sentirsi sicura e di fidarsi. Si chiamava Stella ed era di mantello sauro. È evidente che io abbia uno speciale feeling con questo colore anche se poi Tuba fu baia e Tex, il mio secondo cavallo, fu grigio pomellato.
Stella si fidava di me ed io mi trovavo assai bene con lei perché era leggera, era assai ubbidiente, bastava solo il tocco della redine e della gamba per farle cambiare di direzione o di andatura. Ma con altri lei si piantava in mezzo dell'aia e non voleva più assolutamente fare un passo. Eravamo in due a riuscire a portarla fuori, io ed un socio del circolo più grande di me con cui vissi qualcosa che vi racconterò più avanti. Evidentemente avevamo la stessa sensibilità.
Ma, tornando alla prima risata del maestro, quel giorno appunto avevo comprato da poco Tuba e da poco l'avevo condotta a vivere in casa mia, superando il veto della cooperativa. Il pomeriggio era davvero bellissimo. La primavera rendeva la pineta tutta punteggiata di gemme e foglioline verdissime negli abbondanti cespugli di rosa canina ed altre specie che popolavano piuttosto intensamente il sottobosco.
Qualche lezione prima avevo saltato per la prima volta alcuni ostacoli fissi in pineta e mi ero divertita assai.
Gli ostacoli fissi, che fanno parte del percorso di campagna delle gare di ' Completo ' sono barriere, massicciate, tronchi ed altro, costruiti con fantasia usando solo parti naturali in fusione con l'ambientazione esterna, in modo che sembrino ostacoli spontanei che madre natura avesse piazzato lì per rendere più difficili le cose al cavaliere o per farlo divertire di più. Ovviamente, al contrario del comune ostacolo da maneggio, che, quando il cavallo lo colpisce con lo zoccolo o altra parte del corpo, è costruito in modo che la barriera di legno si stacchi dal riporto e cada a terra, evitando guai e ferite all'animale, l'ostacolo di campagna è fisso: se il cavallo ci sbatte contro può facilmente cadere, con le conseguenze che potete immaginare.
Vi ho detto che sono totalmente spericolata, no? Ebbene, quel pomeriggio, recandomi al circolo che distava tre chilometri da casa mia, decisi che avrei saltato una specie di gradino di massi che sarà stato alto cinquanta centimetri e che si trovava sul sentiero che percorrevo.
Cinquanta centimetri sono pochi, direte voi. Provate, vi dico io.
Sapevo benissimo dove si trovava quell'ostacolo e quindi feci partire la mia cavalla al galoppo qualche decina di metri prima, inquadrandola bene di fronte al gradino di terra e sassi ricoperto di vegetazione e poi spronandola con il tempo giusto per la battuta.
La cavalla spiccò un bellissimo balzo, portandomi al di sopra del gradino, sul sentiero che proseguiva con il terreno sopraelevato. Dopo ancora qualche battuta di galoppo la misi al passo e poi mi fermai per congratularmi con lei, battendole la mano con affettuosità sul collo. Poi volli provare a saltarlo dalla parte opposta, presi un po' di rincorsa, partii al galoppo e giù: perfettamente all'unisono ci ritrovammo al piano più basso.
Felice allo stato puro, non mi fermai,invertii la direzione dopo una decina di metri, sempre galoppando, saltai di nuovo il gradino a salire, con uno zompo ancora più alto della cavalla che evidentemente si stava divertendo come me.
Dovete sapere che un po' a lato dell'ingresso al circolo c'è una vasta radura chiamata ' L'aia del pozzo ' dove erano posizionati svariati di questi ostacoli fissi. Quando arrivai lì pensai che avrei voluto provare a saltarne un altro, prima di andare dal maestro e raccontargli le mie gesta e quanto ero stata brava.
Certo, gli altri allievi avevano cavalli che valevano decine se non centinaia di milioni e saltavano fino a due metri mentre la mia Tuba era costata il prezzo della sola carne e non superò mai nella sua carriera l'altezza di un metro e venti ma poiché il circolo ippico era ubicato sui terreni adiacenti a quelli della cooperativa che gestiva Carlo, dato l'importanza che questo aveva per loro, i favori che sempre mio marito gli faceva, mandando trattori, prestando attrezzi, facendo piccoli lavori di aratura o altro ai loro campi, tutti quanti lì erano assai gentili e disponibili con me.
Però il maestro era un uomo molto appassionato e, pure se assai burbero con me, eseguì sempre con grande scrupolo e fino in fondo il suo compito, anche se la mia cavalcatura era il fanalino di coda di quel consesso di divinità equestri. Per quanto comportava me, poi, io non partecipai mai alle gare nazionali ed internazionali che si svolsero regolarmente ogni anno a cadenze prestabilite ma solo alle piccole garette sociali. Non avevo i mezzi, né economici né fisici per ambire ad altro ma la mia genuina passione e il mio carattere gioviale e totalmente disinvolto, che mai si intimorì di fronte alla loro grandezza, portò tutti quanti a trattarmi come una di loro: io, moglie del fattore tra ricchi e ricchissimi tra cui notai avvocati medici, qualche nobile e imprenditore e pure un famoso industriale il cui figlio maggiore sfondò tempo dopo nella formula uno automobilistica e che tenne lì per lungo tempo i cavalli di altri due suoi rampolli.
Così, già pregustando gli elogi de maestro, decisi di provare a saltare il ' parc a mounton '.
Che cos'è? Direte voi, almeno quelli che non hanno mai fatto un percorso di Concorso Completo..
Beh, è il modo un po' pomposo di chiamare uno spiazzo erboso rettangolare largo una ventina di metri e lungo cinque battute di galoppo, recintato da una staccionata di sottili pali di castagno, alla moda dei recinti per gli animali, da cui il nome.
La staccionata è alta circa ottanta - novanta centimetri e l'ostacolo si esegue saltando la prima parte in entrata per poi effettuare le battute di galoppo intermedie e volare oltre la seconda staccionata.
La vera insidia di tutto questo, che in sé e per sé non sembra assolutamente difficile e che mi trasse allora in cotanto inganno, è che i pali usati per costruire la palizzata sono appositamente sottili in modo da creare un difficoltà visiva all'animale che, arrivando al galoppo spiegato, può calcolarne male l'altezza.
Io, ovviamente, questo non lo sapevo: vedevo di fronte a me un bel prato erboso ed una innocua staccionata, come avevo visto saltare senza problemi in migliaia di film western della mia infanzia e giovinezza. E che ci voleva dunque?
Avevo letto sul mio bellissimo ' Il grande libro del cavallo ', che è stata la mia bibbia equina per tanti anni, che saltare un ostacolo era come lanciarvi oltre il proprio cuore e poi, con coraggio, correre con il fido amico a quattro zampe a riprenderlo.
E così feci.
Inquadrai ad una trentina di metri l'ingresso del ' parc a mounton ', spronai la cavalla, partii al galoppo e, giunta alla battuta, di fronte al primo cancello del recinto, la incitai ancora per il balzo ma, decisamente fuori tempo io e non lei, Tuba partì ' troppo grande ', come si dice, cioè in anticipo e si ritrovò già in traiettoria discendente proprio sopra l'ostacolo. Io non avevo nessuna esperienza di salto e neppure lei, che aveva poco più di tre anni: la mia fu davvero una follia.
Mi trovai gettata violentemente a terra, come se qualcosa avesse frenato di botto il mio impulso e fossi precipitata da una notevole altezza. Picchiai forte le spalle e la testa, poi tutto il resto e rimasi semi tramortita a terra, per diversi secondi, forse minuti: ero da sola, non lo seppi mai. Non svenni nel vero senso della parola ma mi girava tutto intorno, anche la volta del cielo azzurro orlato dagli ombrelli verde scuro dei pini; inoltre avevo la bocca piena di terra e stavo sentendo il sapore del mio sangue.
Ma anche quella volta la mia buona stella era giunta puntuale all'appuntamento e non riportai altro che la solita forte contusione, qualche scortico e il labbro rotto. Mi misi seduta e sentii che ero ancora tutta intera, mentre già il mio pensiero correva alla mia cavalla: il silenzio intorno era rotto solo dai consueti canti degli uccelli. Mi accorsi che avevo nel colpo perduto gli occhiali e non vedevo assolutamente nulla così mi misi in ginocchio e li cercai a tentoni tra l'erba abbastanza altra. Per fortuna li trovai dopo pochi attimi che erano miracolosamente intatti: li inforcai, mi alzai girandomi verso la parte da cui ero giunta e lì rimasi veramente di stucco: la mia povera Tuba era in piedi, con la staccionata dell'ostacolo sotto la pancia e, dato che se appoggiava le zampe posteriori non poteva appoggiare quelle anteriori e viceversa, come si trovasse sopra una altalena a fulcro, non riusciva assolutamente a muoversi da lì.
Non so dirvi quanto tremò il mio cuore, vedendo quello spettacolo.
Corsi da lei e la controllai tutta ma non era affatto ferita, a parte una piccola lesione cutanea su di uno stinco. L'accarezzai dolcemente, le abbraccia il setoso collo e, piangendo, le chiesi di perdonarmi, di scusare la mia stupida vanagloria e la mia grande idiozia ma lei mi guardò con occhi dolci e tranquilli, come dicesse: ' Su, non è nulla, tutto è bene quel che finisce bene, ti perdono. Però, ora fa qualcosa per togliermi da qui!! '
Ed evidentemente quella era la priorità assoluta: toglierla da quella scomoda posizione, prima che il legno della staccionata si rompesse e la ferisse seriamente al ventre: ma come fare, cosa fare?
Cercai di incitarla a saltane fuori ma davvero non appoggiava che solo due zampe alla volta e ciò era assolutamente impossibile, quindi dovevo in ogni modo e in fretta correre a cercare soccorso. Le tolsi allora la sella ed i finimenti della testiera, per evitare che le cose potessero ulteriormente complicarsi e poi scappai via, correndo a perdifiato e a più non posso per le diverse centinaia di metri, più di un chilometro, comunque, forse due, che mi separavano dalle scuderie.
Arrivai senza fiato e cianotica, pur gridando a gran voce: ' Maestro maestro!! '
Egli che era nel maneggio coperto, corse fuori allarmato e quando vide che ero io a chiamare si allarmò ancora di più. Corse verso di me e cercò di farsi spiegare cosa fosse successo; sapevo che mi avrebbe aspramente rimproverato e tremavo di paura non solo per la mia cavalla ma anche per quello. Gli dissi che bisognava correre più velocemente possibile all'Aia del pozzo con il trattore ed una sega, che Tuba per il momento stava bene ma era prigioniera nel parc a mounton e che quindi temevo le cose potessero degenerare. Mi guardò in tralice, sorpreso ed assai adirato ma non si perse in chiacchiere, - che sicuramente sarebbero venute dopo... - chiamò gli stallieri, prese la sega a motore e il trattore con il rimorchio, mi fece salire e tutti di corsa, - seguiti da un nutrito gruppetto di allievi ed adulti incuriositi, che nel frattempo erano lì giunti richiamati dal vociare,- raggiungemmo in una decina di minuti o poco più il luogo dell'incidente. Anche quella volta la vegetazione ci precludeva quasi fino all'ultimo momento la visuale, dato che intorno all'Aia la pineta era intricata e i sentieri assai stretti e pieni di curve. Il maestro guidava il trattore, scuro in volto ma quando finalmente la vegetazione si aprì e ci permise uno sguardo completo sull'aia, vedendo la mia povera cavalla, per fortuna ancora perfettamente tranquilla ed illesa, così buffamente sospesa, esplose in un una gigantesca risata, seguito a ruota da quella di tutti gli altri che, come per epidemia, non poterono trattenersi dal ridere fino alle lacrime. Devo dire che io quella volta alle lacrime ci ero già arrivata senza passare dalle risa, che mi sentivo troppo in colpa nei confronti della mia amica equina.
In pochissimo tempo la staccionata fu segata, mentre io tenevo tra le braccia la sua testa perché non si spaventasse e Tuba fu liberata indenne.
Il maestro, allora, me la fece sellare, mi issò in groppa, mi comandò di andare al passo e poi trottare per qualche minuto, controllando che l'animale non zoppicasse o non fosse rattrappito o contuso. Ma Tuba stava benissimo, era davvero una cavalla eccezionalmente forte. Allora lui mi comandò di galoppare e di andare a saltare un tronchetto basso, appoggiato per terra, che era poco distante, cosa che eseguii con il cuore che batteva a mille, mentre Tuba saltò, serenamente, come nulla fosse accaduto. Poi la sua voce bassa ed un po' perentoria mi ordinò il passo e mi consigliò di tornare a casa.
Solo l'indomani mi diede una notevolissima lavata di capo: appena giunsi all'ora consueta con Tuba per la lezione nel maneggio coperto mi ordinò di scendere da cavallo e di legarla all'apposito anello. Poi mi fece entrare nel suo ufficio e chiuse la porta dietro di noi: io e lui da soli.
Egli aveva una cinquantina d'anni ed era un bell'uomo: molto cuori femminili spasimavano per lui e ci fu poi, anni dopo, uno scandalo che lo coinvolse con una delle sue allieve.
Non che mi piacesse ma era assai difficile essere del tutto insensibili al suo fascino e lui, questo, lo sapeva benissimo.
Per tutti gli anni che io fui sua allieva non mi chiamò mai per nome proprio, come faceva con gli altri allievi più giovani ma sempre con il mio cognome: io ero per lui la signora Amaducci.
Ma quel pomeriggio, in quella stanzuccia che sapeva di cavallo e di polvere di paglia, dopo avermi fatta sedere di fronte a lui, dalla parte opposta della scrivania, mi guardò dritta negli occhi e mi disse: ' Arianna, ma ti rendi conto di quello che hai rischiato?.'
Io abbassai gli occhi, non reggendo quel suo sguardo così umano.
Certo, lui era un personaggio e doveva per forza atteggiarsi. A volte, forse anche molte, avrà dovuto ordinare o fare in prima persona cose che non avrebbe mai voluto ma in quel momento mi trattò come un padre. Poi, con un fugacissimo sorriso, si alzò dalla sedia, aprì l'uscio dello studio e cominciò ad alta voce a dirmene di tutti i colori, che mi vietava di saltare in pineta da sola, che ero stata una pazza, che l'avevo deluso eccetera eccetera eccetera, le solite cosa che diceva a tutti, quando ne combinavamo una. Io uscii rossa in viso e ad occhi bassi, commossa. Poi, assecondai il suo gioco quando tutti gli altri allievi mi circondarono per sostenermi e consolarmi, mentre piangevo a dirotto come una fontana..
Non so se anche quella era una sua tattica ma, vi giuro, funzionò un sacco perché mi ebbe alleata fino all'ultimo, fino a quando me ne andai da lì.
Il mondo dei cavalli è un mondo magico ma può essere anche un mondo assai sporco e in un questa sporcizia il letame non è contemplato.
Ho visto picchiare a sangue dei cavalli, perché si rifiutavano di saltare o per altro, non moltissime volte ma alcune mi è accaduto. Mi chiedo ora perché non abbia allora denunciato quelle sevizie. Ero giovane, non avevo le idee chiare come ora, io stessa, qualche volta, ho usato il frustino e gli speroni, soprattutto con Tombolo, sotto comando del maestro. Certo ora, potessi andare ancora a cavallo, non lo farei assolutamente mai ed assistessi a scene del genere correrei a chiamare le forze dell'ordine. Ma allora pensavo che quello fosse nell'ordine delle cose, il rovescio amaro ma necessario di quella lucente medaglia.
Ci fu però una avventura che più di tutti mi lasciò tanto dolore addosso.
Facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo nel maneggio di Paolo e Marinella, nella seconda estate della nostra amicizia.
Un giorno arrivai all'orario consueto e trovai, troneggiante sotto la tettoia, una gigantesca femmina baia oscura: vicino a lei Nuvola sembrava una formichina.
Era di razza irlandese, aveva sette anni ed era stata di proprietà dell'esercito italiano e poi venduta. Era stupenda. La accarezzai e chiesi a Paolo come si chiamasse. Lui mi disse di sceglierlo io, il nome ed d'istinto esclamai ' Black Power ' che da quel momento rimase suo. Il ragazzo, con uno strano sorrisetto malizioso, mi chiese se volessi montarla, cosa che io accettai, ovviamente entusiasta.
Portò allora la cavalla al centro del maneggio e mi issò su: accidenti come era alta!!.
Mi sistemò le staffe e mi mise in mano le redini che, mi accorsi, erano due comuni corde da lunghina: vidi allora che la cavalla non indossava una normale testiera con morso o filetto in bocca ma una cavezza di corda che aveva come una specie di cappio intorno al suo muso, subito al di sopra delle narici. Avevo visto cose simili sul mio librone – bibbia ma mai da vicino né mai ne avevo usato uno.
Paolo mi spiegò che l'uso era il medesimo ma mi consigliò la mano leggera, cosa che mi stupì, perché ero certa sapesse benissimo quanto io lo fossi, leggera.
Mi misi al passo lungo la staccionata, accarezzando il bellissimo animale sul collo: non avevo mai visto una cavalla così bella, mai, davvero.. Dopo averle sciolto un po' i muscoli, come da manuale, la spinsi al trotto e poi al galoppo. Era come una bicicletta, era favolosa, era come stare seduti comodamente su una bomba atomica, tanto la sentivo potente, sapendo che però non sarebbe esplosa mai. Le parlavo, chiamandola per nome: Power, le davo leggeri comandi con il piede, appoggiando la redine appena un po' di più al suo collo per farla girare, era davvero fluida, cosa che io ho sempre apprezzato moltissimo. Ci sono tanti troppi cavalli di maneggio che, passando da una mano all'altra, si stancano e diventano ' duri di bocca ', come si suol dire, cioè insensibili al morso, e pigri e lenti, perché annoiati ed intristiti da una vita senza affetto vero.
Ma lei era davvero meravigliosa.
Vidi, mentre montavo, che vicino a Paolo, al bordo del maneggio, con i gomiti appoggiati alla staccionata c'erano due uomini che non avevo mai conosciuto. Uno, non era un vero e proprio uomo ma poco più di un ragazzo. Mi guardavano e parlottavano tra loro.
Paolo dopo una mezz'ora mi chiamò e mi comunicò che si voleva andare tutti, con i suoi nuovi amici, a fare una passeggiata in centro, fino alla spiaggia e mi domandò se avessi voluto montare anche in quel caso la nuova cavalla. E certo che lo volevo!
Ero davvero contenta, anzi.
Allora mi presentò i due: del più grande ora non ne ricordo il nome ma il ragazzo si chiamava Mario ed era sardo, così mi disse, aveva diciotto anni ed era pastore e fantino.
Intanto che si sellavano gli altri due cavalli, Mario salì su Nuvola, volteggiandole sopra come fosse un acrobata da circo e si esibì, sotto i miei occhi sgranati per lo stupore ed ammirati, in tutta una serie di volteggi ed esercizi al passo trotto e galoppo che io non mi sarei mai sognata di eseguire neppure nelle mie più ardite fantasie.
Veramente, a chi mi chiedesse quando avevo quattro cinque anni cosa volessi fare da grande, io rispondevo convinta: ' La cavallerizza in un circo! ' ma quello restò il mio primo sogno inespresso.
Quindi guardai Mario con grande ammirazione e gli battei le mani più volte, entusiasta della sua bravura e felice di aver conosciuto uno così bravo: di certo mi avrebbe insegnato tantissime cose che non sapevo.
In effetti quello accadde perché nei mesi a seguire, per tutta l'estate, Mario restò ospite di Paolo e da lui imparai una infinità di nozioni, trucchi del mestiere, ricette e soluzioni che mi furono bagaglio preziosissimo.
Quel pomeriggio, dunque, in quattro, passeggiammo a lungo per il paesino, scambiando informazioni con le gente che ci chiedeva se affittassimo anche le cavalcature e dove: era un bel modo di fare pubblicità al maneggio e noi lo usavamo spesso.
Poi ci recammo in spiaggia, - ormai era sera e non c'era quasi più nessuno - e trottammo sul bagnasciuga, lanciandoci anche in qualche breve galoppo.
La cavalla era docile ma assai recettiva, pronta alle partenze con grande desiderio di correre. Io ero al settimo cielo e mi divertivo un mondo eppure vedevo gli strani sguardi che gli uomini si scambiavano fra di loro: non erano sguardi di ammirazione ma piuttosto di uno stranito stupore. Eppure io davvero non stavo facendo altro che montare una meravigliosa cavalla perfettamente ' dressata ', cioè allenata.
Non me ne spiegai il motivo che il giorno dopo.
Quando arrivai al maneggio alla solita ora vidi subito i tre uomini nel centro: Paolo e l'altro erano a terra mentre Mario montava Power: alzavano grida, insulti, erano furiosi, arrossati, sudati fradici e la cavalla non muoveva più un passo, impennandosi continuamente.
Continuarono per tutto il pomeriggio e non ci fu frusta o speroni che la convinsero a recedere dalla sua decisione di non muoversi: non faceva altro che impennarsi, impennarsi ed impennarsi ancora, stremata, coperta di sudore, tremante e fremente, con gli occhi in fuori dalle orbite per la tensione, le froge dilatate e furiose ma irremovibile.
Marinella, che era giunta a fianco a me, mi spiegò che la cavalla, di proprietà dell'uomo più adulto, era un rifiuto dell'esercito proprio perché, nonostante tantissimi tentativi di ogni genere e tipo, non voleva assolutamente postare il morso. Essere rifiutati dall'esercito, mi disse, era una cosa molto grave e non c'era da pensare neppure di farne una fattrice, che i puledri sarebbero stati rifiutati da chiunque. Mi spiegò che quel signore che l'aveva acquistata per una manciata di spiccioli, se confrontata al valore della razza dell'animale, stava cercando di vedere se, con l'aiuto di Mario, che era molto esperto ed un vero fenomenocon i cavalli, fosse riuscito a convincerla, in un modo o nell'altro, a collaborare docilmente. Se non ci fosse riuscito neppure lui, la povera cavalla sarebbe stato macellata. Io, a quelle parole, mi arrabbiai, gridai, protestai, ne feci e ne dissi di ogni, implorandoli di farmela montare ancora. Tanto insistei che, dopo avermi messo in guardia che se mi fossi fatta male nessuno mi avrebbe pagato i danni e dopo che io li tranquillizzai su quello, si convinsero a farmi provare di nuovo.
Power era al centro del maneggio ed era fuori di sé: le avevano messo una testiera normale con un morso in bocca che agli angoli estremi sanguinava una schiuma rossa che mi atterrì. Dissi a Paolo che le volevo rimettere la capezza del giorno prima e me la feci portare. Intanto la accarezzavo e le parlavo, con la voce tremante dalla pena che mi dava vedere quelle assurde ferite in quella povera bocca ed i baccelli sul dorso ed i fianchi, segni delle frustate. Passando la mano sulla pelle del suo collo teso, indurito come marmo, sudato e coperto di schiuma, le sfilai il crudele attrezzo, le asciugai con il mio fazzoletto da naso la schiuma sanguinolenta e le misi lentamente la capezza di corda. Poi, sempre lentamente la feci muovere piano e le feci eseguire un giro lungo tutto il perimetro del maneggio, perché si calmasse un poco, cosa che sembrò accadere davvero. Finalmente decisi di salirle in groppa, aiutata da Mario che si offrì di darmi la gamba. In sella gli chiedi di allontanarsi: avevo paura, sì, tremavo, eppure qualcosa mi diceva che dovevo rischiare, che dovevo far qualcosa perché Power potesse aver salva la vita. Non mi era mai successo di essere in sella ad un cavallo che si impennasse, sapevo che era piuttosto pericoloso, che assolutamente era necessario spostare il proprio peso in avanti, al contrario della forza che si riceveva dal gesto dell'animale, che invece catapultava indietro, con l'inevitabile e terribile caduta anche del cavallo ed i danni che si possono facilmente immaginare.
Cercai di stare calma e di stare pronta poi diedi la voce alla cavalla, il suono gutturale molto usato conosciuto ed efficace che chiede un aumento di andatura.
La sentii irrigidirsi ma non si mosse. Di nuovo le diedi la voce: li si allertò ancor di più ma non mosse un passo. Allora le appoggiai piano i talloni al costato, sussurrandole: ' Vai, bella, vai, coraggio... ' ebbe un fremito ed accennò ad alzarsi sulle zampe posteriori, ma solo un accenno: io spostai d'istinto il mio peso in avanti ed altrettanto d'istinto mollai le redini, aggrappandomi al suo collo. Power, per fortuna, riappoggiò subito gli anteriori a terra, il suo era stato più che una impennata, un balzo in alto ed in avanti ma io restai aggrappata al suo collo e continuai a parlarle piano, dandole di nuovo una leggera pressione dei talloni. Ancora lei eseguì quella specie di balzo ma questa volta più basso, più leggero. Di nuovo eseguii la manovra e ancora lei sobbalzò ma senza muoversi. Continuammo così per qualche minuto, mentre attorno a me il silenzio di chi mi stava guardando era assai loquace. Poi, dopo un tempo che mi parve interminabile, la cavalla si mosse. Inizialmente fu qualche passetto nervoso, poi, pian piano, si rimise tranquilla ed accettò di buon grado, di trottare e pure di galoppare.
La feci lavorare qualche minuto e poi la misi al passo per asciugare la sua copiosa sudata. Ed anche la mia. Ma era caldo e non si correvano i seri pericoli di infreddatura come quando è più freddo: mettere nella stalla un cavallo ancora sudato equivaleva a farlo raffreddare e a provocargli problemi ai polmoni.
Così la riportai sotto la tettoia, la feci bere un po', che era assetata, le diedi una bracciata di fieno fresco e tornai più velocemente possibile nel gruppo degli altri che avevo visto cominciare a discutere animatamente.
Marinella stava asserendo energeticamente che l'unico modo di montare quella cavalla era con la cavezza di corda e che, dato che con me si era comportata così bene, l'unica cosa da fare era abituarla a quello e punto. Il proprietario di Power e Mario però erano contrari a quella soluzione, asserendo che fosse un metodo di contenimento poco efficace e che quindi montare una cavalla in quel modo fosse sempre troppo pericoloso. Io intervenni, ovviamente appoggiando la teoria di Marinella, anzi, accalorandomi ancor di più: sul mio libro avevo visto che c'erano altri tipi di testiera senza morso e che quindi si sarebbe potuto scegliere il più adatto a lei ma gli uomini sembravano stranamente contrari. Ma non erano contenti che ci potesse essere una soluzione ai problemi della cavalla e che si potesse salvarle la vita? Non era per quello che lui l'aveva comprata? La cosa non mi era chiara e, devo dire, non mi fu chiara mai.
Me ne tornai a casa che così furiosa non ero stata mai. Avevo sentito sotto le mie mani la diffidenza la paura e la riottosità di Power sciogliersi a poco a poco, l'avevo vista calmarsi, ricominciare a collaborare: insomma, io non ero che una ragazzina con pochissima esperienza, se ci riuscivo io, a farla lavorare, perché mai non potevano riuscirci anche loro?
Ma fu evidente che il proprietario di Power la pensava diversamente da me.
Il pomeriggio seguente, quando arrivai al maneggio, trovai la scena di quello precedente, con Mario in sella alla cavalla che aveva di nuovo il morso in bocca ed impennate e frustate e grida. Addirittura le ruppero sulla sommità della testa, tra le orecchie, un fiasco di quelli impagliati, perché non si ferisse, pieno di aceto. Lo fecero perché dissero che ricevere quel trattamento l'avrebbe convinta a non impennarsi più.
La povera cavalla lì per lì rimase quasi tramortita, dal colpo ricevuto e dall'odore forte dell'aceto che le si versò lungo il muso e sul collo ma quando questo le entrò negli occhi e nelle narici, bruciando all'impazzata, lei cominciò ad impennarsi più di prima, correndo più volte il rischio di ribaltarsi. Io mi infuriai, cercai di dissuaderli in ogni modo, litigai, gridai contro quell'uomo così cattivo e stupido ma quello a mala pena mi ascoltava, come non esistessi più. Disse del tutto indispettito che aveva perso anche troppo tempo dietro a quell'animale e che il giorno dopo l'avrebbe fatta portare via al suo triste destino.
Piansi tanto, anche Marinella pianse come me e con me ma non servì a nulla: la cavalla era di quell'uomo insensibile e cattivo, e punto. Allora io e lei, in preda ad un dolore immenso, cercammo di convincere Paolo ad acquistare Power ma i soldi per i cavalli li metteva fuori la signora Dina, dato che ancora il maneggio non aveva dato un gran guadagno e lei non ne volle neppur sentire parlare.
Avessi avuto del denaro mio!!! Avessi avuto una madre come altre che amavano gli animali... ci provai, quella sera, a parlarne con lei ma ebbi solo, in risposta, un'occhiata che fu più eloquente di cento discorsi.
Il giorno dopo, al maneggio, Power non c'era più.
Non ho mai mangiato carne di cavallo, nella mia vita né mai di certo ne mangerò, dato che ora sono diventata anche vegetariana.
Sono certa che morirei tranquillamente di fame, piuttosto che uccidere un cavallo per mangiarmelo.
Una volta lessi da qualche parte questa frase, che mi colpì molto: ' Non voglio più nutrirmi di qualcosa che abbia gli occhi.' e questo è oggi il mio pensiero.
Mi chiedo perché l'uomo debba mangiare la carne degli animali, uccidendoli, quando potrebbe benissimo vivere, anzi molto meglio, nutrendosi di legumi verdura frutta e cereali.
Mi chiedo come l'uomo possa trattare con brutalità e violenza ogni altro essere vivente.
Ma queste mie domande non hanno una risposta certa e definitiva.
È evidente che in questo mondo la bestia più grande è colui che dice di non esserlo.
Negli anni a venire ho vissuto tantissime altre avventure con i cavalli:
ho visto nascere due puledri, ho visto morire due cavalli, di cui uno sotto i miei occhi, stroncato da un aneurisma mentre saltava un ostacolo in una gara.
Io e Tuba abbiamo arricchito la serie delle nostre follie:
attraversando al galoppo lanciato una siepe di ' spin marug ' dalle lunghe acuminate spine tipo quelle della corona di Cristo, uscendone graffiate dalla testa ai piedi, sia io che lei, io pure con gli abiti lacerati..
rifiutando lei il salto su di una pozza d'acqua e buttandomici dentro, con conseguente bagno di fango...
lei divorando, una notte che era riuscita a sganciarsi dalla sua postazione, un intero sacco da trenta chili di avena asciutta e gonfiandosi come un elefante. Si salvò in zona cesarini ma io ed il veterinario fummo ricoperti dalla testa ai piedi di quel lassativo rosa che cercammo di farle prendere a tutti i costi........
lei dando un calcio allo stalliere che le aveva preso uno zoccolo per aiutare il maniscalco che la stava ferrando, rompendogli una gamba...
io, salvandola da una colica certa dato che mi accorsi che la stupidona aveva defecato proprio dentro la conca di ferro nella quale beveva l'acqua corrente – questo accadde mentre era ospite nei box del circolo - . la cavalla stava male e non si capiva cosa potesse avere: era inquieta, batteva lo zoccolo ripetutamente a terra, non mangiava. Fu proprio il gesto di rampare con l'anteriore il terreno che mi fece dubitare che avesse sete. Era una cosa di cui non ci si preoccupava, dato che i cavalli avevano sempre l'acqua a disposizione. Fu così che, controllando la conca, che era fissata all'altezza di un metro e mezzo circa in un angolo del box, la trovai piena delle sue feci... per forza aveva le scatole girate e stava male, povera Tuba!!! …
Io, facendole prendere uno spavento memorabile quella volta che mi travestii da King Kong. Mi avvicinai a lei per montare in sella, tutta così paludata e non pensai che avrebbe visto un gorilla venirle a fianco e non me!! Infatti reagì nitrendo ed impennandosi, come non aveva mai fatto. Lo stalliere le dovette mettere una coperta sulla testa per farmi salire in groppa!!...
E quando una volta in passeggiata in spiaggia con i cavalli di Paolo, uno di loro si rotolò in acqua, portando con sé in un fatidico bagno lo sfortunato cliente che lo cavalcava...
oppure quella volta che mi travestii da passatore per il carnevale del paesino dove Angela frequentava la scuola materna e seguii i carri mascherati con la mia Tuba tutta divertita ed io, con mantella e schioppo, trovati da amici vari ed i baffi posticci...
o quell'altra volta che le maestre della scuola materna di Angela vennero a casa nostra con i bambini del paese e li facemmo cavalcare tutti, uno per uno, a pelo, maestre comprese, mentre Tuba, felice, riceveva carezze carote e zuccherini...
e tante altre cose strane o divertenti che ora sono confuse nella mia mente..
Risento il colpo del suo zoccolo contro la mangiatoia, con il quale ci svegliava e ci richiamava all'ordine, appena faceva mattino, perché scendessimo a darle la colazione. La rivedo nella stalla, guardarmi con quegli occhi dolci ed intelligenti, con addosso la coperta rossa che le mettevo d'inverno perché non avesse freddo e le fasce, sempre rosse, agli stinchi, per riposarle le gambe.
Lei, che quando la comprai era piuttosto nervosa e che poi divenne così docile e dormiva con la capretta e lasciava che le galline le si appollaiassero sulla groppa.
Che amava tutti i nostri cani e lasciava che le si avvicinassero senza calciarli mai.
Che mangiava di tutto, anche il cavolfiore, le barbabietole, ogni tipo di frutta, il pane secco, i finocchi ed era golosissima di zuccherini, tanto da spaccarmi tutte le tasche delle giacche con il muso, per venirli a cercare.
Ma ricordo anche Tex, così bello e bianco e veloce ed originale, un po' nervoso un po' ilare un po' fanciullo.
Ricordo le carraie ed il sordo rumore degli zoccoli contro, l'odore della sera ed i moscerini negli occhi o su per il naso, mentre mi spingevo al galoppo nei giorni estivi. Ricordo ogni altro cavallo che ho montato poi, in vari maneggi in giro per l'Italia e i visi degli amici, le allegrie delle cene e delle feste, i discorsi sempre incentrati sui cavalli.
Il profumo buono del fieno, il colore dorato della paglia, il tatto del cuoio della sella, il sapore di sale del sudore, l'odore del letame e della pelle di un cavallo che, secondo me, è il più buon odore del mondo.
Ma quello che mi piace, quando penso al mio vissuto con i cavalli è chiudere gli occhi e rivedere lei, Tuba, alta lunga e sempre troppo magra ma così bella... e sentire di essere ancora lì, a galoppare per i sentieri sabbiosi della pineta, per le radure tra gli altissimi pini o le rive della palude: il nostro respiro, il nostro battito cardiaco all'unisono.
Io e lei e l'universo intero, tutto in un tempo di galoppo.

CAPITOLO SEDICESIMO
Rufus, Batù. Angela sta di nuovo male.
La nuova casa e Lady
Vivevamo quindi in quella grande vecchia casa senza comodità ma eravamo assai felici. Avevamo preso con noi anche un altro cucciolo, una specie di pastore tedesco semi meticcio che io chiamai Rufus, che in latino vuol dire rossiccio. Perché gli diedi quel nome proprio non me lo spiegai mai, dato che lui non fu mai rossiccio ma grigio e color sabbia e dato che, quando ce lo portarono, avendo cacciato il naso curioso in un cancello appena riverniciato, era piuttosto verde.. ma evidentemente Rufus mi piaceva, e così fu.
Che strano animale, quello: pauroso come un coniglio, si trasformava in aggressivo: infatti, non essendoci lì un'area recintata, lo dovemmo legare ben presto alla catena, cosa che io non potevo sopportare.
Ma lui non ci diede un'altra scelta perché assai presto cominciò a rincorrere, piuttosto iroso e abbaiando furiosamente, tutti quelli che passavano di lì.
Così Carlo tendette fra due alberi un filo di metallo assai lungo, sul quale la catena potesse scorrere in modo che il nostro cane potesse muoversi almeno un po' e fummo costretti a tenerlo in quel modo. Questo anche perché Rufus non fu mai definitivamente addomesticato ma rimase sempre sul chi va là pure con noi, fin da cucciolo, ragione per la quale non ce la sentimmo di accoglierlo in casa come avevamo fatto con Birba, temendo una sua qualche reazione strampalata con la nostra bambina.
L'unica persona a cui obbedì, in tutto il tempo che rimase con noi, fui io: lui mi amava molto ed era come se fossi per lui l'unica degna di fiducia ma anche con me ebbe strani comportamenti. Per esempio, ogni volta che andavo a tagliarmi i capelli, che allora facevo allungare un po' per poi tagliarli corti e stare in ordine qualche mese - con la permanente, perché erano diventati ancora più ribelli – e quindi tornavo a casa un po' cambiata nell'aspetto, lui sembrava non riconoscermi e mi ringhiava contro minaccioso, guardandomi con occhi spauriti ed incerti. Gli ci voleva qualche giorno per tornare a fidarsi nuovamente di me.
Ho avuto tantissimi cani nella mia vita: Gine, la meticcia che ora è con me è la numero centouno e tanti di più ne ho conosciuti e maneggiati a causa del mio lavoro ma mai e poi mai più mi è capitata una cosa del genere....
Però Rufus fu a suo modo l'eroe dei nostri cani.
Una notte di quell'inverno, era gennaio e fuori faceva un gelo terribile, con una bora tesa e forte che aveva portato la temperatura ben sotto allo zero, - fu quell'anno che tirò il famigerato terremoto in Friuli che contò così tante vittime e distruzioni – io dormivo, ben rannicchiata sotto le coperte, tirate fin sopra al naso perché in quella stanza non vi era alcun riscaldamento. Infatti Angela aveva il suo lettino in un piccolo vano dopo la cucina e lì, in quella cameretta, nonostante il tetto non avesse il solaio e si vedessero direttamente i coppi del tetto, poiché in cucina tenevamo accesa una grossa stufa a cherosene, la temperatura era sempre sopra i quindici gradi. Lei poi ha sempre sofferto il caldo, ricercando il freddo e andando in giro scalza anche in inverno, fin da piccolissima, cosa che mi ha fatto sempre penare in modo incredibile, quindi per la piccola la temperatura era giusta. Ma la nostra camera da letto si trovava oltre la sua ed era piuttosto ampia, essa pure senza solaio e con una finestra che di finestra aveva solo il nome, dato che da serrata entrava più aria che se fosse completamente aperta.
Quindi noi tenevamo sempre la nostra porta chiusa, in modo che il caldo della stufa non fosse risucchiato via, con il risultato che, però, lì dentro si gelava.
Carlo era caloroso come sua figlia, io un po' meno ma comunque non soffrivo più di tanto.
Però, quella notte era davvero gelido: la Bora fischiava attraverso quella imposta scardinata e sembrava di essere nella steppa.
Verso le tre, forse dormendo male a causa del fischio del vendo, sentii Rufus abbaiare: avevo il sonno abbastanza leggero anche allora ma l'abbaio del cane era uno di quei suoni che si ascoltava spesso, almeno di giorno e quindi il cervello aveva imparato a registrarlo senza distogliersi sempre dal sonno.
Ma quella notte, lui abbaiava, io lo sentii bene, in un modo diverso, anche se si capiva che il cane non stava proprio vicino alla porta di casa ma piuttosto all'estremo della sua catena, cosa che rendeva anche più ovattato il suono.
Io lo udii, allora e cercai di non farlo, volendo continuare a dormire ma lui insistette finché, convinta che ci fosse qualcosa di particolare, mi alzai ed andai a vedere alla finestra. Guardando fuori vidi il fascio di luce dei fari di una macchina sorger fuori da dentro il fosso, dall'altra parte della strada, un duecento metri da lì.
Mi venne un colpo: corsi a svegliare Carlo che sua volta corse dal vicino che aveva il telefono, per chiamare soccorso: nell'auto c'era un uomo, svenuto per il colpo tremendo che aveva ricevuto nel momento in cui la sua auto, sbandando su di un probabilissimo strato di ghiaccio o a causa di un colpo di sonno, uscì di strada e volò nel fosso. I soccorsi arrivarono in fretta: sapemmo poi che l'uomo restò in coma per diverso tempo ma poi si riebbe completamente. Il nostro strambo isterico cagnone - dato che era diventato piuttosto grosso – gli aveva salvato la vita.
Comunque i giorni trascorrevano entusiasti della nostra sistemazione ma Angela stette di nuovo male: ebbe le convulsioni durante una comune infreddatura ed una alterazione della temperatura piuttosto modesta.
Successe una volta, poi due, ogni volta seguita dal ricovero in ospedale di qualche giorno.
Di nuovo accadde una terza in quell'episodio che ho già narrato, quando io corsi sulla statale attigua con lei svenuta tra le braccia e diverse macchine tirarono dritto, prima che una si fermasse per raccoglierci e portarci al pronto soccorso.
Fu così brutto! Carlo non era in casa, non avevamo telefono, i vicini, che ne avevano uno, non c'erano in quel momento ed io non potevo lasciarla lì da sola per correre col motorino, mio unico mezzo, a telefonare.
Visto il ripetersi delle crisi e che dopo la terza l'elettroencefalogramma registrò segnali allarmanti di un inizio di epilessia, ancora a livello di piccolo male ma evidenti, la piccola fu messa in cura con il Luminale, unico medicinale che a quei giorni era un valido antagonista di quelle malvagie convulsioni ma che era un barbiturico. Angela divenne intrattabile, vivacissima, prepotente. Il suo pediatra ci raccomandò di cercare di assecondarla il più possibile, di non farla arrabbiare, di lasciarla correre e sfogare per quanto ne chiedesse e ciò ci costrinse ad un atteggiamento molto remissivo con lei, che di certo se ne approfittò subito.
Ma, soprattutto, cominciò a detestarmi evidentemente.
Aveva sempre preferito il padre a me, fin da neonata ma allora cominciò a rifiutare ogni mio insegnamento, ogni mia richiesta: qualsiasi cosa le chiedessi di fare, lei lo rifiutava. Se le chiedevo un bacio lo rifiutava, se le chiedevo di venire con me da qualche parte, lo rifiutava. Voleva stare solo con il padre.
Allora lui la prendeva con sé, in macchina e la portava per i campi, con gli operai e le braccianti che erano assai gentili ed affettuosi con lei. Mentre lui parlava con loro per controllare lo stato del lavoro o dare indicazioni, Angela poteva correre tra i filari o le carraie. Altrimenti voleva sempre recarsi a giocare con la bambina della casa di fronte, che aveva la sua stessa età.
L'area nella quale sorgeva la casa che abitavamo era un'aia sulla quale era stata costruita successivamente una costruzione più bassa che fu messa a posto con tutti i comfort per il collega di Carlo e lui viveva lì con la moglie ed i due figlioletti. Avevano una piccola area recintata a giardino e si poteva far giocare le due bimbe senza pericolo. Il terzo, un maschietto, quando arrivammo noi aveva pochissime settimane.
Margherita, così si chiamava l'altra bimba ed Angela legarono subito in un modo incredibile se si pensa alla loro giovanissima età e non litigavano mai: stavano ore ed ore fuori a sporcarsi con la sabbia, il secchiello la palla e le loro Barbie, quelle bambolette bionde americane di cui erano entrambe scalmanate fan, tanto che ne possedevano già un discreto numero.
Io cercavo di farmi amare da mia figlia ma non ci riuscivo, anzi, più mi ci impegnavo e più lei mi rifiutava.
Io stavo molto male per quello, tantissimo ma anche mi innervosivo parecchio, mi innervosivo così tanto che ebbi delle palpitazioni.
Credendo fosse il cuore ad avere qualche problema, andai da un cardiologo che mi disse che erano crisi neurovegetative e mi prescrisse un bando calmante.
Dopo avermi fatti l'elettrocardiogramma ed una accurata visita, mi chiese, guardandomi negli occhi: ' Perché soffri? '
Ma io non glielo seppi dire: io ero felice, non soffrivo.. avevo tutto quello che avevo sempre desiderato.
Un giorno, Angela ne combinò una delle sue.
Dovete sapere che, appeso alla trave del soffitto, pendeva con un sali-scendi il lampadario della cucina che era come una specie di larga goccia di plexiglas bianco con un anello di metallo attaccato alla punta. In quell'anello io tenevo il blister dei miei anticoncezionali, per non dimenticarmeli, ogni sera prendendone uno all'ora di cena.
Quel pomeriggio io ero a cavallo al circolo ippico e la bambina era affidata a Carlo. Lei dormiva e lui scese di sotto a parlare con non so chi, per qualche minuto: quando tornò su trovò la nostra piccola peste che si era svegliata, era evasa dal lettino con le sponde, si era arrampicata sulla sedia e poi sul tavolo ed in piedi su questo era riuscita a raggiungere quell'anello, prendere il blister, tirar fuori le pillole una ad una, che lei evidentemente credeva caramelle e mangiarsele tutte.
Carlo mi raccontò questo, la sera, mentre la bambina dormiva ed io gli diedi una lavata di capo da scorticarlo vivo: come era potuto succedere? Ma era successo.
Aveva poi condotto Angela all'ospedale dove le fu praticata una lavanda gastrica.
Nel frattempo io ero tornata a casa con il mio motorino e seppi dal vicino quello che era successo. Corsi allora, così com'ero, vestita da cavallo, al pronto soccorso, correndo come una disperata per fare presto. Arrivai alla scalinata del palazzone proprio nel momento in cui loro ne scendevano: lui la teneva per mano e lei era pallidissima. La presi in braccio e lei mi raccontò che le avevano messo un tubino nella pancina e che non avrebbe mai più mangiato le mie caramelle. Aveva poco più di due anni....
Per fortuna quel gesto non ebbe nessuna ripercussione, anche se ci tenne in sospeso per parecchi giorni, temendo peggioramenti improvvisi o strascichi a livello psicologico: Angela era già così difficile da trattare che certo la lavanda gastrica non ci sarebbe voluta!
Passarono i mesi.
Birba ebbe una cucciolata di bassotti che fu una bellezza veder nascere ed allevare.
Li tenevamo in cucina in una grande cassetta da uva, esattamente della grandezza giusta per la piccola mamma ed i suoi cuccioli. Lei era affettuosissima e molto attenta ma assistemmo ad un evento che ci meravigliò non poco: quando lei si alzava da lì per ansare a fare i suoi bisogni o bere e mangiare, Nerone, che era il suo gatto preferito, entrava nella cassetta, tra i panni morbidi e puliti e si sdraiava tra i cinque cuccioli, che gli salivano tutti addosso cercando il seno, come fosse la loro mamma e ciucciandolo tutto. Lui si lasciava fare ed esplodeva in sonore fusa, guardandoci con un intenso sguardo serafico. Lo spettacolo era davvero unico.
Ma Nerone fu davvero un gatto straordinario: golosissimo di biscotti e dolci in generale, aveva imparato ad aprire lo sportello del pensile della cucina ber rubare il pacchetto dei biscotti, straziarlo con le unghie e divorare tutto il contenuto. Mai più vista una cosa del genere. Una volta, persino, spazzolò tutta la parte superiore di una torta di mele che avevo cucinato io - come facevo almeno una volta alla settimana - e posto sul tavolo della cucina, coperta da un panno, perché si raffreddasse... davvero incredibile.
Purtroppo un brutto giorno la nostra bassottina morì sotto sotto le grandi ruote di un trattore: chi lo guidava non si accorse di lei, che era così piccola.
Il dolore fu grandissimo, un vero lutto di famiglia. Per fortuna lei aveva avuto la cucciolata e noi potemmo consolarci almeno un poco con il maschietto che avevamo tenuto per noi, al quale avevamo dato il nome di Artù, detto Batù dalla nostra bambina, che non sapeva pronunciare meglio.
Angela parlò assai presto e molto ma all'inizio aveva un modo tutto suo di storpiare le parole che noi trovavamo simpaticissimo.
La prima parola che pronunciò non fu né mamma né babbo ma ' pappa ', - e qui non faccio appositamente commenti -
Io e Carlo eravamo contrari all'abitudine che hanno alcuni adulti di rivolgersi ai bimbi parlano loro come fossero deficienti e discorrevamo con la nostra piccola esattamente come ci rivolgessimo ad una persona adulta ma qualche vocabolo, per forza di cose, restò nell'uso comune.
Ci fece ridere da matti una volta che lei, passando di fronte alla darsena del porto di Ravenna, - che arriva fino nel centro della città - e guardando le barche che le piacevano tanto, come ogni volta ci chiese se facessero il bagno, cosa che noi le confermavamo, ridendo. Lei allora, tutta seria ci chiese, con quel musetto da topolino che aveva: ' Ma non li lavano ma, i ' pilli '??? ' E i ' pilli ', ovviamente erano i capelli. Quanto ridemmo, rendendoci conto che in effetti noi le avevamo fatto immaginare che le barche si recassero al porto appositamente per lavarsi e, dato che lei vedeva sempre gli alberi ed i pennoni vari fuori dal pelo dell'acqua, l'interrogativo che ci porse era più che logico.
Così Batù restò per tutta la durata della sua vita il nome del nostro cucciolotto, che Birba ci aveva donato prima di lasciarci così affranti.
Finalmente, dopo tanta attesa, poco più di un anno dopo il nostro arrivo nelle terre della cooperativa la nuova casa fu pronta: facemmo un altro trasloco e vi andammo ad abitare, felici al settimo cielo.
La casa era un sogno.
Ve l'ho già descritta ma troppe cose dovrei scrivere di lei che io sentii come un essere vivente non come un oggetto inanimato,
Amai quella casa dal primo momento in cui ci misi piede. Era di certo assai bella e molto comodo, noi, poi, avevamo comprato nuovi mobili – una cucina di legno scuro a persianine, come piace tanto a me, una sala di legno di castagno completamente rustico costruita interamente a mano da un artigiano che era davvero originale e bella. Acquistammo anche la cameretta per Angela, bianca ed azzurra, con il lampadario a forma di mongolfiera con un pupazzetto nel cestino. Nella sala c'era persino un meraviglioso caminetto e davanti vi piazzammo un nuovo divano ad angolo, di velluto bruno a fiorellini azzurri, che io amai tantissimo.
Mi aggiravo tra le stanze così belle, con i nostri libri e dischi nella libreria, le tende fatte a filet, con l'uncinetto, rosse in cucina, bianche in sala, in camera nostra e in quella degli ospiti – dove mettemmo i mobili che erano stati di mia madre e mio padre, dato che mio fratello volle acquistare una nuova camera da letto per sé e la moglie - e gialle in cameretta di Angela. Per il lettino della bimba avevo eseguito io con le mie mani, sempre ad uncinetto, una coperta di grossa lana gialla come le tende, con la scritta ' Angela ', rossa, lungo tutta la lunghezza. Era così carina.. non sono mai stata brava come mia madre alla maglia o all'uncinetto ma diverse cose avevo confezionato per la mia bambina, anche qualche tutina e giacchetta.
I mobili li pagammo a rate, acquistandoli dallo stesso mobiliere di sempre e mia madre ci aiutò pagandoci parte di una nuova auto – usata – un bel po' migliore del vecchissimo maggiolino di sedici anni che ogni giorno aveva perso un componente della sua funzionalità e, nonostante il motore andasse ancora benissimo, era diventato davvero inservibile. La nuova ammiraglia di famiglia fu una Citroen Pallas color pastello: che bella così allungata.. che comoda, con gli ampi sedili imbottiti!!! e poi il movimento che aveva di alzarsi sugli ammortizzatori con quel sistema particolare idraulico che sembrava di decollare e davo poi una morbidezza di crociera che mai più ho ritrovato in nessun'altra automobile.
Che giorni avventurosi furono quelli, come la nostra vita si fosse arricchita tutto ad un tratto e le cose e le possibilità ci piovessero dal cielo.
Carlo è stato ed è un uomo molto fortunato: dove mette mano, tutto gli va bene, se gioca a carte o a qualcos'altro, vince con una fortuna davvero sfacciata. Spesso si recava nel baretto del paesino, la sera, per qualche partita a ' beccaccino ', un gioco a carte molto simile al tre sette che là si gioca con grande passione; oppure giocava a mah-jongh. Non si è mai fatto prendere dal demone del gioco, ha sempre impegnato piccolissime somme ma ogni sera tornava a casa con cioccolata biscotti caramelle e dolciumi vari per noi, vinti in quel modo. È assai evidente che io ho goduto di riflesso della sua fortuna.
Ma non furono solo le cose materiali a farmi stare bene in quella casa, assolutamente no.
Era come se fosse sempre stata mia, come se avessi sempre visto quella distesa di campi con l'orlo verde scuro della pineta sul fondo, di cui sentivo il profumo ed il canto. La finestra preferita a cui affacciarmi era quella della cucina che dava appunto verso la pineta. Sotto vi era il tetto in tegole rosse che faceva da portico alla stalla, la cui porta d'ingresso si apriva proprio da quel lato. Sotto quella tettoia noi tenevamo, in bell'ordine stivati, la paglia ed il fieno per la cavalla e gli altri animali e, aprendo i vetri della finestra, il loro profumo mi giungeva, ogni volta parlandomi come io non vi so dire. Era l'odore della terra, del letame messo a maturare sull'apposita spianata, della siepe, delle piante di rosmarino, del salmastro del mare. Era l'odore della pace e della vita. Lo so che se mi affacciavo un po' di più potevo scorgere gli svettanti e puzzolenti caminoni della zona industriale che erano lì vicino e che dall'altra parte sulla grande strada passavano centinaia di camion ed auto ma io dimenticavo quello, io non lo ascoltavo, non me ne curavo.
Era come entrassi in un altro tempo, in un altro mondo.
Come se una bolla temporale chiudesse me fuori da tutto quello che non mi piaceva. Quando ero sola, in casa, spegnevo il giradischi, dato che noi ascoltavamo sempre musica giorno e notte e cercavo il silenzio di quelle stanze, con i rumori del tetto e dei muri, della stalla, dell'intorno che io sentivo scorrere in me.
Quella è stata la mia casa. Non ne ho più avuta un'altra, dopo ma solo rifugi o tetti sotto i quali riparare.
E quell'anno fu davvero particolare.
Infatti in quei giorni comprammo anche il nostro primo cane da esposizione: un levriero inglese a pelo raso, interamente bianco, conoscendo con lei ed in lei una razza che mi era ignota e che, più di una razza, è un mondo a parte, uno stile delle cose.
Lady era bellissima, era così elegante.. .. era la nostra fatina bianca.
La incontrammo per caso per strada nella nostra cittadina natale, un giorno che ci eravamo recati dal nostro carissimo amico veterinario per qualche bisogna dei nostri beniamini. Il suo allevatore e proprietario l'aveva portata lì per il richiamo del vaccino: aveva poco più di tre mesi.
Io non avevo mai visto fino ad allora nella mia vita una creatura così bella. Ce ne innamorammo così immediatamente e di slancio che la acquistammo seduta stante, portandola a casa con noi la sera stessa.
Si può amare in tanti modi ma ci sono amori speciali nella vita di ognuno di noi. Come vi ho detto prima, ora ho presso di me il mio centounesimo cane, Gine, che amo in modo totale, come ho amato tutti i miei cani in modo assoluto.
Ma Lady.. lei era la mia fatina bianca.
Io la guardavo e vedevo la bellezza, la grazia, la gentilezza, la purezza.
Mi rendo conto, scrivendo queste parole, che non ne ho vergate di uguali neppure per mia figlia, né per Carlo o mia madre o altri. E questo può sembrare di certo abnorme.
Ma cosa posso fare se quelle emozioni io le ho provate per lei, per la dolce levriera?
Si può costringere il cuore a provare ciò che non sente o a non provarlo?
Devo forse mentire raccontando cose che so non vere?
No, qui io mi descrivo, come sono. Come ho visto e vissuto la ' mia realtà '.
Forse, anzi, di certo, se confrontati con gli altri protagonisti di questa storia, alcuni accadimenti risulteranno diversi ma io qui desidero essere sincera fino in fondo, con me stessa e con chi legge.
So che ometto, per forza di cose, una grande quantità di avvenimenti: soprattutto quelli quotidiani. Vi sono poi cose che non appartengono a me ma al vissuto di altri, di cui solo io ho sentito e recepito il riflesso e che quindi non narrerò.
Come alcuni fatti sono troppo privati perché io li racconti qui. Ma quello che taccio o non racconto, anche perché volessi scrivere tutto ma proprio tutto quello che ricordo dovrei impiegare anni, non cambia la sostanza delle cose. Né il colore né la valenza.
Perciò, ho amato in tanti modi, l'ho appena scritto ma ci sono state creature, nella mia vita che mi hanno fatto provare emozioni inenarrabili ed incomparabili.
Non tutte sono umane: Lady è stata una di quelle.
Purtroppo il mio amaro e gramo destino era in atto anche in quei giorni fortunati e non mancò di apporre la sua venefica zampata.
Allora il giardino attorno alla casa non era stato recintato.
Lady aveva tredici mesi, quel giorno. Io ero di sopra, in casa a fare le faccende e preparare il pranzo, Carlo era giù, a piano terra, nel suo ufficio ubicato di fianco all'ingresso e vano scala. Feci uscire la cagnolina per il suo giretto salutare, come facevo varie volte al giorno. Io credetti fosse lui a controllarla mentre lui credette fossi io.
Fu un attimo. La casa era ubicata, unico neo e motivo di nostro grande dispetto, lungo una camionabile molto trafficata e, pur se il nostro portoncino d'ingresso era ad un centinaio di metri dal ciglio della strada, ne sentivamo il rumore, che era abbastanza invadente anche se il traffico era di norma piuttosto scorrevole. Però, proprio per quello, molto pericoloso.
Quella mattina sentii bussare alla porta e, stranita di quello perché pensavo che ci fosse Carlo di sotto, mi affaccia alla finestra della camera da letto che dava sul davanti per vedere chi bussasse. Un signore allora alzò la testa verso di me e mi chiese se fosse mio quel cane morto sulla strada. Risposi che no, che il mio era con mio marito..
Ma il sangue mi si era già gelato nelle vene: corsi giù con il cuore che voleva fuggirmi dal petto.
Ricordo quei lunghissimi istanti in cui, seguendo l'uomo, percorsi il tragitto verso il punto che lui mi indicava, cercando di vedere allo stesso tempo di che colore fosse il cane morto e se vedessi spuntare la mia Lady che mi corresse incontro festosa. Fu come due me stesse divise, come due pensieri paralleli, come avessi due teste: una che fissava avidamente quel punto sull'erba, sopra il fosso, un po' in salita rispetto al piano della casa, verso il quale mi stavo ineluttabilmente muovendo, dove sapevo giacere un animale morto, che ancora non scorgevo; l'altra che si volgeva intorno per frugare ogni angolo tra gli alberi, nel prato, dietro la siepe, nel casotto, di fianco la casa, per vederla spuntare all'improvviso e corrermi incontro, lieve e festante, come sempre faceva.
Ma non venne, non vidi mai più quell'incedere di danza, quel fluire bianco d'amore che volava verso di me.
Era lei, infatti, che giaceva sul bordo erboso del fosso: un colpo alla testa l'aveva fermata per sempre. Sembrava che dormisse, era intatta. Ma era morta.
Fu come il mio cuore si spezzasse.
Piansi mesi e mesi, inconsolabile, piena di sensi di colpa.
Piansi continuando a sentire il suono delle sue unghie sui pavimenti di casa, la macchia del suo corpo acciambellato sul divano, il peso del suo fianco contro il mio.
Non era abbracciata a Carlo che io dormivo, la notte, ma a lei.
Si può amare un cane più di un essere umano?
Non mi vergogno a dirlo, assolutamente. La mia risposta è sì, si può, a me è accaduto, con lei.
Posso dire, in tutta sincerità, che sono assai poche le persone che io ho amato come ho amato lei.
Scandalizzatevi di questo, se volete, a me non importa. Io sono pazza e se devo subire tutte i risvolti negativi di ciò, allora voglio godere di quelli, assai pochi, che sono positivi.
Uno di quelli è che posso dire ciò che penso e che sento.
Ormai non ho più nulla da perdere: la mia è una libertà che pago assai cara e per questo la voglio godere fino in fondo.
Ho amato Lady e le parlavo come si parla ad un figlio amato ed adorato.
L'ho guardata correre per i campi come si vede volare l'ala di un angelo.
Ho versato nei suoi occhi e colto dai suoi l'amore che congiunge.
Che fosse un cane a me non importa. Anzi.
Credo di averla potuto amare così proprio per quello.

CAPITOLO DICISSETTESIMO
Tuba. Uno schiaffo. L'università.
Fu allora che Carlo acconsentì ad acquistare il cavallo che tanto desideravo fin da quando, bambina piccola, mettevo una cordicella al manubrio della mia bici e con un bastoncino facevo finta che fosse il mio cavallo e stessi galoppando per le vaste praterie del Texas.
L'acquisto di un cavallo mio era uno dei progetti che, come si può facilmente immaginare, avevo messo tra in primi sul tavolo dei negoziati matrimoniali: avere un cavallo era la cosa che desideravo di più da sempre. Ma fino a quel momento mille accadimenti, mille priorità avevano tenuto lontano da me la realizzazione del mio sogno. A quel punto, però, nulla sembrava non quadrasse: c'era il luogo dove tenerlo, c'erano gli appoggi, le conoscenze, l'esperienza, perfino fieno e paglia gratuiti, quindi, perché no?
Cercammo un po' in giro e poi tramite l'amico dell'amico dell'amico, come sempre accade, ci venne proposta una femmina baia di tre anni, arrivata dall'est europeo da poco. L'andammo a vedere a pochi chilometri da casa nostra. Era assai selvaggia e molto ombrosa, piuttosto magra e panciuta, lunga di reni, con il bacino sporgente ed aveva il muso con una strana ammaccatura sull'osso, come avesse due profili. Di certo non era una bellezza. Ma quando le fui seduta sulla groppa, a pelo, senza sella e la strinsi con le mie ginocchia forti, sentii la sua anima entrare in me.
Come nella scena del film 'Avatar ', quando lei, la creatura dell'altro pianeta, dice a lui ibrido umano - americano: ' Senti il cuore della cavalla pulsare nel tuo. Il suo respiro nel tuo. La forza delle sue gambe in te..'
Fu esattamente così.
La comprammo. Tuba divenne mia.
Per un po' la tenemmo al circolo ippico, perché sembrava una certa cosa, ai braccianti, che il loro sovrintendente avesse un cavallo nella stalla. Avere un cavallo nel 1977, per loro, che erano comunisti e discendenti di chi aveva ottenuto di poter lavorare la terra per il proprio interesse con lotte aspre, costate vite umane e sangue, era ancora il simbolo del padrone, che, montato sulla cavalcatura, passa tra le fila dei braccianti, costretti ad un lavoro faticoso in regime di semi – schiavitù ed esercita issato lassù tutta la sua protervia.. Ma poi, in pochi mesi, si abituarono all'idea, si resero conto che era un mio diritto poter tenere in quella che era comunque ' la mia casa ', ogni animale che desiderassi e così la portammo a casa e la sistemammo nella stalla.
Quella era una stalla da buoi e per quella bisogna era strutturata e quindi divisa in ' poste ', che sono spazi delimitati da muretti alti un metro e mezzo circa, entro i quali si alloggiavano i bovini, a due a due affiancati, con la testa verso il muro, lungo il quale correva la mangiatoia di mattoni ed era posta la fontanella con l'acqua corrente, tenuti al loro posto da una corda agganciata alla loro cavezza e passata a scorrere in un anello, avendo un peso di legno alla sommità estrema per fare in modo che la lunghezza della corda seguisse i movimenti dell'animale.
A me non piaceva che lei dovessi passare le sue ore legata ma non c'era la possibilità di fare un box e dovetti portare pazienza. Però aveva lo spazio per sdraiarsi comodamente, non come i buoi di cui vi parlavo, che erano costretti a dormire in piedi. Se liberi di farlo sia i bovini che gli equini dormono sdraiati, anzi, a loro piace tanto farlo ed anche rotolarsi per terra, nella polvere, ricordo ancestrale di quando il coprirsi di fango e polvere li difendeva dall'assalto di mosche zecche zanzare ed altro. Inoltre la terra, soprattutto l'argilla ha grandi doti disinfettanti e curative e gli animali lo sanno benissimo e le usano per le loro necessità.
Tuba, quindi, era alloggiata in una posta e non in un box, ma la cavalcavo tutti i giorni per ore, vagabondando per campi pinete paludi in trotti e galoppi liberi e, alla fine, quella piccola prigionia era bilanciata da tanta altra parte positiva.
Con me e dopo di me lei è stata comunque una cavalla felice, sana, dalla lunghissima vita.
Con le mie cure e l'ottimo cibo in pochissimo tempo ingrassò, si fese lustra e divenne assai mansueta con noi.
Nei primissimi giorni del nostro sodalizio, infatti, lei era comunque arrabbiata e stranita con il mondo intero perché, molto probabilmente, era stata strappata da un allevamento semi brado, le avevano imposto di certo brutalmente una parziale doma e poi l'avevano caricata su di un carro bestiame portandola in Italia. Di certo un viaggio del genere spaventa a morte un animale, anche se è stato abituato al contatto umano. Si può facilmente immaginare cosa possa essere per un cavallo vissuto in libertà fino a quel momento. Giunta in Italia era stata acquistata da un grosso commerciante e poi dalla persona che me l'aveva venduta che faceva quello non solo per guadagno ma anche per passione. Era stata trattata bene da lui, certo ma comunque non aveva ricevuto mai le cure e l'amore che poi io le diedi.
Per tutte queste ragioni era innervosita ed estremamente riottosa a tutto: non tollerava la brusca e la striglia per essere pulita, non dava spontaneamente il piede per la ferratura e per ricevere le cure quotidiane di cui un cavallo che vive in un box e viene montato ha bisogno.
Per chi non è pratico spiego che sotto lo zoccolo, tra la cornea abbastanza morbida che riveste l'interno del piede di un cavallo ed il ferro, proprio a causa di quello, sempre si ferma, compattato dal peso dell'animale, della paglia sporca, con feci ed altro, perché il cavallo non ha un altro posto dove depositare i suoi escrementi. Paglia che marcisce e può causare facilmente gravi infezioni che possono portare anche alla morte. Quindi, in fase di sellatura, il piede va afferrato e ripulito, svuotando con un apposito ferretto questa specie di nicchia. Poi, prima che il cavallo torni al suo alloggiamento, va di nuovo ripulito da eventuali sassi o fango che possa essersi fermato lì e protetto, almeno così facevo io, con una spennellata di catrame vegetale, che è un fluido vischioso che abbina proprietà disinfettanti a quelle isolanti. Sullo zoccolo esteriore poi mettevo strutto oppure un linimento speciale che curava indurimenti della corona, che è la parte del piede dove termina lo zoccolo ed inizia il tessuto vivo. Le apponevo poi le fasce da riposo, fasce di lana arrotolate attorno allo stinco del cavallo su della bambagia posta ad intercapedine, che esercitano un massaggio de faticante ed una protezione mentre l'animale riposa.
Per poter eseguire tutte queste azioni che richiedono anche un certo dispendio di tempo ed energie è necessario che il cavallo sia consenziente, anzi, che collabori, cosa che gli si insegna da piccolo, quando è facile per lui imparare ogni cosa.
Evidentemente nulla di tutto questo era stato insegnato a Tuba e di certo la prima ferratura le era stata praticata in modo coercitivo, - ferrare un cavallo è una operazione in sé indolore ma abbastanza lunga e disagevole perché il esso deve lasciarsi tagliate e limare l'unghia troppo cresciuta ed apporre il ferro che viene inchiodato con appositi chiodi nella parte cornea, che quindi non sente dolore ma che ugualmente, ad un animale non abituato, crea di certo qualche problema. -
Quindi la prima volta che io, in posizione laterale alla sua zampa posteriore per stare in sicurezza, feci per allungare la mano ed afferrare il suo zoccolo, lei mi rifilò un sonoro quanto robusto calcione.
Se non avete mai visto dal vero un cavallo scalciare, difficilmente potete immaginare quanto potente e veloce sia quel gesto. E pericoloso, perché se un essere umano viene colpito in pieno da un calcio di un cavallo che indossa ferri, di certo riposta ferite gravi, a seconda della zona dove il calcio arriva. Infatti, ricorderete che vi ho già raccontato che Tuba spaccò una gamba allo stalliere che andò ad afferrarle il piede per aiutare il maniscalco, una volta che io non c'ero, dato che ero andata in Inghilterra e l'avevo portata al circolo ippico perché si prendessero cura di me in mia assenza.
Fu una cosa difficoltosa e complessa che richiese diverse settimane di infruttuosi e pericolosi tentativi, convincere Tuba che poteva lasciarmi prendere il suo piede senza venire ferita o infastidita: reagì scalciando vigorosamente per giorni e giorni.
Io, per fortuna o per bravura, riuscii sempre ad evitare di venire colpita e non mi feci mai male.
Per assurdo un incidente con i suoi zoccoli accadde molto tempo dopo, quando lei era diventata docile e mansueta: mentre le stavo mettendo le fasce, in un clima di totale fiducia e tranquillità, lei fece un movimento improvviso con un piede anteriore, forse per scacciare una mosca e mi colpì sul naso, stendendomi a terra svenuta con un autentico e proprio ko pugilistico. Il mio naso non riportò fratture, in modo assai strano e miracoloso, dato il fortissimo colpo subito ma restò violaceo per un paio di settimane ed ancora conserva un leggero ingrossamento verso al radice, che mi ricorda quel fatto straordinario. Ero sola nella stalla, naturalmente e rinvenni quasi subito: mi rialzai veramente stordita ed impiegai parecchio per riuscire a recuperare tutte le mie facoltà...
Ma fu davvero un incidente involontario. All'inizio, invece, lei aveva intenzione di colpirmi per togliersi da torno questa ' matta ' che le faceva ogni sorta di cose a cui non era assolutamente abituata: tre tipi di spazzole passate una dopo l'altra su tutto il copro per avere un mantello perfettamente privo di polvere e lustro, la spugna bagnata per lavare il muso: occhi froge e bocca, la cura di zoccoli e zampe che vi ho appena descritto, spesso un bagno parziale o integrale, questo nei mesi estivi, ovviamente, con shampoo, schiuma e tutto il resto – acqua tiepida, naturalmente -... poi la ferratura ogni due mesi, la tosatura all'inizio dei mesi freddi per evitare pericolose infreddature e relativo uso di coperta. Il lavaggio delle zampe se si tornava a casa tutte inzaccherate di fango, cosa comunissima, poi, vaccini, medicinali contro i parassiti intestinali...
Quante cure vengono prestate ad un cavallo, se lo si vuole tenere sano e bello. A tutto questo si aggiunga la pulizia della paglia o torba o altro strame dove vive, - io usavo la paglia - e la somministrazione del cibo almeno tre volte al giorno. Poi la sellatura, - cosa che Tuba odiava – e la cura dei finimenti stessi con grassi appositi ed altro.. via, vi rendete conto che per anni la mia cavalla è stata la metà della mia giornata, tra una cosa e l'altra.
So che non tutti fanno questo, so che si può essere meno esigenti ma io... io sono esagerata sempre in tutto e troppo puntigliosa, desiderando sempre il massimo, se non la perfezione, per ognuna delle cose a cui mi dedico. Quindi la cura di Tuba ed il cavalcarla mi assorbiva tantissimo tempo. Per questo non posso fare a meno di raccontarvi questi particolari che forse a voi sembreranno meno influenti di altri: perché, la prima volta che allungai la mano per prendere il suo piede e lei non scalciò, io mi sentii percorrere tutta da un brivido di calda emozione che ha un solo nome: amore, il mio per lei, il suo per me.
E l'odore del catrame vegetale, della sua pelle, del letame, del cuoio della sella, del nostro sudore tutto si mescola,insieme, nel mio ricordo, con la più bella sensazione di purezza e di bellezza da me mai provata fino allora e che nulla mai eguaglierà.
Perché si, ho amato assai di più, mi sono fusa assai di più, molti anni a venire da quei giorni che sto ora ripercorrendo con il ricordo ma poi sono stata strappata da quell'unione, a viva forza e contro la mia volontà. Quell'essere unico che si era formato con quell'altro essere da me amato è stato di nuovo dilaniato, squartato diviso, con il dolore che solo chi ha provato una esperienza simile alla mia può capire. Un dolore che porta alla follia ed alla morte.
Tuba no. Tuba, si unì a me e mai si divise. Neppure quando io mi divisi da lei, neppure quando morì. Lei rimase me ed io lei, mai si sottrasse alla bellezza che eravamo, alla purezza all'amore che ci univa. Ed è per questa ragione che affermo che ciò che ho vissuto con lei non ha eguali, nella mia esistenza.
Perché tutta la casa viveva di lei, dei suoi profumi, dei suoi rumori.
Io stessa, per anni, dal 1978 al 1982, ho vissuto di lei.
E dal momento in cui lei divenne la mia compagna equina, per giorni, per mesi, ebbi le palpitazioni.
Quella volta, per l'emozione e per la gioia.
La nostra fattoria ha avuto centinaia e centinaia di abitanti. Capra e capretti pecora conigli galline oche anatre scimmia gabbiano civette colombi criceti canarini puzzola lepri, oltre naturalmente i diversi levrieri la bulldog la dobermann i bassotti e un numero imprecisato di gatti. Ma Tuba è stata il suo cuore. Ed anche il mio.
Mi rendo conto che ognuna di quei cani, quei gatti e di tutte le altre bestioline che hanno abitato con me io dovrei scrivere, narrare. Per alcune un romanzo intero, per altre solo un racconto. Magari lo farò ma non ora. Ora voglio proseguire con il racconto principale.
Voglio però di nuovo sottolineare quanto la mia vita di quei giorni sia stata intessuta a quelle creature che l'essere umano chiama, con grande grettezza e stupidità, 'animali' quindi esseri inferiori. Loro non lo sono, loro sono uniti all'uno, ancora e con grande empatia e ne seguono sempre le leggi, senza mai discostarsi. Quello che gli uomini chiamano istinto altro non è che la genuina essenza della vita, la verità, la via.
È la nostra mente che ci distacca dal vero e dal giusto ed ha creato, macchinosamente e malvagiamente, questa nostra società fondata sul guadagno e sul potere.
Gli ' animali' non vivono che non seguendo le leggi del loro essere e ciò fa capire quanto siano puri.
Io credo e sento che loro siano venuti qui, su nostra madre Terra, per insegnarci che vi è un modo di vivere naturale, che si fonde all'ambiente che ci circonda, che non lo cambia, che non lo altera o lo rovina. Ma, soprattutto, credo che gli ' animali ' siano qui giunti per amarci, per dare a noi, esseri che non sanno amare e farsi amare, quel sentimento incondizionato e totale che solo loro sanno provare.
Quindi, ad ogni nuovo abitante che si univa, per scelta e per avventura, alla nostra fattoria, io, Carlo ed Angela, vivevamo di lui o lei, imparando la sua storia, la sua natura ed arricchendoci di quanto, meravigliosamente, lui o lei ci donava. A chiosa di quanto sopra scritto, riporto questi miei versi e poi riprendo la narrazione cronologica...
IL SOGNO E' ANCORA QUELLO
Era il 12 luglio 2010.
in una notte troppo calda e sola scrivevo questo:
La cavalcata per me sarà in serata
sul mio arabo pomellato che tiene su la coda
come un principe del deserto
Un maschio intero
fremente come il vento
docile come una fanciulla
Cavalcheremo tra dune
di sabbia giallochiaro
e macchie di vegetazione inattesa
rubata all'arsura del ghibli
e là raccoglierò il mio sogno
e lo terrò stretto tra le mani
Gli legherò un lungo filo
d'aquilone
alla coda
perchè gareggi col vento
né si spenga mai
e rida di ogni nuvola che passa
di ogni riccio di vento
di ogni palmizio addormentato
al sole
A notte accenderemo il fuoco
e lui appoggerà il suo muso di
seta e velluto contro la mia spalla:
saremo racchiusi nel cerchio
di luce del fuoco che tiene lontane
le serpi velenose e
i malvagi della notte
Saremo insieme in una vita
che sempre è sogno
che sempre è sonno
che sempre mescola i confini
Saremo io
il cavallo e ..
tu.
Carlo si sentì male ed ebbe diverse coliche biliari.
Lui che era così forte e resistente, che non diceva mai nulla, che non si lamentava mai, sbiancava in viso e doveva coricarsi per ore, finché con Buscopan ed altro non gli passava. Le coliche si susseguirono e alla fine si arrese andò dal medico, si fece fare gli accertamenti e si vide che aveva la colecisti zeppa di calcoli. Così lo ricoverarono e gli praticarono una colecistectomia.
Io caricavo la bambina sul motorino ed andavo in ospedale a trovarlo, era gennaio. Faceva molto freddo, ma non avevo nessuno a cui lasciarla. Allora le mettevo il maglioncino bello caldo caldo, la infilavo nella tutina imbottita impermeabile, che sembrava un palombaro rosso, poi, sciarpa fin sul naso, berretto fino agli occhi e guanti, la assicuravo bene bene ad una seggetta fatta apposta che avevamo comprato e via, si correvano quei dodici chilometri che ci separavano dal papà.
E poi, al ritorno, mi fermavo al piccolo supermercato dove andavamo di solito, a fare la spesa. Ma mi sentivo così sola ed abbandonata, senza di lui.
Ricordo un giorno che c'era la nebbia ed era quasi buio: le nebbie del ravennate sono famose per la loro densità, quando ci si mettono sul serio è come essere immersi in un bicchiere di latte. Andavo pianissimo, ero a qualche chilometro da casa ma non vidi la rotaia che c'era per terra: la ruota del motorino ci si impigliò un po' dentro o scivolò ed io caddi. Ressi il peso con il mio corpo, parandomi tra la moto e l'asfalto, in modo che Angela non toccò terra. Si spaventò solo e cominciò a piangere ma io mi rialzai subito e la rassicurai. Solo che le buste della spesa, in parte colpevoli dell'accaduto, che erano attaccate al manubrio da ambedue i lati della moto, si erano rotte e tutto era caduto per terra. Alcune bottiglie si erano infrante, le mele le arance si erano schiacciate.. era buio, avevo paura che ci investisse un'auto ma non volevo perdere la mia spesa. Così, il più velocemente possibile, riuscii con due buste a farne una che tenesse almeno un po', raccattai da terra, aiutata dai fari della moto, ciò che si era salvato e ripartii, giungendo dopo poco a casa. Diedi la cena ad Angela e poi la misi a letto e, quando fu addormentata, potei piangere a mia volta, sentendomi come un randagio abbandonato e tanto spaventato che dovesse però sostenere il proprio cucciolo nonostante fosse in così grande personale bisogno. E quella sensazione, lo sentivo, non era data solo dall'assenza di Carlo, che di certo era il mio faro nella nebbia ma da qualcosa di assi più profondo.
Ma mi feci forza e lui fu forte, si rimise in piedi presto: dopo una decina di giorni fu dimesso e tornò a casa, dimagrito e pallido ma pronto a riprendere immediatamente il lavoro, nonostante gli avessero lasciato un piccolo catetere che io gli disinfettavo più volte al giorno. Ma per lui il lavoro è sempre stato sopra ogni cosa: ha lavorato sempre, ogni giorno, anche con la febbre, in ogni condizione. Perché si fermasse ci voleva qualcosa di davvero grave e forte, come appunto un'operazione al fegato.
Parlando di questo ho rammentato la sua dolorosissima tonsillectomia, qualche mese prima del nostro matrimonio e il suo incidente con la vespa, qualche anno prima, nel quale si scorticò tutto: pancia gambe braccia. Era come l'avessero spellato vivo. Ma, a parte quegli episodi, Carlo ha sempre goduto e gode di ottima salute.
Ora è un austero signore canuto e pelato, imponente ma non più grasso, che vive ancora per il suo lavoro....
La vita scorreva veloce e la nostra bambina diventava sempre più vivace, autonoma, testarda e a me avversa.
Cominciò a frequentare la scuola materna. Ricordo benissimo il primo giorno: mi recai all'appuntamento, dopo aver sostenuto i giorni precedenti un paio di colloqui per spiegare lo stato di salute di Angela, fare il punto delle sue abitudini alimentari e delle necessità. Inoltre, portandola con me, la lasciammo giocare un po' con gli altri bimbi per vedere quale fosse la sua disposizione d'animo verso un gruppo: aveva appena compiuto i tre anni e, fino ad allora, aveva conosciuto solo Margherita.
Si vide subito che la piaceva giocare e che era vivace. A quel proposito io dissi alle maestre che lei era MOLTO vivace, spiegando loro i motivi. Le maestre mi guardarono con un mezzo sorrisetto tra il sornione, il sufficiente e la piccola derisione e mi risposero che noi mamme dicevamo tutte la stessa cosa e che loro erano abituate, che un bambino vivace era una benedizione di Dio eccetera eccetera eccetera. Io le guardai a mia volta con un tono di sfida e lasciai loro la mia creatura.
Quando tornai a prenderla mi confessarono, con gli occhi fuori dalla testa, che avevo ragione che si, Angela era DAVVERO molto vivace.
Infatti i tre anni di frequenza furono costellati di continui aneddoti.
Uno tra tutti ne racconto, che credo piuttosto esemplare. C'era un bimbo che la mordeva e lei venne a casa più volte con i segni dei suoi denti. Ne parlai con le maestre ma la cosa si ripeté. Angela era spaventata di questo e minacciò di non voler più andare a scuola. Allora il padre le disse, con la sua fredda logica: ' Se lui ti morde, tu dagli un pugno sul naso! '
Non so se Carlo pensasse che la figlia avrebbe eseguito alla lettera il suo consiglio ma così fu: ci telefonarono le maestre tutte arrabbiate che Angela aveva dato un pugno sul naso ad un bambino e di andare subito a parlare con loro. Io lasciai che lo facesse lui ed infatti so che si sistemarono piuttosto definitivamente. E, risultato tra i risultati, quel bimbo rispettò nostra figlia per sempre e come nessun altro.
Di certo a me non sarebbe venuto neppure in mente di consigliare a mia figlia di tre anni di spaccare la faccia ad un coetaneo e forse anche per questo la fede e l'amore per suo padre crebbe a dismisura, dopo che le aveva dato decisamente il consiglio giusto.
Ma ogni giorno per Angela e con Angela ce n'era una nuova.
Problema numero uno: le dovemmo mettere gli occhiali per un astigmatismo. Le facemmo scegliere il colore della prima montatura e sembrava allora un topolino con gli occhiali ma ne faceva fuori un paio alla settimana, no so come facesse, forse tirava in quelle stanghette finché non fossero rotte ma ci riusciva benissimo, nonostante noi le acquistassimo sempre le migliori e le più robuste. Una volta un paio andò perso. Si cercò ovunque ma non venne trovato mai. Mesi e mesi dopo, un giorno che alla scuola materna portarono via il grande mucchio di sabbia nei quali i bambini giocavano, perchè venne ritenuto ad un tratto anti igienico, sul fondo de quella notevole montagnola si trovarono gli occhiali di mia figlia: come fossero riusciti a giungere sin lì, resta un mistero messo al novero degli annali della storia.
Problema numero due: siccome lei, come me, aveva avuto problemi con le anche e aveva dovuto portare il cuscino divaricatore dai sei ai nove mesi. - particolare che mi era sfuggito e non ho narrato a suo tempo – di conseguenza crescendo si vide che aveva il ginocchio valgo ed il piede piatto, così le ci vollero delle scarpe ortopediche che costavano una fortuna. Ci recavamo a Bologna a farle fare tutte le lastre, le visite ortopediche i controlli, dato che il piede di un bimbo cresce in fretta ed ogni tre , quattro mesi ci voleva un paio di scarpe nuove. Per fortuna potevamo permettercele ma per lei fu comunque un problema, che avrebbe voluto indossare le varie scarpe, scarpette ciabattine di Barbie ed invece doveva indossare quegli scarponcini blu, molto duri e pesanti che mi riempivano le gambe di ecchimosi, quando la tenevo in braccio, dato che non stava ferma un minuto ed agitava le gambe continuamente, colpendomi: quella suola così rigida faceva un male notevole.
Problema numero tre: se alla scuola materna dette parecchio da fare alle insegnanti, nulla fu però in confronto alle elementari. Non le piaceva studiare era molto disordinata, poco attenta, non stava mai ferma, non riconosceva la disciplina: le maestre dovevano farla uscire dall'aula e permetterle di correre nei corridoi, perché era incontenibile.
Ma tutti le volevano bene lo stesso.
Era un micro paesino, quello in cui abitavamo, fatto per lo più di case sparse, proprietà di piccoli contadini e poi una scuola una chiesa un negozio - bar. Eravamo conosciuti da tutti: Carlo era il fattore della cooperativa, io quella che aveva il cavallo.
Problema numero quattro: Angela era molto intelligente e sveglia, sapeva quello che voleva e come, cosa che si vide da subito. Ma quello che voleva non era mai ciò che volevo io.
Lotte infinite e continue per lavarla, vestirla, convincerla ad andare in bagno prima di bagnare le mutandine e fare qualsiasi altra cosa: lotte che vinceva sempre e solo lei. Non c'era modo che io la convincessi di nulla,.
Poi mi chiedeva ripetutamente di lasciarla sola in casa, non voleva mai venire con me.
Le regalavamo giocattoli in grandi quantità, soprattutto quelle famose bambole Barbie, di cui ne usciva un modello nuovo ogni piè sospinto e che noi, distrutti dalla sua insistenza, capitolavamo e le compravamo ma che lei distruggeva e tagliava con le forbici, troncando mani, piedi, togliendo scalpi.
Problema numero cinque: anche con la televisione avemmo uno scontro epocale ed epico con lei: io e Carlo eravamo dei rivoluzionari ed eravamo contrari al consumismo ed all'intruppamento di stato. Possedevamo solo una vecchia tv in bianco e nero che prendeva esclusivamente i canali della RAI. Noi guardavamo la tv assai poco, giusto qualche film ed un po' di informazione e ci rifiutavamo assolutamente di seguire le tivù commerciali che stavano sorgendo giusto allora. Preferivamo trascorrere la serata leggendo, ascoltando musica oppure giocando a carte o a Mah – jong con gli amici. Ma i compagni di scuola di Angela vedevano i cartoni animati e ne parlavano tra loro: lei ovviamente era tagliata fuori da questo e ciò la faceva arrabbiare terribilmente. Inoltre era incuriosita e quando aveva occasione di vedere tivù a colori da Margherita o altrove poi a casa ci faceva una testa così per averla lei pure. Come spiegare ad una bambina piccola le nostre idee? Ci provammo ma tutto fu inutile. Alla fine capitolammo e lei divenne tivù – dipendente come tutti gli altri.
Problema numero sei: o cercavo di andarle dietro con le buone, desiderosa di essere una buona madre e assolutamente convinta che le maniere forti non fossero efficaci, con i bambini, anzi, il contrario, fossero distruttive. Quindi le spiegavo sempre tutto, le parlavo, cercando di farle vedere il lato logico e conveniente delle mie richieste ma i miei discorsi cadevano tutti nel vuoto. E non è che io fossi una madre asfissiante: lasciavo che giocasse, che si sporcasse, che avesse momenti di libertà. Ciò che le chiedevo era di rispettare le semplici regole dall'alzarsi per andare a scuola, di lavarsi i denti dopo mangiato, di andare in bagno, di lavarsi e cambiarsi, di non toccare certe cose che erano pericolose, di lasciare i giochi e venire a mangiare se era ora di cena o andare a letto se era giunta l'ora di dormire. Di rispettare le sue cose, di non romperle appositamente, di non camminare a piedi nudi d'inverno, cosa che la faceva sempre ammalare con le conseguenze pericolose che questo aveva, di raccogliere i suoi giocattoli libri ed altro e di rimettere in ordine la stanza, all'inizio insieme a me poi, da più grande, in autonomia. Ma Angela sapeva rispondermi sempre di no.
Mi capitò spesso di perdere la pazienza e gridare, anche di allungarle qualche sculaccione, non sapendo più a che santo votarmi.
Una volta le diedi uno schiaffo a mano aperta sul viso.
Non ricordo più cosa avesse fatto per farmi perdere le staffe a quel modo ma comunque rivedo perfettamente la scena dalla mia mano che partiva, come avesse una volontà sua e si andava a scontrare con la sua guancia dove rimasero impresse le mie cinque dita per due o tre giorni.
Mi sentii un mostro e piansi tra le braccia di suo padre, la notte.
Gli chiedesi tra le lacrime dove io stessi sbagliando, se lui sapesse dirmi cose avrei dovuto fare per risolvere quel problema così spinoso. Lei era felice solo se stava con lui e a lui era portata ad obbedire di più. Ma il fatto era che a Carlo importava meno dell'igiene e dell'ordine, lasciava più correre: per evitare di entrare in contrasto con lei, gliele dava tutte vinte. Quella notte mi disse che avrei dovuto essere più giocosa, più allegra. Io già mi impegnavo a fondo in tutte le attività scolastiche di nostra figlia,, partecipando come responsabile dei genitori eletta per tutti gli anni che abitai lì. Mi impegnai sempre in prima persona per organizzare carnevali, feste e tutto quello che c'era in ballo. Ero il portiere della squadra femminile di calcio delle ammogliate. Ogni qual volta che il paese, la scuola od il parroco organizzavano qualcosa io ero sempre disponibile alla preparazione e partecipazione. La portavo dove voleva, cercavo davvero di fare il mio massimo. E non capii mai e poi mai come farmi voler bene da quella figlia. Rifiutava i miei baci, gli abbracci, le coccole. Rifiutava tutto, da me e di me. E così è ancora oggi.
Anche questa fu una delle ragioni per cui, quando lei cominciò ad andare alla scuola materna, io mi iscrissi all'università di Bologna, alla Facoltà di Veterinaria.
I miei amici, che ancora a volte sentivo o vedevo, quando tornavamo nella nostra città natale e loro erano lì oppure se venivano loro stessi a trovarci, studiavano tutti.
Io cominciai presto a pentirmi di non aver proseguito gli studi ed espressi il desiderio di voler ricominciare a studiare e prendere la laurea in veterinaria, altro mio grandissimo desiderio, da molto tempo ormai.
Carlo, manco a dirlo, non fu d'accordo, non voleva, continuando, ogni qualvolta io esprimessi il desiderio di fare od avere qualcosa, a reagire sempre immediatamente con un bel no, come mia madre prima di lui e come sua figlia.
Dovetti impiegare giorni, mesi per convincerlo ma anche quella volta raggiunsi il mio obiettivo: mi iscrissi all'Ateneo di Bologna.
Non frequentavo le lezioni, però studiavo a casa.
Era impossibile per me farlo perché recarmi in treno a Bologna tutti i giorni voleva dire star fuori di casa fino a sera e quindi non avere più tempo per la casa la bambina la cavalla, per nulla. Così compravo il libro di testo dell'esame che intendevo dare e studiavo.
Il primo che tentai fu istologia ma fui bocciata: ero appena uscita da una polmonite contratta in pieno inverno per aver preso freddo cercando di asciugare un nostro cane fuggito e ritornato tutto bagnato. Per evitare che si ammalasse lei, era la nostra bulldog, Pirata, lo feci io.
Era gennaio e faceva molto freddo, di nuovo come quella volta che Rufus ci avvisò di quell'incidente automobilistico. Pirata, una femmina di bulldog che ci aveva regalato lo stesso allevatore di Bessy, - dato che dopo diversi tentativi non era mai riuscita ad avere cuccioli, - era in calore. Era il tempo in cui non tutta la nostra area cortilizia era recintata ma solo un piccolo quadrato davanti al casotto, dove tenevamo Lazlo.
Laszlo era un bellissimo levriero ungherese che era stato rubato da un gruppo di cacciatori italiani che avevano fatto una partita di caccia lassù: l'avevano visto, l'avevano preso, caricato sul furgone e portato in Italia. Ce lo raccontò lo stesso autore del furto che poi lo aveva chiuso in un piccolo box assai sporco e lasciato lì a vita, senza più curarsi di lui. Io vidi il povero animale una volta che con la mia carissima amica che aveva la sorellina di Lady, che si chiamava Bambi, ci recammo nel macello di polli di quest'uomo per acquistare una piccola partita di carne congelata per i nostri cani. Avevamo Bambi con noi e l'uomo credette che il ' suo 'levriero fosse della sua razza. Ma il cane era ricoperto di piaghe ferite e croste, era magrissimo e così triste ed abbattuto che mi ribellai furiosamente a quel vedere. Avrei ucciso quell'uomo ma, desiderose di salvare il cane, io e la mia amica gli parlammo in modo il più amichevole possibile e lo convincemmo di darmelo, in cambio di un suo futuro cucciolo con la levriera. In fondo a quell'essere spregevole del cane non interessava nulla ed acconsentì, pensando di certo che il cucciolo sarebbe stato facile da rivendere. D'altronde il povero animale era così male in arnese che sarebbe morto tra non troppo tempo. Così portai a casa nostra il bel levriero fulvo e lo chiamai Laszlo, nome che mi piaceva molto.
Lo curammo e con antibiotici cortisone cibo buono e carezze si riprese presto. Era molto docile ma poco ubbidiente e molto agitato, quindi difficile da tenere in casa, dove stavano Pirata e Batù, col quale andava assai poco d'accordo. Così lo tenevamo molto in quel recinto, nel quale poteva correre ed essere più libero. Non tutti i cani amano vivere tra le mura di un appartamento e Laszlo era uno di quelli. Quella notte portai giù Pirata per i suoi bisogni e feci uscire Laszlo dal suo recinto per giocare un po' con lui ed accarezzarlo: avevo sempre paura che si sentisse troppo solo. Era uno spettacolo vederlo correre, velocissimo come il vento, quando lo liberavamo e quindi cercavamo di farlo più spesso possibile: il recinto era di circa venti metri di lato ma non abbastanza grande per permettergli di spiccare i suoi prodigiosi balzi di galoppo.
Ma quella volta feci un grave errore: Pirata, resa disubbidiente dal calore, fuggì via, sorda ai miei richiami disperati e Laszlo, chiamato dalla natura, le corse dietro. Era buio, cercammo con l'auto nei dintorni ma era come cercare il famoso ago nel famoso pagliaio.
Così ci arrendemmo ed andammo a dormire, sperando che presto sarebbero tornati da soli entrambi.
Infatti, alle due di notte sentimmo l'inconfondibile abbaiare di Pirata che, davanti alla porta di casa, ci stava chiamando a gran voce perché scendessimo ad aprirle la porta: era bagnata fradicia ed era sola: di Laszlo neppure l'ombra. Io scesi di corsa in ciabatte e pigiama, a piedi nudi, senza pensare al freddo che faceva, per asciugarla subito con la paglia ed il fon ed evitarle una polmonite che di certo le sarebbe stata fatale, data la natura delicata di quella razza.
Fui così premurosa che la cagna il giorno dopo stava benissimo mentre io avevo quaranta di febbre. E di Laszlo, purtroppo, non sapemmo mai più nulla, nonostante avessimo chiesto a tutti, cercato dovunque per mesi. Non tornò più, con mio immenso dispiacere e senso di colpa.
Per guarire dalla polmonite dovetti farmi una forte cura di iniezioni di antibiotico e quando venne la data dell'esame non avevo potuto finire di prepararlo bene ed ero così debole che ragionavo a stento.
Così, al primo tentativo, non lo passai e fu davvero una delusione enorme. Ma poi, alla sessione successiva, presi 28.
In meno di un anno diedi otto esami, di cui uno, chimica inorganica, tre volte, dato che la chimica che avevo studiato al liceo classico era assai superficiale. Inoltre, la professoressa di quella materia allora richiedeva una prova scritta molto difficile. Fu quella a darmi dei problemi: studiando da sola sul libro di testo non avevo trovato nozioni adeguate per superare quello scoglio. Dopo il secondo insuccesso mi feci dare una decina di lezioni private da una ragazza appena laureata in chimica e passai la prova con ventitre.....
Alla fine delle prime tre sessioni di esami, ad un anno dalla mia iscrizione, la mia media era di ventisette.
Poiché non sempre sui libri si trovava tutto quello che i professori spiegavano a lezione, io, studiando da sola, speso mi trovai in difficoltà: allora avevo imparato ad andare qualche giorno ad ascoltare le interrogazioni prima della mia, in modo da rendermi conto ed imparare quelle nozioni che, appunto, fossero state imprecise sul libro od assenti.
Così mi iscrissi al secondo anno ma dovevo ancora superare cinque esami del primo. Avevo già fatto i conti con il fatto che non sarei mai riuscita a laurearmi in cinque anni ma ciò non mi importava: intanto Angela sarebbe cresciuta ed io avrei avuto perciò più tempo e modo da dedicare allo studio. Fino ad allora, infatti, avevo praticamente sempre studiato di notte, nel mio tempo libero.
Mi misi così a preparare Anatomia Comparata Uno, di gran lunga l'esame più difficile dei primi tre anni: studiare tutte le ossa, i muscoli i tendini, gli organi e le funzioni di tutte le grandi famiglie di animali domestici: bovini equini ovini suini uccelli e roditori comparandoli all'anatomia dell'essere umano, non era uno scherzo. Ma un giorno mentre studiavo cominciai a vedere macchie, lampi, nebbia che offuscava tutto.
Capii immediatamente che i miei occhi stavano male.
Mi feci visitare d'urgenza da un oculista che mi trovò una grave sofferenza alla retina con un primo piccolo parziale distacco. Allora il laser non era cosa usata comunemente. Mi prescrisse delle iniezioni dolorosissime, - venti, che mi feci iniettare soffrendo una breve ma intensa e dolorosa paralisi alla gamba ogni volta, - e poi mi consigliò di indossare lenti a contatto e smettere di studiare.
Fu un colpo pesante, per me.
Nei mesi precedenti avevo cominciato ad andare presso la clinica della mia veterinaria per fare pratica e lì mi ero trovata benissimo anche perchè avevo conosciuto persone a cui mi sentivo legata e non potevo pensare di richiudermi in casa a fare la casalinga.
Ma in verità il fatto era che studiare da sola, senza poter frequentare le lezioni, risultava davvero molto pesante, difficile. Tutte le volte che dovevo andare a Bologna erano problemi con la bambina e poi Carlo continuava a non essere assolutamente contento che io studiassi. La tensione in casa stava salendo, sembrava che io facessi un torto a tutti.
Così decisi di smettere. Con il cuore a pezzi, conscia che stavo chiudendo una porta basilare della mia vita e della mia felicità ma decisi.
Fosse ora non lo farei assolutamente. Avessi saputo allora quanto la vita possa essere ingrata e difficile, a costo di morire e di perdere davvero la vista, mi sarei laureata. Avrei dovuto assumere una baby sitter per aiutarmi con Angela, tanto stava meglio con chiunque che con me.
Ma le favole di Walt Disney mi avevano insegnato che sarebbe bastato impegnarsi fino in fondo ed ogni cosa sarebbe tornata al suo posto ed io, allora, non sapevo che quella era la più grande menzogna sulla faccia della terra.

CAPITOLO DICIOTTESIMO
Cani cani e cani.. poi Scilla
Chiesi allora alla mia veterinaria se volesse assumermi per pulire i canili, i box e lavorare nella toelettatura. Lei, avendo già apprezzato le mie doti di lavoratrice, mi assunse subito.
Fu così che imboccai una delle strade maestre della mia vita.
Noi avevamo questi grandi levrieri a pelo ruvido, cugini della fatina bianca.
Dopo al morte della fatina altri levrieri a pelo raso vennero da noi, regalatici da un vecchio allevatore di Bologna, il famoso dottor Busacchi, che vide in me il fuoco sacro della passione per quel tipo di cane. Lady era figlia di due suoi cani ed io, venendo a conoscenza della sua esistenza, gli telefonai chiedendogli di poterlo andare a trovare e conoscere e visitare il suo allevamento.
Il vecchio gentiluomo si comportò in modo tale da affascinarmi: mi mostrò i suoi cani, tra cui il famoso padre della mia dolce levriera, che si chiamava Dingo, - come il nome del mio primo motorino! - raccontandomi una quantità di storie, aneddoti, consigli, curiosità e cose da sapere. Fu così delizioso che tornai più volte da lui nel giro di qualche tempo. Un suo conoscente aveva allora una cucciolata figlia di cani suoi e, dato che aveva difficoltà a vendere o collocare i cuccioli, il dottore mi chiese se ne volessi qualcuno. Eccome che li volevo!!
Andammo a vedere quella cucciolata e portammo a casa tre femmine: una da regalare ad una amica, Mizar, bianca e nera e due per noi, come capostipiti del nostro futuro allevamento: Swing, tigrata scura, Suzie Wong, tigrata sabbia chiara. Erano bellissime e dolcissime, avevano tre mesi.
Ma il mio gramo gramo destino sempre ha trovato il modo di fermare i miei progetti anche quando sembrava che la fortuna si fosse ricordata di me.
A quei tempi io già mi recavo giornalmente al Canile Municipale di Ravenna che era ubicato non troppo lontano da casa nostra. La prima volta ci capitai per caso, perché avevo trovato un cane sperduto in pineta, un cane da caccia, - cosa che mi è successa più volte- l'avevo condotto con me e, volendo cercare il suo proprietario, mi fu detto di rivolgermi lì.
Venni a conoscenza, o meglio, tornai ad imbattermi in quella realtà terribile che costringeva ogni cane smarrito a perire dopo tre giorni dalla cattura per mezzo del gas.
Proprio quel giorno in cui entrai per la prima volta da quel cancello il custode stava ' infornando ' una decina di ' morituri' ed io assistetti alla loro fine.
La camera a gas era un basso casotto con due porte di metallo: una di rete grossa e l'altra a tenuta stagna: il custode catturava i cani con l'apposito laccio e li conduceva, alcuni assai recalcitranti e furiosi, strozzandoli senza pietà, lì di fronte per poi cacciarli dentro, uno dopo l'altro: prima i più mansueti, poi i più pericolosi e mordaci.
Lì dentro c'era l'odore della morte, della violenze e i poveri animali reagivano in due modi diversi: o paralizzandosi dal terrore o diventando ancora più aggressivi. Infatti, mentre lui faceva entrare gli ultimi condannati, in quell'angusto ed oscuro pertugio già si svolgeva una zuffa terribile e sanguinosa e da fuori si udivano benissimo i guaiti e gli strilli che i cani più deboli emettevano, aggrediti e morsi dagli altri, impazziti dalla paura.
Io assistevo a mia volta paralizzata dallo stupore e dal dolore, sapendo anche che ciò che quell'uomo stava facendo era perfettamente legale, anzi, veniva persino pagato perché lo compiesse.
Quando finalmente il numero dei cani destinati quel giorno alla gasatura fu completato, lui chiuse la seconda porta, quella stagna, girò l'angolo ed aprì, a quel punto per fortuna, perché gli strilli i guaiti ed i ringhi erano divenuti strazianti, il rubinetto del gas: nel giro di qualche minuto, dopo ancora tutta una serie di atroci mugolii, esso decretò il silenzio assoluto nel casotto di mattoni.
Vorrei non aver dovuto assistere mai a quello e neppure allo spettacolo che mi si presentò quando il custode estrasse i cadaveri dalla camera a gas: ognuno di quei corpi, abbandonati finalmente alla pace della morte, recava i segni dei morsi inferti dagli altri ed alcuni di quei poveri animali erano stati gravemente feriti e dilaniati. Le pareti di quella infame piccola costruzione erano interamente ricoperte da schizzi di sangue ed escrementi.
Quando riuscii a smettere di piangere mi feci dire da quell'uomo chi fosse il responsabile giuridico di tutto quell'insano folle assurdo crudele feroce massacro. Che risultò essere il veterinario comunale capo.
Senza por tempo in mezzo telefonai, chiesi un appuntamento e mi recai a parlare con quel feroce burocrate.
' Lui era un veterinario? Ma per favore! Lui era un aguzzino ed un macellaio. ' Questo io gli dissi in faccia, furiosa ed indignata, giunta in quella specie di ufficio ambulatorio tra fegati di maiale portati ad analizzare ed altri organi vari appoggiati dovunque, con un odore che davvero era ripugnante. Sì, era il suo lavoro esaminare gli organi di animali sospetti che erano stati macellati, a guardia della nostra salute ma i cani?
Lui, colpito dalla mia veemenza, cercò di difendersi dicendomi che non faceva altro che mettere in atto la legge. Io gli chiesi se lui avesse un qualche potere decisionale, cioè se la sua parola avesse un qualche peso e colpii sul vivo. Rialzando la testa dalla carta sulla quale stava vergando disordinate parole, mi guardò con lo sguardo duro e desideroso di vendetta, dicendomi che la sua volontà dettava legge, lì dentro.
E così si incastrò da solo.
Per farla breve, perché questa storia che sto raccontando in poche righe durò anni, prima mi diede la gestione di un box dove tenere al massimo quattro cani, a mio insindacabile giudizio, ai quali venivano concessi trenta giorni di moratoria in attesa di trovar loro una famiglia che li adottasse. Cominciò allora la giostra degli annunci per radio, dei bigliettini appesi ovunque: quando il custode aveva nuovi arrivi mi chiamava, e questo accadeva più o meno ogni giorno, io mi recavo al canile e controllavo il povero animale catturato se avesse o meno i requisiti per essere adottato.
All'inizio fu per me molto difficile: avevo quattro posti per trenta giorni e se avessi sbagliato la mia scelta avrei sottratto ad altri cani la possibilità di salvarsi.
Per fortuna la cosa funzionò: gli animali scelti trovavano in fretta una adozione: la cittadinanza neppure sapeva che ci si potesse rivolgere al canile municipale ed avere gratis un cane, se l'avesse voluto, quindi, allertata dagli annunci ed dal passa parola, si rivelò una grande bacino di utenza. Il custode, che sempre, ad ogni cane consegnato, di certo percepiva una qualche mancia, si schierò dalla mia parte, vedendo il suo destino cambiare, diventare migliore e mi aiutò in tutto per tutto: davvero il mio desiderio era un ordine, per lui.
Il box allora, dato in 'uso' per l'affidamento divennero due, poi quattro fino a che praticamente solo cani pericolosi o gravemente ammalati ed incurabili venivano soppressi.
Anche in quello io pestai a lungo i piedi riuscendo ad estorcere per quegli sfortunati il diritto ad una morte indolore, riuscendo ad ottenere che il veterinario capo firmasse finalmente l'ordinanza che sanciva l'uso di una iniezione letale.
E la terrificante camera a gas fu definitivamente chiusa.
All'inizio di tutto questo impegno, altre due persone, due donne, si unirono a me e mi sostennero eseguendo le telefonate e i giri necessari per gli annunci. Ma l'onere di recarmi al canile per scegliere e gestire i cani e il veterinario capo rimase sempre mio.
Fu una dura lotta anche ottenere che venissero fatti dei lavori di risanamento a quella struttura, che ne aveva assolutamente bisogno e fu lunga la strada della rieducazione del personale a norme igieniche e deontologiche che non venivano assolutamente rispettate.
Quel luogo che, il giorno in cui vi entrai la prima volta, era ributtante allo sguardo ed all'olfatto, si trasformò notevolmente ed anche in un tempo abbastanza breve.
col passare dei mesi e degli anni, si affiancarono poi al nostro trio iniziale altre persone fino al giorno in cui l'ENPA si accaparrò tutta la gestione dei cani randagi. Mi chiesero se avessi voluto essere dei loro, mi offrirono un posto come consigliere, io li frequentai un paio di volte poi, sentendomi distantissima da loro, smisi di farlo, lasciando che si prendessero tranquillamente tutto il merito di quanto era stato fatto.
Che mi importava del merito? A me importava che i cani non venissero più uccisi e torturati così, quello solo importava. E dopo anni ed anni, smisi di recarmi al canile.
Ma ai tempi che sto narrando ora, ero all'inizio di quel lungo cammino che ha visto salvare la vita ad un numero elevatissimo di cani e in quei giorni un altro volontario mi mise a conoscenza del caso di una microscopica barboncina nera, chiamata Virgola, che stava vagando senza meta da una casa all'altra senza trovare la sistemazione giusta. Quell'uomo, lo seppi solo dopo, mi mentì, sapendo di mentire: Virgola era ammalata di cimurro, al secondo stadio, quindi portatrice asintomatica, in quel momento. E, dato che il destino è amaro in modo matematico, proprio in quel periodo ci fu per diversi mesi la difficoltà da parte dei veterinari di procurarsi il vaccino contro quella terribile malattia. Io andai a prendere Virgola: era una cosina di due chili, veramente microscopica e mi intenerii così tanto che non potei far a meno di portarmela a casa. Ma le mie levrierine non erano vaccinate, a causa della mancanza del medicinale: si ammalarono e morirono tutte e tre, nonostante le cure assidue ed assai dispendiose che io somministrai loro. Morì anche Virgola.
Allora il dottor Busacchi, colpito dalla mia sfortuna, mi regalò a sua volta una cucciolona di levriero: aveva riportato una lussazione ad una spalla e quindi non era un soggetto da esposizione ma era assai bella, di mantello bianco e nero ed era adattissima ad avere dei bellissimi cuccioli: le misi nome Honey pie.
Finalmente tutta l'area di un ettaro attorno alla nostra casa era stata recintata e quindi la nostra nuova amica, figlia del vento, sarebbe stata protetta e libera di trascorrere una lunga vita con noi ma... si, anche questa volta ci fu un ma.
Una pomeriggio sentii suonare al campanello: erano due carabinieri. La mia cagna aveva saltato la recinzione, era corsa sulla strada ed era stata investita da una macchina, proprio davanti ai loro occhi. L'auto, un'Alfa Romeo, aveva riportato danni notevoli e noi pagammo ottocentomila lire di tasca nostra, che allora erano una cifra notevole.
E, naturalmente, seppellimmo Honey pie, di fianco alla teoria di tombe, in un angolo esterno della nostra aia, che stava notevolmente allungandosi.
Allora io piombai in una crisi enorme e dissi che non avrei mai più tenuto con me un levriero inglese a pelo raso, data l'evidente sfortuna avuta con quella razza.
Ma senza cani non volevo stare. Avevamo cominciato ad esporre Lady e Batù, divertendoci ed appassionandoci alquanto a quel mondo un po' folle e volevo continuare. Volevo inoltre diventare una allevatrice amatoriale di cani.
Quale razza scegliere allora?
Ad una esposizione internazionale a cui ci recammo con Lady, l'ultima a cui lei partecipò, che si teneva a Bellagio, sul lago di Como, avevo incontrato una signora tedesca con dei magnifici giganteschi levrieri a pelo ruvido, grigio ferro ed argento.
Mi avevano colpito tanto, quei meravigliosi signori delle razze canine, come nobili rustici, un po' burberi, ma quieti, eleganti e con uno sguardo davvero vivo e penetrante e fu così che la mia scelta cadde su quella razza.
Naturalmente Carlo si disse contrario, discutemmo a lungo poi, come sempre, capitolò ed anzi, divenne un grande appassionato di quelle meravigliose creature.
Ma in Italia nessuno li allevava né ne possedeva qualcuno così mi rivolsi all'estero. Divenni socia del Club Inglese del Deerhound, il nome originale di quella razza, mi procurai libri che lessi e tradussi dall'inglese, studia i pedigree dei campioni e finalmente scrissi a qualcuno degli allevatori che ritenevo i migliori, chiedendo loro di poter acquistare una femmina alla prima cucciolata disponibile.
Solo una piccola allevatrice amatoriale che viveva ai bordi della Scozia si disse disponibile a venderci uno dei suoi cuccioli, gli altri non accettavano il fatto che l'animale dovesse allontanarsi così tanto da loro. Ma Pat, così si chiamava, capì la mia grande passione, vide che sicuramente l'avremmo tenuta benissimo ed accettò. Nacque tra noi una amicizia che durò anni, con un lungo scambio epistolare.
Noi ci recammo due volte in Inghilterra, facendo entrambi i viaggi in automobile. La prima volta viaggiammo con il Pallas e due amici più il loro bambino.
Fu un viaggio prettamente turistico: alloggiammo per tutto il mese di agosto in una casetta nel sobborgo più a nord di Londra e di giorno ci spostavamo con la metropolitana. Io me la cavavo piuttosto bene, con l'inglese e quindi ero la guida del gruppo.
Fu un viaggio stupendo nel quale visitammo a fondo il British Museum con i faraoni le mummie e Lucy, la prima donna umana – che veramente sembrava in tutto e per tutto una scimmia -e la Tate Gallery con tutto il rinascimento italiano, i fiamminghi Rembrandt, Goya e Leonardo e Van Gogh ed io, che mi fermai quasi un pomeriggio intero davanti ad un quadro di Goya, il ritratto di un uomo che, dovunque ti spostassi all'interno dell'area intorno, ti seguiva con lo sguardo.
Seguimmo poi tutta la serie degli itinerari classici per turisti, dalla Torre, al Big Ben, Piccadilly, il Tamigi, il ponte, Trafalgar, Buckingam e tutte le solite mete ma anche visitammo il Museo delle cere, la tomba di Carlo Marx, una esposizione e serie di gare durate tre giorni dedicati al cavallo in tutte le sue espressioni, tutte le pasticcerie e le birrerie che incontrammo, i pub, - giocammo a freccette con gente trovata nei locali e Carlo segnava il punteggio sulla lavagna con cifre latine, un po' per fare il fenomeno e un po' perché era sbronzo. - Poi Arrods e il mio primo Mac Donald, tutti i parchi e i laghetti ,dando da mangiare ai passerotti ed uccellini vari, un rione che era tutto un mercatino di cose vecchie e vecchissime dove comprammo un servizio da tea di Sheffield ed altre cose bellissime, tra le quali un vaso da notte in ceramica dell'ottocento, tutti i negozi di pipe, grande passione di Carlo che acquistò la prima della sua lunga serie di Peterson, tutte le librerie dove acquistammo libri sui cani in Italia introvabili, il gelato con la soda e la peggiore pizza mai mangiata in vita mia, l'immensa quantità di gente per le strade così larghe, le pettinate autostrade inglesi, guidare contro mano, la grande varietà di razze umane e le toilettes più pulite del mondo. Ma anche la Francia da sud a nord, con le pommes frites lungo la strada, le baguettes, i bistrot, le colline dolci, la Foresta Nera, le vigne dello champagne, i larghi fiumi e l'immensa cattedrale di Reims che svettava su una vastissima pianura,.
Poi, la seconda volta, l'anno successivo, a marzo, con il Land Rover Station Wagon a trazione integrale, acquistato da poco, ottimo per il deserto ma assolutamente inadatto per la pioggia battente che durò tutto il tempo del nostro viaggio e che mi infradiciò le ossa e lo spirito. L'attraversamento della Manica con il mare forza sette e Carlo a prua con il giaccone slacciato e senza cappello mentre faceva un freddo da belare, fermo immobile, con me accanto che cercavo di reggermi in piedi e di non morire di polmonite, a guardare le bianche scogliere di Dover che si avvicinavano. E poi l'abazia di Westminster, la cattedrale di Winchester, il collegio di Cambridge ed i canottieri che si allenavano sul placido canale, Stonhenge e la meraviglia provata nel vederlo spuntare all'improvviso dopo tutta una serie di saliscendi, così enigmatico, imponente, incredibile ed io, come impazzita di gioia a correre come una bambina tra quegli immensi menhir. La dolce campagna inglese con le grandi querce solitarie, i muretti a secco e le pecore dalle zampe corte, il paesino di Pat, su di una collina nera di carbone, che si chiamava appunto: Black Hill, la sua piccola casa ed un grande levriero su ognuno dei sei letti, Anne, la cagnona - mamma che aveva avuto i cuccioli e quella torma di nove puledrini sgraziati grigi che ci corsero incontro e tra loro lei, che fu chiamata Ardeth Neroli che poi divenne madre e capostipite del mio piccolo allevamento che ebbe vita assai breve. E poi la cena in famiglia e noi che non sapevamo come mangiare, in che ordine cioè, tutte le pietanze che erano poste sulla tavola ed io che seguii esattamente tutto quello che faceva il nonno, indiscusso leader di quel gruppo di persone e cani. Poi la passeggiata con tutti i cani lungo le rive di un quieto lago e le loro esplosioni di galoppi e l'emozione di stringere a me la prima volta la mia cucciola, tanto attesa e desiderata, che venne a noi solo un anno dopo la decisione di acquistarla.
Fu un viaggio bellissimo di cui però il ricordo più incredibile resto comunque la stanza da bagno dell'hotel rustico nel quale ci fermammo, alle porte del paesino di Pat, dopo tre giorni interi di viaggio sotto la pioggia senza altra sosta che per i bisogni igienici, quasi senza dormire. Carlo voleva restare ancora in macchina, dove avevamo messo nella lunghissima parte posteriore un materasso e ci si poteva dormire, ma io puntai i piedi: dopo tre giorni di quella vita avevo assolutamente bisogno di un bagno caldo, un pasto bollente ed un letto vero e comodo ma soprattutto asciutto, che nel Land Rover da deserto il problema delle infiltrazioni di pioggia non era stato neppure preso in considerazione, dai costruttori. L'ebbi vinta e salimmo su, in quella vasta camera. Già la vista del letto candido mi sollevò alquanto ma quando entrai nella grandissima stanza da bagno piastrellata di verdino e lilla e vidi l'immensa vasca, quando mi ci adagiai dentro, sparendo fino al naso nella bianca schiuma soffice, dopo tre giorni gelidi ed umidi con gli stessi vestiti addosso e senza potersi lavare che molto sommariamente, io provai una esperienza quasi mistica di benessere e beatitudine, che non dimenticherò mai..
Alla fine, davvero, ogni avventura umana è pur piccola cosa....
Ma una terza volta mi recai a Londra -e questo fu un paio di anni dopo, - però da sola, in aereo, per tre giorni, per visitare la più grande esposizione inglese di cani da bellezza, il famosissimo e decantato Cruft's.
Fu la prima cosa importante che feci da sola: andai a Milano in treno e trascorsi il pomeriggio ed il giorno dopo da Nadia, che viveva lì. Fu l'ultima volta che vidi la mia cara sorella, cara amica di sempre, anima affine, con la quale era proseguita un intensa anche se non costante corrispondenza. L'avessi saputo che già a quei giorni stava meditando quel volo dal cavalcavia che poi le rubò la vita pochi anni dopo! Invece l'essere umano è così cieco e miope e non vede poco meno di nulla e anzi, addirittura distorce quel poco che vede.
Io mi ero aspettata una bellissima rimpatriata con lei ma l'atmosfera tra noi restò strana, come se non riuscissimo a comunicare, come se quello che ci dicemmo, l'una all'altra, non fosse ciò che sarebbe servito, che era atteso. Solo dopo, quando lei morì, capii cosa fosse stato ciò che avevo distintamente captato e che non avevo saputo interpretare.
Ma io stessa ero già in preda al vuoto cosmico ad alla passione amorosa che poi mi strappò alle braccia ed alla dorata gabbia di Carlo. Io avevo bisogno che lei ascoltasse me, lei aveva bisogno che io ascoltassi lei e così nessuna delle due parlò né ascoltò.
Il destino ha mani assai lunghe.
Dopo la parentesi con Nadia, quindi, presi un volo aereo per la grande metropoli londinese, il viaggio era organizzato dall'ENCI – Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Praticamente era tutto preordinato: la mattina grande breakfast nella sontuosa sala dell'hotel a cinque stelle, poi in esposizione fino alla chiusura, alle 17, poi serata libera. Nel gruppo di partecipanti a quel viaggio c'era gente che conoscevo e mi divertii alquanto, facendo persino casino, una notte, andando in discoteca, io che mai ne avevo visitata una. Certo che dovevo essere ben buffa e, se ci credete, tutti mi guardavano. Mettete una discoteca londinese alla moda inizio anni ottanta, tutti vestiti più o meno da febbre del sabato sera, agghindati e stra – fatti, io senza trucco, il maglione verde di lana che mi aveva fatto mia madre ai ferri, i jeans e gli scarponcini. Ma come mi divertii a guardare tutti quei matti, che strana sensazione, io che venivo da piccolissimi paesi e cittadine, tutta quella gente di ogni colore e razza, tutti insieme accalcati ovunque. Allora mi resi veramente conto di quanto fossi fortunata a vivere come facevo.
Però la cosa più bella restò l'esposizione: ventitremila cani di tutte le razze, iscritti nei tre giorni del contest. - Da noi quando ce n'erano cinquecento massimo mille, di iscritti, si gridava al miracolo. -
Vidi tutto, girai dappertutto: dopo aver abbondantemente fatto colazione all'inglese con uova pancetta rognone, funghi salumi formaggi tea dolcetti e tutto quello che riuscivo ad ingurgitare, me ne vagabondavo da sola tra i ring e gli spazi per la toelettatura, la preparazione e gli stand commerciali. Gli inglesi erano cinquanta anni avanti a noi in tutto ma nella cinofilia anche di più. Nelle esposizioni canine italiane, negli stand commerciali era già tanto se si trovava un guinzaglio che non fosse di catena o una pallina o un osso; al Cruft's vidi di tutto, dai prodotti per i cani, con shampoo alla seta e coloranti, lacche, schiume, ed attrezzi dl mestiere a quelli sui cani, per gli umani: cappellini magliette gilè spillette libri tazze statuine portachiavi stampe antiche pupazzi peluche poster ed ogni specie di cianfrusaglia e chincaglieria - anche di ottimo gusto - che si potesse immaginare.
Avevo trecentomila lire per le spesucce, con me e, naturalmente spesi fino all'ultimo penny: ancora libri ed una serie di spillette, poi stampe, piatti decorati, statuette.. cosa non portai a casa...... fu bellissimo.
Ma fu anche bellissimo sperimentare la libertà. Perché Carlo era di certo un ottimo compagno ma piuttosto dispotico: si faceva quello che voleva lui e punto.
Ed io, sapete, ho un grosso difetto, che ho scoperto e capito fino in fondo solo molto più tardi: voglio fare solo ed esclusivamente quello che mi piace, mi appassiona, mi interessa e trovo giusto. E in quei giorni assaporai per la prima volta la libertà di andare, fare, fermarmi, tornare, interrompermi, riprendere, andare di nuovo, mangiare, bere, fermarmi esattamente sempre e solo quando lo volevo io e non al traino di Carlo o nella morsa dei bisogni e dei capricci di Angela.
Troppo presto mi ero sposata, troppo presto avevo rinunciato alla vita.
In quei giorni, lo capii.
E tutto dentro di me stava cambiando.
Nella clinica veterinaria, dove avevo cominciato a lavorare avevo, conosciuto una donna della mia età.
Quando la vidi la prima volta, con i capelli così neri, gli occhi altrettanto profondi di pozzo senza luna, il viso tagliente e l'espressione volitiva e amara, mi dissi che davvero non avrei mai voluto aver nulla a che fare con lei.
Dentro di me esiste una voce che mi dice come sono le persone che ho appena incontrato. Il fatto è che io non l'ho mai ascoltata, mai una volta. Solo dopo, molto dopo, dopo che mi hanno fatto tanto male allora ricordo il chiaro segnale che avevo ricevuto.
Ovviamente neppure quella volta capii quella voce e cosa mi stesse dicendo e in pochi giorni mi innamorai perdutamente di lei.
Si chiamava Scilla, in quei giorni era sposata, anche se poi, più o meno due anni dopo, si separò perché già si era innamorata di un altro, Piero Amaducci, a sua volta sposato, - mio omonimo ma non mio parente - e aveva una bambina coetanea della mia, Selene. Fu proprio il mio omonimo, socio della veterinaria nell'allevamento di cani terrier da esposizione, a condurre la sua amica là.
La bellezza di Scilla era così inquietante, la sua intelligenza così tagliente e logica, la sua dominanza sugli altri così spiccata che io divenni ben presto il suo cavalier servente, di nuovo, per la seconda volta nella mia vita, dopo Tati..
Io avevo ventiquattro anni. Da quel giorno stemmo sempre insieme: lei veniva da me con il suo amante e in quattro si giocava a mah-jongh, oppure si usciva a mangiare fuori.. le bambine giocavano insieme. Noi parlavamo parlavamo parlavamo.
Capii immediatamente di essermi innamorata di lei ma non glielo dissi mai chiaramente. Le confessai che mi stava accadendo qualcosa di molto strano: ricordo bene, quel giorno, eravamo sole, sedute in macchina in giro per la città per qualche commissione e dentro di me sentivo una grande forza che mi spingeva a dirle tutto, a porle il mio amore tra le mani e la mia vita al suoi piedi e un'altra altrettanto forte, che mi impediva di farlo. Lei disse che forse aveva capito ma io, colta da un subitaneo terrore, le chiesi di non dire nulla, di lasciare tutto come stava, che ero troppo confusa.
E così lei fece e quel discorso finì lì...
Mi dicevo che avevo troppa paura che lei mi allontanasse da sé, che l'amavo troppo e non potevo stare lontana da lei. Ero certa che non mi amasse, che mai avrebbe potuto amarmi ed io ero così presa, così disperatamente già dipendente da lei che poche ore senza vederla mi sembravano infinite ma, per fortuna eravamo sempre insieme.
Un giorno, sei mesi dopo il nostro incontro, lei e Piero Amaducci mi chiesero di parlare con me e, davanti ad un caffè, in un bar, mi proposero di aprire una toelettatura insieme. L'uomo aveva appena acquistato una struttura per la pensione e l'allevamento nella quale vi era già una toelettatura ma non avevano nessuna esperienza. Io, incapace di accontentarmi di lavare e tosare totalmente i cani con la tosatrice, avevo già cominciato ad eseguire lavori a forbice sui barboncini ed anche sui meticci, come avevo visto fare frequentando i ring delle esposizioni canine ogni domenica, quando andavo sempre ad ammirare i proprietari di cani a pelo lungo e a guardare come li preparassero per entrare in competizione, cosa che mi affascinava. I miei levrieri al massimo avevano bisogno di una spazzolata ed un bagno semplice ma quelle razze necessitavano di un vero e proprio lavoro di ' scultura del mantello ' eseguito con varie tecniche e strumenti, che io stavo approfondendo sui libri che avevo acquistato in Inghilterra e tradotto e in cui erano foto, schede tecniche, descrizioni teoriche.
Fu così che imparai a toelettare i cani: guardando gli altri, sui libri e sperimentando sui cani da compagnia che avevano necessità più semplici e mi permettevano di fare pratica senza il timore di rovinare nulla..
Quindi io avevo già una discreta esperienza e lui, che era un uomo assai più grande di noi, di più di venti anni maggiore ed era molto scaltro e navigato, aveva già visto la mia totale onestà, la mia voglia di lavorare e la mia passione sconfinata per lei.
La loro proposta mi lusingò molto: mi sembrò così strano che loro due, che erano così superiori a tutto e tutti, mi ritenessero degna di lavorare in società, quindi accettai.
Mi licenzia dalla clinica veterinaria, senza patemi, rimanendo assolutamente amica sua e di tutti gli altri componenti dello staff e detti inizio alla mia avventura di lavoratrice in proprio.
Ma io e Scilla non andammo a lavorare che un paio di volte nella struttura di Piero. Subito si capì che l'ingerenza della moglie di lui sarebbe stata insostenibile e così decidemmo di aprire noi due sole, in società al cinquanta per cento, una toelettatura nostra.
Trovammo una vecchia casa in affitto, tanto grande quanto scalcinata, ad un costo davvero esiguo, dato lo stato in cui versava. Avevamo cercato un negozio vero ma quelli disponibili avevano un canone d'affitto assai alto. Invece lì le spese erano assai basse ed inoltre la costruzione era ubicata su di una delle affollate arterie che convogliavano il traffico in entrata ed uscita dalla città di Ravenna
Al piano terra sistemammo tre stanze ed organizzammo la toelettatura con vasca tavoli, fon professionali eccetera. Facemmo tutto da sole, compresi i rivestimenti lavabili: i nostri mariti ci aiutarono ma io eseguii tutta la parte della pittura sia dei muri che degli infissi.
Il nostro laboratorio venne benissimo, almeno così ci sembrò. Eravamo orgogliose.
Cominciarono a venire i primi clienti, ma il lavoro languiva: erano tempi in cui ancora i cani non erano tenuti così bene come ora. Di certo nelle grandi città era diverso ma n quella piccola cittadina di provincia la gente faceva da sé oppure non faceva affatto.
Io ero felice di stare vicino a lei, tutto era diventato così bello allegro, interessante, le nostre giornate insieme scorrevano via nell'armonia, nel continuo parlare e poi avevamo sempre qualcosa da fare, qualche parte dove andare, anche solo fosse dal fornaio insieme per comprare il pranzo: tutto aveva un sapore nuovo ed intenso.
Eppure, nonostante quello, ancora una volta l'amare una donna, il mio essere omosessuale non raggiunse la completa accettazione e consapevolezza.
La sera scrivevo poesie d'amore per lei, rivolgendomi, io donna, a lei, donna, con i pronomi e gli aggettivi al femminile poi, la mattina dopo, correggevo e parlavo di un fantomatico lui.
Ma il mio stato di innamoramento era così evidente che, per mascherare con lei ed il suo amante il mio animo alterato spolverai la storia del professore, dicendo che pensavo sempre a lui.
Non che non fosse vero, perché in effetti mi mancava moltissimo.
Dal giorno in cui gli portai la mia bambina per fargliene un simbolico dono, non l'avevo più né rivisto né gli avevo parlato.
Scrissi, in quei mesi, un racconto di un qualcosa che tra noi non era mai avvenuto ma che io avevo una immagine chiarissima e particolareggiata: un modo assai diverso da come si erano svolte le cose. E dissi a lei, facendoglielo leggere, che quella era stata la realtà veramente accaduta.
Non so perché lo feci. Non è mia abitudine mentire. Ma lo feci.
Forse per contrapporre, io pure, un amore al suo, evidente, per il suo amante.
Perché io ero la sua consigliera e colei che accoglieva i suoi sfoghi verbali e le contrizioni che le dava la storia con quell'uomo che le aveva promesso si sarebbe separato dalla moglie e non lo fece mai, portandola in una sequela di litigi e riappacificazioni in cui io ero il refugium peccatorum.
Non che lei piangesse, tutt'altro, era inferocita per ogni anche piccolissima cosa che accadesse tra loro e in cui la moglie prendesse il sopravvento su di lei, diventando persino vendicativa. Ero così dentro alla loro storia che la moglie di Piero, che io conoscevo benissimo perché faceva anch'essa parte dello staff della clinica veterinaria, venne un giorno a parlare con me, recitando la parte assurda della moglie innamorata ed ignara, cosa che sapevamo benissimo non fosse e millantando una perfetta armonia col marito, di certo per provocare stizza ed invidia nella mia amica, intento in cui riuscì perfettamente.
Le due contendenti, nel corso degli anni, si fecero tutta una serie di dispetti e cattiverie che io ritenevo assurda: dicevo a Scilla che sarebbe stato meglio per lei e per tutti accettare la situazione con un maggiore buon grado, per eliminare tutti quei continui litigi che le avvelenarono il sangue e la vita. Ma lei non mi ascoltò mai.
Alla fine però la crisi del suo matrimonio divenne evidente ed il marito, finalmente, si rese conto del tradimento che stava subendo. Io, come si può facilmente immaginare, ero sua amica, anzi, giocavamo a tennis insieme e mi ero trovata tra i due, a dover sostenere una situazione assai scomoda. Quando scoppiò la verità anche lui venne a parlare con me, costringendomi a chiedergli di non tirarmi in mezzo, che gli volevo bene ma che sua moglie era mia socia nel lavoro e che assolutamente non potevo schierarmi al suo fianco. Lui comprese e si arrese all'evidenza dei fatti.
Dopo un po' di mesi di furiosi litigi si separarono e lei andò ad abitare nelle stanze sopra alla nostra toelettatura.
Era una casa davvero scalcinata e vecchia e, anche se avevamo cercato di rimetterla in sesto il più possibile, non era certo come il bell'appartamento nel quale aveva vissuto con il marito.
Però era comodo per il lavoro e la quota d'affitto che lei volle a tutti i costi pagare, anche se io non l'avrei voluto, era davvero esigua. Quindi si adattò ed io ne fui felicissima perché potevamo stare ancora più insieme, avere come una casa nostra, dato che io sentivo quelle stanze anche mie, dopo aver lavorato con e per lei riverniciando, stuccando, levigando infissi pareti e pavimenti.
E poi, a pranzo, stavamo insieme, dato che le bimbe erano a scuola, qualche volta cucinavo io, altre lei oppure si andava alla vicina paninoteca, oppure alla pizzeria o più semplicemente mangiavamo frutta verdura e yogurt.
In quel modo io trascorrevo molto tempo con lei, tornando a casa solo nel pomeriggio.
Carlo allora si ingelosì e cominciò a sentire puzza di bruciato: da tempo, ormai, io mi rifiutavo di avere rapporti sessuali, perché fare l'amore con lui era per me altamente insoddisfacente, come se la mia libido si fosse totalmente spenta. Ma non solo. Lo amavo sempre di più come un fratello e sempre meno come un marito, riuscendo a sopportare sempre più con fatica le sue imposizioni.
Scilla mi fece presto notare che ero troppo in carne e mi propose di dimagrire e di cambiare il mio look, che comprendeva solo jeans magliette o maglioni.
Io mi vestivo perché non si poteva andare in giro nudi o perché avevo freddo, non per altro motivo e non mi curavo per nulla del mio aspetto. Lo sguardo di mia madre mi aveva insegnato da sempre che tanto ero brutta e grassa e quindi, come potevo contrastare quello? Perciò me ne fregavo altamente, o almeno pensavo di farlo, evitando di prendere in considerazione il problema.
Ma gli occhi di Scilla posati su di me mi costrinsero, mi portarono a guardarmi allo specchio dell'armadio e, vedendomi come lei mi vedeva, mi vergognai di me stessa: pesavo novanta chili, ero il solito maschiaccio di sempre con i riccioli della permanente perennemente scomposti ed anarchici, mi mangiavo persino le unghie: ero un vero disastro.
Mi misi a dieta.
Smisi immediatamente e senza ricadute mai, fino ad oggi, di mangiarmi le unghie e nel giro di due anni di notevoli sacrifici arrivai a pesare 68 chili. il mio minimo storico da adulta. Difficile per me scendere sotto, dato che sono di struttura imponente. Dalla taglia cinquantadue cinquantaquattro ero giunta ad indossare la quarantaquattro, massimo quarantasei.
Il mio aspetto era notevolmente migliorato, davvero notevolmente: cambiando look, indossando anche abiti più femminili, tornando qualche volta alle gonne ed ai colori che non fossero il solito nero o blu, mettendo camicette foulard, bluse gilè e vari, ero davvero carina. Mi tagliai i ricci fatti con la permanente e scelsi un taglio alla maschietta, con un po' di basettina, lei mi insegnò a truccarmi.
Il risultato era notevole. Mi guardavo nelle foto che mi venivano scattate e nelle vetrine, mentre vi passavamo davanti, chiedendomi chi fosse quella bella e spavalda ragazza che vedevo.
- E qui aggiungo un piccolo inciso su qualcosa di molto importante che ho dimenticato di aggiungere a suo tempo. Dopo il distacco della retina, ero finalmente riuscita a portare le lenti a contatto: dopo mesi e mesi di lacrimazioni troppo abbondanti e sofferenze, ero arrivata a sopportarle e ad indossarle per ore così come ero riuscita a prendere la patente, passando all'esame della vista, con mia grande gioia. Avevo anche comprato una macchinetta tutta mia, pur se fu solo un vecchio catorcio, una FIAT seicento azzurrina che io chiamai Spumina. -
Il mio viso, quindi, si poteva mostrare libero da quelle ingombranti lenti a culo di bicchiere che mi rapinavano occhi e sguardo, rivelando a tutti un paio di occhi azzurro - verdi che, con mio stupore, riscuotevano l'ammirazione.
Ma ciò non bastò a conquistarla. Rimanemmo lì, in quel limbo d'amore.
Scilla di certo sapeva cosa io provassi per lei e non si faceva mai mancare l'occasione di spogliarsi, di fronte a me, di cambiarsi, di fare il bagno.
Io, turbata dall'amore ma impassibile, la guardavo, adorando ogni lembo di quella pelle dorata, che non sfiorai mai.
Mi accontentavo solo di passarle, ogni tanto, il braccio attorno alle spalle, in una specie di abbraccio un po' scherzoso ed impacciato. Quello fu il mio massimo contatto fisico con lei.
Un grande vuoto cominciò allora a crescermi dentro.
E nulla sembrava riempirlo. Né la vita di famiglia né la casa né gli animali né i cani.. neppure la cavalla.
Smisi di fare tutto: l'orto, le pulizie, accudire gli animali, tanto pensava a tutto Carlo che, pian piano mi aveva sostituito in ognuna delle incombenze che erano le mie.
Lui di certo lo fece per aiutarmi ma non si rese conto che, comportandosi così, mi rese sempre più aliena a quella vita ed a me stessa, sempre meno importante, sempre meno necessaria. Lui faceva tutto, io lavoravo in toelettatura e cucinavo.
Smisi persino di andare a cavallo. Accadde così, senza che me ne accorgessi neppure: tornavo a casa il pomeriggio inoltrato ed ero stanca, poi c'era Angela da badare e da portare sempre da qualche parte. D'inverno faceva buio presto, d'estate c'erano troppe zanzare e così, saltando prima solo qualche volta, poi montandola sempre più di rado, giunse il giorno che non cavalcai più.
Nell'orto gigantesco era cresciuta l'erba ed era ben recintato: Tuba trascorreva lì le sue giornate, libera e felice..
Oppure le mancavo??
Non lo so, credo di si, me lo chiesi molte volte e lo chiesi anche a lei. Ma senza avere mai una risposta.
Andavo dalla mia cavalla, quando rientravo a casa, le portavo gli zuccherini e le carote, l'accarezzavo, le parlavo, poi la riaccompagnavo nella stalla, la spazzolavo, le facevo le solite cure ma non andai più a galoppare con lei per i nostri sentieri solitari e selvaggi.
Forse perché ero così infelice che non potevo accogliere più nessuna felicità.
Quel vuoto era enorme: sapevo, sentivo che io ero altro, che c'era un amore a cui ancora non avevo avuto accesso e che assolutamente volevo provare e vivere.
Ma pensare di lasciare mio marito e quella mia casa mi era impossibile.
Trascorsero altri lunghissimi mesi.

òl
CAPITOLO 19°
La separazione da Carlo. Una nuova
vita.
Pur se non andavo più a cavallo continuavo a frequentare il circolo ippico per alcune cene o feste alle quali mi recavo sola, dato che mio marito
non aveva mai fatto parte di quella porzione della mia vita.
Una sera, ad una cena, uno degli amici storici, Leo, un uomo assai più grande, proprio quello che montava, unico insieme a me la cavalla cieca, mi fece la corte.
Quella era davvero una nuovissima esperienza.
Fino ad allora sembrava che fossi trasparente per gli altri uomini e ragazzi: ad eccezione dell'amore platonico con il mio professore e di una brevissima storia di sesso con un mio vicino di
casa, quando avevo sedici anni, durante uno dei periodi in cui avevo allontanato Carlo, egli era stato il mio unico uomo, fino ad allora.
Quella sera la corte di chi che credevo solo un amico, mi lusingò assai.
Certo, ero diventata assai diversa, così dimagrita e tutta in ghingheri ma io non me ne accorgevo affatto: in fondo io ero sempre la stessa: cosa potevano contare qualche chilo in più o il colore
e la forma di una camicetta? Di certo la mia ingenuità era ed è disarmante: non ho mai capito né riuscito a condividere queste regole folli del vivere umano e non ci riuscirò mai.
Comunque Leo sembrò accorgersi all'improvviso che io ero anche una giovane donna, oltre che un'amica di cavalli: parlò con me per tutta la cena, mi riempì il bicchiere, mi porse le vivande, mi
guardò con occhi ammirati ascoltando i miei racconti e discorsi come fossero preziosi. Che cosa bella, era mai quella....
Si certo, Carlo mi amava mi viziava, mi riempiva di coccole e regali, di dolciumi ma di lì a darmi quella sensazione di importanza che provai, per la prima volta nella mia vita, ce ne correva
assai.
Mi lascia trasportare da quella euforia e, un poco tradita dal vino che io non bevevo quasi mai, quando Leo, alla fine della cena, mi invitò ad andare a casa sua per ' continuare le chiacchiere e
bere ancora qualcosa', accettai.
Lui viveva solo, dato che era separato, in un vastissimo appartamento sopra il suo laboratorio di artigiano, arredato con un gusto sobrio che mi piacque assai. Mi offrì da bere ed io mi sentivo
molto emozionata perché sapevo che stava per succedere qualcosa di inedito. Infatti lui si avvicinò a me, guardandomi intensamente e mi baciò. Lo lasciai fare, poi, assaporando quelle labbra di
uomo, così dolci ma esigenti, così diverse dalle labbra sottili di Carlo che mi baciava senza passione, in modo tenero oppure umido ma mai acceso, risposi al suo bacio.
Leo allora, incoraggiato e sempre più infiammato, cominciò ad accarezzarmi il viso, poi il collo le spalle il seno, a spogliarmi. Era invadente, insinuante ed il mio corpo voleva abbandonarsi al
suo calore. Non che mi sentissi particolarmente eccitata ma era il suo evidente piacere, la sua evidente eccitazione che premeva ormai contro di me, che mi accendeva di un qualcosa che non avevo
provato mai.
Però, dentro, al fondo di me, ero gelata. Solo riuscivo a pensare: ' Ari, che stai facendo, come puoi fare questo a tuo marito, a Carlo, a lui
che è la tua vita?? '
Cercai di resistere a quella voce, cercai di non ascoltarla ma lei cominciò a gridare sempre più forte, così mi divincolai da quell'abbraccio.
Spiegai al mio amico, che mi guardò stupito e dispiaciuto, che non avevo mai tradito mio marito e che non lo potevo fare.
Leo allora si slacciò da me e di certo fu molto comprensivo: venire bloccato ed interrotto quando ormai era lanciato in modo completo immagino che non debba essere stato piacevole ma, evidentemente, il mio gelo aveva contagiato pure lui perché si spense subito. Però, da vero gentiluomo, continuò a farmi complimenti, a guardarmi con l'aria ammirata e ci ridemmo sopra. Poi mi riaccompagnò a casa.
Non era accaduto nulla, dunque, oppure appena più che nulla ma quella esperienza mi aveva dato degli spunti di paragone che non avevo mai avuto: certo, il bacio con il mio professore, quell'unico bacio, era stato assai più emozionante ma anche quel contatto fu senza un corpo, fu un bacio di anime.
Con Leo avevo assaporato una passione carnale che per me era del tutto inedita. Dunque era vero quello che sentivo e cioè che vi era tutto un mondo, tutta una parte di me che non conoscevo e non stavo vivendo!
Nei giorni e nei mesi a seguire quel vuoto dentro di me continuò ad aumentare ed era assordante.
Quell'estate, era il 1981, la mia amica Pat mandò da me sua figlia diciottenne, Eveline, per trascorrere un mese di vacanza in Italia.
Fu bello averla con me, era giovane, bionda, due grandi occhi azzurri meravigliosi: era una deliziosa bambina che si stava affacciando con curiosità e una discreta malizia alla vita.
La condussi a vedere un po' di monumenti ma si capì assai presto che ciò che le interessava veramente dell'Italia era il sole, le spiagge, guardarsi intorno, divertirsi.
Per questa ragione cominciammo ad andare al mare tutti i giorni, scegliendo, diversamente da quanto io facevo di solito, una spiaggia più frequentata: lei si sdraiava al sole fino a diventare un
peperone incandescente, dato che era assai chiara di pelle, ed io, rigorosamente sotto l'ombrellone, leggevo un libro.
Di certo la sua avvenenza non passò inosservata e assai presto ci trovammo circondate da uno stuolo di mosconi a due zampe che la invitavano a fare un bagno, una partita a beach volley, una
passeggiata sul bagnasciuga, una bibita fresca al bar.
A quel punto per Eveline la tintarella sembrò divenire di secondaria importanza e si lasciò condurre a questi, per lei inusitati, svaghi.
Io la tenevo d'occhio, un po' allarmata ma nello stesso tempo felice per lei che potesse godere così appieno della sua gioventù e del suo soggiorno presso di me.
Però, quando poi mi chiese di uscire la sera con qualcuno di quei giovanotti, dato che io non li conoscevo affatto e mi sentivo completamente responsabile della sua incolumità, mi opposi
fermamente ma, desiderando che vivesse fino in fondo quel sogno italiano, dato che i latin lover del nostro paese sono giustamente famosi ovunque, pensai bene di procurargliene uno di cui mi
potessi fidare.
E qui entra in scena un personaggio che avrà prossimamente un grande ruolo nella mia vita: il mio amico Stefano.
Per parlare di lui qui sotto riporto in corsivo alcuni brani tratti da “Quello che non dico a nessuno”.
Ci eravamo conosciuti a venti anni, lui aveva la mia stessa età, era dell'esatto anno della mia nascita.
Ma lui è un leone, io invece un acquario.
Era bello il ragazzo Stefano, biondo, gli occhi scuri ma dorati nei riflessi, molto mobili e impudenti, che sorridevano assai prima delle sue labbra.
Il viso regolare ma non troppo mascolino nascondeva un qualche cosa di muliebre, di infantile, di bambina appena cresciuta.
Alto senza esserlo, forte senza saperlo, piacente e completamente conscio del suo potere, seduceva sapendo di sedurre, seduceva chiunque per poi tradire ogni aspettativa con comportamenti
irresponsabili ed irrazionali.
E pure si beava del livore altrui, della delusione che lasciava dietro le spalle, dello stupore maligno che accompagnava le sue sfuriate o i suoi eccessi.
A queste reazioni assurde dava spiegazioni rocambolesche che io trovavo delizianti e perfettamente logiche.
Gli perdonavo tutto, perché era mio amico, era uno spirito libero che rifiutava ogni regola ma seguiva esclusivamente quella del suo istinto e del suo desiderio.
Io vedevo in lui quello che avrei voluto essere ma non ebbi mai il coraggio di diventare, vedevo l'uomo che sarei stato se madre natura mi avesse dotata della barba e dei suoi bei baffi folti e
curati e pure di qualcos'altro.
Così per Eveline pensai proprio a Stefano, non curandomi assolutamente di quello che avrebbe pensato sua moglie e mia cara amica Marina:
sapevo che lei vi era del tutto abituata.
Lui anche quella volta si dimostrò perfettamente all'altezza e la fanciulla anglosassone non dimenticò mai il suo tempo in Italia.
E io fui felice di averle regalato un vero maschio italiano e di avere regalato a lui una dolcissima preda dagli occhi di cielo.
Fu in quelle dorate giornate di sole di settembre che conobbi un altro fremito che il mio cuore non aveva ascoltato mai.
Tra i vari farfalloni che vennero a dispiegare le loro variopinte ali di asciugamani da mare, stendendoli poco lontano da noi ed adagiandovisi sopra con grazia e non chalance, un giorno più
quieto del solito, ben presto io ed Eveline notammo una stupenda creatura: era alto, abbronzato, statuario e totalmente solo!
Notammo anche che guardava insistentemente verso di noi.
Io le dissi in inglese, che la mia amica non spiccicava una sola parola di italiano che non fosse ciao e grazie, che quella volta al suo amo era abboccata una preda davvero considerevole ma
Eveline, con mio grande stupore, mi fece notare che il giovane bellissimo uomo non guardava lei ma sembrava proprio fissasse me.
Poiché io ritenevo non solo fortemente improbabile ma assolutamente impossibile quello che la giovinetta mi aveva detto, trascorremmo qualche decina di minuti a confabulare fra noi, cercando di
capire quali fossero le effettive intenzioni dello scultoreo adone, dato che nessuna delle due voleva farsi sfuggire un'occasione simile. Ma, accidenti, sembrava proprio che Eveline avesse
ragione poiché mi accadde più volte d'incrociare il suo sguardo quando io, cercando tra le mie trepide paure, trovai finalmente il coraggio di volgere uno sguardo aperto verso di lui.
Ripetei la manovra più volte e sempre incrociai quei due tizzoni d'ebano che lui aveva al posto degli occhi.
A quel punto, persa da una incontenibile felicità e desiderio di toccare con mano quanto lui mi stesse “quatando”, mi alzai, raccolsi la mia maschera subacquea e, con passo misurato ma agile, gli
sfilai davanti andandomi a gettare fra le onde. Mi immersi e, dopo un tratto in apnea, sbucai fuori dal pelo dell'acqua guardandomi intorno: incredibile ma vero lui pure si era alzato dal suo
asciugamano e stava proprio in quel momento fendendo a passi vigorosi l'acqua ancora bassa sotto i suoi piedi.
Un attimo appena e fu lì, accanto a me, stillante di gocce di mare che, come perle azzurre, gli correvano sulla pelle ambrata.
Da vicino era così bello da mozzare il fiato.
Mi rivolse un sorriso bianchissimo, tra la timidezza di un bimbo e la scaltrezza di un attore navigato ed io, sentendomi cedere le ginocchia, lo salutai con un filo di voce: “Ciao........”
Fu un tutt'uno dimenticare ogni cosa, persino di avere le gambe e non le ali, con le parole che sgorgarono fra noi: uscimmo dall'acqua, sempre parlando, gli occhi negli occhi, le mani
pericolosamente vicine senza arrivare ad afferrasi mai e “ come ti chiami”, “ quanti anni hai”, “che cosa fai”, divennero prestissimo scandagli gettati nelle anime, nelle menti e nei cuori.
Di cosa parlammo in quel lungo pomeriggio che avrei voluto fermare ed incastonare come una pietra preziosa nella teoria delle mie lunghe giornate vuote? Non lo ricordo.
Ricordo solo che le sue parole terminavano con le mie e le mie iniziavano nelle sue e che i nostri occhi erano avvinghiati come due corpi ardenti sulla sabbia che andava lentamente
spegnendosi.
Venne comunque, perché sempre viene, il tempo di andare e dovemmo slacciarci da quell'amplesso di sguardi, dovemmo di nuovo ricordare che avevamo
due gambe e una vita e una famiglia e qualcosa che ci portava via da lì. In piedi, l'uno di fronte all'altra, attardammo l'addio finché ci fu possibile, poi io con un gesta maldestro quanto
fragoroso, estrassi dal mio borsello il primo pezzetto di carta che trovai, vi vergai sopra il mio numero telefonico e glielo porsi, come si dona un fiore e come si dà uno schiaffo:
“Mi chiamerai?”
“Domani....”
E ce ne andammo.
Tornai a casa e vissi per giorni in stato di trance.
Aspettai che lui si facesse vivo ed ovviamente questo non accadde.
Attesi attesi ed attesi e sempre più mi apparve chiara una verità che di certo sapevo da sempre ma che fino a quel momento avevo voluto tenere celata: non amavo mio marito.
L'incontro con il bellissimo Roberto me lo fece capire così bene da non lasciarmi scampo e lo dovetti accettare.
Così presi coraggio e gli dissi a bruciapelo a Carlo, una sera, dopo aver messo a dormire Angela, che volevo andarmene. volevo separarmi.
Per lui fu un brutto colpo e vivemmo giorni durissimi: non litigammo mai, ma la tensione era evidente.
La nostra bambina aveva avuto ed ebbe in quei mesi altri problemi:
una caduta dalla macchina in corsa, per fortuna ad una velocità molto ridotta quindi senza gravi conseguenza,
La frattura del naso sbattendo contro un tavolino, come sempre non stava mai ferma e non ascoltava i miei ammonimenti.
Poi ancora convulsioni e una colica di reni.
Facemmo esami e scoprimmo che aveva un rene mobile con l'uretere ritorto.
Io vedevo che stava male, lo capivo, sapevo il perché fosse sempre difficilissima da trattare ma che fatica affrontare ogni volta tutte quelle difficoltà, quelle ansie, quei giorni e quelle notti
in ospedale al suo fianco, sempre su una sedia, sempre non sapendo cosa fare, sempre sentendomi io più bambina di lei che era forte e volitiva, non piangeva mai e sembrava fosse padrona del
mondo.
Io invece, che lei metteva continuamente in discussione, ero sempre più confusa, smarrita stranita.
Carlo mi chiese di non lasciarlo e di provare a vivere dandoci reciproca libertà:
io allora cominciai ad uscire da sola al sera, con qualche altra amica, ma lui era gelosissimo e stava troppo male.
Io non facevo nulla, non lo tradii mai ma lui soffriva troppo lo stesso.
Quella mattina eravamo in macchina insieme per qualche commissione e lui astioso e sarcastico mi apostrofò sulla serata precedente, che io avevo
trascorso con gli amici del circolo nella più totale innocenza, rivolgendomi parole come io fossi una donna di malaffare.
Una rabbia subitanea ed incontenibile mi prese: l'ira dei buoni. Cominciai a gridare “ Ferma questa macchina!! Voglio scendere!!”
Desidero qui apporre un piccolo inciso: io e Carlo abbiamo vissuto una storia durata quasi ininterrottamente per quindici anni, che poi ha avuto una ripresa in tempi successivi, come racconterò.
Ancor oggi ogni tanto, regolarmente, mi telefona e i nostri rapporti sono sereni. Ma c'è una cosa che non gli perdonerò mai: lui ha sempre guidato come un pazzo.
Per quanto la moto o la macchina potesse andare, così forte lui la spingeva, noncurante se fossimo in città, in collina con le curve o in
autostrada, ed erano sempre frenate al cardiopalma fino quasi a toccare il paraurti del mezzo che avevamo di fronte, al quale poi s'incollava, viaggiando a pochissimi centimetri da esso, fino a
quando, trovato un ristrettissimo pertugio, sorpassava, accelerando al massimo.
Quanta strada abbiamo percorso io e lui insieme? Centinaia di migliaia di chilometri in giro per l'Italia, la Francia, la Svizzera, la Germania, l'Austria, l'Inghilterra, la Scozia ed il
Lussemburgo. Con i nostri cani, in macchina o in camper, eravamo capaci di partire il venerdì sera per il nord della Germania, per recarci ad una esposizione canina, e tornare la domenica
notte.
Guidava sempre lui; perchè si fermasse bisognava implorarlo per lungo tempo e manteneva sempre, chilometri dopo chilometri, quella folle
velocità.
Quante volte gli avrò chiesto: “Carlo vai più piano, per favore?!”
Si possono contare le gocce di pioggia d'un temporale estivo? Non credo, ma vi assicuro che le mie suppliche furono molte di più.
Ma lui non mi ha mai ascoltato neppure una volta.
Così quella mattina buttai fuori tutta la frustrazione accumulata fino a quel giorno e gridai con quanta aria avevo nei polmoni: “Ferma questa
cazzo di macchina!!”
E lui non si fermò.
Io allora ,in preda a qualcosa d'inedito, afferrai la leva del cambio dell'auto ed inserii violentemente la prima.
Ovviamente il mezzo gridò tutto il suo dolore e Carlo fu costretto a fermarsi: inferocita ed infuriata scesi dall'auto sbattendo la portiera e m'incamminai a piedi.
Eravamo nella periferia della città: non sapevo cosa volevo fare, non ne avevo la minima idea, sapevo solo che volevo andarmene, che volevo andarmene.
E così feci, anche se ciò mi spezzava il cuore.
Vendetti il mio appartamento nella città natia, eredità di mio padre e acquistai una villetta in un limitrofo paesino di mare lasciando la mia
amata fattoria.
I cani ed i gatti e tutti i superstiti di quella che un tempo era stata una grandissima famiglia animale restarono con mio marito.
Il distacco fu crudele ma non potevo pensare di portare in una microscopica abitazione chi era abituato a quella libertà felice.
Regalai la mia Tuba al circolo ippico, con tutti i suoi finimenti ed il suo corredo, - avevo acquistato per lei tutta una serie di cose per farla vivere al meglio: coperte, copertine, fasce,
linimenti ed altro. - La donai con il patto che non sarebbe mai stata ceduta né macellata.
Non tornai mia più a vederla.
Seppi dagli amici del circolo, di cui uno ne era diventato l'istruttore, delle sue tappe. Trascorse anni portando a spasso per le pinete ed i maneggi, bambini ed adulti. Era tornata ad essere
parecchio ombrosa, però.
Poi ebbe diversi puledri.
Quando fu troppo vecchia fu messa al pascolo con altre cavalle che non avevano più possibilità di lavorare. Morì di morte naturale a più di venti anni.
Mi interessai sempre di lei ma non la rividi mai più e non andai più a cavallo per tantissimo tempo.
Separarmi da lei fu lancinante.
Quando, dopo averla cavalcata per l'ultima volta, tolta la sella, spazzolato accuratamente il suo mantello e sistemate tutte le sue cose, la condussi nel box del circolo ippico che divenne la sua
nuova casa, stetti a lungo con lei.
Mangiava la sua avena e ogni tanto prendeva qualche boccata di fieno fresco che le avevo messo a disposizione. La paglia era abbondante pulitissima e croccante, come sempre. Il suo corpo era
caldo. La pelle fine come la seta. Il manto lucido. Il respiro profondo.
L'abbracciai al collo. Le dissi: “ciao Tuba, grazie”. La baciai sul muso. Poi uscii dal box e chiusi la porta senza voltarmi indietro.
Non piansi neppure.
Quelle lacrime scendono ora dai miei occhi, mentre scrivo.
Allora la vita mi attendeva: sentivo che c'era qualcosa di grande, immenso, che dovevo scoprire e vivere.
Sapevo che lasciando tutto ciò che avevo stavo rinunciando a molto ma l'impulso verso ciò che mi chiamava era fortissimo e copriva tutto il resto.
Ma ora, che davanti a me ho solo malattia e vuoto, vivo quel distacco come una gravissima perdita.
Le ore che non ho trascorso con lei. Le passeggiate e i galoppi di cui mi sono privata. La bellezza che ho rifiutato.
Ora questo mi pesa infinitamente, ora che darei non so cosa per poter di nuovo fare una passeggiata a cavallo.
E non posso né potrò mai più.
Anche il distacco dagli altri animali e dalla cosa, dalle mie cose fu terribile.
Lasciai tutto a mio marito. Nella nuova casa misi mobili nuovi, stoviglie nuove, biancheria nuova.
Presi con me solo i miei effetti personali e quelli di Angela, anzi, neppure tutti i suoi, perché una parte fu lasciata lì, in modo che ne usufruisse quando si recava dal padre nei fine
settimana.
Lasciai tutto.
La mia vastissima collezioni di fumetti. I dischi. I libri. I soprammobili. I premi e i trofei dei cani. La biancheria della casa.
Mi sentivo un'assassina nel distruggere la vita di mio marito e non potevo essere anche la ladra che gli rubava le sue cose.
Non so come riuscii ad andarmene ma lo feci.
Mia madre venne a passare qualche mese con noi: nella villetta al mare tutta nuova bianco-celeste, perché avevo voluto appositamente staccarmi dal legno rustico che lasciavo, impressi
immediatamente alla mia vita nuovi ritmi, nuove abitudini, come per scrollarmi di dosso ciò che era stato e non pensarci mai più. Era giugno 1982 e in quei mesi estivi, tornando il pomeriggio
tardi dal lavoro, scendevo nella vasta spiaggia semi deserta che era a cinquanta metri dalla porta d'ingresso e facevo lunghe nuotate. La domenica mattina presto invece mi godevo lsolitarie
passeggiate sul bagnasciuga, raccogliendo le conchiglie più belle, come facevo da bambina.
In autunno Angela cambiò plesso scolastico e i suoi problemi con compagni, libri e quaderni non mutarono affatto, semmai peggiorarono. Dalla scuoletta di paese, dove il clima era assai familiare,
era passata ad una scuola cittadina di periferia e la differenza si avvertì notevolmente. Mi diede ancora diversi problemi di salute con piccole coliche renali, un'indigestione gigantesca di
cioccolata di un enorme uovo di Pasqua vinto ad una lotteria, che solo il medico del pronto soccorso seppe risolvere e poi ci fu l'appendicite con relativo ricovero d'urgenza.
Fu anche capace di rompersi per la terza volta il naso, scontrandosi faccia a faccia con un suo compagno di classe che come lei correva per i corridoi di scuola ma in direzione contraria. Furono
entrambi accompagnati al pronto soccorso ed io mi presi un altro notevole spavento.
Ma il vero problema fu quello economico che divenne pressante, infatti il lavoro in toelettatura non bastava più per la sopravvivenza della mia
socia e mia, ora entrambe separate.
Per rimpinguare gli introiti trovai impiego come cuoca, in una paninoteca, nel turno di pranzo.
Mi piacque molto quel lavoro: la mattina mi recavo lì per fare le pulizie e preparare il necessario per il pubblico, mentre Scilla, da sola in toelettatura, affrontava i lavori che era in grado
di fare. Poi dopo il servizio ed aver rimesso in ordine la cucina, verso le quindici, tornavo in toelettatura ed insieme disbrigavamo tutto il resto.
Ma lei non era contenta: mi diceva che era tutto troppo sulle sue spalle rispetto all'esiguo guadagno che ne ricavava e si dimostrava irritata ed irritabile, sprofondandomi in uno stato di grande
tristezza. Davvero ero più preoccupata per lei che per me.
Alla fine del mese di prova il proprietario del pub mi confermò l'incarico ma lo stipendio che mi offrì risultò troppo basso per le mie
necessità.
Allora decisi di acquistare un'attività commerciale tutta per me.
Lasciai alla mia socia tutto, attrezzature comprese, non chiedendole nulla, accettando solo una piccolissima cifra che lei volle a tutti i costi darmi. Di certo tra le due quella che eseguiva i
lavori più difficili ed anche quelli più faticosi, ero io: lei era rimasta fino ad allora una figura subalterna ma mi disse che si sarebbe arrangiata.
Feci il corso per l'iscrizione al registro dei commercianti ed acquistai una latteria in un paesino a cinque chilometri da dove abitavo
allora.
La pagai una manciata di milioni, chiedendo un prestito: all'inizio il lavoro non era tanto ma nel giro di pochissimo triplicò e gli incassi divennero soddisfacenti.
Io ci misi tutto il mio impegno, mi piaceva tantissimo avere quel genere di negozio: il contatto con il pubblico, il latte, il formaggio, la panna, il burro.. i dolci..
Cercai e trovai prodotti particolari e di ottima qualità per distinguermi dall'altra latteria, lontana qualche centinaia di metri, che aveva il monopolio nel paesino.
Infatti le strappai molti clienti in breve tempo.
Avevo ventisette anni, ero magra, bella, forte, allegra e piena di ottimismo: tutte le mie sofferenze sembravano sopite.
L'aver ritrovato la libertà mi galvanizzò tanto che cominciai a frequentare altri uomini.
Il primo, Lorenzo, che avevo conosciuto lavorando in paninoteca, era un bel giovane allegro e franco. Era sposato, ma io mica volevo risposarmi! Avevo giurato che mai più mi sarei fatta mettere
le briglie al collo!
Lui era molto galante e splendido, mi portava in locali di classe, mi offriva rose e champagne, divertendosi come un pazzo alle mie subitanee euforie. Davvero bello, alto, ricciuto, gli occhi
color smeraldo, forte come un piccolo toro, era del segno dell'acquario come me, edonista ed originale e ammirava il mio anticonformismo, così diverso dalle abitudini della moglie, tutta casa e
famiglia.
Non eravamo innamorati ed anche il sesso non fu mai così esplosivo tra noi ma ci divertivamo troppo, insieme.
La sua corte, al di là del bancone del pub, fu un'altra eclatante sorpresa per me: solo dopo diversi giorni mi resi conto che quel bel giovane non veniva lì tutte le mattine alle dieci per bere
un bicchiere di vino bianco fermo - che restava quasi sempre pieno - ma veniva per parlare con me. Infatti si tratteneva a lungo mentre io terminavo la macedonia, grattugiavo il formaggio,
avvolgevo le posate nei tovagliolini, e se ne andava solo quando arrivava il proprietario con i primi clienti ed io non avevo più tempo da dedicargli.
Anche quando mi chiese di uscire la prima volta, restai stupita e la sera, quando mi venne a prendere sotto casa, entrando nella sua auto e cogliendo il suo sguardo ammirato, tremai tutta.
Poco tempo dopo riuscii persino a rintracciare in modo rocambolesco, tramite l'incontro fortuito con un suo amico, il bellissimo giovane
incontrato in spiaggia con Eveline.
Accadde che un giorno entrò in latteria un uomo dai capelli rossi, che acquistò del latte e del formaggio e si trattenne un poco a chiacchierare con me, che ero sempre ben disposta e socievole.
Parlando mi disse che proveniva dal piccolo paesino nel quale abitava anche Roberto ed io non potei far a meno di chiedergli se lo conoscesse. La risposta fu naturalmente positiva ma tutto finì
lì.
Qualche pomeriggio dopo scorsi un'auto sportiva parcheggiare di fronte al mio negozio e ne vidi scendere proprio ' lui '.
Mamma mia, avevo il camice e la cuffietta, da perfetta lattaia!!!
In fretta la feci sparire, cercando d'aggiustarmi un po' i capelli, slacciai il camice per mostrare almeno abiti normali e nel frattempo lui entrò.
Quel sorriso illuminò il mio negozio, la mia mente, il mio cuore, i miei pensieri, le mie speranze: quanto era bello!!
Fu come il tempo non fosse passato, sentii i suoi occhi avvinghiarsi ai miei e ci trovammo di nuovo su quella spiaggia al tramonto.
M'invitò a cena ed io poi invitai lui a casa mia per un ultimo bicchiere, che sapevamo entrambi non avremmo assolutamente bevuto.
Mi baciò sulla soglia, chinandosi su di me ed io mi sentii come un fiore reciso dal suo gambo.
Nel mio letto, proprio su quella dalla trapunta di raso azzurro a fiori con colori pastello, egli mi travolse e mi trasportò in un luogo di baci, di mani, di pelle, di profumi, di sospiri, d'impulsi così violenti e carezzevoli, dove ci amammo fino allo stremo delle nostre forze. Era quasi mattino quando si allungò, abbandonandosi alla stanchezza ed io mi rannicchiai accanto a lui: mi cinse allora con le braccia, quelle braccia forti di uomo vero ed io sentivo le sue mani posate su di me come mai avessi avuto pelle e sensi. Ci addormentammo, così, nudi ed abbracciati.
Veloce fu, purtroppo, il sonno che si dissolse sentendo quelle grandi mani animarsi sulle mie spalle ed il mio viso: si era svegliato e così mi destò, tenendomi ancora in quella nicchia calda ed
odorosa di noi ed aspettando che i miei occhi fossero ben fissi nei suoi. Mi confessò allora, senza mai distoglierli dai miei, di essere sposato e di avere un bambino piccolo, di amare entrambi,
moglie e figlio e di non potere assolutamente pensare di lasciarli.
Fu come precipitare. Si alzò dal letto, si rivestì e se ne andò, lasciandomi come ultimo gesto il dolce accomodare la trapunta, che recava i segni del nostro amore, contro il mio corpo ancora
caldo di lui.
Soffrii.
Lo cercai più volte al telefono, lo pregai di rivederci ma lui rifiutò sempre: quello che avevamo vissuto quella notte era stato troppo
forte.
Capii allora che per lui sarebbe stato impossibile passare dalle mie braccia a quelle di sua moglie senza creare profondi dolori ad entrambe e così ascoltai la vita che mi stava chiamando a gran
voce.
A Lorenzo s'aggiunse Valerio, che amava portarmi ad ascoltare dolcissimi concerti di piano bar, e poi Gianfranco, passionale e improvviso, che saltando fuori dal nulla trovavo ad attendermi alla
chiusura del negozio già vestito per la cena.
Mi sentivo una dea.
C'era poi sempre mio marito che mi faceva regali, mi telefonava sempre, passava quasi ogni giorno in negozio. Giocavamo anche a tennis tre volte alla settimana, insieme, perché in quella nostra abitudine, consolidata ormai da anni, non riuscimmo mai a separarci.
Facemmo persino di nuovo sesso.. perché io ero diventata così bella, così diversa.
Mi ero comprata dei begli abiti, cose fini, eleganti, sobrie ma di gusto.
Ho pochissime foto di quel periodo ma mi mostrano davvero una splendida giovane donna: mi ero fatta allungare di nuovo i capelli fino alle spalle e ne avevo ancora tantissimi, che mi danzavano
intorno al viso in ampi ricci naturali.
Mi truccavo anche in modo molto femminile
Insomma, che potevo desiderare di più dalla vita?
La convivenza con mia madre e mia figlia non era affatto semplice, tutt'altro, ma ormai la famiglia era per me una parte tangenziale della mia
giornata.
Ero viva e padrona di me stessa: davvero mi sentivo benissimo.
Risale a quei tempi ciò che narro in una delle mie novelle, tratta dal libro Kaiki e che potete leggere qui di seguito in corsivo
IL SALUTO DELLA VECCHIA 128 FIAT GIALLONA
…..................... Non volendo svuotare il nostro nido ….........
Portai però con me la nostra seconda auto, una vecchia 128 Fiat, che stava tirando il fiato con i denti e che noi chiamavamo, con affettuosa derisione, Giallona, per l’orrido colore ocra acceso.
Proprio quel colore accresceva la sua ormai dichiarata e raggiunta estraneità alla vita corrente, nella quale ancora prestava il suo servizio prezioso di trasportarci ovunque volessimo andare, pur denunciando in pieno l’avvicinarsi della fine già sancita dei propri giorni e della propria specie.
Io amo le cose e mi circondo sempre di quelle di cui percepisco l'amore, dato che sono in grado, per una mia sensibilità particolare, di captare i sentimenti silenziosi che emanano e che provano nei miei confronti.
Le cose non sono tutte uguali. Hanno anche loro un'anima, un carattere, una tendenza e la rivelano a chiunque sia un attento ascoltatore e spettatore.
Per questo chi, come me, è capace di accogliere dentro di sé la vibrazione emessa da ogni essere intorno, vivente o meno, si accorge della grande differenza che corre tra un oggetto e l'altro.
Davvero Giallona mi amava in modo incondizionato, tanto che ogni mattina ce la metteva tutta per avviare i suoi esausti ingranaggi, emettendo brontolii di sforzo sempre più accorati e raggiungendo sempre più tardi il proprio intento.
Ogni giorno o quasi, però, perdeva una delle sue funzionalità accessorie ma non per questo poco importanti: oggi non funzionava più il tergicristallo, domani la ventola interna dell'aria... una settimana dopo si bloccava un finestrino e così via.
Ma lei, impavida cocciuta e generosa, ogni mattino, presto o tardi, andava in moto e mi portava al mio lavoro.
Io e mia figlia, accarezzando ogni volta il suo nero cruscotto di similpelle, tutto liso e screpolato, ci dicevamo che non sarebbe durata più a lungo e che avremmo dovuto cambiarla con una vettura più recente, ma nel dirlo provavamo una specie di sgomento dentro e un dolore soffuso insieme ad un specie di riluttanza di fronte alla sensazione di avvertire la tristezza emanata da quell’anima meccanica, giunta alla fine dei suoi giorni di onorato e indefesso servizio…
Così il tempo passava, inesorabile e Giallona restava con noi; finché, una fredda mattina sferzata dalla pioggia e dal vento, non riuscì nel suo consueto sforzo quotidiano, la batteria l’abbandonò definitivamente e lei, mesta, si arrese inevitabilmente, ma rassegnata al suo destino, lasciandomi seduta sul suo sedile un po’ distorto a guardare la chiave di accensione divenuta un inutile pezzetto di metallo buffamente sagomato.
Mi recai al lavoro in bicicletta, percorrendo quei pochi chilometri sotto il temporale, arrivando perciò alla mia destinazione stanca, affannata e irritata per il ritardo, tutta bagnata e infreddolita.
E questo fu abbastanza per farmi decidere di acquistare un'auto nuova.
Erano i tempi quelli in cui potevo farlo: alzare la cornetta del telefono prendere un appuntamento in una concessionaria, scegliere un'auto, firmare un sacco di fogli per un finanziamento millenario e via.. uscirmene contenta con la macchina nuova..
Così, quel mattino stesso, cercai e trovai la sua sostituta. - che comunque non amai mai e che rappresentò fino all’ultimo per me una fonte di guai e di avversione, - e al telefono concordai col venditore che mi sarei recata io stessa a prelevare la nuova auto, lasciando la mia vecchia amica Giallona al suo triste destino di rottamazione.
Nel pomeriggio infatti, aiutata da un vicino di casa a rimettere in moto con i cavi della batteria la moribonda 128, mia figlia, che non voleva perdere assolutamente il primo viaggio della nuova automobile e io le facemmo compiere il suo ultimo tragitto.
Quando arrivammo alla concessionaria prescelta, la pioggia era cessata, lasciando uno squarcio di sole invernale a far brillare le goccioline d’acqua sul giallo della carrozzeria e sul parabrezza, solo in parte asciugati dal vento durante il viaggio.
L’addetto che ci aspettava ci mostrò dove parcheggiare la vecchia auto da rottamare e se ne andò voltandoci le spalle, del tutto indifferente ed avvezzo a quello che per lui era una storia di quotidiana abitudine, mentre io entravo in uno spiazzo recintato e facevo manovra per parcheggiare la nostra vecchia auto di fianco ad altri ruderi in attesa di essere ridotti a scatolette di lamiera.
In quel momento fui assalita da un dolore acuto, come se invisibili dita di ferro mi avessero stretto il cuore in una morsa.
Immaginavo la Giallona che piangeva lacrime di olio, benzina e antigelo.
Ma il tempo stringeva, il venditore ci attendeva per espletare le ultime formalità e mia figlia mi era accanto ed io mi ero accorta che lei pure si stava facendo prendere dalla malinconia di quell'addio.
Regalai, quindi, un’ultima carezza alla vecchia auto, passando lentamente la mano sul cofano ancora umido e un ultimo bacio furtivo, lieve quanto accorato, sull’orlo dello sportello che si era aperto per accogliermi innumerevoli volte, in preda ad una sensazione di estraneità dalla vita terrena che mi avvicinava incredibilmente a quello che per i terrestri era diventato ormai solo un ammasso inutile ed inservibile di lamiere, mentre per me era un cuore fratello, un'anima amica..
Poi, cercando di nascondere la mia inusitata quanto incomprensibile emozione, mi voltai di scatto dandole le spalle, mormorando: «Addio, Giallona, e grazie di tutto…»
Infine presi per mano la mia bambina, che ora scalpitava per vedere l’auto nuova, le girai le spalle e mi diressi verso l’addetto che, poco più avanti, attendeva impaziente sulla soglia dell’officina antistante agli uffici.
Dovete sapere, tra le varie cose, che Giallona era muta: lo era stata da sempre, o almeno da quando la comprammo noi da un amico, per un pugno di spiccioli, adattissima agli scopi di auto di servizio e di sostegno per le giornaliere necessità famigliari e, mentre invece l’ammiraglia di casa dormiva riparata nel suo ampio e ben costruito garage, lei trascorreva le sue notti all’aperto, sotto le stelle, al caldo o alla fredda pioggia invernale, immersa nella nebbia della bassa padana, cosa che non aveva fatto altro che incrementare effettivamente questa sua congenita o acquisita afonia…
Per quello non avevamo mai sentito la sua voce.
Ma, come ci fummo allontanate da lei una decina di passi, un grido meccanico però estremamente umano, scaturì dalle viscere metalliche di Giallona e inondò del suo pianto addolorato l’intera officina, scuotendo e facendo sollevare la testa a tutti i meccanici al lavoro, chini dentro le fauci spalancate delle auto ammalate che stavano curando e facendomi tremare le ginocchia fino quasi a piegarmi per terra.
Era Giallona che, per salutarmi, abbracciarmi e ringraziarmi per l’ultima volta, aveva ritrovato la sua voce.
Una voce straziante e penetrante che gettò tutta quanta, nella sua veemenza data da un lungo silenzio e un lungo incondizionato amore, in uno straziante, assordante, profondo, accorato, disperato indimenticabile addio, fino a quando uno dei meccanici, infastidito, accorse, aprì l’intimità del suo cofano e con una gelida, impietosa tronchese, le tagliò di netto le ritrovate corde vocali, sancendo definitivamente il suo silenzio e la sua morte.
Io mi asciugai frettolosamente le lacrime.
«Senti, la nostra Giallona ci sta salutando per l’ultima volta…», sussurrai a mia figlia commossa e piangente .
Poi, guardandola ancora un attimo con amore, facemmo ciao con la mano e abbandonammo quel freddo capannone, dove venivano lasciate al loro destino di morte le auto dismesse, senza pietà, né più uno sguardo di affetto, dopo aver dimenticato il tempo in cui esse erano state lustre e nuove e noi le avevamo guardate con orgoglio e meraviglia , del tutto incuranti del fatto che un'auto potesse o meno provare sentimenti e sensazioni, pur se espressi in modo diverso dal nostro.
Questa è una storia vera, autentica come le lacrime che stanno scendendo ancora dai miei occhi, una storia dedicata all’amore silenzioso ed altruista che ci donano tutte le cose inanimate, senza chiedere mai nulla in cambio, fino a che non si rompono, o noi, annoiati e perennemente insoddisfatti, non le condanniamo alla rottamazione per lasciare il posto ad altre che ci illudiamo possano essere migliori.

CAPITOLO VENTESIMO
Antonio. Betta. Una nuova casa
Il sabato sera andavo a ballare in una sala dove si recavano per lo più uomini e donne sopra i trent'anni, in cerca di storie. Andavo da sola ed
era terribilmente eccitante.
Ebbi diverse avventure di una notte.
Cosa stavo cercando?
L'emozione profonda che avevo provato con Roberto mi aveva dato la prova tangibile dell'esistenza di una dimensione alla quale io avrei potuto
avere accesso ma che ancora non avevo conosciuto fino in fondo.
Sapevo però che in quel locale più che altro si recavano uomini in cerca di storie facili eppure, in fondo in fondo, così in fondo da tenerlo quasi celato a me stessa, qualcosa mi diceva che lì
ero attesa.
Infatti a novembre, il 27, uscendo di casa sentii chiarissimo il segno della predestinazione.
Era una notte non fredda, lievemente nebbiosa. Quando arrivai, il parcheggio delle auto era già gremito: mi strinsi nel giaccone sentendo l'aria
fresca entrarmi sotto la camicetta leggera che indossavo. Avevo scelto per quella sera un completo di blusa e gonna pantalone, color ruggine intenso e tutto decorato con piccoli arabeschi dorati,
rifinito con il colletto alla coreana. Il foulard grigio perla e rosa chiaro dava un piccolo tocco ingenuo al mio viso truccato in modo più marcato del solito. Quel pomeriggio ero andata dalla
parrucchiera ed i miei capelli erano così giovani e vitali.
Dopo il rito della biglietteria e del guardaroba entrai nella sala e mi diressi direttamente al bar per prendere il mio Cuba Libre: avevo bisogno di entrare subito in sintonia con le luci basse,
la musica anni settanta, le coppie abbracciate sui bassi divani ed il frullio dei “pretendenti” tra una pista e l'altra.
Tirando con la grossa cannuccia nera il primo sorso della bevanda gelata, cercai con gli occhi un tavolino un po' appartato e solitario, lo raggiunsi, appoggiai il bicchiere e mi sedetti,
sprofondando lievemente. Ripresi il bicchiere fra le mani e sorseggiando lentamente cominciai a guardarmi intorno: non avevo ancora voglia di ballare ma non volevo neppure restare a fare
tappezzeria, per ciò cercavo di vedere se vi fosse un ragazzo simpatico che avevo conosciuto due sabati prima, giusto per spezzare il ghiaccio e anche quel nodo che sentivo allo stomaco.
Ero ancora in tenta a frugare con lo sguardo fra i tavolini e le piste da ballo quando passò davanti a me un uomo alto, dalle spalle larghe, con i capelli un po' lunghi e la barba ben curata,
appena brizzolata. Indossava una giacca di camoscio beige chiaro, un paio di pantaloni scuri ed una camicia bianca senza cravatta con il colletto aperto, entro il quale era elegantemente adagiato
un foulard di seta scura.
Lo guardai mentre passò oltre, si fermò, si volse verso di me, tornò sui suoi passi e, senza sorridermi, mi disse a bruciapelo:
“Ma dove è stata tutto questo tempo una ragazza bella come te?”
Io gli sorrisi e gli risposi che non ero poi così bella e lui, perentorio:
“Lascia che sia io a deciderlo”
Poi, posando il bicchiere che aveva fra le mani, dove un doppio whisky senza ghiaccio era già in parte stato bevuto, mi chiese – ma non era una domanda - :
“Vuoi ballare?”
Ballammo. Io gli cinsi le braccia al collo e lui mi appoggiò una mano, la sinistra, alla vita, mi avvicinò a se ma non troppo, guardandomi con quella sua aria tra il serio, l'imbronciato ed il
canzonatorio.
Io mi sentii indagata da quegli occhi nocciola intensi e quella mano posata alla sorgente dei miei fianchi era come volesse entrarmi dentro.
Eppure il Cuba Libre era stato appena assaggiato, perché mi girava la testa?
La musica era alta anche se lenta, lui mi chiese avvicinando le labbra al mio orecchio e quindi frugando tra i miei capelli:
“Come ti chiami? Io Antonio”
Il suo respiro disegnò una carezza sulla mia guancia ed io istintivamente mi posai su quell'alito che vibrava, mi scaldava, “Ari.“ gli risposi alzando un poco gli occhi verso di lui che non fece
un vero gesto ma mi guidò a posare la testa nell'incavo della sua spalla.
Ballammo in silenzio.
Ma non era silenzio tra noi..... il suo torace potente sussurrava i movimenti del suo respiro contro il mio seno, il suo bacino aveva allacciato un dialogo intenso con il mio ventre e quella mano
aperta, scivolata appena un po' verso la curva del mio fianco, era come cantasse: “Vieni qui. Vieni da me.”
Ed io mansueta ingenua e felice acconsentii a quel richiamo.
La notte stessa fui sua.
Rientrata come volando nella mia casetta silenziosa che era già mattino, così colpita da quell'incontro, come prima cosa presi dalla mensola il grosso volume rosso dell'Oracolo Cinese e,
sedendomi al tavolo, gettai sei volte le tre monetine dorate, interrogandolo.
- Cosa è giusto che io creda sarà Antonio per me? -
La risposta dell'oracolo mi sorprese vivacemente: La Casata.
Una nuova famiglia? Impossibile!!...... sorrisi tra me, deposi il libro e me ne andai a dormire sfinita.
Ma l'oracolo cinese non sbaglia mai.
Fu un colpo di fulmine anche per lui e ci tuffammo a capofitto in una storia.
Io lo trovavo bellissimo, tenebroso, intelligente... perché lo era.
L'attrazione fisica tra noi era potentissima e fin da subito ci legammo in amplessi esplosivi e completi tra amore e piacere. Di nuovo con lui provai l'estasi, almeno l'assaggio.
Ma lui mi disse che non voleva legami.
Ci vedevamo massimo due volte alla settimana, a volte neppure una ed io continuai a frequentare anche gli altri: il mio primo marito mi amava e non vedeva altre all'infuori di me, gli altri tre
miei amanti erano i miei cavalieri serventi, pronti a soddisfare i miei capricci.
Il lavoro andava sempre più a gonfie vele, avevo acquistato una piccola auto nuova e presi un cane, un altro levriero a pelo raso bianco e tigrato che chiamai: The First and last love of mine.
(il mio primo ed ultimo amore).
Naturalmente lo chiamavo Last ma quel lungo nome imposto sul pedigree di quel puledrino dalle lunghe gambe aveva una lunga storia dietro di sé:
quella razza era stata il mio primo amore ma quel cucciolo sarebbe stato l'ultimo, se non avessi avuto un po' più di fortuna con lui.
La vita mi sorrideva.
Il mondo era stretto nel mio pugno, che io guardavo con soddisfazione e senso di potere.
Ma nulla mai dura, nella vita umana e ben presto arrivarono cambiamenti.
Il mio ex marito si innamorò di un'altra.
Rimasi davvero di stucco quando me lo disse.
Fui felice per lui... la nuova arrivata era un'artista e anche mia figlia ne era affascinata, tanto che provai persino gelosia ma non me lo
permisi.
Lui aveva tutti i diritti di essere felice e che la sua nuova compagna si trovasse benissimo anche con mia figlia era assolutamente splendido....
Solo che non me lo sarei mai aspettato: mi sentivo come un'istituzione nella vita di Carlo e ad un tratto mi trovai detronizzata.
Comunque, io ero proiettata in quel nuovo amore che stavo vivendo, sempre più presa ed affascinata da Antonio, anche se lui aveva momenti di un vuoto assoluto, amaro... e sparizioni che mi
lasciavano sofferente.
Come emblema, racconto un piccolo accadimento: un brutto giorno a mia madre fu diagnosticato un tumore alle ossa.
- Ho dimenticato di dire che, quando la mia bambina aveva quattro anni, lei riportò la prima frattura spontanea ad una costola. Cominciò così il suo lunghissimo calvario che non è ancora
terminato.
Tra diagnosi certe: osteoporosi ed artrite, altre meno certe ed azzardate, come quella accennata più sopra, si diede il via ad una serie di visite specialistiche, indagini di laboratorio,
ricoveri in tutti i centri specializzati limitrofi: Ferrara, Firenze e Bologna. Così cercavamo consigli a destra e a manca e si facevano indagini ma lei stava sempre peggio e il dolore aumentava.
Io la portavo dappertutto, la seguivo da vicino.
Era sempre stata una donna più che attiva ma ora ogni cosa che le costava un dolore ed una fatica tremenda.
Decise di vendere il negozio. Io mi trasferii da lei per qualche mese, portando con me la bimba che fu iscritta pro tempore in una scuola materna lì vicino, dove insegnava mia zia.
Il negozio vendeva merceria, maglieria e intimo. Un negozietto piccolo piccolo, stipato fino all'inverosimile, tanto che io lo chiamavo scherzando “ l'uovo sodo”.
Ero sempre andata ad aiutare mia madre, sin dagli inizi dell'attività. Quando si recava a fare acquisti con la mitica Erre Quattro Renault grigia metallizzata, io ero con lei.
Spostavo pacchi, davo consigli.... ero l'addetta all'acquisto delle cravatte. Si vide subito che il mio gusto era molto apprezzato dai poveri mariti che troppo spesso si vedevano regalare
cravatte di bellezza davvero dubbia.
Evidentemente il mio uomo interiore amava le cravatte.... quindi ero io che le sceglievo.
Spessissimo, fino alla nascita della bambina, trascorrevo ore in negozio per sollevare mia madre dall'onere molto gravoso che era tutto sulle sue spalle. Ogni giorno mi recavo da lei ed ero in
grado di vendere qualsiasi cosa, così sotto le festività e nei giorni di lavoro più intenso o quando mamma aveva una qualche altra necessità, io la sostituivo e la supportavo.
Ero beneamata ed accettata dalle clienti: quella era una vera borgata e la vita allora era alquanto corale.
Le clienti erano sempre le stesse: donne più o meno giovani, madri di famiglia che cucivano da sé gli abiti per tutti i componenti del loro clan. Così bottoni, cerniere, filo da cucito, fettucce
varie ed elastico per me non avevano più segreti e anzi mi divertivo tanto con tutte quelle scatoline, quei colori e le chiacchiere, spesso argute, di quelle comari.
Poi con il tempo mia madre aveva aggiunto la maglieria, l'intimo e l'abbigliamento per i bambini. Aveva veramente di tutto, era brava ed onesta nei prezzi, così la clientela crebbe a
dismisura.
Ma io mi sposai, lasciai la città e lei dovette fare da sola.
Quando si ammalò nessuno poté prendere in considerazione l'idea di mettersi al suo posto: l'unica a poterlo fare ero io ma, a quei tempi, neppure
il pensiero di separarmi da mio marito e dalla mia casa mi era tollerabile.
Così si vendette.
Si effettuò una grandissima svendita e tutto il contenuto, diverse decine di milioni, di merce, fu ceduto a prezzi scontati, pezzo dopo pezzo.
Quella fu la definitiva demolizione di mia madre.
Io soffrii con lei e l'aiutai il più possibile. Abitava ancora con mio fratello, che aveva nel frattempo avuto un altro figlio. Ma, con l'avvento della sua malattia e la perdita del negozio,
sorse presto la sua necessità di vivere sola, perché era divenuta insofferente a tutto: era disperata.
Andò a vivere in un piccolo appartamentino in affitto.
Negli anni successivi ne girò parecchi. Trascorse anche molti mesi al mare, in appartamenti o pensioncine familiari. Praticamente l'inverno lo passava là, perché in città i dolori le aumentavano
notevolmente.
Era sempre stata dura ed inquieta e lo divenne ancora di più. Non faceva altro che parlare della sua malattia.
Ben presto non fu in grado di camminare se non appoggiandosi su due stampelle ma, forte e combattiva, dato che tutti i medici le dicevano che non doveva smettere di muoversi, pena la perdita
della sua indipendenza, - cosa che lei non poteva assolutamente ammettere - ogni giorno camminava per chilometri, appesa alle sue grucce, solitaria ed arrabbiata con tutti, soprattutto con quel
Dio che l'aveva ancora una volta così duramente punita.
Il suo è stato un calvario di più di trenta anni che qui riassumo in poche righe.
Fu, inoltre, sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico alla colonna vertebrale: le venne rimosso uno scrigno osseo che le stringeva il midollo e quello le alleviò quasi completamente
il dolore feroce che provava.
Poi fu operata più volte alle mani ed ai polsi per il cedere dei tendini.
Le si ruppe la colecisti e fu gravissima, in coma per giorni. Le dovettero asportare anche un pezzetto di stomaco ma ce la fece.
Le asportarono per due volte alcuni noduli tiroidei.
Provò tutti i medicinali per la cura dell'osteoporosi che erano in commercio, subendo e sopportando i loro terribili effetti collaterali.
Fu davvero un calvario, anche perché lei era assolutamente solo incentrata su di quello. Io la portavo dappertutto e, che fosse a casa, all'ospedale o al mare, ogni settimana l'andavo a
trovare.
Feci e disfeci decine di valigie.
Ascoltai migliaia e migliaia di volte le stesse cose: gli stessi ricordi gli stessi lamenti. Venne a vivere con me e se ne andò, sempre ogni volta con problemi e liti, quattro/cinque
volte...
Io le fui sempre accanto, almeno fino ad un certo punto ma di questo parleremo più avanti.
Oggi ha ottantotto anni e sta meglio di me: si muove ancora e fa ancora molto da sola, aiutata della sua assistenza ma non esce più da qualche anno. Vive vicino a mio fratello che si occupa di lei ed è serena, cosa che è davvero miracolosa perché a quei tempi fu tutto una grande tragedia: vendere il negozio fu la sua tragedia.... forse ancora più grande della morte di mio padre. -
Tornando al 1983, quando le diagnosticarono quella gravissima malattia che poi non risultò reale, io piombai in una profonda crisi.
Stetti male per qualche giorno, colpita dalla notizia ma lui, il mio uomo, sparì per una settimana....
Io lo perdonai comunque, pensando che non avesse potuto far di meglio: il confronto con la morte era sempre arduo da affrontare.
Il fatto è che già allora, ogni volta che io ebbi bisogno di lui, Antonio si defilò velocemente. Avrei dovuto insospettirmi ma non lo feci, per me lui era bellissimo e stupendo, sempre... Anche
se non mi dava la mano o il braccio in pubblico, lo scusavo dicendo che era riservato. Anche se non mi diceva mai: ti amo. Anche se non commentava mai le poesie d'amore, tantissime, che io
scrivevo per lui in piccoli quaderni che poi gli davo da leggere e che mi riconsegnava senza una parola. Anche se non stette con me il giorno del mio compleanno e del Natale....
Anche se quando io gli chiedevo qualcosa era proprio la volta che ottenevo ancor meno del solito.
Io, comunque, avevo gli altri “amici” attorno a me e le sue mancanze mi facevano meno male.
Non so se lui pure avesse altre “amiche”... forse... ma era un qualcosa che non ci interessava. Lui non chiedeva mai cosa io facessi quando non ero con lui e questo era la pace di tutto.
Però la decisione di lasciare la toelettatura, cosa che accadde quando io e lui ci eravamo già incontrati, fu una scelta che spinse in modo
deciso: il mio lavoro non gli piaceva assolutamente e quando gli chiedevo di venire in laboratorio si sentiva fortemente a disagio: non legò neppure con la mia socia e a lei non piaceva affatto,
così come non piacque affatto a mia madre, quando glielo presentai.
Io mi chiedevo come potessero non restare affascinate da lui: per me era splendido in tutto.....
Arrivò così la Pasqua del 1984. il Lunedì di Pasqua, per l'esattezza.
Trascorremmo tutto il giorno insieme, perché il precedente lui lo aveva passato con la famiglia.
Furono quelle le mie prime festività solitarie: il natale 1982 lo trascorsi da sola piangendo sul divano a righine bianche ed azzurre della mia nuova bellissima casetta.
La mia bimba era andata con il padre dai nonni, mia madre stava male e volle restare da sola... io non andai dalla zia che mi aveva invitato....
Restai così, a sentire che l'era delle feste allegre era finita per sempre.
Quel lunedì di Pasqua Antonio venne a pranzo da me, che preparai il mio meglio per lui. Mangiammo, bevemmo ottimo vino bianco, che con lui avevo cominciato ad apprezzare, e passammo il pomeriggio
e la notte a letto, avvolti nei turbini della passione.
Ero felicissima: l'amavo e lui era travolgente.
Dopo pochi giorni mi sentii cambiare e pensai di essere rimasta incinta, lo dissi al mio primo marito, quando ci trovammo a giocare a tennis. Lui mi scherzò e ci rise su, però il ciclo non
arrivava ed io ero davvero certa di aspettare un figlio.
Ma a lui, al mio amato, non dissi nulla.
Attesi qualche giorno e feci un test di gravidanza di quelli di farmacia: risultò negativo.
Respirai di sollievo anche se in fondo mi dispiacque un po'.... attesi ancora.... ma nulla... il ciclo era un fantasma. Portai le urine al laboratorio...
Negativo.
Continuavo la mia vita: lavoro tennis uscite varie ma dentro sentivo che stava per cambiare tutto.
Attesi ancora: il ciclo non venne.
Prenotai una visita dalla ginecologa e lì non vi furono dubbi: ero davvero in attesa di un bambino.
Che colpo fu.
Ma dentro io già sapevo e già avevo deciso che avrei dato alla luce quella creatura.
Scilla mi disse che ero pazza, così pure Carlo.
Io volevo quel bambino, anche se il padre non avesse acconsentito alla nostra unione.
Così glielo dissi.
Lui restò di pietra. Si rabbuiò profondamente e mi chiese tempo per riflettere.
Si alzò dal tavolo del bar al quale eravamo seduti e se ne andò così, senza neppure girarsi, a malapena salutandomi.
Restai ferita dal suo comportamento. Sparì per dieci giorni: divenni certa che non avrebbe accettato quel figlio ma rafforzai in me la volontà e la gioia di averlo.
Quel bambino che era sbocciato in me, quella miracolosa nuova vita nata da un giorno di così grande amore e felicità era per me solo gioia: gioia allo stato puro.
Poi lui ricomparve e mi disse che accettava, a patto che io avessi venuto il negozio e mi fossi presa cura di nostro figlio.
Mi rassicurò dicendomi che avrebbe cercato fonti di lavoro aggiuntive, oltre al suo lavoro fisso di operaio specializzato, se ci fossero stati problemi di ordine economico.
Io lo abbraccia commossa fino al pianto.
Salutai Lorenzo e gli altri due miei “ amici “ con un ultimo brindisi alle rispettive saluti. Fu soprattutto Lorenzo che si dimostrò molto dispiaciuto di perdermi e mi chiese se fossi davvero certa della mia scelta ma il mio incrollabile entusiasmo lo portò ad abbracciarmi con molto affetto ed a lasciarmi andare senza altro aggiungere.
Rividi ancora una volta quel caro ragazzo: diversi anni dopo lo ricercai ma lui viveva in quel momento un'altra storia parallela al suo matrimonio e, ovviamente, io proprio non potevo più avere alcun ruolo. Però ci incontrammo per bere qualcosa insieme e per parlare.
Non lo dimenticherò mai quel suo sguardo, così colmo di tenerezza e rimpianto di non potere più portarmi in giro a divertire per i locali più belli, festeggiando le notti di una giovinezza che andava velocemente fuggendo tra le bollicine dello champagne.
Io ed Antonio demmo la notizia della mia futura maternità ai suoi, che conoscevo già da un po', durante uno dei rituali banchetti domenicali.
Furono felicissimi, anche la sorella di lui, ancora nubile. Mi accolsero a braccia aperte nella loro famiglia.
Erano ottime persone, mia cognata era gentilissima, mio suocero, anche se un bel po' burbero e collerico, fino a quel momento aveva evitato di esagerare. La mamma di Antonio era una donna dolce,
sottomessa e così generosa che io amai con tutto il cuore: dopo quell'arpia della prima suocera, lei era un sogno.
Misi in vendita il mio negozio ed in meno di un mese lo vendetti. Guadagnai anche una sommetta: era stato acquistato per 18 milioni, merce esclusa, cioè licenza arredamento ed avviamento e lo
cedetti per 37 milioni, sempre merce esclusa.
Inoltre c'erano una decina di milioni di inventario.
Mi dispiacque venderlo, perché mi sentivo orgogliosa della trasformazione che quella piccola bottega vuota e dimessa aveva subito col mio avvento. Chi entrasse ora nella mia latteria veniva
assalito dai colori e dai profumi: la varietà era tale che, per forza di cose, usciva avendo acquistato qualcos'altro oltre il litro di latte di sua intenzione.
Il lavoro mi riempiva e mi rendeva piena di energie ma mi attendeva di nuovo una famiglia. Ed io ero così felice proprio perché, pur vivendo quelli che furono gli anni più belli e divertenti
della mia vita, sentivo comunque la mancanza di un uomo accanto a me, nel mio letto.....
E non certo per il sesso, che assolutamente non mi mancava visto che in quel periodo ne ebbi in quantità e qualità da me mai provate ma per l'amore delle cose quotidiane, per la presenza:
nonostante avessi tutti quegli uomini per me, comunque continuavo a sentirmi sempre sola....
Così vendetti la mia latteria e prenotai quindici giorni in un alberghetto al Parco Nazionale degli Abruzzi, regalando al mio futuro compagno una
vacanza/viaggio di nozze.
Lui si sarebbe trasferito da me dopo la nascita del bambino.
Ebbi un po' di paura quando parlai di quanto mi stava accadendo ad Angela, che non sembrava legare in nessun modo con il mio nuovo amore ma lei non rimase male alla notizia, tutt'altro, sembrò
contenta di avere un fratello o sorella, - cioè, sorella, l'opzione fratello non fu neppure contemplata: doveva essere una sorellina a tutti i costi. -
Quindi partii per quel viaggio come nuotando in una nuvola di felicità.
Furono giorni bellissimi per me, anche se lui non sembrava poi così felice.
La natura là, eravamo a giugno, era stupenda. Facemmo lunghissime passeggiate, vedemmo i lupi, gli stambecchi, un orso.... come era luminoso quel luogo dove l'essere umano ancora non aveva messo
le mani più di tanto.... era puro....
L'alberghetto poi, era delizioso e si mangiava divinamente, infatti presi un paio di chili ma mi dissi che li avrei smaltiti subito, tornando alla mia ferrea dieta di mantenimento che mi aveva
fino ad allora permesso di rimanere in quei fantastici sessantotto chili.
In effetti, in quegli anni, io mangiai pochissimo.. ma pochissimo... perché il cibo continuava a trasformarsi immediatamente in grasso.
Il parco, dunque , fu un'esperienza stupenda ma lui non si dimostrò così affettuoso come io avevo sperato e per tutto il nostro soggiorno si rifiutò d'avere rapporti d'amore con me. Si sentiva a
disagio, pensai, in un posto estraneo.
Io attesi in silenzio, notte dopo notte, che lui ritrovasse quella passione con la quale mi aveva più volte avvolto: il mio sogno romantico era
che quei giorni ci avrebbero uniti come mai eravamo stati in effetti ma nulla avvenne. Lui si addormentò sempre, girandosi sul suo fianco e dandomi le spalle, dopo avermi augurato la buonanotte,
senza altro aggiungere.
Antonio non mi diede mai molte spiegazioni del suo comportamento, anzi, non me me diede mai, punto.
Purtroppo io avevo già un timore reverenziale di lui, quando lo vedevo rabbuiarsi negli occhi e diventare torvo, quindi non facevo domande, accettando quella sua peculiarità, amandolo così
com'era.
Ero davvero felice e pronta a capire e perdonare ogni cosa.
Tornai a casa raggiante ma dopo pochi giorni ebbi crampi e perdite di sangue: di certo mi ero strapazzata troppo in quel viaggio, dato che
avevamo camminato per chilometri e chilometri ogni giorno.
Infatti la ginecologa che mi visitò urgentemente mi disse che rischiavo un aborto.
Mi prescrisse riposo assoluto: dovevo alzarmi solo per andare in bagno e sperare che tutto si rimediasse.
Il pensiero di perdere quel bambino mi era insopportabile.
Mi misi a letto e finì che vi trascorsi tutto il resto della gravidanza, perché la minaccia d'aborto restò costante.
Quell'anno c'erano le olimpiadi ed io guardai tutti gli sport a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il mio cane Last, il mio bellissimo
levriero, se ne stava sdraiato a letto accanto a me... ma era inquieto. Era molto giovane e facevo fatica a tenerlo tranquillo senza poterlo portare in spiaggia a correre come avevo sempre fatto
fino a quel momento: il moto gli mancava moltissimo. Così il suo allevatore mi propose di cederlo ad un suo conoscente che aveva un vastissimo giardino e che desiderava uno dei suoi levrieri. Io
accettai: non avevo mai legato molto con quel cane, era un po' tonto, troppo vivace, non so.. non c'era un grosso feeling tra noi.. era disubbidiente, nervoso. Quando lo avevo preso, da cucciolo,
certo non potevo immaginare che dopo poco tempo avrei avuto un altro cucciolo e decisamente più esigente.
Così lo cedetti, sentendomi molto in colpa ma lo feci...
Non potevo in quel momento prendermene cura, rischiavo di abortire tutte le volte che mi alzavo dal letto... d'altronde sarebbe stato benissimo, di certo meglio, nella sua nuova casa.
I giorni passarono.
Mia suocera mi cucì dei comodi vestiti prema-man.
Stavo rigidamente a dieta, aumentai solo del minimo indispensabile dei chili: dieci a fine gravidanza.
Il parto cesareo era stato programmato dall'inizio, anzi, quando la ginecologa mi annunciò che ero in attesa di un bambino, le dissi subito che l'avrei accettato solo se avessi potuto contare su
quel tipo di parto: un'altra esperienza come quella precedente mi terrorizzava.
Giunto lo scadere del termine, alla data prestabilita, mi ricoverai.: sentivo già muoversi delle contrazioni, era assolutamente necessario non fare aprire il canale del parto.
Erano i primi giorni di gennaio 1985, avevo trent'anni, li avrei compiuti dopo meno di un mese. Anche mia madre aveva trent'anni, quando io nacqui: corsi e ricorsi storici.....
Antonio mi accompagnò in ospedale che già cominciava a nevicare. Continuò per tre giorni e fu una nevicata storica: mia figlia nacque nell'unica sala operatoria funzionante di tutto l'ospedale di
Ravenna.
Alle 17 e 45 me la posarono tra le braccia, dopo averla estratta dal mio utero tagliato.
Io ero sveglia: avevo scelto l'anestesia epidurale per non far dormire il mio bambino mentre nasceva, per non avvelenarlo subito così. Ma anche e soprattutto perché non volevo perdere il momento
della sua venuta alla luce.
Antonio non aveva voluto sapere il sesso, così durante le ecografie chiedemmo che non ci venisse rivelato ma io ero certa che sarebbe stata una femmina.
Durante l'iniezione lombare rimasi calmissima, anche se non fu di certo gradevole e mi mantenni molto serena per tutta l'operazione. L'anestesista accanto a me si stupì alquanto del mio
comportamento ed io trovai strano il suo stupore: perché non avrei dovuto essere tranquilla? Anzi, io avrei voluto vedere tutto quello che stava accadendo al mio corpo: trovavo questo naturale e
logico. Infatti all'inizio, mentre mi preparavano, guardai tutto nello specchio che non era ancora stato coperto. I medici, seguendo il mio sguardo, poco dopo se ne accorsero e l'oscurarono,
mettendo un telo poco davanti al mio viso.
Protestai dolcemente, chiedendo loro di farmi assistere all'estrazione della mia creatura ma furono irremovibili: peccato, avrei voluto davvero vedere.
Molte volte avevo pensato che mi sarebbe piaciuto fare il chirurgo ed ero comunque stata assistente di sala operatoria nella clinica veterinaria: nulla m'impressionava.
Ma il mio parto non mi fu permesso di vederlo.
Sentivo i medici affaccendarsi intorno a me, li sentivo muoversi e premere contro la parte superiore del mio corpo ma dal seno in giù non
avvertivo nulla.
Fu solo la sua voce a darmi la notizia della sua entrata in questo mondo.
Qualcuno mi disse: “E' una bellissima bambina di tre chili!!”.... E poco dopo l'ebbi tra le braccia.
Com'era bella...
Lacrime scivolarono lungo le mie guance e l'anestesista mi chiese se stessi bene.
Gli risposi che quello era il giorno più bello della mia vita.
Aveva odore di buono, avvolta nella tela verde della sala operatoria, sembrava un miracolo appena sbocciato.
Guardavo quel viso di bambola dai capelli corvini ed i lineamenti perfetti. Agitava le piccole mani dalle dita lunghe e perfette, come se non avesse fatto altro che suonare il pianoforte nel mio
grembo e pensai che mai avevo visto una creatura più bella.
Mi sentii una teca preziosa che aveva levato il suo coperchio e mostrato all'intero universo un frutto inaudito ed inatteso.
Poi me la tolsero dalle braccia dicendomi che l'avrebbero lavata, visitata e vestita. Lasciai fare, finalmente stanca e mi abbandonai chiudendo gli occhi a quella sensazione che sapevo
irripetibile. Qualche passo più in là sentivo i suoi piccoli vagiti e la voce della levatrice che dolcemente le parlava, raccontandole di quanto fosse bella. Io pensai, dietro le ciglia
socchiuse, che era la mia bambina, mia figlia, che di me si era cibata per quei lunghi nove mesi, del mio sangue e del mio amore e ciò l'aveva resa perfetta.
Sentivo come da molto lontano i medici che terminavano il loro lavoro ma il mio corpo era come fosse volato via: io e la piccola Betta eravamo abbracciate tra petali di gioia purissima.
Quando mi riportarono in camera Antonio, appena diventato padre, circondato dai suoi erano lì ad aspettarmi. La camera era invasa di fiori.
Lui si avvicinò commosso e m'infilò un anello al dito. Un anello di oro giallo con un corallo rosa, molto elegante e semplice ma bellissimo.
Lo guardai in viso e vidi un altro uomo: emozionato, presente, innamorato. Gli presi la mano e feci per sussurrare qualcosa; lui si chinò su di me ed io dissi piano al suo orecchio: “E' la nostra
bambina.”
Sembrò una lacrima quella che vidi brillare nei suoi occhi? Forse lo era ma con un dolce bacio lui fece chiudere i miei.
“Ti amo.” e sorrise.... ero mai stata così felice?
Tutti mi si fecero intorno ripetendomi che ero stata bravissima e meravigliosa a partorire una bambina così perfetta, trattenendosi alquanto
accanto a me.
Poi se ne andarono lasciandomi ad un sonno ristoratore.
La notte mi portarono la piccola per la prima poppata: ero così ansiosa di rivederla e di stringerla tra le mie braccia!
Avevo dormito non in modo profondo: il mio corpo si stava risvegliando dall'anestesia e rilasciava dolori e strane sensazioni ma il mio pensiero era fisso su di lei. Mi chiedevo cosa stesse provando, se sentisse la mia mancanza, se avesse paura, fame, qualche piccolo dolore. Non mi piaceva l'abitudine che vigeva in quel reparto di maternità, di tenere i neonato divisi dalle madre e tutti raccolti in una nursey ma non vi fu modo di evitarlo. Così dovetti attendere la sera inoltrata per poterla avere di nuovo con me.
Finalmente me la portarono ed era così carina, tutta vestita di bianco. Anche i piccoli abiti erano dell'ospedale ed erano assai semplici e comodi ma la sua bellezza risaltava come fosse avvolta di pizzi e trine preziosissimi.
Le diedi il suo primo latte, purtroppo con il biberon ma cercai di porre tra le mie braccia tutto il calore, l'amore, la meraviglia che il mio seno le avrebbe dato.
Lei era serena, sembrò adagiarsi e sprofondare nel mio abbraccio, succhiò il suo piccolo pasto e poi si addormentò come per incanto, affondando in me ancor di più. Io faticavo un po' a muovermi, il taglio al mio ventre si faceva sentire ma non ascoltai nulla se non quella pace e quella delizia.
Quando tornarono le infermiere a prenderla ci trovarono addormentate entrambe.
Nei giorni seguenti tutto proseguì con serenità: la piccola stava bene, mangiava e cresceva normalmente. Io mi rialzai subito dal letto. Avevo un po' di dolore ma di certo non era nulla, in tutta quella felicità.
Venne Angela con il padre a vedere la sorellina.
Quel giorno la mia primogenita indossava il bel vestitino scozzese con il colletto bianco che le aveva cucito la mamma di Antonio, per farle capire che lei pure era importante come la nuova nata. Credo che quella fu l'ultima volta che la vidi ancora bambina: aveva undici anni, il suo tempo ero alle porte ma quel pomeriggio provai una grande tenerezza per lei. Volle prendere in braccio la sorellina e le rivolse un sacco di moine e complimenti: Betta era davvero un bambola, nessuno, neppure gli infermieri, i medici, gli altri visitatori potevano esimersi di notare e lodare la sua bellezza. Anche Carlo ne fu conquistato ma tra noi vi fu un po' di imbarazzo: di certo le nostre strade si erano definitivamente divise.
La neve cessò. Quando uscii dall'ospedale, gli spazzaneve l'avevano accumulata in enormi montagne in ogni angolo disponibile: faceva un freddo acutissimo, in quei giorni il termometro scese fino a venti sette sotto lo zero e quindi la neve restò a lungo a ricordare un evento che restò negli annali del secolo.
Io tornavo a casa con la mia bimba e Antonio sarebbe sempre stato con me.
Fu quel giorno che promisi a me stessa che mai avrei spezzato un'altra famiglia.
Ma le mie felicità sono sempre di breve durata.
Lui cominciò ben presto ad essere troppo inquieto.
Quella piccola casetta, quella villetta sul mare, non gli piaceva: era vissuto in campagna da quando era nato e il suo ambiente naturale gli mancava troppo.
Poi la villetta era davvero minuscola: ingresso - sala da pranzo con angolo cottura, tre gradini per salire alla zona notte, due camere non troppo grandi, un bagno con doccia, un balcone, un minuscolo giardino, un garage. In quattro eravamo strettini: una cosa diversa era stato quando mia madre aveva trascorso diverse settimane con me ed Angela, c'era familiarità tra noi; poi, nel fine settimana, la bambina andava dal padre e mia madre a casa sua per stare un poco con mio fratello e gli altri.
Ma per la nostra nuova famigliola quella si delineava come una situazione stabile.
La mia primogenita ben presto divenne piuttosto gelosa della sorellina: i primi giorni voleva sempre tenerla in braccio e darle il latte ma poi quel bambolotto le venne presto a noia e di certo vedere che il ritmo della casa fosse incentrato su quello della piccola la infastidì parecchio. Era sempre stata lei il centro e l'orologio di tutto, fino a quel momento. Inoltre con Antonio non era sorta nessuna simpatia tanto che si parlavano a malapena, anzi, cercavano entrambi deliberatamente di ignorarsi e quando si rivolgevano parole quelle erano tese e dure.
Io mi curavo di loro ed accudivo la mia piccola che cresceva senza alcun problema: era buonissima, non piangeva mai. Le facevo lunghi discorsi, le cantavo mille canzoncine, esattamente come avevo fatto con la prima ma allora i problemi che erano sorti furono tanti e tali, le sofferenze vissute così grandi, che tutto trascorse in una dilagante angoscia.
Ora con lei era tutto diverso.
Se solo il mio compagno fosse stato felice...... Invece era sempre più torvo ed ombroso.
Una sera a cena ebbe la sua prima – almeno davanti a me – crisi collerica.
Avevo preparato un bel piatto di spaghetti alla carbonara. Eravamo soli: la bimba più grande era dal padre, la piccola dormiva. Io lo guardavo con occhi adoranti ma lui, alla prima forchettata, la buttò contro il piatto sbottando che la pasta era troppo salata troppo cruda e che io non ero capace di fare nulla di buono..
Mi disse altre parole molto cattive. Io reagii, mi alzai, lui gridava, io gli urlai contro più forte. Fece per alzare le mani contro di me.
Gli afferrai un polso e sibilai: “ Fallo. Ma se lo fai è l'ultima cosa che avrai con me. “
All'improvviso lui si blandì, come riscuotendosi da un incubo.
Allora dispiaciuto mi chiese di scusarlo, quasi alle lacrime. Mi disse che c'erano tensioni sul lavoro, mi raccontò di problemi con i colleghi, il suo capo.. era davvero contrito.
Mi dispiacque per lui, così tanto che lo perdonai immediatamente e lo consolai.
Parlammo a lungo. Mi confessò che in quella casa non si trovava.
Gli dissi che non era un problema, che ne avrei acquistata un'altra, in campagna come suo desiderio.
Io pure amavo la campagna e mi mancava.
Lui era tutta la mia vita, io lo amavo: che mi importava una casa oppure un'altra? Io volevo solo che fosse felice con me.
Mi misi così alla ricerca di una nuova casa per noi, ponendo in vendita la villetta marina.
Scegliemmo come zona dove andare ad abitare una cerchia di paesini tra Ravenna a Forlì, assai vicini al suo natale; il luogo lo scelse lui, tanto per me una posto valeva l'altro.
Vidi diverse case da sola, accompagnata da un mediatore. Poi, quelle che mi sembrarono adatte, le tornai a visitare con lui.
Dopo diverse delusioni ne trovai una che mi entusiasmò ed avrei voluto acquistarla, tanto mi piaceva: era ben rifinita, ristrutturata da poco e molto capiente. C'era il riscaldamento, bei pavimenti, un camino nella sala, una camera per tutti, due bagni molto belli ed il prezzo era assai conveniente: costava solo 40 milioni. Questo perché non risultava del tutto indipendente ma era la parte centrale di una grande abitazione colonica dalla quale erano stati tratte tre frazioni.
In pratica vi era un cancello di ingresso comune ed un cortile comune, poi giardini recintati divisi per ciascuna famiglia.
Posta su di una stradina per nulla frequentata, con un bellissimo portico sul retro che dava su di una vigna, a me parve un posto da sogno. Ma a loro, al mio compagno ed ai suoi, non piacque, anche perché era ubicata in una frazione che ritenevano di seconda scelta.
Io non capivo, secondo il mio punto di vista quei paesini erano tutti uguali ma non ero nata lì e questo aveva una decisiva importanza.
Loro, -e qui continuo ad usare il ' loro ' perché ci fu una massiccia ingerenza dei miei suoceri nell'acquisto di quella casa, - ne preferivano un'altra.
Era una casetta singola ad un piano con 3000 metri di terreno da un lato. La parte abitabile era davvero piccolissima: due stanze, camera e cucina, entrambe 4 x 5, un corridoio troppo vasto che era stato interrotto con un tramezzo di vetro e legno per farne un ingresso e, in fondo, un'ala appoggiata di contro alla casa nella quale era stata ricavata una stanzina, un bagnetto minuscolo con doccia e un altrettanto angusto disimpegno dal quale, tramite un portoncino di metallo, si usciva all'esterno. Di fronte, a tre passi, si trovava un'altra piccola costruzione ancora più bassa che serviva da sgombra roba. Di seguito c'era una specie di porcile a due piani nel quale i proprietari allevavano colombi e dieci metri più in là, costruito in parallelo, una garage di metallo ed ondulato..
Una parte della terra, una piccola parte, era recintata come giardino, nell'altra c'era una vigna con diversi alberi da frutto ed un antico noce.
La casa aveva già in essere il progetto per venire soprelevata di un piano ed era sita in un micro paesino, su di una stradina asfaltata ma molto stretta, esattamente a metà tra due curve consecutive e contrarie di verso.
Era certo un posto molto tranquillo.
C'erano un paio di case di fianco e null'altro. Ma, pur con tutto questo spazio vuoto, la recinzione dall'altro lato passava a mezzo metro dal muro, in linea con il confine del vicino, rendendo difficile ogni lavoro si dovesse eseguire lì.
Il riscaldamento aveva una caldaia alimentata a GPL con il bombolone già installato poco lontano al garage. Quando l'andammo a vedere era tutto molto verde, perché tra la vigna, il noce e i susini e gli albicocchi vi erano altri arbusti.
Quel verde mi piacque, ma la casa davvero no. I pavimenti erano di ceramica ma assai brutti, così come i rivestimenti. Il colore delle mura esterne spiccava di un rosa acceso che non mi piaceva per nulla mentre gli annessi dietro, anche se area edificabile, però versavano in uno stato di notevole abbandono. Inoltre erano costruiti di mattoni forati e neppure intonacati: insomma, davvero una povera cosa.
A me non sembrava tutto quell'affare ma a lui piaceva e allo suocero pure.
Il progetto l'avrebbe rialzata creando al primo piano la zona notte con tre stanze ed un bagno, dietro sarebbe sorto un portico che l'avrebbe collegata ai presenti stalletti i quali sarebbero stati demoliti per far sorgere al loro posto un vasto bagno e una bella camera da letto per noi. Le due stanze attuali con una parte dell'ingresso sarebbero stati trasformati in un vastissimo salone con zona cottura all'americana. Il colore sarebbe stato mutato in bianco e una nuova recinzione avrebbe abbracciato l'intera area, trasformata in un bellissimo parco - giardino.
Sì, certo, il progetto era bello, ma il costo?
Cinquanta milioni la casa così com'era. Il resto un po' alla volta, dicevano i due uomini con il fare: ci pensiamo noi, facciamo tutto noi.
Uno dei più grandi motivi di litigio con mia madre è sempre stato il fatto che, secondo lei, io avevo sempre voluto fare di testa mia, non ascoltando mai nessuno.
Me lo disse e ridisse tante di quelle volte che ogni volta che desideravo fare qualcosa o avere qualcosa non capivo più se era un mio vero bisogno o soltanto la necessità di contrastarla.
Provai a perorare l'altra casa, che era accogliente, già ristrutturata in modo moderno e pronta subito. Aveva, sì, quella servitù ma costava ben dieci milioni di meno.
Ci provai, in fondo i soldi erano i miei ma assolutamente le mie considerazioni non li convinsero.
Lui si rabbuiò, diventando taciturno e solitario.
Allora io mi sentii la solita testona e zuccona ed acconsentii: comprai la casetta rosa.
Era maggio quando ci trasferimmo: intanto i due uomini avevano già lavorato.
Avevano divelto la vigna perché sarebbe stata da seguire e non ne avevano voglia o tempo; degli alberi da frutto ne furono salvati solo due o tre e tutti gli arbusti, anche quelli fioriti, venne abbattuti, per dare aria alla casa, dissero.
Anche il noce, pochissimi mesi dopo, venne abbattuto perché i suoi rami si estendevano troppo vicino al tetto in modo, quindi, pericoloso.
Quanto piansi, quel giorno. Quel grande albero era vivo, era una creatura bellissima sotto la quale mettevo la piccola Betta, adagiata nella sua carrozzina rossa, mentre io lavoravo a far tornare nuove le tapparelle delle due stanze, che erano tutte scorticate e screpolate. Mentre mi davo da fare, sentivo la bimba che emetteva strilletti e versetti di gioia, come se parlasse con le fronde ed il vento, come se vi giocasse, ne venisse cullata, tanto che poi si addormentava tranquilla. Ma loro furono irremovibili.
Quindi tutto quello che era piaciuto a me, di quel posto, fu eliminato immediatamente.
Furono piantati un paio di piccoli sempreverdi là nel mezzo della terra, che fu arata, con il risultato che di tremila metri ora se ne potevano calpestare solo seicento compresa la casa. Quindi il sogno delle mie sieste sotto il noce e i filari, dei giochi a rincorrersi con le bimbe nel frutteto, tra bianche margherite ed azzurri non ti scordar di me furono immediatamente depennate dalla realtà.
Quello che restava era piuttosto squallido.
E scomodo.
Il bagno era piccolissimo, con la doccia. Per lavare la piccola dovevo armeggiare non so quanto con bacinelle ed acqua calda sul tavolo della cucina.......
Ebbene sì, fui subito infelice, lì, ma lui sembrava trovarvisi a suo agio.
Si riavvicinò a me.
Il lungo periodo di post parto era finito e Antonio una notte mi cercò di nuovo: io ancora sentivo dolore alla ferita ma averlo ancora tra le mie braccia mi consolò un po'.
Così mi feci coraggio: ero forte, davvero non era un bel bagno comodo ciò che importava nella vita..................

CAPITOLO VENTUNESIMO
Gabriele. Io lavoro di nuovo, il bar, la decisione di Angela
Quanti abbracci di passione ci furono tra me e Antonio? Due o tre ma dopo un mese sentii di nuovo la medesima sensazione che avevo provato quando ero rimasta incinta della piccola.
Pensai: “ Mio Dio, no. “
Ed invece fu si. Ero di nuovo incinta. Gli ormoni sballati ci avevano tratto in inganno così come gli altri metodi, diciamo così, naturali.
Glielo dissi subito.
Lui mi disse semplicemente: “ E' una scelta tua. “
Tornai dalla ginecologa che mi visitò accuratamente e mi confermò la nuova gravidanza. Mi disse che rischiavo la vita se l'avessi portata avanti: il cesareo precedente era troppo fresco, l'utero poteva spaccarsi all'improvviso, era molto pericoloso. Ed anche c'erano grandi possibilità di una interruzione naturale per distacco della placenta. Mi consigliò assolutamente di abortire.
Fu un grave colpo, per me. Io avevo sempre pensato che avrei voluto avere un altro figlio, perché non desideravo un'altra figlia unica. Avevo sofferto troppa solitudine per non pensare che Betta avesse diritto di avere un fratellino od una sorellina di un'età più simile alla sua, dato che Angela più che una sorella avrebbe potuto essere per lei una seconda madre. Ma non ero affatto sicura che fra le mie due figlie si sarebbe potuto instaurare un rapporto sereno ed affettuoso e anche per quel motivo avevo pensato ad un terzo figlio. Però non così presto! E poi con Antonio le cose erano tutto fuorché chiare e tali da infondere fiducia. I problemi economici erano già fortemente palesati e su tutto pesava quella seria possibilità di perdere la vita. Ma ugualmente il pensiero di uccidere quella mia creatura mi era insopportabile.
Avevo bisogno di pensarci su e chiedere consiglio.
Parlai con Scilla. A suo dire era una follia aver un altro figlio. Il mio compagno percepiva uno stipendio di un milione al mese.. avevamo molte spese perché lavorava a diversi chilometri da lì ed usava la macchina per recarsi sul luogo, quindi erano necessarie due auto. C'era la piccola che era certo un costo notevole da sostenere. C'era la più grande: anche se percepivo un mensile dal primo marito di duecentomila lire il costo degli studi e di tutto il resto era assai oneroso: Angela aveva sempre molte necessità: occhiali scarpe e una marea di altre piccole grandi necessità e vizi che non potevo sottrarle ora, in un momento così delicato.
Certo in quattro con quell'introito non era uno scherzo. Poi il mio compagno fumava e molto, inoltre comprava tutta una serie di giornali e pubblicazioni.. non so, il denaro che lui portava a casa nel conto comune se ne andava subito: già dai primissimi mesi avevo cominciato ad intaccare il piccolo gruzzolo che mi era rimasto dalla vendita della latteria.
Ad aggravare il tutto la villetta era rimasta invenduta a lungo e quindi, alla fine, svenduta a quarantasette milioni. Pagati i notai vari, di quel denaro non era rimasto più nulla.
La mia amica aveva ragione.
Con la morte nel cuore decisi che avrei abortito: feci tutte le carte, gli esami preparatori, i colloqui con gli psicologi; era tutto pronto, mancava solo la visita dall'anestesista da effettuarsi il giorno prima della data dell'intervento.
Ma ogni giorno piangevo.
Sulla culla della mia bambina parlavo con quel figlio che avrei ucciso di lì a poco. Gli chiedevo di perdonarmi, gli chiedevo di non soffrire. E poi pensavo che non avrei mai visto il suo viso, le sue manine, i suoi occhi. Che non avrei mai ascoltato la sua voce che mi chiamava mamma.
La piccola cominciava allora a chiamarmi con quel dolcissimo nome.
Quello che sentivo nel mo cuore e nella mia mente era un rifiuto totale a quell'omicidio, perché era un omicidio.
Avevo naturalmente sostenuto la legge per la liberalizzazione dell'aborto perché le donne erano troppo spesso le vittime in una serie di situazioni limite e quindi in quelle storie di vita la soluzione estrema era assolutamente necessaria ed inalienabile. Ma io? Io non ero un caso limite.. forse sì, dal punto di vista fisico ma, per il resto ero lì, ero cosciente, presente... E poi, ero davvero padrona di quella vita che era fiorita in me? E ancora, se avessi abortito, come avrei potuto vivere con quel peso sulla mia coscienza così esigente?
No, non ce la potevo fare, più il giorno si avvicinava e più chiaramente sentivo che non avrei dovuto, potuto, voluto uccidere il mio bambino, si un bambino, erché ero certa fosse un maschio. Lo avevo sognato ed era biondo e così bello: mi aveva sorriso, guardandomi con il suo sguardo luminoso, da angelo
Decisi che avrei accettato rischi e difficoltà: che fosse il destino o Dio o chi per lui a prendere quella decisione, che io sentivo non fosse assolutamente mia.
Così parlai ad Antonio. gli raccontai il mio dolore, gli chiesi aiuto. Lui mi promise che, se avessimo avuto dei problemi economici, sarebbe andato a lavorare per qualche anno all'estero con la sua ditta, percependo così stipendi notevoli, ed avrebbe sistemato tutto lui.
Gli credetti e fui felice: avremmo avuto un altro bambino, un fratellino per Betta, quella creatura angelica che mi si era mostrata sarebbe giunta tra noi.
Dopo aver preso la decisione, lo dicemmo a tutti i nostri parenti: mia madre mi disse che ero pazza e la stessa cosa mi dissero gli suoceri.
Avevo tutto il mondo contro.
Ma io non potevo assolutamente uccidere il mio bambino, possibile che nessuno mi capisse? Possibile che questo cavolo di mondo andasse avanti solo di soldi e scelte apparentemente logiche e ' comode '?. Ma era ' logico e comodo ' vivere con il peso dell'omicidio di un bambino nel cuore e nella mente?
Ma davvero nessuno la pensava come me?
I mesi passarono, io, sola contro tutti: il mio uomo non mi cercava quasi mai, era freddo e distaccato. Di certo, pensavo, la gravidanza non lo metteva a suo agio.
I suoi genitori cambiarono atteggiamento e divennero piuttosto ostili, soprattutto mio suocero col quale ebbi una sgradevole discussione. Quando io, punta sul vivo dalle sue parole di riprovazione della mia scelta di vita gli ricordai quello che Antonio sempre mi diceva e cioè che la grande e bella villa nella quale vivevano era stata costruita anche e soprattutto con il suo contributo economico, dato che allora lavorava in trasferta e percepiva uno stipendio notevolmente alto, lui lo negò vigorosamente, dicendomi che io non avevo capito nulla di suo figlio, che Antonio aveva le mani bucate e si era speso sempre in futilità tutto quello che aveva guadagnato – cifre considerevoli -.
Mi rinfacciò di avere una figlia non sua e mi dichiarò che da lui non avrei avuto nessun aiuto economico di nessun genere. Mi aveva avvertito ed ora sarebbero stati cavoli miei.
Rimasi colpita profondamente da quelle parole astiose: percepii ancora più chiaramente che il mio compagno celava nel suo cuore segreti, parti oscure della sua vita che non voleva affrontare: mi aveva raccontato di un periodo assai difficile vissuto ai diciotto anni, risolto anche con l'aiuto di uno psicologo e poi con la decisione di non proseguire gli studi, per non pesare più sulle spalle del padre; vedevo ormai chiaramente il carattere collerico ed ombroso dei due uomini ma sotto c'era altro, qualcos'altro che però rimase un fantasma che non mi fu rivelato mai.
Ma amavo Antonio ed allora avvertii solo un sottile senso di paura. Mi dissi che i genitori sono sempre troppo negativi nei confronti dei loro figli, come d'altronde mia madre era sempre stata con me e rimasi con il mio malessere.
Altri mesi passarono....
Per fortuna quella gestazione fu buona. Avevo la bambina piccola e lavoravo giorno e notte per mandare avanti tutto come desideravo. Ripresi con me il mio Last, il levriero, che non si era mai ambientato con il nuovo proprietario ed accolsi uno dei cuccioli di levriero a pelo ruvido nati con il primo marito, era una femmina che avevo chiamato Alchemilla, venduta qualche anno prima a tre mesi dalla sua nascita ma poi abbandonata al canile; la mia amicizia con il custode mi rese, quella volta, un servizio: lui riconobbe la razza e, dato che allora ero l'unica in Italia ad averne degli esemplari, mi telefonò, avvertendomi.
Avere i miei due levrieri con me mi rese felice. Ma i due cani scappavano sempre, seminando il panico tra le galline dei vicini ed anche qualche vittima, con notevole disagio mio e spese per riparare il danno. Ebbero anche una bellissima cucciolata: era l'incrocio di due razze diverse ed io non avrei voluto che nascessero ma Last, nottetempo, troppo innamorato della sua Milla, come chiamavamo affettuosamente quella dolcissima cagnona, riuscì ad aprire la porta dello stalletto dove lei era rinchiusa e si accoppiarono. Regalai i cuccioli ad amici ma non fu facile piazzarli, perché cani così grandi e particolari, ma uno Thunder, andò a vivere presso una vicina che lo regalò a Marcello, il suo figliolo adolescente. Così potei vederlo crescere e togliermi la curiosità di scoprire come sarebbero state poi le sue fattezze anatomiche, in verità molto simili a quelle della madre. Infatti tutti i cuccioli avevano ereditato il tipo ed il colore del mantello del Deerhound.
Non ho raccontato di quando Neroli ebbe i cuccioli, nel 1980, a novembre. L'avevamo fatta coprire da un grande campione tedesco che viveva con la sua allevatrice nel sud della Germania: fu quella l'occasione per un viaggio bellissimo sul Bodenshee. Il lago di Costanza. Mai più visto un luogo così civile ed ameno, con abitanti così cordiali.. visitammo anche l'isola di Mainau, detta anche L'isola dei fiori: era settembre e i colori e le varietà ci accolsero lussureggianti. Vidi lì, inoltre, delle sculture vegetali davvero incredibili. Non che fossi mai stata entusiasta di coloro che potavano gli alberi facendoli assumere delle forme geometriche o altro ma quello che mi si mostrò là era davvero una fantastica espressione artistica e gli alberi che davano vita a quelle figure: gruppi di persone, animali a grandezza naturale e paesaggi sembravano incredibilmente soddisfatti del loro stato, come dire? Come fosse avvenuta una fusione tra il mondo vegetale e l'altro che veniva rappresentato.
Nacquero nove cuccioli ma il parto fu molto lungo e difficile e ne sopravvissero solo cinque. Avevamo deciso di dare loro nomi particolari: il primo nome legato al mondo di Carlo, le piante officinali e il secondo un aggettivo latino, che ricordava la mia impronta, gli anni del liceo.
E così furono: Amaranthus Vir Fortius, che significa Uomo più forte perché era il cucciolo maschio più grosso e sembrò, proprio da appena nato, un vero adone canino, Alchemilla Prima Lux, perché fu la prima a vedere la luce, Artemisia Pulcherrima, perché era appunto, bellissima, Achillea Magna Domina che vuol dire: grande padrona, perché era la più prepotente del gruppo ed infine Agropiron Puer Rex dato che, come un piccolo re bambino, si accoccolava sempre tra le mie braccia.
Rimasero con noi Amaranthus e Artemisia. Il primo divenne il più bel Deerhound dei suoi tempi, esposto in numerosissime manifestazioni, anche in Francia e Germania, risultò sempre imbattuto. Fu un cane così elegante e signorile che venne ammirato da tutti, anche dai non amanti della razza. Ma il destino non aveva finito di accanirsi sui miei più amati: a poco più di due anni contrasse una micidiale epatite virale ad una esposizione e dovette morire dopo una lunga agonia durante la quale lo curai con tutto l'amore che mi fu possibile, dato che venne a mancare proprio nei mesi della separazione da Carlo. Fu come se quanto di bello avevo progettato lì non potesse sopravvivere, senza e dopo di me. Artemisia si dimostrò, molto stranamente, di un carattere pauroso e schivo e un giorno fuggì da casa riparando in pineta dove visse in modo selvatico ancora qualche anno, avvistata spesso dal mio amico guardacaccia che me ne dava notizia. Di Alchemilla ho raccontato, aggiungo che finì i suoi giorni da Carlo, morendo di tumore, molto vecchia, come pure la madre Neroli e la cugina Iska. Achillea fu ceduta alla allevatrice del padre, la gentilissima signora tedesca, che accettò uno scambio di femmine, dandoci al suo posto una sua cugina, di nome Iska vom Ahslachoff, che venne regalata ad Angela come suo primo cane personale. Iska fu esposta da Carlo per qualche tempo divenendo campionessa ma poi lui, evidentemente, aveva vissuto la passione per le esposizioni canine in riflesso dalla mia. Achillea fu una grandissima campionessa in vari paesi d'Europa e madre di diversi campioni.
L'accoppiamento fra Neroli ed il suo zio tedesco, padre dei cuccioli, che io studiai lungamente a tavolino prima di eseguirlo, risultò molto azzeccato ma, con la separazione, tutto finì e fu un vero peccato.
Ma non posso non raccontare di Neroli, attesa per un lungo anno, acquistata con un notevole investimento di tempo e di denaro, che crebbe bellissima, elegante e femminile ma, prima di poter debuttare nei ring, correndo nei campi dietro casa, si ruppe una zampa anteriore, sotto i miei occhi, a pochi passi da me, semplicemente inciampando in un fossetto di dieci centimetri: correva felice e poi, come un fiore reciso dalla falce, si schiantò a terra con un gemito acuto. Corsi verso di lei con il cuore in gola, che già sapevo cosa fosse successo: infatti la vidi gemente a terra con l'arto spezzato. La presi delicatamente in bracco e la riportai in casa, piangendo. Fu operata immediatamente dal miglior veterinario della zona, che era uno dei migliori chirurghi ossei d'Italia che le infibulò la lunga tibia infranta. Guarì bene e camminò bene senza avere problemi ma, dato che al mio destino non ne sfuggì nemmeno una, l'arto rimase piegato verso l'esterno, nonostante che io, per un mese, le abbia impedito di camminare portandola in braccio sempre, anche di sotto per i suoi bisognini. La esponemmo qualche volta ma un cane con una zampa storta, pur a causa di un incidente e pur se così bello da venir scelto per la pubblicazione come emblema della sua razza su di una prestigiosa enciclopedia delle razze canine uscita a quei tempi, edita da De Agostini, non può avere un futuro in una competizione canina e così desistemmo. E tutti i miei sogni andarono in fumo un'altra volta. Neroli fu una cagna davvero intelligente: conosceva sia l'inglese che l'italiano, dato che noi ci rivolgevamo a lei nelle due lingue. Amava spasmodicamente il tea inglese con un goccio di latte, tanto che ne beveva sempre una tazza lei pure, quando lo sorbivo io. Inoltre sapeva cogliere le fragole - solo quelle mature! - con i denti delicatamente dalla pianta, senza rovinarle per nulla.
Quanto potrei scrivere sui miei animali..
E qui, ancora una volta, mi riprometto di farlo, se avrò vita avanti a me.
Tornando alla narrazione in diretta, il primo Natale con la piccola Betta, che aveva quasi un anno, fu una gioia. Vederla ad occhi sgranati davanti a doni ed albero riccamente illuminato e decorato, fu bellissimo. Le regalammo un cavallino a dondolo che fu poi il ' cavallo di battaglia ' di suo fratello, più che il suo...
Io però, in quella gravidanza non riuscii a a contenere il peso, come nella precedente, e sorpassai di nuovo gli ottanta chili.
Ma non mangiare con tutto quel da fare e quei pensieri nella testa non mi fu possibile.
Dieci giorni prima del compimento del settimo mese ebbi delle contrazioni.
Il parto si era aperto.
Mi ricoverarono d'urgenza in ospedale, mi fermarono a letto con flebo 24 ore su 24. Non potevo alzarmi neppure per andare in bagno: il bambino si era girato con la testa verso il canale del parto, aveva appoggiato i piedi contro il mio fegato e spingeva con tutte le sue forze, per uscire, lo sentivo distintamente.
Per quanto era stata tranquilla e delicata Betta, nei suoi movimenti intrauterini, per quanto esagitato fu quel terzo figlio. Si seppe subito che era un maschio e non solo a causa del mio sogno e della ecografia, che fu interrogata a proposito, a differenza della volta precedente ma anche e soprattutto perché mi sembrava di avere una intera squadra di calcio in allenamento perenne, custodita nel mio pancione.
Dopo dieci giorni i medici mi dissero che il pericolo era scongiurato e che lunedì, quel giorno era sabato, sarei potuta tornare dalla mia bimba, che era con i nonni. Mi asserirono che certamente avrei portato a termine la gravidanza.
Ma io sentivo il bimbo spingere: glielo dissi e loro risposero che era solo una mia impressione.
Mi alzai, dopo dieci giorni, presi una bellissima doccia e mi feci una lunga dormita. La mattina dopo mi svegliai, mi misi a sedere sul letto e sentii le acque rompersi.
Altro che mia impressione!!
Fu convocato il chirurgo e il mio bambino nacque a mezzogiorno e mezza di quella domenica dei primi di febbraio 1986, anche lui sotto una nevicata. Avevo 31 anni appena compiuti.
Quella volta il parto non fu così semplice. Sempre eseguito con la epidurale, l'utero però era così legnoso che non voleva cedere e lasciar uscire il nascituro.
Il chirurgo ostetrico mi strattonava in malo modo, staccandomi dal tavolo operatorio. Chiesi cosa stesse succedendo e con molta malagrazia mi fu detto di non disturbare.
Ma tutta la questione partì male.. appena arrivarono i medici uno di loro fece un commento assai sarcastico e scortese sulla mia mole. L'anestesista, molto imbarazzato, gli disse che io ero sveglia. Il medico si scusò ma a me rimase un amaro groppo in gola. Che bestie che sono certe persone.... ma molto peggio di bestie, che nessuna ' bestia ' tratta male una sua pari solo perché............ è in possesso di una laurea...
Ci vollero diversi minuti di strattoni prima che il chirurgo riuscisse a tirare fuori il mio bimbo.. la tensione era tangibile. Io tremavo ma non avevo paura per me: tremavo per il mio piccolo. Finalmente sentii il suo grido, un vagito piccolino ma deciso.
Era nato.
E lì lacrime scesero. Ma il sarcasmo di quel giorno era destinato a rovinare tutto. Qualcuno disse: “ Ma dai, invece guarda, è bellino.... “
Che simpaticoni, quelli lì.. che rabbia che mi venne lì per lì..... ma poi me lo portarono, il mio Gabriele.
Era due chili e mezzo. Piccolino piccolino... ed era......blu... o meglio, azzurro.
Mi dissero che aveva ancora quello che viene chiamato ' il velo o la camicia della Madonna'. Mi commossi ancora di più.
Pensai, guardandolo con amore, che lui aveva voluto assolutamente venire al mondo, contro tutti i ragionamenti logici e basati sulla convenienza; chissà a cosa sarebbe stato destinato.
Guardavo quel visino da vecchietto, completamente pelato, - che poi gli venne una testa di capelli incredibile, fini lisci e biondo cenere, come nel mo sogno, - sentii di nuovo quel buon odore: il profumo della vita.
Poi lo portarono via, come avevano fatto un anno un mese ed un giorno prima per Betta, per lavarlo e sistemarlo. Era tutto sano e vitale, non c'era necessità della incubatrice. Mi ricucirono, io mi abbandonai: ero sfinita. Sfinita.
Quando mi riportarono in camera non ricevetti le ovazioni della volta precedente. Niente fiori anello e dichiarazioni d'amore.
Ma perché??
Qual'era la differenza? Non capii.. ero triste vedendo che quel bambino, quella creatura che aveva gli stessi diritti della sorellina non venisse accolto con il medesimo entusiasmo..
Stetti male nei giorni successivi: l'addome mi diventò tutto blu e pesto, mi faceva un male cane. Le gocce per le contrazioni per ripulire l'utero mi provocavano dolori fortissimi, avrei potuto partorire non so quanti figli con parto normale, con quelle doglie; inoltre la ferita non ci stava affatto chiudendo per colpa del fatto che il taglio era stato eseguito su quello precedente e quindi il tessuto era cicatriziale e non rispondeva in modo normale alla richiesta di produrre le nuove cellule per riparare la ferita. Dopo qualche giorno ancora non si parlava di tornare a casa.
Io ero in grande pena per la mia piccola Betta che diceva cose strane: raccontava alla nonna, alla zia ed alla giovane che avevamo assunto per prendersi cura di lei per non gravare troppo sulle spalle dei miei suoceri, di avere due mamme.
La bimba aveva tredici mesi, non camminava ancora ma parlava benissimo, così bene che era meraviglioso ascoltarla. Me la portarono spesso in ospedale, perché mi cercava e chiedeva di me insistentemente: io le avevo parlato a lungo del fratellino che sarebbe arrivato, le avevo raccontato quanto saremmo state felici a giocare con lui e lei volle subito vederlo. Lo guardò, quella prima volta che glielo mostrarono, con uno sguardo d'amore che mi commosse. Così, quando arrivava all'orario di visita, volava tra le mie braccia e si rifugiava con il suo visino contro l'incavo della mia spalla, facendosi accogliere e coccolare per un bel po', poi, quando portavano il suo fratellino per la poppata, lei lo guardava mangiare, seduta sul letto accanto a me e gli sorrideva contenta. Lele era così bellino, io sono certa che a lei sembrasse il suo bambolotto che era per incanto divenuto vivo. E gli parlavamo insieme ma lei mi diceva che io ero la sua mamma ' americana ' e che la sua mamma vera era a casa.
Che strano discorso.
Mi ci volle un po' per capire questi suoi ragionamenti e che cioè lei pensasse che la sua mamma fosse a casa e che quella che si recava a trovare fosse come un clone. Di certo la parola ' americana ' aveva il significato di qualcosa di fantastico e mirabolante ma non reale.
Ebbi paura di traumi, per lei ma io stavo male, non potevo firmare e tornare a casa: ci avevo pensato ma davvero non era qualcosa di assennato da fare, anche perché durante l'operazione di taglio cesareo avevo chiesto che mi venissero recise le tube, per evitare un'altra gravidanza che assolutamente non avrei potuto superare viva.
Anche quella era stata una decisione difficile e dolorosa, perché sentivo dentro di me che rinunciavo per sempre a qualcosa di meraviglioso: il diventare madre e cioè essere donna nell'eccellenza di quel dolce nome. Ma davvero restare incinta un'altra volta sarebbe stato con una eccessiva probabilità fatale, per me. E non era la paura di perdere la vita che mi spaventava ma il dolore di lasciare i miei tre figli soli, senza la loro mamma, come cuccioli abbandonati. Così firmai e chiesi l'intervento risolutivo perché anche il legare le tube aveva a volte generato strane sorprese. Quindi avevo subito due interventi in uno e stavo davvero in una situazione delicata, appesantita anche da una montata lattea con febbre alta e dolore diffuso, esattamente come mi era successo per Betta. Evidentemente il mio corpo si ribellava al dover eliminare quel latte che riteneva, in totale accordo con me, assolutamente prezioso.
Dopo dieci giorni, quando finalmente il tutto cominciò a rischiararsi, il mio bimbo smise di mangiare. Me lo portavano dalla nurse che dormiva, io gli mettevo il biberon in bocca ma nulla, non succhiava più, mentre i primi giorni era avido. Era sceso persino di trecento grammi di peso, che per lui erano una quantità notevolissima. Io cercavo di scuoterlo, di dargli dolci colpetti di fargli il solletico, ma lui dormiva, ammantato da un torpore dal quale sembrava non volesse riemergere.
Trascorsero così tre giorni. Gli fecero flebo ma non si vide mutare nulla: il mio Lele, dormiva, dormiva e dormiva, di certo il cucciolo più quieto di quella nidiata di fagottini che mettevano su di un carrello, tutti in fila, per portarli alle loro mamme e poi ritornarli nelle loro culle. Era così buffo vedere quella sfilata di ometti e donnine, ognuno già così diverso, con il suo carattere e la sua peculiarità: ciuffoni di capelli scuri scuri, testoline pelate, qualcuno gridava giorno e notte; di certo il mio bimbo era il meno difficile da trattare....
Mi dissero che se non avesse ripreso a mangiare, il giorno dopo lo avrebbero messo nella incubatrice.
Allora, quella sera, io gli parlai.
Gli raccontai della sua sorellina che ci aspettava, dei cani, del verde dei campi, delle partite a pallone che avremmo fatto insieme, io e lui. Della sua bici.. dei giocattoli. Delle gite, del mare delle montagne. Gli chiesi, per favore, di destarsi dal suo letargo, di mangiare, almeno un pochino. Lui dormiva. Gli aprii la bocca forzando lievemente sul mento e gli misi la tettarella in bocca. Cercai di fargli scendere qualche goccio di latte caldo.
E lui mi ascoltò, come all'improvviso mosse la piccola delicata boccuccia, quasi da femmina, così simile alla mia, che ora, che è un bellissimo giovanotto, gli da un fascino da sciupa femmine.... allora succhiò e bevve qualche grammo di latte.
Io piansi di gioia.
Si rimise in fretta, cominciò a mangiare regolarmente e crebbe di qualche grammo: dopo un mese di ricovero finalmente tornai a casa.
Avevo due bambolotti tutti per me.
Angela aveva deciso di rimanere a vivere con il padre: dato il protrarsi del mio ricovero mi chiese, un giorno che mi venne a trovare, se mi sarei offesa ad una eventualità del genere. Io le avevo promesso, quando mi separai da suo padre, che le avrei lasciato sempre la libertà di scegliere dove vivere, il tempo da dedicare ai suoi due genitori. E quindi non le dissi quanto male mi fece quella sua proposta. Ma la capii. Con Antonio assolutamente non andava d'accordio, c'era un sordo e muto astio, tra i due, inoltre tutti quei bebè volevano dire vedermi presa in tutto e per tutto attorno a loro mentre lei, in quel momento, aveva la nuova donna del padre, Rosella, che le prestava un sacco di attenzioni, coinvolgendola nei suoi progetti artistici e portandola con sé ovunque, per negozi, per musei.. decisamente meglio di quella mamma troppo mamma.
Suo padre, inoltre, mi aveva chiesto il divorzio annunciandomi che si sarebbero sposati il prima possibile e la sua nuova ' mamma ' sarebbe andata a vivere con loro, in quella che era stata le ' mia ' casa.
Quanto mi sembrò strano, tutto quello: vedere Carlo che mi portava a casa libri, fumetti, le centinaia di foto che aveva scattato a noi e a tutti i nostri animali, le tendine all'uncinetto, altra biancheria della casa, i poster, i soprammobili in legno grezzo e quelli acquistati a Londra, anche il servizio da tea di Sheffield, persino le sue amatissime caricature eseguite da un suo amico molto famoso e ricercato e la serie dei quadretti inglesi con gli uccellini.... vederlo arrivare ogni giorno carico di cartoni e buste, così, senza guardarmi in faccia, come se adesso fosse lui, il ladro. Sapere che gettava via i mobili, persino quella cucina così bella e pure costosa, di legno di ciliegio e la sala di legno di castagno, rustica, fatta a mano, il davano a fiorellini azzurri, la pelle do mucca che avevamo comprato agli inizi del nostro matrimonio, che era il nostro bellissimo tappeto e che lui aveva sbattuto così tante volte dalle finestrine di quella grande casa di mattoni... immaginarlo che smontava il nostro armadio, il letto, bruciando tutto, senza neppure dirmi nulla.
Mi sentii violare, rifiutare ma pensai che di certo Rosella non voleva vivere in quello che era diventato un tempio ed aveva tutti i diritti di buttare a terra le effigia della divinità che spodestava. Eppure mi fece male lo stesso come mi fece male dire di si alla mia bambina - che bambina non era ormai più -, che sottolineava quanto io non contassi più nulla: ma ben vedevo che vivere con noi, in quella strana famiglia esplosa in un paio di anni, per lei era una sofferenza.
Però, per fortuna, Carlo nel frattempo aveva cambiato lavoro e per uno strano gioco del destino aveva il suo nuovo ufficio ad un chilometro dalla mia nuova casa. Così Angela non dovette cambiare scuola, già frequentava le medie, che già aveva fatto troppi travasi in pochissimi anni. Anzi, alla fine dell'orario scolastico, veniva a casa da me per il pranzo e per fare i compiti, trascorrendo ogni pomeriggio con me ed aspettando il padre che la veniva a prendere alle diciassette, all'ora di rincasare.
In quel modo il distacco non fu così terribile.
Ma lei, la mia ragazzina, che allora aveva dodici anni, era sempre più aspra con me. Aveva cominciato ad ingrassare dopo che, finalmente, tornato l'elettroencefalogramma normale, le furono sospese quelle malefiche compressine di Luminale e da una bambina iper attiva divenne una statua di piombo perennemente davanti alla tv, mangiando tantissimo e continuando ad essere ribelle in tutto: non studiava, non ascoltava, era sgarbata con me e con i piccoli, e con l'uomo che avevo accanto erano sguardi di nero rancore reciproco: certo Antonio ci aveva provato ad essere gentile con lei ma non ci era mai riuscito.
Davvero con il padre lei stava meglio e così accettai quel parziale distacco e mi concentrai sui due germogli che avevo generato: lei mi aveva rifiutato dalla nascita.
Io mi ero chiesta migliaia di volte cosa avessi fatto per scatenare tutto ciò ma non lo avevo mai capito. Lei era stata sempre troppo terribile, troppo vivace e ribelle, sempre troppo ammalata o incidentata.
E non ho parlato delle botte che dava a tutti i compagni di scuola.. non ho parlato di troppe cose.. di tante.. ma impossibile narrare tutto.
Angela era sempre stata molto intelligente ma rifiutava di comportarsi in un modo intelligente, almeno con me ed a scuola, non accettando nessuna gerarchia né imposizione: fu così difficile crescerla.
Invece i miei due piccoli erano dolci e tranquilli.
Il maschietto per i primi mesi ebbe il sonno spesso disturbato perché soffriva di coliche gassose e quindi gli faceva male il pancino, che si gonfiava come un barilotto. Allora io lo giravo per cambiarlo di posizione, lo massaggiavo, gli facevo emettere aria, lo ninnavo, gli cantavo la sua canzone preferita, - ' La bella la va al fosso – e lui si riaddormentava.
La piccola Betta era buonissima e deliziosa, sempre sorridente ed affettuosa, non piangeva mai: dove la mettevo, lei stava.
Dopo i primissimi mesi divennero come due gemellini: vivace e precoce lui, nei movimenti e nel mettere i denti, tranquilla e lenta lei, - camminò a diciotto mesi ed il primo dentino lo mise dopo la nascita del fratello. -
Così si trovarono presto a pari passo. Però nel parlare lei lo sopravanzava di gran lunga: lui solo verso i tre anni cominciò ad esprimersi in modo più articolato.
Lele piangeva parecchio Certo le coliche gli avevano indotto l'abitudine di esprimersi così e ci vollero diversi anni prima che cambiasse quel suo modo di affrontare le piccole – grandi difficoltà quotidiane. Era molto vivace, anche se meno della sorella maggiore ma abbastanza obbediente, almeno nei sui primi anni di vita. Era poi allegro e molto affettuoso: erano entrambi così tanto affettuosi.
Mi adoravano ed io adoravo loro.
Cantavamo le nostre canzoncine, giocavamo al leone ed al cavallo e loro sul lettone mi strapazzavano in tutti i modi, a cavalcioni della mia schiena.
Ogni giorno ci perdevamo in lunghe passeggiate per i campi e le stradine di quelle campagne a raccogliere fiorellini. Era bellissimo essere la loro mammina.
Mettevo Betta nel passeggino e Lele mi trotterellava accanto, sempre incuriosito da qualcosa: li portavo ovunque, dove io ero, loro erano e la gente di quel paesino ci vedeva passare ogni giorno per andare alla latteria o a comprare il pane e ci fermava, colpita dalla bellezza delle mie due creature.
Entrambi avevano i capelli tagliati alla paggetto, lunghi fino alle spalle, lei così castana intensa, quasi d'ebano, lui biondo cenere, con queste fattezze così fini che tutti si chinavano esclamando:” Che due belle bambine!! “ Lele si adombrava a quelle parole, perché sapeva e sentiva di essere orgogliosamente un maschietto e ben presto ci chiese di tagliargli i capelli. A me dispiacque tanto!!!! Erano così belli, così dorati ma capii lo stato d'animo del mio bimbo e lo portai dal barbiere del paesino che, dopo averlo messo seduto sul sedile a forma di cavallo ideato per far stare più tranquilli i bambini, gli fece un taglio corto corto, salvando solo un lungo ciuffo posteriore, un codino alla moda del famoso calciatore, che Lele fu orgoglioso di portare fino alla sua adolescenza. E da quel giorno nessuno più gli disse di essere una bambina....
Ma quelle gioie erano interrotte da tanti tanti problemi.
Si vide subito che il denaro non sarebbe bastato, con un bimbo in più. Ma il mio compagno non mantenne mai la promessa che mi aveva fatto.
Quando il maschietto ebbe otto mesi mi chiese bruscamente se io non avessi intenzione di lavorare mai più, se avessi voluto farmi mantenere da lui.
Ci rimasi così male che reagii con rabbia. Io farmi mantenere?? Ma mai al mondo.
Dopo una settimana lavoravo già.
Iscrissi i bimbi al nido e cominciai a vendere i libri per la Mondadori, porta a porta. Feci un corso serale e presi l'iscrizione all'albo degli agenti e dei rappresentanti.
Fu una campo di battaglia assai duro ma importante per iniziare il lavoro della vendita e mi arricchì di esperienze molteplici: i libri si vendevano, io ero portata, si vide subito e chiudevo i contratti da sola ma era dura anche perché mi sentivo di essere una invadenza, nella vita delle famiglie, che venivano contattate in un modo un po' subdolo, consegnando ai bambini all'uscita della scuola elementare una cartolina che prometteva loro un bellissimo regalo se avessero accettato di rispondere ad un questionario. E il regalo c'era e piaceva ai bambini, come c'era il questionario che però era un pro forma per accedere con le domande alle informazioni basilari di quella famiglia e dare a noi venditori lo spunto per inserire e proporre l'acquisto di una delle opere librarie. Era anche il momento in cui si regalava un computer con l'acquisto di una enciclopedia per ragazzi ma in effetti, io lo sapevo benissimo, che il pc veniva più che pagato.
I libri erano importantissimi nella vita di ogni bambino, io ne ero convinta e in quei paesini di campagna, in quelle case di piccoli contadini di certo non erano il pane quotidiano: sapevo perciò che non stavo truffando a facendo del male a nessuno ma avrei preferito una maggiore trasparenza. Il fatto era che, diversamente, nessuno avrebbe acquistato mai neppure un volume.
Accadde allora che un giorno in una famiglia in cui mi ero recata per un appuntamento, - portavo a termine quattro o cinque visite al giorno, - invece di acquistare i libri, colpiti dal mio entusiasmo, dal mio modo di fare e dalla mia abilità, comprarono me, proponendomi un lavoro di rappresentanza per la loro ditta di generi alimentari. Accettai.
Mi affidarono una zona già avviata, con diversi esercizi che acquistavano regolarmente la merce del nostro catalogo, quindi un minimo di fatturato già consolidato, sola da incentivare.
Iniziai subito con immensa carica, aumentando con grande facilità sia il numero dei punti vendita che il fatturato: nel giro di tre mesi divenni la seconda venditrice in un gruppo di sei, seconda solo, anche se con distacco, al genio di turno, all'affascinante Giuliano.
Purtroppo i bimbi si ammalarono diverse volte e non fu proprio possibile mandarli al nido.
Cominciava Lele con il mal di gola, la tonsillite ed il febbrone e poi ecco che arrivava Betta con l'otite e la febbre alta, lei pure: non si poteva farli andare avanti ad antibiotici una settimana si ed una no.
Non avevo un'altra possibilità per continuare a lavorare e smettere era impossibile. Allora assunsi a tempo pieno una tata, una donna giovane e bravissima che li seguì fino a quando restammo nel ravennate, nel 1996.
Io lavoravo come una matta, fuori di casa alle sette del mattino, percorrendo anche duecento chilometri al giorno. Comprai un'auto più comoda, adatta al mio nuovo incarico, una bella Renault Nove grigia metallizzata, usata ma messa benissimo.
Il fatturato cresceva a vista d'occhio, i negozianti mi volevano un gran bene: ero puntuale e cortese, simpatica, ricordavo tutto; davo tutti gli sconti possibili, il catalogo era ottimo.
Triplicai in pochi mesi … mi piaceva da morire girare per i paesini della Romagna vendendo le mie buone cose da mangiare: era come fossi la vivandiera di una grande famiglia.
Mi mancavano tanto i miei bimbi ma quando ero a casa, tutto il mio tempo era per loro, dato che la tata faceva anche tutte le faccende: restavano solo l'onere delle spese e del rifornimento del cibo ed io mi organizzavo in modo tale che fosse sempre tutto a posto e potermi dedicare il più possibile ai due bimbi: i loro sorrisi, al mio ritorno, le loro vocette, i giochi i bacetti.. erano un sogno.
Non così andavano le cose con lui, con Antonio.
Era sempre più ombroso e torvo e beveva. Non si ubriacava, no, reggeva l'alcol in modo stupefacente, ma la bottiglia del vino e le vodke al bar erano giornaliere. Fra noi era sceso un gelo grande, non mi cercava più. Tra un rapporto e l'altro passavano mesi.
Io soffrivo intensamente di questo. A letto mi avvicinavo a lui, cercavo di abbracciarlo ma lui rimaneva indifferente. Oppure mi respingeva accusandomi di cercare solo sesso, da lui. Così offesa da quello, cominciai a dirgli davvero che il suo pene era la sua parte migliore.. tanto mi faceva soffrire ed arrabbiare la sua freddezza.
Ero un po' ingrassata, va bene ma ero ancora assai bella... eppure sembrava che Antonio non mi vedesse più.
Sul lavoro. un collega mi fece la corte, quel bel ragazzo, campione di tutto: cedetti alle sue lusinghe, un pomeriggio, dopo un pranzo di lavoro con tutta la ditta. Era un bellissimo uomo, così dolce ed ardente mi fece complimenti, mi lusingò, io non ressi e tradii per la prima volta il mio compagno, da quando, dopo essere rimasta incinta la prima volta, avevo chiuso con tutti gli altri miei 'amici ', perché quando il mio uomo prese un impegno con me, io lo presi con lui.
Ma la sua freddezza mi feriva, mi umiliava. Non era il sesso, solo il sesso. Era essere donna. Essere amata.
Così lo tradii ma fu una cosa di un pomeriggio: non volevo assolutamente avere un amante. Amavo il mio compagno, volevo lui.
Scossa da quanto accaduto cercai di capire cosa gli stesse succedendo, cercai di parlargli di farmi spiegare cose ci fosse che non andava ma non ottenni risposta.
Le uniche che mi diede in quei lunghi anni di tormenti furono: l” Io lavoro, non rubo non ammazzo. Cosa vuoi di più da me?”
Il nostro rapporto prese uno strano andamento: lui si raffreddava sempre di più, si allontanava. Più un bacio, una carezza, assolutamente nessun amplesso. Passavano i giorni. Era sempre più duro e collerico, instabile. Lo temevo. Non sapevo mai come comportarmi, sbottava per un nonnulla. Non facevo non dicevo mai bene. Era come un crescendo rossiniano.
Poi, una notte mi cercava.
Io, ferita, lo respingevo. Allora lui piangeva, chiedeva il mio perdono, mi diceva che erano problemi sul lavoro, che mi amava e finiva che ci amavamo con la nostra consueta passione, Io, ogni volta credevo che la crisi fosse risolta.. stava sereno qualche giorno poi, tutto ricominciava. E il periodo tra un rapporto d'amore ed il seguente andò sempre allungandosi. D settimane a mesi.. due tre... io ingrassavo. Mangiavo, soffrivo piangevo
A volte mi svegliava di notte mentre era addormentato: era come se i nostri due corpi, staccate le menti nel sonno, si riallacciassero nell'amore. Ma anche queste notti si diradarono fino a sparire definitivamente, nel corso degli anni.
E più gli chiedevo spiegazioni, meno me ne dava.
Un brutto giorno litigai con il proprietario della ditta di alimentari. Fu una brutta storia: si scoprì che lui era il nemico giurato di giovinezza del mio compagno.
Io non lo sapevo né Antonio mi spiegò mai cosa ci fu con precisione fra di loro. Ma l'odio tra i due era folle.
Successe così: il mio datore di lavoro organizzò un tranello e mi scoprì mentre ritiravo, rimborsando di tasca mia, della merce che era stata venduta con il patto del ritiro sullo scaduto. Il negoziante, d'accordo con il mio capo, parlando, mi portò a dire che il mio superiore aveva sbagliato a quelle parole lui saltò fuori. Era nascosto dietro una scaffalatura.
Uscì gridando urlando bestemmiando che lui era il capo ed io dovevo fare solo quello che lui mi comandava. Io gli mollai la borsa con il catalogo in mezzo al negozio e me ne scappai piangendo.
A casa, quando raccontai al mio uomo l'accaduto, presi altre grida urla e bestemmie.
Mi licenziai. Dopo una settimana il mio collega, quello con cui avevo avuto quella storia, venne a portarmi le scuse del titolare e a chiedermi di tornare con loro ma per rispetto ad Antonio rifiutai.
Allora una mia amica mi propose una affare. Il cognato era morto improvvisamente, investito da un auto mentre era in bicicletta.
Quel povero giovane uomo, caro e simpatico che io pure avevo conosciuto, aveva inventato un brevetto; era un macchinario che stampava piccoli pezzi di teflon per le barche, un prodotto innovativo e molto interessante. Per dodici milioni mi avrebbe venduto macchinario, brevetto, un po' di materia prima e la clientela esistente.
Mi sembrò un affare, una cosa bellissima. Avremmo potuto mettere il macchinario nel garage e lavorare in casa, senza dover lasciare i bimbi con la tata e risparmiando il suo salario che era di seicentomila lire al mese.
Vedevo un grande avvenire per quella tecnologia. Studiai un po' la cosa e immaginai altre possibilità: facendo fare altri stampi si sarebbero potute forgiare altre parti per altre necessità: il teflon era un materiale assolutamente futuribile, secondo me.
Ma non ci fu nulla da fare.
Sebbene avessi trovato facilmente il prestito presso la mia banca, senza ipoteche od altro, solo con una piccola rata di rientro, Antonio non ne volle sapere.
Discutemmo a lungo: o gli dicevo che lui avrebbe potuto aiutarmi in quanto aveva molto tempo libero: usciva alle sedici dal lavoro, anche se prima delle diciotto diciotto e trenta non era mai a casa. Aveva i sabati e le domeniche in festivi liberi, più di un mese di ferie l'anno.
Ma fu irremovibile.
E come avrei potuto fare quello contro la sua volontà??Mi arresi dopo giorni e giorni di di aspre discussioni.
E feci assai male.
La persona che acquistò quel brevetto si arricchì in fretta, lo seppi con certezza.
Era l'inizio dell'estate del 1987.
Nel paesino dove vivevamo c'era una piccola ditta di ingrosso di bevande che serviva bar ristoranti stabilimenti balneari: d'estate la mole del lavoro cresceva a dismisura. Il proprietario seppe della mia bravura e mi propose di prendermi cura del settore balneare. Accettai con gioia.
Il denaro scarseggiava, senza un secondo stipendio davvero non si poteva tirare avanti. Ero stata ferma solo tre settimane ma ero assai preoccupata e così cominciai subito quella nuova avventura.
Alle sei del mattino ero già in macchina, fino alle nove di sera.
I punti da visitare erano moltissimi ogni giorno, la cadenza delle visite frenetica, perché nessuno aveva la possibilità di stivare troppe scorte e la birra l'acqua il vino le coca cola scorrevano a fiumi.
In quegli anni la gente aveva soldi da spendere, le spiagge erano gremite, i tavolini dei bar e dei ristoranti sempre pieni.
Lavoravo e lavoravo, vendevo e vendevo. Faceva un caldo pazzesco, in macchina con il tailleur e le scarpe chiuse ma ero contenta, molto: guadagnai assai bene in quella estate.
Però – ed è ovvio che c'è un però... - mi stancai moltissimo, troppo.
Alla fine di agosto, una mattina, il braccio destro cominciò a formicolare. Si gonfiò la mano. Risalì lungo la spalla, il collo la guancia.
Spaventata mi recai nell'ambulatorio del mio medico che era lì vicino: lui mi spedì di corsa con un'ambulanza al pronto soccorso e mi ricoverarono in neurologia.
Non si capì mai bene cosa fu. I sintomi persistettero per settimane. Feci un mese di ricovero, poi mi dimisero praticamente senza una diagnosi ma io ero disperata per i miei bimbi e volli tornare a casa.
Imparai a sopportare quel fastidiosissimo stato e a conviverci. Una successiva visita da un luminare di Bologna a cui portai tutti i miei esami e trecentomila lire, rivelò che forse avevo avuto una infezione virale spinale. Il grande scienziato mi disse che se si fossero aggravati i sintomi, avrei dovuto recarmi da lui che mi avrebbe ricoverato nella sua clinica e fatto accertamenti più approfonditi, come la puntura lombare con esame del midollo. Intascò il mio denaro e mi congedò.
Ma le cose, in casa, nonostante il mio evidente malessere, peggiorarono.
Il mio compagno era geloso del mio titolare.
Non ho mai capito veramente cosa avesse contro di lui. Fra noi non ci fu mai davvero nulla, neppure l'intenzione. Era un ometto piccolo piccolo, sfortunato, un po' strano. Io però mi ci ero affezionata, lui era molto gentile con me, forse galante ma senza intenzioni, almeno a mio vedere.
Per Antonio lui era come il fumo negli occhi.
E poi, alla fine dell'estate il lavoro crollò di botto.
Cercai di recuperare un po' di fatturato andando a vendere del vino a nuovi ristoranti. E, per vendere, vendevo ma di certo la mole del movimento estivo era assai lontana.
Il mio titolare mi suggerì di aprire io stessa un bar.
Avevo già l'iscrizione al REC, dovevo solo far aggiungere la somministrazione di alimenti e bevande, con un esame integrativo.
C'era un baretto in una via centrale di Ravenna, ma un po' defilata. Era assai piccolo ma lavorava abbastanza. Era giusto per una persona sola, come ero io.
Mi piacque così tanto, quando lo vidi, me ne innamorai a prima vista, come egli non stesse attendendo altri che me e si mettesse a scodinzolare felice, nel vedermi entrare per la prima volta dal suo portone di vetro con l'infisso di metallo nero satinato. Ne chiedevano settanta milioni, da pagarsi in due rate a distanza di dodici mesi l'una dall'altra.
Ne parlai con il mio compagno, lui non ne fu entusiasta ma io, quella volta, non mollai e lo comprai.
Ma altre novità grosse accaddero in quel 1988.
Il mio ex marito, che si era risposato, un giorno comparve con la macchina piena delle cose di nostra figlia. Mi disse, lì, in piedi sull'orlo del fosso, con il portellone aperto mentre scaricava tutto, che io avevo goduto abbastanza della libertà, che adesso era il suo turno, che la sua nuova moglie gli aveva posto un aut aut: o la figlia o lei.
E lui aveva scelto la moglie.
Mi disse che aveva diritto di un po' di felicità. Scaricò le cose e senza dare altre spiegazioni alla sua ' amata 'figliola, che ovviamente non aveva ascoltato quel terribile discorso, se ne andò e scomparve dalla sua vita.
A quel punto la casa era diventata davvero piccolissima. Non era più pensabile continuare a vivere lì, con i tre bambini, in due stanze più una cameretta di due metri ed un bagnetto nel quale chiudevi la porta senza alzarti dal wc.
Seppi che in paese era in vendita da tempo una grande casa: aveva solo quattrocento metri di giardino ma era grandissima. S
Disposta su due piani, quattro camere di sotto, quattro di sopra, un capannone trasversale con camino e sopra a quello un lunghissimo mansardato grezzo. C'era anche un capannetto in muratura nel giardino: i vecchi proprietari vi avevano venduto i fiori e quella era la stanza coibentata e refrigerata.
L'andai a vedere e mi piacque. Nella grandi stanze vuote sentii già le voci dei miei figli, vidi i loro giocattoli per terra, sentii che era il posto nostro.
Tornai a casa e dissi al mio compagno che l'avrei acquistata.
Ormai ero troppo arrabbiata con lui.
Le sue scelte si erano rivelate sbagliate, scelte fatte con il mio denaro.
Il peso della famiglia era tutto sulle mie spalle. I bambini col padre non dicevano mai nulla, ero io quella che doveva sempre risolvere i loro piccoli problemi. Tornavo a casa dal lavoro e loro mi raccontavano quello e quell'altro: avevano fatto una cosa, avevano male lì, c'era bisogno di comprare o andare là.. Betta aveva cominciato a frequentare la scuola materna.
Ma al padre non chiedevano mai nulla.
Lui, tornato dal lavoro due ore dopo aver staccato e congedata la tata, sedeva al tavolo della cucina, leggeva il giornale e loro giocavano, in silenzio. Solo al mio ritorno ed a me rivolgevano i loro piccoli grandi quesiti.
Ed io avevo già da tempo cominciato a pensare che quell'uomo non era poi così fantastico come mi era sembrato.
Inoltre mia madre stava male ed aveva bisogno di essere accudita: nella grande casa c'ara posto anche per lei.
Nel giro di tre mesi vendetti la casetta rosa a cinquanta milioni, comprai quella più grande, che era giallo ocra, per settantacinque.
Il bar per settanta, pagando i primi trentacinque in contanti.
La grande casa aveva bisogno di diversi lavori per diventare comoda come dicevo io.
Gli impianti di riscaldamento ed elettrici, i pavimenti, gli infissi, i due bagni, la recinzione.. accesi un mutuo di ristrutturazione prima casa di quaranta milioni da pagare in rate mensili di trecentomila lire. E, naturalmente, tutto a mio nome, assolutamente tutto a gravare sulla proprietà mia di quella casa.
Facemmo diverse cose da soli: Antonio era bravo a fare quasi tutto, lavorammo come matti anche se era sempre più iroso e mi strapazzava come fossi il più scemo dei garzoni... lavorare con lui era un incubo: bestemmiava, gridava, gettava oggetti per terra, non finiva mai un lavoro del tutto, restava sempre una vite che mancava, una placchetta da montare o vattelappesca non so cosa.. lasciava la sua strumentazione in casa ovunque, le scarpe, i vestiti, era disordinato.... se faceva qualcosa, tipo imbottigliare il vino, cucinare la carne nel camino, per la cena, sporcava tutto il piano terra, che aveva il pavimento a grandi piastrelle bianche e grigie, con gli stivali a carrarmato bagnati, infangati... la nostra tata lasciava tutto immacolato ma dopo dieci minuti sembrava che nessuno avesse pulito quella casa da anni.
A settembre 1988 vi andammo ad abitare.
Il bar aveva aperto da un paio di mesi.
Mi alzavo alle cinque del mattino, quindici chilometri di macchina con tutti i tempi, nebbie intense e ghiaccio compresi.
Alle sei ero operativa: panini sandwich tartine paste cotte da me, oltre quelle del pasticciere.
Avevo fatto un ottimo lavoro in quella bomboniera: messa carta da parati azzurra così carina, tovaglie nuove, due videogiochi: l menù dei panini caldi era allettante. Usavo solo prodotti freschissimi e della migliore qualità: il latte fresco intero della centrale cooperativa, il migliore caffè.
I miei cappuccini si presentavano con una soffice densa schiuma: avevo imparato in un attimo tutto.
Comprai tutto un assortimento di ' caramelle di plastica ', come le chiamavo io, che stavano spopolando fra bimbi e ragazzetti: lì vicino c'erano tre scuole.
Nelle primissime ore del mattino si entrava a stento, tanta era la ressa.
Io diventai velocissima: facevo tutto da sola, anche la cassa, naturalmente.
La clientela crebbe in modo notevole, all'ora di pranzo i miei panini gustosi, grandi e a buon mercato attirarono diverse persone ed ero molto soddisfatta.
Solo che il locale, purtroppo, era davvero piccolo: due tavolini accanto al bancone e quattro in un soppalco rialzato, a fianco, quindi più di tanto non si poteva lavorare.
E poi, avevo solo due mani.
Il pomeriggio era più tranquillo, allora approfittavo per ripulire tutto, fare gli acquisti. Incrementai gli aperitivi serali inventandomi nuovi pastrocchi colorati da servire con canapè e salatini: nel corso serale che avevo frequentato prima di aprire il bar ce ne avevano insegnato, di cose......
Chiudevo alle venti e trenta, lasciando tutto pulito e pronto per l'indomani.
Il giorno di chiusura era la domenica.
E poi correvo a casa, dai miei figli, che mi accoglievano festanti, almeno i due più piccoli.
Nella nuova abitazione si viveva magnificamente.
A lui non piaceva, diceva che c'era poco spazio intorno, poco giardino.
Ma a cosa erano serviti quei tremila metri di terraccia se non a spendere soldi per tenere l'erba più bassa di una giungla??
provai un anno a piantarvi dei fagiolini, ma non recuperammo neppure le spese.
La mia amica, l'ex socia, mi disse più volte che avrei dovuto acquistare qualche cagnolina di razza e vendere i cuccioli. In quei casotti, che erano rimasti inutilizzati ed abbandonati ricettacoli di polvere, si potevano ricavare dei comodi caniletti. Ma Antonio, al solito, non volle: non voleva gente per casa, telefonate, affari.. nulla di tutto quello che girava intorno al mondo dei cani gli piaceva.
Allora tutto si era risolto nel vivere tre anni in due stanze, senza nessuna comodità per i due bebè ma soprattutto per me.
La nuova casa era perciò per me un sogno.
Mia madre si trasferì da noi ed apportò ulteriori tensioni.
Litigava con la nipote maggiore, era dispotica con i due più piccoli, sempre in contrasto con il mio uomo.
Ma stava molto male. Fu operata alla schiena poi al fegato: era necessario sopportarla. Inoltre lei ci aiutava economicamente. Ci aveva dato quindici milioni per sistemare la casa e farle camera e bagno a sua necessità e ogni mese contribuiva con una cifra che non era piccola.... non la ricordo. Credo trecento mila lire ma non ne sono sicura.
Il caro vita aumentava, i prezzi salivano vertiginosamente, la famiglia di sei persone era assai dispendiosa.
Poi c'era la tata; io ero fuori casa tutto il giorno, era assolutamente impensabile fare senza di lei.
La tensione in casa crebbe a dismisura. Il mio compagno era sempre più agitato nervoso scontroso ed irascibile.
Finalmente anche Lele andò alla scuola materna.
I due bimbi crescevano bene: lui era più vivace e birbante, anzi, molto di più, lei era una donnina e gli faceva da mamma. Il piccolo si arrabbiava molto, per quello, dicendole che di mamma gliene bastava una ma la sorellina non mollava: gli faceva persino il letto.
Li avevamo sistemati in due grandi camere contigue ma loro vollero unire i lettini, che si potevano trasformare a castello e dormire insieme: Lele sopra e Betta sotto.
Erano inseparabili: li sentivo chiacchierare tra loro mentre si addormentavano, dopo che li avevo messi a letto.
Quanti salti su e giù da quei due lettini rossi ed azzurri!! E una volta poi, Lele, sognando di fare un tuffo in mare, come facevamo sempre, che io andavo sott'acqua, lui mi saliva con i pedi sulle spalle, tenendosi alle mie mani tese verso di lui ed io mi alzavo di scatto, catapultandolo in alto in alto e facendogli fare tonfi incredibili, si buttò di sotto e diede una botta notevole, piangendo disperato per almeno mezz'ora ma, per fortuna senza altre conseguenze.
Quel fatto, però, restò negli annali e loro se lo raccontavano sempre...
La vedo ancora, quella grande camera dal pavimento di mattoni vecchi che avevamo fatto levigare e le due grandi finestre ampie, con le tendine bianche ed azzurre, che davano sui campi, al di là della strada e la casa colonica sulla destra con l'immenso platano frusciante al vento.
E sento le loro voci, i loro discorsi, rivedo i loro pigiamini, i colori delle magliette preferite.
Quando tornavo dal lavoro, loro avevano già mangiato. Dopo aver giocato e parlato un po' li portavo di sopra e gli facevo il bagnetto, entrambi insieme dentro la capiente vasca da bagno piena di acqua calda schiuma e barchette che avevo fatto installare nella nuova stanza da bagno del piano superiore.... come ho amato quella stanza!! Dopo tanti disagi in quel bagnetto, questo era grandissimo e lo avevo fatto rivestire di piastrelle grige chiare a scure col il piano di marmo rosa del lavabo... era così bello... c'era anche un ampio box doccia, non mancava davvero nulla. Loro giocavano scherzando, non volevano mai uscire dall'acqua, gridavano cantavano, si facevano dispettucci. Finalmente riuscivo a farli venire fuori, li asciugavo, gli mettevo i pigiamini. Che belli, i loro corpicini sani, dolci guizzanti, che tenere membra, che dolci pelle e labbruzze e bacetti ed occhi stanchi.... e poi si infilavano tra le lenzuola. Io mi trattenevo un po' con loro, raccontavo una favola, cantavo una canzoncina. Stanchissimi, scivolavano presto nel sonno. Io mi recavo in bagno per rimettere tutto a posto e sentivo i loro ultimi discorsi del giorno. A volte Betta finiva di raccontare lei la favola al fratellino.
Altre sere, però se avevano fatto già il bagnetto con la tata, io, finalmente rincasata e stanchissima, dopo aver cenato amavo rilassarmi con un bel bagno caldo, d'inverno, ovviamente,
Allora salivo al piano superiore e loro dietro, tutti. Ma TUTTI dietro......
Abbiamo avuto diversi cani e gatti in quella casa, negli anni, difficile parlarvi di ognuno di loro, ora qui, cercherà di farlo man mano.. ma quelli che c'erano in casa in quel momento, tutti su a fare il bagno con me.
Riempivo la vasca di schiuma e mi ci immergevo: a quel punto Lele cominciava a farmi navigare le sue barchette palline ed altri giochi vari e tanto alla fine si bagnava lui più di me, mentre Betta, seduta sul sanitario di fronte con il coperchio abbassato, rosa come il piano di marmo, chiacchierava chiacchierava e mi raccontava di tutto il suo mondo.. e i cani e i gatti accucciati qui o lì, appollaiati sul lavabo.. a molti piaceva bere l'acqua saponata.... e leccavano le bollicine.... e, almeno due volte, due di loro hanno fatto il bagno con me: Yuki, la piccola terrier giapponese e un gatto, Thor, gattone bianco con i fanaloni gialli di un tir.... c'entrò sempre Lele, ovviamente lui era la pietra dello scandalo, e che risa che grida che acqua dappertutto, da asciugare....
Erano due creature meravigliose. Intelligenti e dolcissime. Così diversi dalla loro sorella maggiore, sempre dura ed anaffettiva. Io mi scioglievo di tenerezza.
Ma era la mia sola dolcezza.
Con il mio uomo le cose andavano sempre peggio.
Con la figlia grande ci fu da passare una grossa crisi.
Dopo che il padre me l'aveva scaricata così brutalmente ed era sparito completamente, se non per qualche breve impacciata telefonata, lei pazientò qualche mese, poi mi fece domande precise: volle sapere cosa fosse successo.
Aveva quasi quindici anni, era ormai una donna: alta più di me, forte, assai robusta, volitiva, di certo non la si poteva trattare come una bambina.
Dopo le scuole medie, finite un po' per il rotto della cuffia, la moglie di suo padre la convinse di iscriversi alle magistrali. Io ero contraria.
Angela era molto intelligente ma assolutamente non aveva voglia di studiare e non tollerava nessuna disciplina.
Infatti frequentò qualche settimana e poi passò il resto dell'anno in giro per la città con i più sbandati che trovò. Divenne punk e dark e si truccava pesantemente con quello stile che io trovavo davvero di dubbio gusto. Ma non mi opposi. Giudicavo che avesse il diritto di seguire un suo stato d'animo; a scuola però ci doveva andare.
E, dato che non lo faceva, la ritirai, per non farla bocciare e la costrinsi a venire ad aiutarmi un po' nel bar.
Ma era una frana. Tutto quello che faceva mi complicava di più la vita. Così le lasciai la libertà. Si mise con un ragazzetto brutto e stupido. Mi chiesi mille volte – e lo chiesi a lei – cosa ci trovasse ma, ricordando i discorsi di mia madre quando io avevo la sua età, accettai anche lui. Passavano dal bar per bere o mangiare.. io davvero non ero felice nel vederli così: mi dava l'impressione che stessero sbagliando tutto.
Quando mi chiese del padre io le dissi la verità: cercai di addolcirla un po' ma non le mentii.
Per lei fu un colpo durissimo. Forse sbagliai ma io ho sempre creduto che la verità non sia mai un errore.
Divenne ancora più riottosa ribelle prepotente aggressiva.
Litigava con tutti, con me la nonna e il mio compagno, per ogni piccola sciocchezza.
Fuggì di casa.
Venne vista per strada con una sua amica. Me lo vennero a dire dei ragazzi che venivano sempre a mangiare i panini da me e che quella mattina mi avevano vista sconvolta e a cui avevo raccontato che la mia ragazza la notte non era rincasata ed io non sapevo dove fosse.
Avevo telefonato al padre, il quale mi disse che non sapeva cosa fare e mi invitò a rivolgermi alla polizia. Io volli attendere qualche ora ancora e feci bene.
Quando mi indicarono dove fosse, chiusi il bar di corsa ed andai a riprenderla, riportai a casa l'amica e cercai di parlare con mia figlia.
Volevo che smettesse di vagabondare così, che decidesse cosa fare del suo futuro. Che si cercasse un ragazzo migliore; anche lui aveva lasciato gli studi e fumava canne. Scoprii che lei pure fumava, dall'età di undici anni, lei che aveva sempre torturato il padre, grandissimo fumatore, perché smettesse.
Mi cascò il cielo sulla testa.
Ma come fare??? Io ero dentro quel bar tutto il giorno..
e cominciai a stare male.
Presi una prima broncopolmonite. Tenni chiuso il bar una settimana. Stetti malissimo. Poi una seconda, più lieve, che curai in piedi lavorando.
Poi cominciarono le coliche. Veramente erano cominciate ancora quando stavamo nella casetta rosa. Tutto ad un tratto mi coglieva un fortissimo dolore allo stomaco, tanto forte da piegarmi le ginocchia e farmi accasciare a terra.
In quei mesi si intensificarono. Feci esami. Si parlò di calcoli alla cistifellea. Feci una gastroscopia.
Risultò una brutta ulcera pilorica con stenosi. In pratica il piloro, immerso nei succhi gastrici ,si era eroso e stringeva l'anello dello sfintere. I boli del cibo non fuoriuscivano, lo stomaco si riempiva di gas ed arrivava la colica.
Mi curarono e i sintomi dell'ulcera migliorarono ma peggiorarono le coliche epatiche. Però,calcoli non se ne vedevano.
Giunse l'estate, mi prese una colica fortissima e mi ricoverarono un'altra volta.
In quei giorni mia figlia maggiore fuggì di nuovo di casa.
Rubò i gioielli di mio padre e mio nonno, anello medaglia al valore, vecchissimo orologio d'oro a catena, anello con topazio e le mie spille e catenine e anellini e braccialettini di battesimo e comunione. Razziò tutto, anche il denaro che trovò in casa, qualche centinaio di mila lire, della nonna e fuggì con la sua vespa ed il suo ragazzo.
Quando il mio compagno me lo disse, io stavo malissimo, in preda da tre giorni a quella colica che non passava con nulla.. Telefonai al mio primo marito ma anche quella volta se ne lavò le mani.
Furono due giorni di assoluta angoscia. Poi la polizia ferroviaria li trovò su di un treno diretto ad Amsterdam.
Li fermarono e li portarono a Milano... di certo io non potevo andare a prenderla. Il padre di mia figlia si negò di nuovo. Allora solo il mio compagno si fece avanti, quella volta si comportò assai bene: prese la macchia ad andò a Milano a recuperare i fuggitivi.
Ma la portò il giorno stesso direttamente dall'auto. Piangente, sporca puzzolente, fumata visibilmente, distrutta. Io l'abbraccia in preda ad un grandissimo dolore. Piangemmo così su quel letto di ospedale. Lei mi raccontò che il suo ragazzo aveva avuto una strana reazione alla pelle, che era stato certo avesse contratto L'AIDS, dato che si bucava, che fosse il morbo di karpof. E quindi era certa l'avesse contratto pure lei. Per quello erano fuggiti. Le chiesi di tornare in sé. Promise. Furono fatti esami che, per fortuna, risultarono negativi: lui aveva solo una crisi di acne.
Mi dimisero senza diagnosi: i calcoli non si vedevano, gli esami erano perfetti, dissero che somatizzavo. Ma io continuai a stare male. Tornai al bar, che questa volta avevo lasciato nelle mani di due mie amiche, pagandole, ovviamente, per non chiuderlo di nuovo.
Ma stavo male.
Però sembrava che mia figlia si fosse calmata. Non usciva più. Disse che aveva lasciato quel ragazzo; invece scoprimmo che usciva di nascosto la notte, scavalcando la finestra.
Mia madre, in tutto quel trambusto, si arrabbiò tantissimo e se ne tornò a vivere accanto a mio fratello.
Mi disse che ero pazza, che la mia vita era una follia. Le chiesi se avesse una ricetta per risolvere tutto con la bacchetta magica. Mi rispose che il problema era mio, che quello era il frutto delle mie scelte.
Io ribadii che quello era il frutto soprattutto di scelte altrui ma di certo io avevo lasciato fare. Le dissi che una buona parte di tutti quegli errori dipendevano dal mio non sapere mai cosa volere. Se facevo di testa mia sbagliavo, se davo retta ad altri sbagliavo. Lei mi disse che non sapeva cosa dirmi che aveva dato la vita per me, che mi aveva aiutato in tutti i modi. che non resisteva più. E se ne andò.
Lasciandomi così anche senza aiuto economico, oltre che senza la sua presenza che comunque si dimostrava preziosa nei momenti di vuoto. In casa lei c'era sempre ed i bambini potevano così non rimanere mai soli, permettendomi di risparmiare qualche ora della tata.
La capii, però. Casa mia era davvero un girone infernale.
Quando scoprii che mia figlia usciva di notte scavalcando la finestra mi arrabbiai tantissimo. Le vietai di vederlo. Montai una guardia armata. La chiusi in casa.
Ma ormai era troppo tardi: dopo pochissimo mi confessò di essere incinta.
Rimasi di sasso.
Ma non la sgridai. Le dissi che potava contare su di me. Che scegliesse in tutta libertà cosa fare. La portai a fare colloqui con una psicologa che disse che la colpa era tutta mia, che la ragazza aveva sofferto troppo sin da neonata e la responsabilità era solo mia.
Mi sentii un mostro.
Pensavo a questo bambino, immaginavo potesse assomigliare al padre, che era quasi anormale, e rabbrividivo. Ma era un bambino, era una creatura, era sacro. Era mio nipote.
Lo amai.
Ma mia figlia decise di non farlo nascere. Con dolore accettai la sua decisione. La portai a fare tutto quanto, cercai di starle vicina ma lei si chiuse in se stessa.
Ed anche si chiuse in casa. Non uscì più. Fino all'autunno del 1989, quando si iscrisse alla prima istituto alberghiero, - cucina - e cominciò a frequentare regolarmente le lezioni.
Io piansi in silenzio per mesi, anni, per tutta la vita quella piccola vita spezzata. Ma mia figlia non voleva avere bambini. Aveva sempre affermato quello sin dai suoi primissimi anni. Non voleva sposarsi né avere figli. Mentre invece i figli vanno desiderati amati. E poi è difficilissimo anche così.
La vita era la sua: aveva diritto di scegliere. Ma io piansi quella piccola vita mai nata.
E, per terminare di parlare di questo, riporto qui un brevissimo passo tratto da ' Io non sono di qui ', in corsivo.
Non ho visto mia figlia piangere per questa perdita, ma sono sicura che dentro di lei questo dolore è ancora vivo e acutissimo.
Io ho pianto per lui, che ho sempre chiamato il mio piccolo Angelo, dato che gli angeli non hanno sesso e corpo, ma sono presenze poetiche e dolcissime. Ho pianto per molti anni…
Da allora ne sono passati quasi venti. Ora sarebbe adulto.
Le cose in casa, però, si acquietarono un po'.

CARISSIMI AMICI
inserisco da oggi, 17 agosto 2017, il tasto per ricevere vostre donazioni...
finora non vi ho mai chiesto nulla..
ho messo qui le mie opere perchè fossero a vostra disposizione e l'ho fatto come scelta politica e personale..
ma la mia vita è diventata durissima...
Mia madre non mi aiuta più in maniera costante ma solo molto saltuariamente.
i miei figli non mi parlano quasi...
il denaro che il mio ex marito mi diede in fase di divorzio, nel 2013, che mi ha permesso di sopravvivere fino ad ora, è terminato...
ricevo mensilmente 800 euro dallo stato ma 500 se ne vanno per l'affitto e le spese di casa..
capite che quel che resta non basta neppure per il cibo mio, per Brugola e per Stellina
Non vi chiedo un ingresso obbligatorio, chi non può o non vuole, continui pura a fruire dei contenuti del mio sito in maniera gratuita...
ma
ora tu, che entri qui per leggere, guardare, ascoltare, puoi aiutare arianna amaducci...
grazie se lo farai..
fare una donazione è molto semplice, clicca sul tasto e segui le istruzioni...
non vi è un tetto minimo... bastano anche 50 centesimi ogni volta che passi di qui...
grazie, sinceramente
pace e luce nel tuo cuore e nella tua vita
Scrivi commento