
KAIKI
KAIKI è una raccolta di novelle che si svolgono tra le varie dimensioni spazio temporali delle quali io ho coscienza e ricordo, fatto
che rappresenta la particolarità di questa mia inusualte vita extra - ordinaria.
le novelle vengono divise in quattro corpi omogenei.
il primo: EROS E THANATOS, raccoglie ricordi di vite passate rivissute in visioni ricorrenti a partire dall'anno 1998.
il secondo: RITRATTI DI DONNE, riporta la narrazione dei miei primi inconsci amori omosessuali.
il terzo: IO, ARIANNA, storie di vita che hanno lasciato un ricordo speciale in me
il quarto: L'ASSOLUTO NATURALE, presenta aneddoti del mio specialissimo raporto con la natura e le sue creature.
il quinto: L'INFINITO E OLTRE, racconta mie visioni di altre dimensioni.
la pubblicazione su questa pagina avverrà a capitoli e seguirà l'ordine di pubblicazione del cartaceo.
io e Walter Manzoni ringraziamo chi leggerà e commenterà-

EROS E
TANATHOS
KAIKI
Li si faccia, per legioni e legioni ancora,
crepare, saltare ai ferri, sanguinare, fumare negli acidi, e tutto questo perché la Patria sia sempre più amata, felice e dolce!
Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte
Primavera del 1954, la guerra d’Indocina è al suo culmine:
i Vietminh del generale Giap lottano senza quartiere contro le truppe inviate dal governo di Parigi nelle colonie ribelli del Sudestasiatico.
I popoli del Viet Nam, del Laos e della Cambogia
vogliono l’indipendenza, l’emancipazione definitiva dal giogo coloniale che la Francia ha imposto loro da quasi un secolo. E sono pronti a morire pur di ottenerla…
Il mio nome era Francis Coubert.
Ero nato ad Avranches, nella Bassa Normandia e comandavo
un plotone del CEFEO, il Corpo di Spedizione
Francese in Estremo Oriente.
Avevo ventotto anni, un aspetto fisico tutt’altro che disprezzabile, una carnagione chiara imbiondita dal sole che filtrava attraverso il fogliame
della giungla.
Perlustrando attentamente la folta
vegetazione tropicale attorno al delta del Mekong, il mio plotone si estenuava nel dare la caccia a un nemico quasi invisibile, peggio armato ed equipaggiato di noi che ogni volta, tra una sparatoria e l'altra, lasciava sul terreno
molti cadaveri dalla pelle gialla e dagli occhi allungati.
Erano corpi esili e scarni, quelli dei Vietminh, assuefatti da tempo immemore a una denutrizione endemica e a un’esistenza di fatica e di stenti, da autentici «dannati della terra»: ma le loro scorte di combattenti, che ci assalivano chiamandoci merde e cochon con quel loro strano accento gutturale, parevano inesauribili come le gocce d’acqua di un fiume lento e limaccioso…
Mio padre era un ufficiale di carriera (salito fino al
grado di generale di brigata) autoritario e quasi sempre
assente.
Mia madre era una donna frivola e languida, intenta
a farsi consolare da uno sciame di dandy sfaccendati e adoranti, che si affollavano attorno a lei, attirati non solo dalla sua avvenenza ma anche dalle squisitezze offerte durante i ricevimenti nella nostra residenza resa elegante e lussuosa grazie al sangue dei nemici uccisi nelle varie campagne condotte da mio padre: il raffinato champagne di Louis Roederer nelle inconfondibili bottiglie arancione, le prelibate ostriche normanne, il paté de foie gras della Dordogna e le lumache alla borgognona della Côte-d’Or, delicatessen pagate al prezzo di innumerevoli vite spezzate di donne e bambini innocenti.
Sono cresciuto in mezzo alle mollezze di una casa ricca, piena di domestici e di precettori ossequiosi verso i miei desideri, abituati a subire i miei repentini cambiamenti di umore pur di non suscitare fastidi a mia madre: lei infatti troncava ogni problema alla radice, licenziando qualcuno e assumendo qualcun altro munito delle opportune credenziali fornite delle sue mille conoscenze.
E non prendeva neppure in considerazione l’idea di
affrontare seriamente il problema della mia crescita senza regole e senza impulsi vitali, piena di smanie da protagonista e di riottosi capricci rivolti a chiunque fosse disposto a concedermi anche solo uno sguardo colmo di rabbia o venato di commiserazione.
Sulla base di simili presupposti, quando, alle soglie
dell’adolescenza, giunse il momento di scegliere la mia strada, feci il raffronto tra l’alta borghesia indolente e parassitaria alla quale apparteneva mia madre e la casta militare di cui faceva parte mio padre, proveniente da una laboriosa e modestamente agiata famiglia di viticoltori, ma con un’immensa voglia di riscatto che gli
scorreva nelle vene.
L’esercito era indubbiamente fondato sulla violenza, ma si trattava di una violenza ben gestita e ordinata, un’incubatrice di future glorie e di crescente prestigio, un’istituzione rispettata dall’intera nazione, che nei soldati di Francia vedeva il simbolo della forza, dell’espansionismo, dell’orgoglio patriottico e della prosperità del Paese, della grandeur di napoleonica memoria, insomma.
E poi, le preziose materie prime, rapinate
a costo zero alle popolazioni asservite al giogo
coloniale e immesse sul mercato con un ricarico da capogiro, garantivano un plusvalore da cui colava il grasso della ricchezza per tutti i ceti sociali della nostra Repubblica borghese e interclassista.
Fu così che io scelsi la carriera militare, sentendo urgere dentro di me la necessità di esprimermi nell’obbedienza e nel comando, nella disciplina e nella scansione precisa e regolamentata della vita di caserma.
Non importava se in parallelo al flusso elegante delle parate e delle cerimonie in alta uniforme scorressero rivoli di sangue innocente…
La mia vita era risultata fino ad allora orfana di maestri e di filosofi, disorientata da esempi contrastanti tra loro, e tutti decisamente malsani: tra i due mondi a confronto, la divisa costituiva la maschera ideale da indossare, dietro cui nascondere le mie infinite incertezze, le mie domande inespresse o rimaste senza risposte, l’assenza di qualsiasi orizzonte esistenziale.
Mi piegai, così, consenziente, alle rigidità dell’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr a Coëtquidan, in Bretagna, dove, dalla stanza traboccante di giocattoli e ninnoli, di sete e di mussoline, passai alle brandine spartane in camerate enormi e fredde, nelle quali doveva regnare il
più assoluto silenzio.
Un silenzio a volte così assordante per le mie orecchie – abituate all’incessante cicaleccio
salottiero degli ospiti impomatati nella dimora materna – da lasciarmi smarrito e nello stesso tempo fiero del coraggio che dimostravo nell’aver gettato dietro le mie spalle l’ozio e l’agiatezza per mettermi al servizio della Patria.
Mi feci promettere solennemente da mio padre che
non avrebbe esercitato l’influenza che possedeva per addolcirmi in qualche modo l’agone che mi attendeva.
Volevo trasformare quel verme che mi sentivo di essere in un soldato d’acciaio e molto velocemente mi adattai ai ritmi a volte disumani dell’addestramento militare, irrobustendomi nel corpo e nella volontà, dato che mi cibavo del mio stesso orgoglio, della mia caparbietà e resistenza
a negare a me stesso ogni diritto in nome di
una Patria di cui, in fondo, non mi importava niente,ma al servizio della quale avrei raggiunto lo spessore umano che sentivo di possedere, anche se intaccato dall’incuria e dal lusso sfrenato e indecoroso dei miei trascorsi da rampollo debosciato di una famiglia benestante.
Passai a pieni voti ogni esame e travolsi ogni ostacolo che si intrometteva tra me e il mio obbiettivo e, da pulcino debole e implume quale ero, mi trasformai in un fiero cadetto che accese di luce lo sguardo di mio padre il giorno che mi vide marciare tra le fila dei miei simili, all’unisono, sfavillante nei finimenti d’ottone della divisa
lucidati fino allo sfinimento, con lo sguardo che sprizzava salute e i muscoli sciolti e scattanti, frutto di innumerevoli levate all’alba e di estenuanti marce attraverso terreni impervi, con addosso lo zaino colmo e perfettamente equipaggiato per affrontare i disagi delle campagne in terre lontane e sconosciute.
Una volta promosso sottotenente, superai di slancio tutti gli ostacoli, adattandomi senza sforzo alle privazioni di una vita grama ma colma di un significato che altrimenti non avrei mai trovato né dentro né fuori di me.
Ormai temprato ad affrontare l’ignoto delle colonie,
fui impegnato dapprima in oscuri compiti di controllo
agli imbarchi delle navi colme dei tesori sottratti a quelle terre generose: riso e pepe dalla Cambogia; tabacco e legni pregiati dal Laos; tè, lattice, zinco, stagno e carbone dal Viet Nam.
Il mio compito era di tenere a freno con mezzi drastici e spietati (il confino, la detenzione e, nei
casi più estremi sfociati in attentati terroristici, la ghigliottina) le teste più calde fra gli indocinesi: agitatori politici che, conservando gelosamente il sentimento di naturale appartenenza alla loro terra sottoposta al dominio coloniale straniero, tentavano di risvegliare nei compagni abbruttiti dalla fatica e dalle umiliazioni lo spirito combattivo delle antiche tribù guerriere da cui discendevano sin dalla notte dei tempi.
Quando scoppiò la guerra d’Indocina, fui destinato a Saigon con il grado di tenente e il comando di un plotone.
Il mio trasferimento avvenne in tempi rapidissimi: il
mio compito era quello di dare man forte, nuove idee e nuova linfa vitale alle già sfibrate guarnigioni locali, che si erano lasciate cogliere impreparate dall’insurrezione dei Vietminh galvanizzati dai proclami di Ho Chi Minh, il loro redentore nazionale che predicava il vangelo comunista.
Quando approdai nella fitta giungla della quale
avevo solo sentito parlare, rimasi letteralmente rapito dall’incredibile profumo delle ninfee affioranti dalle acque pluviali e dai venti che spiravano, insinuandosi tra una forra e una radura, portando semi, foglie cadute e lontani echi di battaglie nascoste nell’intrico della vegetazione.
Fu atroce, all’inizio, abituarsi al clima torrido e
umido, ma il cognac francese e la cannabis vietnamita mi sostennero non poco nel sopportare una temperatura per noi assolutamente micidiale. Per prevenire l’insorgere della malaria, masticavamo di continuo pillole di atrabina: ma quando ci rendemmo conto che l’abuso di quel farmaco rendeva sessualmente impotenti, finimmo per gettarle via.
Le scaramucce tra i giunchi, le canne di bambù, le liane, le larghe foglie che celavano splendidi fiori carnivori o velenosi, erano entrate ormai a far parte della mia realtà quotidiana, come se la sinergia della battaglia si fosse fusa alle meraviglie naturali del luogo.
Ogni mattina si usciva in perlustrazione, attenti alle
trappole mortali che i guerriglieri Vietcong seminavano nottetempo, in completo silenzio, avvolti e nascosti dalla loro giungla, illuminati solo da uno spicchio di luna che per loro era risplendente come il sole di mezzogiorno.
Cercavamo, in ogni piccolo agglomerato di capanne,
ancora abitato dalle donne e dai bambini, i sentieri quasi invisibili e le gallerie sotterranee immediatamente ricoperte dalla folta vegetazione perenne, che portavano ai rifugi dei Vietcong, mimetizzati nel fogliame cascante e incredibilmente intricato.
La determinazione dei nostri nemici era dura e implacabile: intendevano sterminarci e cacciarci via dalle loro case di palme e bambù, dai loro pozzi di acque semi palustri, dalle radure che a fatica sfuggivano all’abbraccio soffocante della giungla, dove seminare riso e cereali e pascolare piccoli armenti di capre e maialetti scuri di pelle.
Quando poi ci si incontrava – loro silenziosi come
serpenti tra i rami frondosi, noi intruppati nel nostro marciare pieno di sussiego e di protervia – infuriavano carneficine spaventose: talvolta, svuotati i caricatori delle armi automatiche, si completava il lavoro all’arma bianca, con la baionetta o con il pugnale, tra grida soffocate e urla disumane che zittivano tutta l’infinita popolazione alata degli alberi generosi di nascondigli.
Ci si scannava con diligenza, sia da una parte che dall’altra,
fino a che la schiera rimasta più esigua di numero, a un gesto di mano silenzioso di un comandante Vietminh dall’uniforme di stampo cinese, o al mio perentorio comando di ritirata, cedeva il campo ai vincitori del momento.
Il massacro svaniva in un attimo, così come si era
acceso, sfumando nel lieve movimento di fronde che inghiottiva l’ultimo superstite in fuga. Qualcuno dei nostri, ripiegando, portava sulle spalle un compagno ferito che respirava ancora, anche se era destinato a crepare poche ore dopo, divorato dalla febbre scatenata dalla setticemia.
Le ferite si trasformavano in ascessi purulenti
in mezzo al lezzo dolciastro degli ospedali da campo: era come se il calore malsano sprigionato dalle tiepide piogge quotidiane istigasse le infezioni a propagarsi più in fretta nell’organismo.
Un calore vivificante per la vegetazione, ma mortifero per la fibra di noi francesi, abituati alle arie frizzanti, pregne di iodio e di ozono, con cui l’immenso Atlantico lambiva le coste della Normandia e della Bretagna.
Al ritorno nel nostro accampamento seguiva il triste
computo delle vittime, la cura dei feriti e la distribuzione
di cibo, fumo e alcool agli scampati, stramazzati
sulle loro brande o sotto il getto di docce rudimentali.
La sera trascorreva nello scrivere lettere all’innamorata lontana o nel leggere quelle arrivate con la posta, lasciando defluire i flussi palpitanti di adrenalina ancora presenti in ogni fibra.
In tutti noi la paura e l’aggressività di chi lotta quotidianamente per sopravvivere convivevano con il dolore lancinante e la nostalgia amara di chi sa che sta pagando con la propria pelle i giochi sporchi della politica a Parigi.
A volte trascorrevano lunghi periodi di tregua, durante i quali si sentivano solo i rumori consueti dell’immensa giungla che ci circondava come una gigantesca cattedrale, i cui pilastri erano le arcate di fogliame lussureggiante che il sole intarsiava di arabeschi lucenti.
Noi seguitavamo a effettuare le nostre quotidiane perlustrazioni, ma subito captavamo dalla quiete priva di tensione dell’ambiente circostante che quel giorno si sarebbe consumato senza combattimenti. Erano le settimane durante le quali i nostri nemici si dedicavano alla coltivazione di riso e di cereali che noi avremmo poi sistematicamente bruciato, oppure mettevano in pentola qualche animale sopravvissuto alle nostre razzie, per
donare un minimo di nutrimento ai loro corpi spossati dalla fatica della guerra e per garantire la sopravvivenza alle loro famiglie sfinite da una vita raminga.
Fu durante una di quelle tacite tregue che trovammo, sperduto e nascosto nel folto della giungla, un piccolo gruppo di capanne, completamente isolato, lungo le sponde di un placido fiume dalle acque giallastre.
Nessuna traccia di nemici nelle vicinanze, ma solo alcune donne, vestite di abiti dai colori vivaci, meno consunti del solito.
Ce n’erano di giovani e di vecchie, e assieme
a loro vagava qualche bambino che nello sguardo non
sembrava racchiudere né il passato né il futuro.
Le strane abitanti di quella piccola comunità vivevano ai limiti della sussistenza, ma apparivano comunque piene di dignità e scevre di ogni paura: si intuiva che la loro era una posizione intermedia tra i due belligeranti.
Ci accolsero con un suggestivo rituale sobrio
e rispettoso, accostandosi a noi con sguardi sereni
per porgerci fumanti tazze di tè forte e aromatico.
Noi ci sentimmo onorati da quella accoglienza inattesa, e tirammo fuori dai nostri tascapane tutti gli alimenti di prima necessità che facevano parte della nostro equipaggiamento.
I nostri doni suscitavano occhiate piene di gratitudine e quelle donne a stento trattenevano
i loro bambini dal gettarsi famelici sulle gallette,
sul latte condensato, sulla carne in scatola e sulle sardine sott’olio delle nostre razioni.
Si stabilì da quel giorno un legame molto forte fra noi soldati stranieri e le meravigliose abitatrici di quel Tempio privo di statue votive, che però odorava sempre d’incensi bruciati nel segreto delle ombrose capanne.
Il nostro arrivo era atteso con una specie di serafica pazienza, con una gioia intimamente segreta.
In breve tempo si formarono delle coppie: offrendoci spontaneamente i loro corpi, quelle donne delicate ci dimostravano nel modo più naturale la loro gratitudine e il loro affetto.
Le loro effusioni erotiche non assomigliavano
neppure lontanamente a una qualsiasi forma di
prostituzione e anche noi soldati rifuggivamo del tutto dalla violenza che di solito esercitano gli occupanti sulle donne del paese occupato.
A poco a poco quel villaggio pieno di amache dondolanti si trasformava in un’oasi quieta e riposante fuori dal tempo e dallo spazio, come
se avessimo trovato una dimora segreta, un inatteso rifugio proprio nel momento più furioso del tifone tropicale.
Per me, inoltre, esisteva un’immensa gioia in più.
Tra le piccole creature che vivevano in quell’inusitato anello di pace al centro di una delle più sanguinose guerre del secolo, c’era una bimba di quattro anni, di nome Kaiki, minuta e aggraziata nei movimenti, come se la danza e la musica le scorressero nelle vene assieme al sangue.
La udivo cinguettare come un usignolo, felice
del suo raggio di sole, quando mi vedeva arrivare, e mi correva incontro, cingendomi il collo con le sue manine come se volesse aggrapparsi alle corde di un’altalena che la spingeva tra le stelle.
E io la sollevavo in aria, perdendomi tra le sue risa
cristalline, nel bruno lucente e acceso di quegli occhi identici ai frutti del mandorlo e del pesco, tanto l’ovale della forma spiccava nella freschezza di quel viso appena fiorito.
I giochi fra noi erano semplici e spontanei: io mi riposavo nell’ombra di una capanna, con la schiena appoggiata alle frasche, e Kaiki si trastullava a suo piacimento, indossando il mio elmetto, frugando nei miei svariati tasconi alla ricerca, come in una caccia al tesoro, di prelibatezze che io avevo accuratamente celato e delle quali negavo l’esistenza, facendo il finto tonto, fino a
che la sua intrufolante manina scopriva il tubetto del latte condensato denso di zucchero, o una palla da tennis trovata tra le cianfrusaglie di ogni genere che ci spedivano da Saigon.
Man mano che scovava quegli attesi ma sempre nuovi tesori, gli occhi di Kaiki si illuminavano di gioia e di meraviglia e io pure fremevo di contentezza nel vedere quel visetto di bimba, dipinto con la gravità di una statua votiva, perdere la sua compostezza di maiolica per aprirsi in un sorriso che varcava gli oceani, cancellava le guerre, annullava le differenze di pelle e di razza.
Il riso dei bimbi è l’unica vera uguaglianza su questo
pianeta, insieme alla morte…
Ma ciò che è bello non dura mai a lungo…
Quel giorno il silenzio nella foresta era impenetrabile e denso di minacciosi presagi.
Le nostre perlustrazioni si erano rivelate infruttuose e i vapori umidi della giungla
tropicale ci avvolgevano come un sudario, rendendoci il fiato affannoso e imperlando la divisa di macchie umide
e scure.
All’approssimarsi del buio, mi resi conto che eravamo ancora assai distanti dall’accampamento ma invece abbastanza vicini alla nostra oasi di felicità.
Un’insopportabile stanchezza rallentava il nostro cammino: ci sentivamo stremati nel corpo e svuotati nella mente.
Dopo un’intera giornata passata a dare la caccia a
fantasmi che comparivano all’improvviso per poi svanire subito dopo nel fitto della vegetazione, fummo assaliti dalla nostalgia per la calda accoglienza che sempre ci veniva riservata nel villaggio delle nostre amiche.
E così tornammo verso le donne del Tempio.
Il villaggio ci accolse con il consueto calore: appena
posammo i piedi nel cerchio più scuro disegnato dalle ombre delle capanne, le abitatrici accorsero festose verso di noi e Kaiki mi saltò tra le braccia come era sua abitudine.
Fu allora che, all’improvviso, si scatenò un inferno di fuoco e di fiamme e una torma di Vietminh ci piombò addosso, scaricando all’impazzata raffiche ululanti con le armi automatiche. Nel trascorrere di pochi istanti che parvero un’eternità, in un interminabile ralenti di morte, mentre le capanne si scheggiavano in sibili violenti tutto intorno a noi, e pezzi di legno si staccavano fischiando sotto l’impatto dei proiettili, le nostre amiche caddero una dopo l’altra, come delicati fiori recisi da
una forbice impudica e feroce, macchiando di rosso acceso le lunghe tuniche colorate e i bei capelli corvini portati sciolti lungo le spalle.
In pochi minuti la nostra oasi di pace era diventata una palude di desolazione e di orrore.
«Tenente! I Vietminh sono troppo superiori di numero! Non ce la faremo mai a respingerli! Dobbiamo ripiegare in ordine sparso se vogliamo salvare le pelle!»
La voce del mio attendente mi giunse nitida anche
se ovattata, mentre, facendole scudo col mio corpo, stringevo a me la piccola Kaiki, che singhiozzava sommessamente, tremando e invocando disperatamente la madre.
Mi resi conto in un attimo che tutto era perduto.
Il piccolo villaggio circolare ardeva di vampate scarlatte in ogni capanna.
Nessun grido di donna risuonava più nell’aria e le abitatrici del Tempio giacevano mute come
farfalle abbattute da un vento maligno, con le fragili ali spezzate, affogate per sempre nelle chiazze vermiglie del loro sangue innocente.
Mi rassegnai a dare il segnale della ritirata, alzando una mano, come per dare un pugno al cielo e, sempre stringendo a me la mia piccola «fiore di loto», mi acquattai camminando all’indietro, cercando di uscire da quel muro di fuoco e di spari per portare in salvo con me almeno lei.
Ma, a un tratto, un brivido la percorse tutta e la sentii emettere un piccolo leggero singulto di sorpresa e di dolore: subito dopo Kaiki si adagiò esanime tra le mie braccia.
Mi fermai, al riparo di un fitto gruppo di alberi
e mi chinai su di lei, scostandola un poco da me, per rendermi conto di cosa le fosse successo, per medicare la piccola ferita provocata dalla pallottola di striscio che aveva sfiorato il mio elmetto, deviando il suo corso.
Ma ai miei occhi increduli si presentò l’immagine del suo solare, immutato sorriso ormai spento per sempre negli occhi ancor aperti ma privi di luce, mentre il suo sangue mi scorreva in rivoli carminio tra le dita e lungo i polsi, inzuppando le mie maniche, la camicia e quegli sporchi pantaloni da soldato che tanto le piacevano, perché nascondevano sempre nelle tasche qualcosa di buono o di bello per lei.
Restai così, come paralizzato, a guardare il suo sangue che continuava a laccare, sempre più lentamente, le mie dita, su cui lei aveva posato quella sua delicata testolina, ed i riflessi rossi si mescolarono per sempre nella mia mente a quelli neri di ogni uomo o donna uccisi durante quella guerra inutile quanto disumana, della quale anch’io mi sentivo in parte responsabile.
Le braccia robuste del mio luogotenente mi strapparono alla mia paralisi, staccandomi rapidamente ma senza brutalità da quell’essere amato che ormai altro non era che uno straccio sporco di sangue…
Mi trascinarono via e io sentii le mie gambe correre e la mia voce, con l’autorità di sempre, chiamare a raccolta i miei uomini verso una salvezza che si palesava difficile ma che raggiungemmo, centuplicati nelle forze dallo scempio del nostro rifugio segreto, ammazzando i nemici senza tregua, con i denti digrignati in una frenesia da forsennati.
Nei giorni che seguirono nessuno parlò più dell’accaduto, tanto ci sentivamo in colpa per aver attirato i nostri nemici verso quel luogo di pace e di armonia.
Ma per me era una consapevolezza ancora più dolorosa, perché mia era stata la responsabilità della scelta di fermarci lì quella sera e più ci pensavo, più mi assalivano morsi allo stomaco, violenti e continui.
Mi aggiravo per l’accampamento, torvo, in disordine, come nessuno mi aveva mai visto prima, ossessionato dai fantasmi delle donne morte per colpa mia e mi guardavo le mani, che,
se pur lavate e rilavate energicamente, mi sembravano sempre orribilmente lorde del sangue della piccola Kaiki, sangue innocente che mi ricadeva addosso come una maledizione.
Il passo fu breve, da quei fantasmi singoli alla moltitudine degli altri, sconosciuti, infiniti: tutti mi passavano davanti, mi sfioravano girandomi intorno, ricordandomi le loro vite che avevo soppresso, stracciato, gettato alle ortiche senza altro motivo al di fuori della mia incapacità di dare un senso alla mia esistenza.
Perché se io non avessi accettato di costituire uno degli ingranaggi di quella malefica e disumana macchina di morte chiamata Esercito, non avrei mai stroncato le loro esistenze: avrei consumato i miei giorni tra i futili cicisbei di mia madre, vivendo senza scopo, sciupando il mio tempo in un ozio sterile e vacuo, ma tutto sommato inoffensivo.
E forse sarebbe stato meglio così…
Quel nulla io l’avevo trasformato in sangue, in grida
di dolore e di morte di esseri umani dei quali non sapevo niente e nel martirio, ancora conficcato nella mia memoria, dell’unica creatura che avessi mai amato in questa mia vita desolata.
Quel delirio insensato si protrasse per alcuni giorni, e ammutolì l’intero plotone, in una specie di irreale sospensione temporale.
Poi, come un lampo all’orizzonte in una limpida e rovente giornata d’estate, tutto cambiò nuovamente: radunai i miei uomini, che si rallegrarono nel vedermi di nuovo pettinato, sbarbato, con la divisa mimetica riordinata e gli anfibi ripuliti dal fango.
Tutti pensarono che avessi superato finalmente lo shock e si strinsero con rinnovato entusiasmo attorno al loro comandante redivivo.
Li feci mettere in riga e li passai lentamente
in rivista.
Con affetto virile, pieno di commozione, ricordai ai miei uomini i sacrifici che avevano affrontato
in guerra, la dedizione che avevano mostrato
verso i commilitoni, al punto da non lasciare mai nessuno (neppure i cadaveri) nelle mani dei Vietcong, che, noi lo sapevamo, avrebbero infierito sui loro corpi, vivi, morti o moribondi, con rabbioso accanimento.
Li abbracciai tutti, uno per uno, con le lacrime agli occhi, con l'intima consapevolezza che quelli erano gli ultimi momenti che trascorrevo con loro.
Poi dichiarai la missione d’ordine prevista per la mattina: recarsi sul luogo dell’eccidio e, seguendo attentamente ogni piccolissima traccia che potessero aver lasciato i nostri nemici, trovare il loro covo e far pagare a caro prezzo ciò che essi avevano compiuto contro donne inermi della loro stessa razza, con il solo scopo di uccidere un esiguo manipolo di nemici.
E così facemmo: ci trasformammo tutti in cani da pista di sangue e in capo a poche ore, attraversando forre incredibilmente intricate e guadando una basa palude alquanto insidiosa per le sabbie mobili, arrivammo fino al loro campo, non sentiti né avvertiti, dato che anche noi avevamo ormai appreso da loro l’arte di muoverci nella giungla come silenziosi animali feroci.
Il loro era un grande accampamento, brulicante di uomini e le poche guardie piazzate nei punti strategici, furono messe a tacere per sempre dalla nostra nuova sagacia e dalla potente rabbia che ci ribolliva dentro.
Il loro numero era soverchiante rispetto al nostro, ma nessuno di noi, toccato come me nel profondo dei propri sentimenti e ormai conscio dell’inutilità di questa guerra d’invasione, non ammettendo neppure a noi stessi la possibilità di rinnegare il giuramento fatto alla nostra patria, ci gettammo urlando come un sol corpo tra di loro, uccidendone una quantità notevole e cominciando a cadere, l’uno dopo l’altro sotto i loro colpi, dopo aver cercato l’ultimo sguardo del compagno più vicino.
Io fui l’ultimo ad offrire il petto alle loro spade, dopo aver benedetto ognuno dei miei compagni di armi nella lingua universale di ogni soldato che sta per morire:’ Che la tua sia una breve agonia!’
Poi mi gettai allo scoperto, urlando il nome della mia piccola amica: ‘ Kaiki!’ come un grido liberatorio e mentre cadevo, trafitto innumerevoli volte in ogni parte del mio corpo, mentre sentivo che la mia anima, purificata dalla codardia e dalla insicurezza, si separava dalle mie membra agonizzanti, vedevo le mie mani macchiate dal suo sangue mondarsi, allo stesso ritmo della vita che usciva da me, purificando la mia anima gravata da innumerevoli passati di violenza.
Morii sorridendo e il mio spirito trovò quello che da sempre cercava, offuscato dalle mode del mondo, nel desiderio di pace, coscio che mai più sarei ricaduto nell’orrido errore commesso di uccidere un altro essere a me assimilabile, nel nome di un ideale o per servizio alla patria, scuse addotte per gestire una vita che non aveva il coraggio di sostenere se stessa e le proprie convinzioni.
Morii conscio che da quella morte violenta sarebbero seguite vite difficili, per riparare ai torti fatti alle persone che più avevo amato, ma che sarebbero state vite piene e portatrici di luce, nella ricerca e il raggiungimento della pace in tutto il pianeta.
Non c’è una mia tomba sulla quale fermare il vostro passo o gettare un fiore, né servirebbe: la mia energia dedita alla pace vaga per l’universo a contrastare la violenza, ovunque essa si nasconda.
Fermate invece il vostro pensiero e la vostra coscienza sulla soglia della vostra propria violenza, lasciando che questa mia vita vi racconti il fine ultimo di ogni vita: l’amore universale.

GERARD
Persino le stelle sembravano stanche di attendere l’alba.
Venne infine con un chiarore di madreperla allo zenit, come non avevo mai visto prima ai tropici: senza brillare, quasi grigia e con uno strano ricordo di latitudini elevate.
Joseph Conrad, La linea d’ombra
Nel 1701, agli albori di quello che sarebbe stato ricordato come il Secolo dei Lumi, in Europa divampa la guerra di Successione
spagnola: la Francia del Re Sole lancia una sfida temeraria ad una coalizione di sette stati (Inghilterra, Paesi Bassi, Austria,
Prussia, Hannover, Portogallo e Savoia), pur di insediare un principe della casa di Borbone sul trono vacante di Spagna.
Lo scettro d’Inghilterra è nelle mani dell’ultima delle Stuart, Anna, che si dimostra lungimirante affidando il comando dell’esercito a uno degli strateghi più geniali dell’epoca, sir John Churchill, duca di Marlborough.
La Marina da guerra di Sua Maestà britannica, al comando dell’intraprendente quanto corpulento ammiraglio Sir George Rooke, domina gli
oceani e incute un vero e proprio terrore ai vascelli francesi e spagnoli che vanamente tentano di sbarrarle la rotta verso Gibilterra…
Io, capitano di lungo corso della Marina Militare di sua Maestà Britannica Anna Stuart, ero in viaggio, da lungo tempo ormai, alla perenne caccia, punteggiata di battaglie feroci e sanguinosissime ma alla fine vittoriose, delle navi francesi e di quelle dei pirati che infestavano i mari osteggiando il nostro fiorente commercio con ogni angolo del mondo allora raggiungibile.
Ero un uomo ancor giovane, ma segnato nel volto e nei capelli precocemente argentati dalla durezza dei miei compiti sanguinari, dove la pietà non aveva sedi né trovava giustificazioni.
Ero colto, autoritario, portato al comando, amato e rispettato dai miei uomini che a me, proprio a me in persona e non alla Regina, che era una donna fragile e omosessuale, legata alle sue favorite in modo fatale e non nascosto, che però era degna del mio rispetto perché aveva portato a termine importanti azioni per l’Impero Britannico, tra le quali l’annessione della Scozia.
Essi sentivano la loro Sovrana assai lontana e dedicavano il loro sudore quotidiano, il salmastro che seccava e induriva la loro pelle, il sangue che versavano e l’ultimo singulto nella loro morte al loro capitano, vicino a loro, ogni giorno, condividente e condiviso.
Io ero duro e inflessibile, tutto seguivo e comandavo in prima persona, andando ovunque per la mia nave elegante, potente e veloce, fiorita di candide vele sempre gonfie di vento e di gloria.
Visitavo le cambuse e le cucine, dividevo lo stesso loro cibo e lo stesso loro rhum, mi alternavo al timone e chiamavo i miei sottotenenti a discutere con me le azioni di guerra e le strategie. Controllavo nasse, gomene, stato delle armi, dei cannoni, delle polveri e, quando potevo, elargivo svaghi e donne nei porti accoglienti, cibo fresco e sano, pagando con la mia moneta, col mio credito inesauribile concessomi da Sua Maestà in persona, ciò che poi loro avrebbero ricambiato col loro sangue per tenere salva la mia vita.
Ma a me non interessavano le donne.
Quando, spinto dall’euforia generale di un approdo per i rifornimenti o di un raro ritorno in patria, venivo portato in luoghi adatti al mio rango e mi venivano offerte le più giovani schiave ed ancelle, con i capelli profumati di oli esotici, ornati di fiori ed i seni appena celati da vesti colorate di veli trasparenti ed ammiccanti, io non riuscivo a cogliere di loro che questa primaverile essenza e giovinezza e non rispondevo alle loro lusinghe né alle insinuanti carezze, ritirandomi, dopo aver lasciato un buon ricordo di me in denaro e gioielli, nella mia cabina di legno odoroso di mare e del fumo della mia pipa.
Ero un uomo che amava prendere, avere, rubare, nel corpo e nell’anima, la virilità di altri uomini.
E su questo nessuno aveva da ridire, né si permetteva di commentare, poiché quella era una regola vigente tra i marinai di lungo corso, cioè sfogare sui mozzi bambini o adolescenti le proprie voglie carnali, ed era, per i mozzi stessi, di solito orfani e prelevati dalle strade fumose e violente della Londra notturna o degli oscuri porti infidi, infestati di ladri e assassini, di taglia-gole della peggior specie, l’unico mezzo per sopravvivere, venire protetti e raggiungere l’età matura.
Io non mi congiungevo di solito ad essi, lasciandoli alla ciurma, ma eleggevo il mio attendente personale, accuratamente scegliendolo tra la nobile giovinezza destinata alla gloria e al comando delle flotte marine regali, seguendo i miei canoni di bellezza e qualità umane e scegliendo creature forti ma femminee, appena più che adolescenti, fiori non ancora sbocciati da forgiare alle mie esigenze e ai miei gusti.
Non ero paterno, ma neppure violento, non ero protettivo ma neppure un estraneo.
Forgiavo quelle teneri virili vite ai miei voleri, indicando loro una autonomia e dignità basata sull’essere il mio favorito e ripagata con cariche, onori e saggezza marinara.
Ma il giorno in cui perdevano il loro sapore di boccioli io, senza affatto soffrirne, li promuovevo a cariche maggiori, mandandoli su altri vascelli al loro destino, con addosso il mio indimenticabile fardello e la mia influente fortuna.
Quando Gerard, di padre francese e madre inglese, nato in Inghilterra, di media famiglia benestante artigiana, venne a cercare la libertà del mare salato presso la mia truppa come mozzo, fu la prima volta che io andai contro alle mie ferree regole.
Il suo capo corvino e ricciuto vagava perennemente tra la ciurma e la sua voce ancora bitonale, tra l’infanzia e la giovinezza, addolcita e graffiata da una erre arrotata e un po’ afona, si levava sulle altre impersonali e gravi, aggraziata ma impertinente, eletto subito a capo dei mozzi in modo plenario per la luminosità dei suoi occhi verdi che emanavano scaltrezza, intelligenza e acutezza.
Lo scelsi d’ impeto, ma forse fu lui a scegliere me e, tolti di dosso gli abiti rigati della condizione più grama, rivestito di autorità nella bianca divisa orlata di blu di mio attendente, diventò la mia ombra, il mio silenzioso consenso.
Egli leggeva i miei desideri e necessità prima ancora che io ne diventassi cosciente e il tea era già pronto proprio nel momento in cui io glielo chiedevo, così come un forte bicchiere di rhum in una notte ventosa di luna piena, mentre vegliavo afferrato al timone, sentendo fremere la mia nave, scolpita dalle mie mani.
Entrò lui di sua iniziativa, nel mio letto, la prima volta che avvertì il mio desiderio, facendosi carne dei miei ordini senza neppure che io li pronunciassi, senza bisogno che io li vedessi.
Si prese cura del mio corpo, adorandolo ed ammirandolo, rendendosi felice fautore del mio potente afflato fisico e collettore del mio respiro di piacere.
Egli mi amò e per me fu la prima volta: la prima volta che incontrai quel calore dopo le braccia di mia madre, alle quali fui strappato a sette anni, desinato al collegio militare.
Io pure lo amai, ma non lo ammisi a nessuno, né a me stesso, né a lui.
Ma l’amore è assoluto padrone di chi lo accoglie e si palesa di propria incontrastabile volontà ad onta di tutto e di tutti.
Non ero abituato a quel fremere di pelle, a quel calore di mente e di cuore, alle ginocchia cedermi al suo apparire, mentre lui, fiero della breccia scavata, così profonda e inattesa, vita della sua vita, ne delirava negli occhi e nel canto notturno, dolce e malinconico, fuso alla forza di amare ed essere amato, nella solitudine profumata di venti lontani della prua, mentre, sotto coperta, il rumore si mescolava agli odori forti degli uomini salati della ciurma.
Per questo tutto fu chiaro a tutti, in poco tempo e i motti faceti degli uomini miei asserviti, fino ad allora adoranti, cominciarono a minare sottilmente il mio innato e declamato privilegio di proprietario di vite, fino a metterlo in discussione, fino a trasformarlo in una lisa tela per vele da gettare agli stracci per lucidare i ponti e gli ottoni.
Gli uomini di violenza, vivono violenti e violentano chi è meno violento di loro.
Questa era la legge della Marina Militare.
Gerard aveva col suo amore non richiesto né atteso, coll’amore del suo corpo intessuto di dolcezza, aggiunto latte al rhum, acqua dolce alle onde salate della tempesta che aggrediva e scuoteva spesso la nave, creando una falla dalla quale sarebbe entrata l’onda che ci avrebbe tutti affogato.
Conscio di questo, aggredito al mio tallone d’Achille, pur sanguinando internamente in ogni mio oscuro anfratto, lo allontanai da me, promuovendolo ad una carica maggiore sulla ciurma, dato che non aveva né i natali né gli studi per aspirare ad accedere alla carriera militare, togliendogli l’incarico di mio attendente e di proprietario del mio letto e dei miei sentimenti, che non volevo e non potevo permettermi di provare.
Poi, essendo da poco arrivato sulla mia nave un giovane cadetto di una famiglia nobile scozzese, avviato alla carriera e destinato a portare avanti il potere della sua casata sui legni lucidi dei galeoni di Sua Maestà, lo scelsi come sostituto di Gerard.
Egli era alto, ancora flessuoso, ma di potente costruzione, rosso di capelli e di peluria fitta, che lo ricopriva assieme alle efelidi, sulle braccia e sulle gambe, nascondendo una pelle marmorea, quasi trasparente.
Gli occhi azzurri rubavano in ogni momento il colore del mare e del cielo, restituendo ingenua grazia alla creatura acquea, ora placa ora furiosa, che dominava le nostre vite.
Egli era placido e silenzioso, né uomo, né giovane, ma vecchio e saggio, rassegnato e conscio del suo compito: era un figlio modello di una genia di orgogliosi forti invincibili uomini, ora sottomessi e asserviti al potere inglese, dopo secoli, da una fragile donna, amante delle donne.
Io a lui feci lo stesso che la mia diretta padrona aveva fatto al suo popolo: eletto mio attendente e, senza concedergli l’onore delle armi, lo presi, incurante di chi passasse o guardasse, gettandolo con foga su di un covone di gomene arrotolate e sfogando dentro di lui, che silenzioso non mosse un muscolo né uno sguardo, tutta la rabbia dell’amore che avevo dovuto rifiutare e che mi arroventava le viscere, bruciando come una piaga di peste accesa e purulenta.
Un lieve rivolo di sangue lungo l’ancora infantile eleganza delle sue cosce sancì di nuovo il mio riaffermato potere e in lui trovai il più fedele e presente attendente che io ricordi, diventando poi un grande capitano di lungo corso, identico a me, mio testamento militare e spirituale.
Il suo nome era Vincent e nacque vincente dalla morte della sua verginità.
Gerard vide, o fu informato di quanto accaduto e subitaneo si accese di una violenta gelosia, che lo portò a divenire torvo, a incarnare il lato oscuro di quella pallida luminosa luna notturna che era stato tra le coltri della mia cuccetta e tra le gomene della prua solitaria della notte.
Divenne violento, spesso ingiusto con i più deboli ed indifesi di quella moltitudine di offensori, intristito, annegato nel rhum, riottoso ai miei ordini, spesso incurante e disobbediente, fino a che mi portò ad infliggergli una pena corporale davanti a tutta la nostra deviata comunità.
Legato a torso nudo all’albero maestro ricevette dal mio steso attendente, che gli aveva sottratto il posto al sole regalatogli dall’essere capace di amare, una sfilza di vibranti scudisciate, nel silenzio totale degli uomini che sentivano l’ombra del destino agitarsi tra le vele ed i nodi delle nasse.
Ogni colpo che ricevette, senza che lui esprimesse alcun suono, fu inferto al mio cuore, direttamente e lì rimase a sanguinare per sempre..
Finita la punizione esemplare, mentre la ciurma e gli ufficiali mormoravano tra loro il sunto dei loro pensieri, e nell’aria raffreddata dagli schizzi delle onde contro le paratie il mio volere, la mia autorità ed il mio carisma aleggiavano sovrastando tutto e tutti, Gerard fu slegato e, sanguinante, ma indomito, andò verso la sua cabina, fendendo la folla che gli fece ala aprendosi al suo passo incerto ma volitivo, mostrando il suo corpo ferito e il suo onore infangato, con il sorriso amaro volto in un ghigno che era uno sberleffo carnevalesco, un rifiuto del rifiuto subito, una rivolta silenziosa alla luna che celava dentro il suo essere.
Per giorni la nave veleggiò in acque tranquille, dentro e fuori, vicini alla fine del conflitto che ci vedeva ormai vincitori, dopo aver contato non so quanti tuffi di corpi umani, morti o feriti a morte, tra le mani gelide e impietose del grande mare, nostro padrone e servitore.
Tutto sembrava sancito e recuperato, Gerard aveva ritrovato il controllo di se stesso e svolgeva con rinnovata energia e volizione i suoi compiti, mentre Vincent viveva di me e per me, senza dare nell’occhio, sedando il grande sconcerto datomi da un sentimento dimenticato e sepolto nei meandri della mia memoria.
Ma una mattina, alzandomi di scatto assai presto, prima delle luci dell’alba, in preda ad un presentimento furioso come per l’arrivo di una immane tempesta o dello scontro funesto in un iceberg, uscendo d’impulso dalla mia cabina, non del tutto vestito della mia uniforme, andai a sbattere nella penombra dello stretto corridoio, in un ostacolo che al mio impatto emise un tonfo sordo e oscuro, come un afono grido di dolore.
Era il corpo di Gerard, ormai irrigidito nel rigor - mortis, che pendeva inanime e inanimato dopo essersi appeso da solo col collo stretto nella cintura di spesso e resistente cuoio che misurava il suo grado gerarchico, alla trave che sorreggeva la plancia sopra la mia cabina.
Pur nel devastare della morte e nel violaceo che gli alterava il dorato colore della pelle, il suo sorriso emergeva come avesse ritrovato la sua vera identità e i suoi riccioli neri, muovendosi nel rollio leggero della nave, sembravano pensieri che volavano via, finalmente liberati.
Il mio grido strozzato fece alzare di scatto Vincent, già allarmato, nel suo sonno leggero ed attento ad ogni mio respiro, del mio svegliarmi e che rimase impietrito per un attimo accanto a me, guardando esterrefatto i lucidi occhi verdi del mio amato, protesi verso di me nell’ultimo cieco sguardo d’amore.
Poi si riscosse, tagliò con l’affilato coltello che portava alla cintola il cuoio che reggeva il corpo per sempre immoto e orgoglioso di chi mi aveva tanto amato e aveva pagato con la vita il debito contratto con l’amore.
Lo sollevò tra le forti braccia e lo portò, risalendo senza apparente sforzo le strette ripide scale che portavano fuori dalla coperta, adagiandolo sul legno del ponte ancor umido della notte quasi finita, accompagnando con grazia e rispetto il capo del suo non cercato antagonista, accogliendolo nella sua grande e pallida mano, affinché non battesse sul duro della plancia sotto l’ultimo suo amico fil di luna che si posò sul suo viso in una definitiva accorata tremula carezza.
Io, Arianna, porto in me, viventi, le vesti oscure del capitano di lungo corso e il mio amato Gerard è qui, accanto a me.
Ogni volta che piango, ogni volta che ho bisogno d’amore e non lo trovo poiché, non conoscendolo, l’ho per chissà quanto a lungo tempo rifiutato, mi offre il suo amore incondizionato, reincarnato in un corpo canino ma con gli occhi e il cuore di un uomo innamorato.
nella foto NAUFRAGIO
tempera su legno, mia prima opera pittorica dicembre 2006
20 x 25

PARTE II
RITRATTI DI
DONNE
IRIS
Il cortile della scuola materna era vasta e rettangolare e a me sembrava immenso, tutto orlato di alte robinie dalle foglie ovali di un verde tenero e acceso, che a primavera si rivestivano di grappoli di fiori bianchi e fragranti, dolcemente ricurvi e chiusi in loro stessi, come a celare un tenero segreto.
Ne succhiavo il nettare, dopo aver raccolto a manciate quelli ormai maturi, caduti al suolo.
Al centro del grande spiazzo c’era un teatrino di mattoni e cemento poggiato su tre alti gradini, coperto da un tetto a forma di pagoda, dove noi bimbi, guidati dalle nostre maestre, recitavamo lo spettacolo di fine anno, intonando canzoncine ripetute all’infinito per tutta la durata delle lezioni, e inscenando piccole storie, vestiti di costumi di carta crespa colorata e variopinta, che con pazienza, tanta pazienza, confezionavamo con le nostre inesperte e piccole mani, sotto l’occhio attento delle nostre educatrici.
Amavo andare alla scuola materna: l’adoravo! Dentro le stanze dalle volte altissime e dalle enormi porte a vetri con le cornici in legno dipinte di grigio, i muri avevano zoccoli di vernice lavabile gialli e verdini, sui quali erano allineate le fila dei nostri armadietti e degli attaccapanni affissi bassi al muro, in modo tale che noi potessimo arrivarci senza fatica.
Su ogni armadietto era incollata una figurina rappresentante un oggetto coloratissimo, un frutto oppure un fiore, in modo che noi riconoscessimo il nostro posto, dato che non sapevamo ancora leggere il nostro nome.
Il mio era un folletto col cappello verde dai sonagli dorati e i calzoni corti rossi, i piedi scalzi e uno scanzonato sorriso malizioso.
Le mie maestre avevano intuito subito con quale soggetto avrebbero avuto a che fare.
Nelle aule spaziose dalle ampie vetrate, dove filtrava la luce del sole o si rifletteva il rincorrersi delle nuvole accompagnato dal picchiettare della pioggia, spiccavano piccoli tavoli rossi e verdi con seggioline dello stesso colore, raggruppate come macchie circolari di funghetti su un prato. Disponevamo di giochi svariati e ogni giorno si cantava, imparando note e parole nuove.
36
I grossi barattoli colmi di pastelli ci invitavano al disegno e i nostri lavoretti venivano appesi ad asticelle di legno con puntine dalle capocchie colorate.
Avrei voluto disegnare tutte le forme che si affollavano nella mia mente, ma la mia mano malferma riusciva a tratteggiare solo arzigogoli
contorti.
Nell’apprendere l’alfabeto invece ero risultata precocissima: già sapevo scrivere il mio nome e leggevo on facilità le lettere e le parole che campeggiavano sui cartelloni appesi in alto lungo le pareti: A come albero, E come elefante e così via.
A quattro anni scrivevo e leggevo senza fatica tutte le parole che incontravo a passeggio per strada, purché formate da caratteri grandi.
La merenda, a base di pane, burro e marmellata o latte e biscotti, era un gioioso appuntamento a metà mattina, quando, affamata dopo aver consumato tante energie nel gioco e nel disegno, regolarmente me ne spalmavo un po’ sul grembiulino bianco: una marachella che ossessionava mia madre, indaffarata ogni volta a ripristinare il suo colore originale.
All’ora di pranzo i profumi provenienti dalle cucine lievitavano stuzzicanti fino a noi, diffondendosi attraverso i corridoi: le pietanze che ci venivano servite in ciotoline decorate di bachelite erano
appetitose e saporite.
Impossibile non richiederne una seconda porzione, che mi veniva concessa con parsimonia a causa della mia leggera pinguedine: ma la mia fame era impellente!
Ogni mattina, stringendo nella piccola mano il cestino di plastica rosa dove erano riposti il cambio e il tovagliolo pulito, sgambettavo allegra dietro le lunghe falcate di mia madre, che già pensava alle sue quotidiane faccende domestiche e mi accompagnava a passo di marcia, pregustando quelle ore di pace che la mia assenza da casa le consentiva.
Io assaporavo invece l’allegria che avrei condiviso con gli altri bambini e soprattutto pensavo già ad Iris.
Iris era la mia maestra.
A me sembrava incredibilmente alta, ma lei si accomodava sorridente sulle nostre seggioline per poterci accogliere meglio.
Quando, puntualissima, entravo in aula, Iris scandiva il mio nome come un rintocco festoso e io volavo tra le sue braccia, salutando frettolosamente mia madre, che già girava l’angolo del corridoio, assorta dall’assillo dei lavori che l’attendevano a casa.
Mi lasciavo avvolgere dalle lunghe braccia invitanti della mia maestra, che mi stringevano a lei facendomi aderire alle sue forme morbide e lievemente generose.
Il suo profumo di viole o di rose quasi mi inebriava, trasportandomi per valli fiorite e un sorriso spontaneo e solare affiorava su quelle labbra delicate e prive di rossetto.
Iris per me incarnava quello spicchio della luna che a volte vedevo sorgere lentamente sui tetti, più luminoso dell’argento: in quei momenti un tremito misterioso mi scuoteva il fondo del cuore, mescolando dolcezza e languore dentro di me.
Il suo nome riecheggiava tra le mie labbra come un’antica nenia muliebre di donne al lavoro nei campi e il fiore da cui aveva rubato le parvenze aggraziate decorava i balconi dei miei occhi.
La chiamavo mille volte al giorno e sempre il mio sguardo la seguiva mentre giocavo, scrivevo o 37
37
disegnavo.
Appena potevo, mi rifugiavo tra quelle braccia sempre disponibili.
Era Iris che correva a risollevarmi quando cadevo e mi sbucciavo un ginocchio sul ghiaietto del cortile, lei che mi asciugava le lacrime con il suo morbido fazzoletto tranquillizzandomi con la sua voce carezzevole.
Mi capitava spesso di cadere, perché soffrivo di problemi di vista sin dalla primissima età e altre volte picchiavo la testa contro ogni genere di ostacolo, dato che non sapevo valutare bene le
distanze. Ogni volta che questo mi succedeva a casa, mia madre non faceva altro che sgridarmi, ritenendomi solo sbadata e troppo vivace.
Iris, invece, mi teneva abbracciata al suo collo, dove io, cercando il morbido incavo, nascondevo il viso inondato di lacrime.
Scossa dai singhiozzi, mi lasciavo calmare dalla sua voce suadente, fino a quando, passati il dolore e lo spavento, lei mi lavava e disinfettava la ferita, sulla quale poi applicava un
fazzoletto pulito piegato a triangolo e annodato per le becche, in modo che non sanguinassi più. Rasserenata, potevo così tornare ai miei giochi e io, che mi sentivo letteralmente miracolata dalle sue cure amorevoli, ostentavo con fierezza quel bendaggio artigianale, come se mi avessero decorata con la medaglia d’oro.
C’erano poi quei giorni terribili nei quali stavo male,
perché il mio intestino mi torturava con dolori lancinanti: me ne stavo in disparte, col viso corrucciato e triste e cercavo un angolo solitario del cortile in cui rintanarmi assieme al mio dolore, che non era solo fisico, ma anche intensamente mentale.
Iris se ne accorgeva subito, si avvicinava e mi faceva sedere sulle sue ginocchia, accarezzandomi
delicatamente il pancino dolente, dopo aver chiesto alla cuoca di prepararmi una camomilla calda.
Senza dire nulla, come se già sapesse tutto di me e del mio dolore, come se i suoi occhi fossero in grado di leggere l’odissea del mio animo malato, mi cantava sottovoce una canzone tutta per me e, mentre sorseggiavo la mia camomilla, mi cullava con una cadenza così rasserenante da farmi assopire in pochi minuti.
Poi mi adagiava sulla mia brandina e mi copriva, canticchiando ancora sottovoce e dondolandomi lievemente, come su un’amaca scossa da una tiepida brezza primaverile.
Forse sognavo cose che ancora non conoscevo e non capivo,ma che già percepivo distintamente…
Venne Natale e fu tutto un avvicendarsi di decorazioni ritagliate da noi, con carte variopinte e lucenti, con le statuine del presepe ricavate da turaccioli di sughero e da stuzzicadenti, con la capanna di cartone, l’erba secca del giardino e il muschio degli alberi spogli.
Festoni intrecciati pendevano da ogni angolo e una miriade di palline di svariate forme e colori decoravano un abete vero, nel centro del grande salone.
Anche noi, a casa, preparammo l’albero e il presepe: quest’ultimo era compito di mio padre e di mio fratello, dato che io ero ritenuta ancora troppo piccola per maneggiare oggetti fragili e costosi.
La decorazione dell’albero era invece affidata
a mia madre, che la eseguiva a regola d’arte, collocando con cura in mezzo ai rami le sfere policrome di vetro soffiato: c’erano i nanetti, i funghi con la capocchia rossa a puntini bianchi, una mongolfiera verde brillante con fili colorati che reggevano un minuscolo cestello, Babbo Natale sulla slitta, stelline di ogni dimensione, candeline rosse con un supporto fatto a molla, capelli d’angelo argentati, festoni 38
38
lucenti di tutte le sfumature e piccole falde di cotone idrofilo a figurare la neve.
Infine, come in una specie di prodigio, si spegneva la luce e tanti piccoli lampioncini di ogni foggia rilucevano grazie alle minuscole lampadine intermittenti racchiuse al loro interno: l’albero diventava un tripudio di bagliori che mi faceva battere le mani, pazza di gioia.
Ma a scuola le lucine non c’erano e mi rattristava che Iris non potesse vedere quello spettacolo incantevole: avrei voluto renderla partecipe della mia contentezza, vederla risplendere con me tra quelle luci da favola.
Così, la notte prima delle vacanze natalizie, quando
tutti dormivano e l’albero era stato spento (e per fortuna era staccato anche il cavo elettrico dalla spina), io rubai le forbici dal cassetto della cucina, scesi silenziosa a piedi scalzi lungo le scale del piano superiore dove erano situate le camere da letto, presi il cestino di scuola e tagliai, con pazienza e tanta fatica, ogni lampioncino, nascondendoli accuratamente tra i miei panni in modo che non si vedessero né si rompessero, fino a che ne fu pieno.
Volevo farne dono alla mia amata Iris, immaginandola circondata da quelle luci fantasmagoriche e godendo in anticipo della sua felicità nel ricevere un regalo così inatteso.
Poi, con le piccole dita affaticate dallo sforzo e gli arti indolenziti per essere stata a lungo in piedi su una sedia, tornai a letto, silenziosa come ne ero uscita e mi addormentai di botto.
Al mattino, al primo richiamo della mamma, mi destai subito, smaniosa di raggiungere la scuola; ma mia madre mi sembrava lenta e indolente, rendendo interminabile il tempo che mi separava dalla mia audace sorpresa.
Uno strano languore, misto di impazienza e di dolcezza, mi lievitava nello stomaco.
Quando finalmente arrivammo a scuola e mia madre se ne fu andata, attesi, con malcelata impazienza, il momento adatto.
Appena ci fu una pausa nelle attività ricreative, attirai Iris in un angolo e le dissi che avevo una sorpresa per lei.
Poi la condussi nel corridoio vuoto, nel segreto del mio armadietto e aprii il cestino, mettendole tra le mani i lampioncini.
«Presto si illumineranno!» le dissi pregustando la gioia immensa che le avrebbero donato.
Il volto di Iris fu rischiarato da un dolcissimo sorriso, venato da una punta di muta malinconia, come una lacrima solitaria che scende su una gota. Era una luce ancora più splendente di quella dei miei lampioncini, ma più intima e soffusa, una luce che si diffuse in tutto il mio essere, fino a una radice nascosta che neppure sapevo esistesse in me.
Poi, con infinita tenerezza, Iris mi abbracciò stretta stretta e mi spiegò che, privati del filo che li collegava tra loro, i miei favolosi lampioncini sarebbero rimasti spenti per sempre.
E mentre mi parlava mi fissava negli occhi così intensamente da rapirli.
Iris mi aveva rivelato il segreto della luce elettrica: non avrebbe mai visto il bagliore di cui io volevo circondarla, per donare una degna cornice alla sua bellezza.
Delusa e triste, presi a piangere e a singhiozzare: non avrei potuto mostrarle quanto io la vedessi bella.
Ci volle molto tempo perché riuscisse a calmarmi. Rimasi sconsolata per tutto il giorno, nonostante Iris cercasse con discrezione di farmi capire che aveva comunque apprezzato tantissimo il mio gesto e che, nonostante la mancata accensione dei lampioncini, si era sentita più bella che mai.
39
Quando venne mia madre a prendermi, fu svelato il mistero casalingo dei lampioncini spariti e le due donne ci risero sopra entrambe, divertite dalla mia ingenuità.
Ma io invece mi adombrai ancora di più.
Imploravo di lasciare i lampioncini a Iris, ma la maestra, intuendo la disapprovazione di mia madre,
si schernì così fermamente che il mio tenero sogno incompiuto fu incartato in un giornale e prese la strada di casa, tra il mio profondo sconforto e la palese irritazione di mia madre, che già si preoccupava di come raccontare l’accaduto a mio padre…
Non fui sgridata aspramente, quella volta, ma solamente rimproverata e ammonita sul rischio che avevo corso: se il filo non fosse stato staccato, avrei potuto restare folgorata.
Inoltre mi fu spiegato altrettanto chiaramente che gli oggetti di casa nostra appartenevano a mamma e papà e che io dovevo sempre chiedere il permesso a loro prima di prenderne uno.
Mio fratello, invece, la prese malissimo: visibilmente incollerito, mi investì di cattive parole. Come mi ero permessa di rubare le luci del suo albero di Natale?
Da ultimo, ci fu la desolazione del buio profondo nel quale era sprofondato l’albero a causa della mia malaccorta birichinata…
Ai lampioncini furono tolte le lampadine e attaccati ganci di fil di ferro, trasformandoli così in comuni decorazioni prive di illuminazione.
Ma Iris mi amò in modo particolare, da quel giorno fino a quando ci separammo al termine del ciclo di scuola materna: io non tralasciai mai di regalarle un fiore colto da una siepe o una coccinella che mi si era posata addosso.
E quell’amore profondo, celato in quella radice segreta,non mi abbandonò mai.
Qualche lampioncino esiste ancora tra le mie decorazioni natalizie e ogni anno, mentre le estraggo dalla scatola impolverata, li osservo con intensa commozione e con infinita tenerezza.
Non rividi più Iris da quando si è trasferì in un’altra città, ma un giorno mia madre mi disse che si era sposata e aspettava un bambino.
In quel momento mi sembrò di stabilire un contatto telepatico con lei, una specie di corrispondenza interiore con la sua anima, e pensai che quel bambino, forse, un pochino apparteneva anche a me.
nella foto
ANGELO NUDO
olio su tela 13 x 18
--------------------------------------------------------------------------------------------

VIOLA
Avevamo la stessa età, nove anni, io qualche mese di più.
I nostri genitori erano amici e ci conoscevamo da sempre, ma arrivò un giorno che il grattacielo fatto costruire da mio padre fu finito: noi andammo ad abitare nell’appartamento grande del secondo piano e loro esattamente sotto di noi, al primo piano.
Non andavamo a scuola insieme, perché lei continuò a frequentare le elementari del quartiere dove aveva vissuto fino ad allora, ma ora eravamo vicinissime e la nostra lunga amicizia cominciò a crescere.
Appena più bassa di me ed un poco pingue, come erano quasi tutte le bambine romagnole di quel periodo, figlie della guerra durante la quale i nostri genitori avevano patito la fame che quindi ci nutrivano in abbondanza, Viola era bella.
Il viso di un ovale perfetto, con la carnagione diafana e trasparente delle creature che richiamano affetto, portava magnifici capelli castano scuro lunghi sino alla vita ed oltre, perché non le erano mai stati tagliati.
Sua madre ne andava molto orgogliosa e glieli curava continuamente, tenendoglieli quasi sempre intrecciati come un fascio di giunchi in una treccia grossa e morbida che, partendole dalla base del collo, le scendeva sinuosa, accompagnando con guizzi o lente danze come onde ogni suo movimento.
Era lucido e cangiante, quel fascio di brune alghe marine abbandonate alla corrente e il confronto con la mia corta zazzera rossa, scompigliata e ogni giorno atteggiata ad una nuova autonoma foggia, lo rendeva ancora più muliebre, incorniciante queste tenere gote opalescenti e i grandi occhi verdi.
Come me portava gli occhiali e dello stesso colore avevamo le iridi ma, mentre io ero miope e le mie grosse lenti a fondo di bicchiere infossavano e spegnevano il mio sguardo, rendendolo simile ad una lumaca che si rintanava nel suo guscio, lei era astigmatica e le sue lenti, più sottili e di diversa curvatura, aumentavano a dismisura la grandezza dei suoi occhi lustri, rendendoli come due laghi di montagna nei quali specchiarsi.
Gli abiti che indossava, seppure di foggia casalinga, le cadevano addosso eleganti come fosse sempre vestita a festa ed ogni suo movimento per aggiustarsi la gonna o sollevare il colletto della camicetta, suggeriva un frusciare di sete d’altri tempi, mentre sedeva sul divano di casa che subito si trasformava in una esotica ottomana damascata.
Le lunghe gambe sottili, con i calzini sempre bianchissimi ed attillati, si atteggiavano naturalmente ad una composto e pudico abbandono, lievemente ripiegate sotto di sé, unite tra loro come in un abbraccio malizioso e innocente, mentre io non sapevo trattenermi di allargare le mie, facendo scendere l’ampia gonna a pieghe che odiavo, per nascondere ciò che di una signorina per bene, diceva mia madre, non si doveva vedere.
Viola non correva mai, non sudava mai, a volte giocava con me alla ‘ settimana ‘, disegnando col gesso per terra i quadrati lungo i quali saltellava leggera e precisa, oppure ci lanciavamo la
palla, usando il cancello come rete da volley, senza però raggiungere grandi risultati, perché, mentre io mi affannavo a correre dietro ai suoi lanci bislacchi in ogni direzione per cercare di
rimandargliela indietro, lei il massimo sforzo che compiva era allungare il braccio: se la palla non la raggiungeva come di sua propria volontà, la lasciava correre via, seguendola con uno
sguardo corrucciato, come si sarebbe usato per redarguire un paggio sbadato.
Molto più abile era nel giocare ai ‘ dieci fratelli ‘ lanciando la palla contro il muro una volta , poi due e tre, fino a dieci, eseguendo ogni volta un movimento diverso con le mani o le gambe, o piroettando come una ballerina nel plicèt.
Spesse volte suo fratello Giacomo, coetaneo di mio fratello, coi riccioli biondi scomposti e crudeli bellissimi occhi azzurri, si intrometteva tra noi, rubandoci la palla ed invitandomi a riprendermela, dribblando come fanno i calciatori.
Io mi infuriavo immediatamente e ingaggiavo con lui, così più grande di me, un corpo a corpo dal quale uscivo perdente ogni volta, accompagnata dagli sberleffi di quel maligno viso d’angelo; colpita nel mio amor proprio allora lo sfidavo alla boxe ed incrociavamo i pugni, pur se lui aveva le braccia forti di ragazzo e assai più lunghe delle mie, ma io ero impavida e orgogliosa e tante ne prendevo quante glie ne davo, incurante del dolore che mi faceva sulle spalle, le braccia e lo stomaco e, pur uscendo anche allora sconfitta, riuscivo ad allontanarlo, e a riprendere la palla sequestrata ingiustamente, cosa che lui fingeva di concederci per la sua magnanimità, mentre invece il suo viso era acceso d’ira nel l’impossibilità di riuscire a domarmi e a ridurmi alla ritirata.
Viola allora mi guardava grata e stupita, un poco scandalizzata dal mio osare, ma un luccichio di ammirazione animava i suoi occhi da bambola e io mi sentivo un piccolo fiero soldato, degno di una decorazione al valore.
Nelle giornate di pioggia o di freddo lei, che era cagionevole di salute e soffriva di tossi violente, non poteva uscire, così io scendevo nel suo appartamento, dopo aver fatto i compiti come un fulmine e giocavamo in casa: se c’erano i nostri fratelli o i cugini si giocava a ‘ Monopoli ‘ o a ‘tappo ‘, oppure a briscola e scopa, come ci insegnava la vecchia nonna ormai fusa in un tutt’uno con la sua poltroncina ed il suo scialle dal colore indistinto.
Altrimenti c’era il ‘ Gioco dell’oca ‘ o la ‘ Tombola ‘ed io ero sempre sfortunatissima e mi rabbuiavo alquanto quando perdevo, permalosa all’eccesso anche perché perdevo quasi sempre.
Se però eravamo in casa da sole e la nonna se ne stava sulla poltrona vicino alla finestra, agucchiando e dormicchiando, noi ci rifugiavamo in camera sua e giocavamo a ‘ Babbo e Mamma ‘.
Sul tappeto che fungeva da scendiletto apparecchiavamo una minuscola cucina fatta di piattini e piccolissimi bicchieri di bachelite e lei aveva pure le tazzine di porcellana vera con la teiera e la zuccheriera, con la quale mi serviva un aromatico inesistente tea.
A fianco i nostri bambini, bambolotti vestiti dalle mani esperte di nonna dei ritagli più estrosi e inutili, dormivano o giacevano malati, con la febbre alta tanto da dover chiamare il dottore.
Io ero il ‘ Babbo’ sempre, né mi ricordo di essere stata la ‘ Mamma ‘ mai una volta e tornavo la sera, stanco, dal lavoro trovando la tavola apparecchiata e una profumata cena a rifocillarmi dalle fatiche della lunga giornata di lavoro, quando allora lei mi chiamava affettuosamente ‘ Caro ‘ e io le dicevo ‘ Grazie Tesoro ‘ mentre mi serviva trasparenti e succulente pietanze, accompagnate da mezzo bicchiere di un mai imbottigliato rosso vino generoso.
Se i bimbi poi stavano male, ecco che mi trasformavo nel ‘ Dottore ‘ che con saggia maestria
, dopo aver constatato la gravità di quella malattia, li guarivo con una puntura eseguita alla perfezione mimandola con le dita sul sederino di plastica del malcapitato bambolotto, mentre lei fingeva un terrore e una apprensione degna di una grande attrice.
Alla fine di tutto il trambusto, rigovernati e riposti i piatti della cena ed ogni altra cosa fosse rimasta nel mezzo, ecco giungeva il momento più intimo, quello che io aspettavo con impazienza dall’inizio del gioco: era giunta l’ora di andare a dormire, perché il giorno seguente sarebbe sorto presto e faticoso.
Così ci sdraiavamo l’una accanto all’altra sul tappeto morbido, coprendoci con una copertina di quando lei era neonata, che la madre le aveva regalato per i suoi giochi e lei faceva finta di addormentarsi subito, dopo avermi detto ‘ Buonanotte, Caro!’
Ma io allora la cingevo tra le mie braccia, stringendola a me in silenzio, senza proferire neppure un sospiro e lei si abbandonava al mio abbraccio, con gli occhi chiusi e il viso illuminato come da uno spicchio di luna che sembrava origliasse dalla finestra.
E con la mano leggera e un poco tremante, le accarezzavo la lunga treccia, riempiendomene la mano, affondando il mio viso tra l’incavo del suo collo per respirare l’intimo odore che le saliva dalla pelle delle braccia e delle ascelle, per poi passare a percorrerle il viso con carezze lunghe e leggerissime, mentre con una gamba la imprigionavo e, appoggiandola tra le sue leggermente separate, sentivo il calore delle sue cosce e del sue ventre farmi vibrare ogni fibra.
Poi le percorrevo tutto il corpo, con tocchi setosi e aderenti, soffermandomi sul piccolissimo seno che appena appena stava per spuntare, mentre lei continuava a fingere di dormire, pur tradendosi ogni tanto con sospiri e fremiti…
Ed io non avrei voluto mai staccarmi da lei, ogni volta ascoltando una parte diversa del suo ingenuo infantile corpo abbandonato e desiderando fortemente di esserle dentro con ogni mia parte, con ogni mio respiro, con ogni mio sconosciuto piacere.
Poi la nonna ci chiamava e lei si scuoteva come da un torpore, come da un sonno vero e un po’ imbarazzata, senza guardarmi in faccia, si riassettava i vestiti , rianimava il tono della voce che aveva squillante da soprano e correvamo a fare la merenda, oppure io risalivo nel mio appartamento per la vera cena, tornando il chiassoso ragazzaccio di sempre..
A notte fonda, mentre tutti dormivano e io ascoltavo il ritmico russare di mio padre che soffriva di sinusite e il leggero sospiro allungato di mia madre, dopo aver letto per ore, spegnevo la piccola lampada del mio comodino e mi adagiavo, con l’orsacchiotto stretto al mio infantile petto, risentendo quel profumo e quell’ardore che mi avevano così scaldato il sangue mentre la stringevo a me e mi addormentavo, finalmente stanca, sognando di essere un principe con un bianco destriero che giungeva da paesi remoti e sconosciuti a prostrarsi a quella nera lucida treccia.

LA CONTESSINA
Che fosse migliore di noi non era messo in dubbio da nessuno.
Il padre era un conte che trascorreva la sua vita a Milano, frequentando i salotti bene e il mondo della lirica.
Ogni tanto tornava e lasciava alla moglie, altera, severa e tristissima, un altro frutto del suo prezioso seme, da crescere perché il mondo avesse poi in regalo la prosecuzione della sua altisonante specie.
A loro non faceva mancare nulla se non la sua presenza e il suo amore.
Proprietario di vigneti e terreni che producevano ricche messi, condotte e guidate dal suo fattore, un uomo alto e duro come il legno, aveva adagiato la sua numerosa prole con la moglie e la servitù in una villa alla sommità di una collina ricoperta e circondata da un fitto bosco, dove i suoi fidi potevano cacciare e procurargli le prede a cui lui ambiva quando tornava alla ricca ma rustica magione, ornata e definita da una torretta centrale con gli smerli che si distingueva in ogni parte di tutta l’ ubertosa pianura circostante, tenuta a frutteti e vigneti.
Il giardino era ben curato e fiorito in ogni stagione dell’anno e nelle scuderie ancora un cavallo di rango conduceva una vita d’ozio dorato, ultimo esemplare di una lunga schiatta di cavalcature che per generazioni si erano distinte dalle giumente e dalle carrozze dei mercanti e degli uomini d’affari; cavalli e fattrici ricordati a lungo da tutta la cittadinanza per la loro purezza, estrema eleganza e portamento e per la perizia nel montarli e portarli che l’intera casata sembrava tramandarsi geneticamente.
Le stanze di quella enorme villa, che io non visitai mai per intero, avevano soffitti altissimi, ed in alcune di esse giacevano mobili e immensi lampadari pendenti, accuratamente ricoperti da bianchi panni e tenuti lustri e puliti come fossero di uso quotidiano, mentre il tempo delle feste e della musica risonante lungo le basse colline circostanti e le dolci valli, era finito da un pezzo.
Ricordo una grandissima cucina con un camino di marmo che occupava quasi tutta la lunga parete e vasellami fini, stoviglie decorate con scene di caccia, bicchieri eleganti dal lungo stelo, riposare nelle grandi credenze di noce dalle vetrine scintillanti come accese di luce propria.
La madre della mia amica contessina viveva in quel regno decaduto con una dignità degna di Penelope, dirigendo la servitù come se nulla fosse cambiato dai fasti che erano ormai niente più che un ricordo corale e sempre nei forni cuocevano carni odorose, con verdure fresche di stagione, frutta appena colta dagli alberi e dolci preparati con cura che riempivano l’aria della nostra merenda di una magica atmosfera quando a metà pomeriggio, richiamate dalle passeggiate nel parco o dalle letture nella camera da letto della contessina, ci venivano servite su lini immacolati con posate di lucido argento, frutto del lavoro di quelle semplici e generose fantesche che vezzeggiavano la loro preferita e le sue amiche in visita.
Lei era la primogenita.
Era una mia compagna delle scuole medie.
Aveva un incedere come di giunco flessuoso, nonostante l’alterigia le sostenesse le larghe spalle e le ergesse la testa sopra tutte noi: era alta e forte ma aggraziata, elegante e vivamente volitiva.
Il viso era puro come l’avorio, il naso tagliato netto e affilato, gli zigomi alti traevano a se le labbra sottili ma ben disegnate in un atteggiato sorriso, imparato negli anni dell’infanzia, che non si accompagnava quasi mai a quello degli occhi che, scurissimi e allungati, imprimevano tutta la propria risolutezza e coscienza di sé già a quella giovane età.
I capelli, anche loro molto scuri e lucidi di cosmetici alla seta, emanavano un profumo lieve e penetrante, scendendo come una fitta cortina impenetrabile e immota ben oltre le scapole, a volte scossi da un colpo di quel grazioso capo che imprimeva loro un fremito che li attraversava tutti come un’onda marina ma senza scomporli minimamente.
Le mani erano curate, con dita lunghe e sottili, energiche per gli esercizi al pianoforte che ogni giorno ella eseguiva per volere paterno e non per propria volontà, ma l’attitudine, anche se riluttante, era così evidente che le note fluivano da quelle corde scosse dai piccoli martelletti del grande nero pianoforte a coda del salone come fughe canore di usignoli, finalmente liberati da lunghe prigionie, oppure scuotevano i silenziosi corridoi come galoppi di cavalli in una invisibile quanto eccitante caccia alla volpe.
Io l’ammiravo e sentivo la sua bellezza sovrastarmi e rendermi schiava.
Tutto quello che ella mi comandava, io eseguivo: se richiamata allo studio, inforcata la mia bicicletta e percorrendo a perdifiato diversi chilometri, arrivavo puntuale all’appuntamento, ed insieme sedevamo alla sua scrivania di prezioso legno intarsiato, dove alternavamo i compiti di scuola allo sfogliare di libri assai antichi che parlavano di allevamento di cavalli e ne mostravano tutti i particolari, anche quelli anatomici meno pudici che lei mi indicava con un falso ma ben simulato distacco.
Oppure mi chiedeva gentilmente di aiutarla a raccogliere dei fiori per ornarne la casa ed io, lasciando a lei la scelta ed il taglio, mi prestavo come paniere vivente, incurante delle spine delle rose, facendomi graffiare le braccia come fossi accarezzata dalle sue mani.
A volte mi portava per forre e segreti nascondigli che lei diceva essere di sua esclusiva proprietà e ci sedevamo tra tappeti di viole dal profumo stordente o sotto centenarie querce avvolte da liane di edera, in silenzio, oppure parlando dei nostri progetti futuri.
Scendendo per passaggi scoscesi io sempre la precedevo porgendole la mia mano forte e salda dove, come una bianca colomba che si abbeverasse dopo un lungo volo, ella appoggiava la sua, indugiando nel contatto, con gli occhi frementi che mi scuotevano ovunque io esistessi.
C’era una distanza tra noi che non fu mai colmata in abbracci più intimi o in cameratismo di amanti di cavalli, ma io ero l’unica che aveva imparato a memoria le arie sue preferite dell’Aida e del Rigoletto e a me affidava la sua musica, alla mia voce potente e ancora purissima, avvezza al canto nei lunghi anni della chiesa, così che le sue mani sembrava suonassero direttamente le mie labbra.
La rividi dopo tanti anni, dato che il padre l’aveva voluta con sé a Milano alla fine delle scuole medie, per farle proseguire gli studi in scuole di élite più adatte alla sua viva intelligenza e al suo rango ed ella era diventata una donna bellissima, mentre io ero ormai ingrassata e fiaccata dalle sofferenze e dai parti, ma nei suoi occhi che mi guardavano ardenti, mi rividi fiera e indomita nei miei tredici anni.
Non parlammo molto, lei era di fretta e l’incontro fu del tutto casuale per le vie della nostra cittadina, un giorno in cui era tornata a trovare la madre, ma la sua mano corse come quella colomba, ora mansueta, alla mia mano, accogliendola, come l’avesse aspettata troppo a lungo e finalmente ritrovata, anche se, ahimè, troppo tardi.
Le sue labbra allora sorrisero accompagnate dai suoi occhi accesi di un fuoco inestinguibile e dopo avermi salutato, si voltò alcune volte a guardarmi con una lenta nostalgia mentre io, impietrita dall’emozione, ascoltavo il mio cuore divorare di battiti il mio petto.
Qualche anno dopo la rovina si abbatté sul suo casato: il padre avendo sperperato nel lusso tutto il suo patrimonio, si sparò un colpo di pistola alla tempia.
La villa e i terreni furono contesi dai creditori e seppi che la contessina per vivere insegnava musica ai bambini a Milano.
Ma il suo cavallo nitriva ancora nel nostro sangue, che si mescolò allora e mai si divise, stretto nel ricordo e nell’amore mai pronunciato.

III sezione
IO, ARIANNA
IL PROFESSORE
Frequentare la Prima Liceo per me significava fare ingresso nell’età adulta: i ginnasiali, ospiti di vetuste aule al piano di sotto, erano sempre e solo delle matricole, anche nell’ultimo giorno della quinta ginnasio, in ricordo dei tempi in cui, per passare al liceo vero e proprio, bisognava affrontare e superare un esame assai duro.
Quando giunsi io, l’esame era stato abolito da non molto tempo e noi eravamo ancora considerati come studenti delle medie, solo di un grado superiore.
Passare in prima era un salto di valore, tutto aumentava: il rispetto degli insegnanti, quello dei compagni, sia più grandi che più piccoli, la comodità delle aule, il numero dei professori, la specializzazione e la difficoltà delle materie studiate, l’autostima e l’autodeterminazione di chi ci
arrivava.
Infatti, anche se non c’era più l’esame, alla fine della quinta ginnasio era avvenuta una falcidiata tra i nostri ranghi e diversi dei miei compagni non erano riusciti a oltrepassare quella fatidica soglia.
Ci fu chi si arrese e cambiò scuola; chi l’abbandonò definitivamente per il mondo del lavoro, che allora era immenso e offriva ogni possibilità; chi invece rimase sulla strada intrapresa ripetendo l’anno.
Io passai a pieni voti e fui molto delusa dal calo delle mie quotazioni nei primi compiti e nelle prime interrogazioni del nuovo anno scolastico.
Non mi ci volle molto per capire che era stato impresso un giro di vite e che ci veniva richiesto molto di più, e così mi adeguai.
Ma quello che mi diede più soddisfazione fu conoscere i professori nuovi, che mi sembrarono subito interessanti, più preparati, più profondi, più
esigenti, poiché eravamo abituati ad averne uno solo
che ci insegnasse le cinque materie principali, riempiendo così di monotonia le nostre mattinate. Egli era un docente molto colto e preparato, ma del tutto privo di genio e di originalità, che banalizzava qualsiasi nozione tentasse di trasmetterci.
Ma lui fu una folgorazione.
Entrò in classe la prima volta indossando il suo trench dal taglio moderno ed elegante, anche se sobrio, sopra un accurato vestito grigio chiaro con una cravatta vivace, la camicia bianca immacolata,
stringendo tra i denti il bocchino in cui innestava, come uno stendardo di riconoscimento, una sigaretta di marca straniera dall’aroma accattivante.
Alto e distinto, ci ispirò subito soggezione: zittiti tutti all’unisono, al suo ingresso ci alzammo in piedi in segno di rispetto come si faceva allora, affascinati da quell’entrata da attore consumato, da quel talento istrionico che subito ci catturò tutti.
La sua voce risuonò chiara, con un tono caldo ma distaccato, anche se gentile e assai curato nella scelta dei vocaboli, con una erre arrotata che gli conferiva un’impronta signorile.
Si rivolse a noi così, quasi in mezzo alla classe, dopo averci fatto rimettere seduti e, nel silenzio più assoluto, ci diede il benvenuto e delineò a grandi linee il suo metodo di insegnamento: un compito in classe alla settimana, alternando il latino
al greco, tre interrogazioni a testa per materia al trimestre, tante ore di grammatica e sintassi e altrettante di letteratura, in parte estrapolata direttamente dagli scritti nella lingua originale, indicandoci quali opere aggiuntive avremmo dovuto procurarci al più presto.
Ci anticipò che le avremmo tradotte insieme a lui, ed emise,stentoreo, il suo dictat:
«Avrete da me quello che mi darete voi».
Poi si tolse il trench, lo appese con cura all’attaccapanni a lui riservato e si accomodò sulla sua sedia, dietro alla cattedra, rialzata rispetto a noi da una pedana di legno, a sottolineare la sua indiscussa e indiscutibile autorità.
Cominciò immediatamente la sua lezione, indagando
con domande varie quale fosse il grado di preparazione al quale eravamo giunti, ed entrando senza indugi nel vivo del suo programma didattico.
Io rimasi rapita.
Il profumo di talco e di tabacco dolce che emanava mi avvolse come un’aura, la sua carnagione olivastra e i suoi occhi scurissimi, mobili e acuti come lame affilate che ci scrutavano, entrandoci dentro la mente e l’anima, carpendoci l’essenza interiore con una sola occhiata, trovarono che le mie porte non opponevano nessuna resistenza al suo tocco leggero ma deciso.
Le sue mani lunghe e scarne, eleganti e curatissime, che gesticolavano leggermente, sottolineando come un direttore d’orchestra tutte le parole che uscivano dalle sue labbra, erano in perfetta sintonia con la sua figura slanciata ma forte, lievemente rigida, coronata da una non celata chierica di capelli nerissimi, fini e lucidi, che
gli conferiva il senso di appartenenza a una età ancora
giovane ma già matura: poco oltre la quarantina.
Io lo ascoltavo attentamente e tutti questi particolari, congiunti alle sue parole colte, chiare, scelte, originali ma estremamente semplici e comprensibili, scavarono un solco nel mio cuore dove piantai immediatamente il seme della mia ammirazione e del mio subitaneo amore per lui.
I giorni passavano ed io non aspettavo altro che le sue ore di lezione, trepidante ed emozionata, mescolando Euripide, l’aoristo, le volute di fumo delle sue instancabili sigarette con un sentimento palpitante che cresceva ogni giorno di più, mentre non gli staccavo gli occhi di dosso quando spiegava qualche argomento, girando tra i banchi.
Cercavo di incontrare il più spesso possibile il suo sguardo, che spesso si fondeva col mio, soffermandosi un attimo, per poi fuggire verso altri occhi, assorto in quello che diceva, pur rimanendo vigile e indagatore.
Io cominciai a fare il confronto tra la dolce semplicità di Carlo, il mio spasimante di allora e la sua scarsa capacità affabulatoria, con la ricchezza e la variabilità delle vivide espressioni del professore, a volte serie e assorte, a volte pungenti e taglienti, spesso ironiche e severamente
divertenti.
Il mondo dei greci e dei latini, la tragedia, il teatro, l’epica, la poesia, la difficile sintassi e la musicalità delle lingue che egli leggeva con una fluidità e una espressività straordinarie, si fondevano in un tutt’uno alla mia voglia di imparare, al desiderio di penetrare la cultura.
E davano sollievo alla solitudine interiore che continuamente insidiava la mia evoluzione psichica, dovuta al dolore mai sopito della mancanza di mio padre, che mi aveva abbandonato troppo presto, passando nell’Ade di cui spesso si parlava in quegli antichi, verosimili e modernissimi classici letterari.
E davano corpo al mio desiderio di un amore puro ed eletto, destinato a pochi mortali, fatto di intenzioni e di fremiti interiori più che di abbracci e di baci.
I miei occhi lo frugavano e lo accarezzavano, la mia memoria incamerava ogni sua parola e ogni suo gesto, per poi ricordarlo e riviverlo nel silenzio della notte, mentre io vegliavo nella casa addormentata, ascoltando il respiro di mia madre, appesantito dalla sua cronica stanchezza, proveniente dalla porta adiacente alla mia.
Tra un cambio d’ora e l’altro e durante la ricreazione, egli si tratteneva con noi ed io ero sempre nel gruppetto di coloro che gli si stringevano attorno per porgli domande, chiedere chiarimenti, pianificare interrogazioni; ma il mio sguardo era troppo intenso e trasparente per sfuggire alla sagacia dei miei compagni di studi, che presto mi fecero confessare la mia passione segreta per il bel professore.
Fu così che subito la voce si sparse in tutto l’istituto, e io divenni «quella che era innamorata del professor Venturi ».
Inoltre i miei sguardi erano così intensi e trasparenti che presto pure lui se ne accorse.
Lo capii perché la sua voce vibrava di una nuova trattenuta tenerezza quando si rivolgeva a me e dagli sguardi lievemente più intensi e frequenti che rispondevano, solerti e disarmati, per un attimo solo, ai miei silenziosi doni d’amore, con sorrisi appena accennati e una misurata affabilità durante le interrogazioni e gli scambi di opinione.
Io lasciai il povero Carlo, che si soffermava a piangere sotto la mia finestra, ma quella dolcezza che dilagava in tutta me stessa quando pensavo al mio professore era un sentimento che non avevo mai provato per lui e mi rivelava che non era lui che desideravo, nonostante gli volessi tanto bene e lui mi amasse fino all’adorazione.
Così, nel pomeriggio, con tutto il tempo che avevo di nuovo a disposizione, facevo lunghe pedalate in bici e finivo sempre per passare davanti alla casa del professore, spiando di sfuggita attraverso la finestra, che sapevo essere quella del suo studio, col desiderio, la speranza e il timore di vederlo, di incontrarlo solo un attimo e con la necessità impellente di stare vicina a lui, di condividere con lui almeno il luogo e l’ora, anche solo per i pochi secondi che impiegavo per superare la sua casa e
svoltare bruscamente, tornando a girovagare altrove, timorosa di dare troppo nell’occhio.
Ad un certo punto dell’anno scolastico egli ci invitò a casa sua, per approfondire i nostri rapporti, ed io convinsi prima Tati e poi Sandro a recarci insieme a trovarlo.
Finalmente potevo entrare in quella casa, una villetta indipendente con un bel giardino curato e ornato di fiori primaverili appena sbocciati.
Lui ci accolse in veste da camera, meno austero e ieratico che in classe, più rilassato e disposto allo scherzo e da quella volta ci trattenemmo diverse volte con lui, a parlare di politica, di grafologia, dei problemi che vedevamo nel presente e dei nostri progetti per il futuro.
Durante quelle visite, che a volte si prolungavano parecchio, io lo bevevo come un’assetata nel deserto e mi riempivo dell’indugiare caldo e sereno dei suoi occhi dentro i miei, del suo rivolgermi la parola a bassa voce, come se fossimo stati da soli in quella stanza, incuranti della presenza degli altri ragazzi e ragazze.
Il nostro era un dialogo silenzioso e sotterraneo, a un livello così profondo che nessun altro poteva raggiungerci, dove le nostre anime si scambiavano parole che neppure noi conoscevamo, si fondevano in abbracci che neppure osavamo sperare, si allacciavano sempre di più in nodi indissolubili come quelli marinareschi…
Un giorno maledetto, una terribile sciagura colpì la
famiglia della nostra compagna Nadia: suo padre morì, folgorato dall’alta tensione nel cantiere in cui lavorava.
Dopo il funerale, io e Sandro, entrambi orfani di padre, le regalammo un criceto in una gabbietta tutta colorata e piena di passatempi: Nadia desiderava tanto un cagnolino, ma la madre era contraria, per cui si era dovuto ripiegare su una bestiola più piccola.
Forse quel simpatico animaletto avrebbe alleviato la sua solitudine…
Mentre si avvicinava l’estate, prendemmo l’abitudine di recarci da lei per sederci al fresco del suo giardino che profumava di rose, seduti in tre sul suo dondolo, per cantare sottovoce alcuni malinconici blues, dando così espressione e sfogo, lei al suo dolore e noi alla nostra affettuosa solidarietà.
Fu il professore che una sera ci chiese di potersi unire a noi, per partecipare a queste meste ma feconde riunioni dei suoi allievi preferiti, e poiché ignorava il percorso per giungere da Nadia, mi offrii di fargli da guida nel corso del tragitto.
La sua automobile gli somigliava in modo straordinario: sportiva ma non chiassosa, scattante
ma silenziosa ed era permeata del suo profumo.
Appena presi posto sul sedile accanto a lui, mi colse una specie di vertigine: mi sentivo già tra le sue braccia, travolta dall’amore che ora poteva assaporare un’intima vicinanza.
Fu una serata dolce, intrisa di malinconia, e lui seppe confortare con tatto e delicatezza la mia amica, che era la migliore della classe, specialmente nelle sue materie.
I nostri blues quasi sussurrati come per non profanare il lutto di quella casa, lo colpirono e lo commossero vivamente: Nadia e Sandro suonavano divinamente la chitarra, dialogando tra loro con arpeggi e fioriture spontanee e le nostre tre voci riunite assieme, quella baritonale di Sandro, quella da soprano leggero di Nadia e la mia da soprano lirico, fuse perfettamente insieme da un prolungato sodalizio, gli suscitarono un’intensa emozione.
L’aria era gradevole, il vento ci accarezzava e sembrava che il tempo si fosse fermato lì, su quella soglia, con tre adolescenti e un loro professore che vivevano una comunione estranea alle consuetudini scolastiche.
Ma il tempo era volato via: si era fatto tardi e il professore mi riaccompagnò a casa.
Abituato a una guida spigliata, quella sera stranamente non pigiava sull’acceleratore, e discorreva tranquillamente con me, tenendo una mano sul cambio e una sul volante.
Le strade erano vuote e silenziose e le ombre di quella notte primaverile ammantavano come un velo oscuro la città addormentata.
Io gli lanciavo occhiate furtive per non apparire
troppo sfacciata, col cuore che mi rimbalzava in gola: non eravamo mai stati così soli e vicini.
Il resto era sparito e io mi sentivo isolata, galleggiante accanto a lui dentro una bolla di sapone.
Ad un tratto i nostri sguardi si incrociarono, restando incatenati a vicenda.
Tutto scomparve all’istante, tutto fuggì dileguandosi in silenzio, liquefacendosi in una atmosfera di totale sospensione: lui accostò, senza distogliere gli occhi dai miei e spense il motore; il silenzio della notte ci era complice, ci accoglieva come un nido.
Smise di parlare e continuò a guardarmi intensamente, poi alzò una mano per scorrere lievemente col dorso la morbidezza ancora infantile della mia guancia e lo fece con un gesto così lento, assorto nei suoi insondabili pensieri, che la sentii tremare leggermente.
Io mi posai su quella innocente e sensuale carezza e tutta la mia spontanea ingenuità lo sommerse di intensa tenerezza, attirandolo inesorabilmente verso di me, fino a che il suo viso non fu così vicino al mio che le sue labbra appena dischiuse, caste e nello stesso tempo infuocate, condivisero con me il sapore dell’estasi in un contatto fremente.
Lui trattenne a stento la violenza dell’amore che ci
premeva nelle vene pulsanti, sbriciolandola in una dolcezza infinita che solo un uomo adulto e puro può provare per una donna-bambina innamorata e indifesa.
Fu un attimo o un’eternità, non lo sapemmo mai, né ci importò mai di saperlo.
In quel bacio egli versò tutta la sua vita ed io gli offrii tutto il mio futuro.
Ma il presente fu più forte di tutto e prevalse nel conflitto tra il cuore e la mente che si agitava furioso dentro di lui.
Lentamente si staccò da me e si appoggiò al sedile, come sfinito da un’aspra lotta dall’esito ancora incerto.
«Lo sai che non possiamo», mi sussurrò e la sua voce era un’isola lontana.
«Ma noi ci amiamo», mormorai io, sentendo un gelo
mortale artigliarmi il cuore.
Allora nei suoi occhi ancora fissi nei miei scintillò il
bagliore di una lacrima trattenuta, mentre mi ripeteva che, pur se il nostro amore era travolgente come un fiume in piena, la vita aveva deciso per noi, togliendoci ogni possibilità e ogni diritto di poterci amare.
Poi distolse gli occhi dai miei e staccò la sua mano dalla mia guancia rigata di lacrime.
Senza più dire una parola, si rimise alla guida fino a fermarsi sotto casa mia: sentivo che la sua era una sentenza senza appello e io l’accettai, perché l’amavo troppo per mettere in discussione l’amara verità che era sorta su quelle labbra che un attimo prima avevano spalancato il mio futuro alla più agognata delle felicità.
Ci guardammo ancora a lungo e i nostri occhi vissero in quegli attimi tutto quello che i nostri corpi non avrebbero provato mai.
Lui si staccò da me e io sentii nettamente la corda del violino che si staccava dal ricciolo di legno levigato e lucido che l’aveva trattenuta fino ad allora e poiché non ero Paganini, ma una ragazza che non poteva fare altro che obbedire al suo maestro d’amore, scesi dalla macchina e, senza voltarmi indietro, varcai la soglia del portone di casa, entrai nel mio alloggio e chiusi la porta dietro le mie spalle.
Da quel giorno piangemmo insieme tutte le nostre lacrime silenziose e invisibili, amandoci disperatamente nelle ore di scuola, donandoci completamente l’una all’altro senza un gesto o una parola.
Ma Catullo sulle sue labbra: Dammi cento baci, e ancora mille, poi cento e mille ancora… fu il suo regalo per le nostre nozze segrete e mai consumate, mentre tutto spariva intorno a noi e le
nostre emozioni si dispiegavano libere in un Eden parallelo dove un uomo può amare un’adolescente ed esserne riamato senza che nessuno lo possa giudicare sporco o immorale.
Furono tre anni di paradisi incontaminati, stillanti di
note e di cupi abissi infernali, formati da vulcani in eruzione, che tutto bruciavano e fondevano, lasciando solo una crosta vitrea fredda e indurita.
Io accettai di nuovo l’amore di Carlo, perché la solitudine mi avvelenava il sangue così violentemente da non permettermi neppure di respirare…
Frequentavo la Terza Liceo quando a maggio rimasi
incinta.
Non appena lo seppe, il professore mi lanciò uno sguardo incandescente di dolore e di nostalgia: i
suoi occhi mi gridavano in silenzio che quel bambino
avrebbe potuto essere suo.
Lui amava moltissimo i bambini ma non ne ebbe
mai uno.
Quando nacque la mia piccola era il mese di marzo, e io, appena ristabilita dal parto, in una bellissima giornata di sole, la adagiai nella sua carrozzina, col suo abitino più bello, tutta bianca, rosa e profumata e varcai di nuovo, per l’ultima volta nella mia vita, il grande portone di quel tetro santuario della cultura che era il Liceo, al suono della prima campanella.
Subito tutti quelli che mi conoscevano si raccolsero intorno a me, festeggiandomi e sommergendo di complimenti la mia piccola e deliziosa creatura, che con gli occhi sgranati guardava un po’ interdetta
tutti quei visi sorridenti.
Accalcandosi intorno a noi, mi accompagnarono di sopra per mostrarla a tutti i professori che mi accolsero con affetto e calore.
Solo lui trasalì da lontano, quando mi vide e aspettò
qualche attimo prima di avvicinarsi a me.
Ci salutammo cordialmente, reprimendo a stento le nostre telluriche emozioni. Lui allungò le braccia ed io gli porsi il frutto di un amore che non era il suo, per donarglielo comunque, come gli avevo donato tutta me stessa, rinunciando al nostro amore senza lottare.
La piccola gli strinse il dito che lui aveva fatto scivolare dolcemente sulla sua perfetta miniatura di mano e gli strappò un mesto e tenero sorriso che mise a nudo per un attimo il suo animo solitario
e straziato.
Poi, mormorando parole di circostanza in mezzo al clamore della gente attorno a noi, me la ripose delicatamente tra le braccia e, con il pretesto dell’imminente lezione si allontanò, senza più voltarsi indietro.
Questa storia ha un seguito, che ora scrivo di getto per la prima volta.
L'anno prima della mia partenza per la Sardegna, un giorno che ero tornata nella mia cittadina per stare qualche giorno con i miei figli e mia madre, recandomi in un negozio, incontrai un mio ex compagno di liceo che lavorava lì.
Ci salutammo con gioia e, come sempre succede in quei frangenti, ci raccontammo un po'.
Erano anni che non ci vedevamo.
Parlammo di un po' di tutto e naturalmente dei vecchi compagni.
Lui li frequentava ancora.
Ma io, che avevo vissuto venti anni in un'altra città, poco dopo il mio matrimonio e che poi mi ero allontanata definitivamente già da qualche anno, non avevo rivisto che pochi di loro.
Ma il mio pensiero ero andato immediatamente al mio amato professore.
Avevo seguitato ad amarlo sempre, senza interruzione di tempo e di intensità, fino a quel giorno, nonostante la mia vita avesse conosciuto altri amori.
Ma lui, lui aveva mantenuto il suo posto speciale, tutto a lui dedicato.
Così non resistetti e chiesi al mio compagno di studi se avesse notizie del nostro insegnante.
Il sorrisetto che spuntò sulle labbra del mio amico fu molto eloquente, però non disse nulla.
Mi racconto che il professore stava bene di salute, nonostante avesse passato già gli ottanta da un po', ma che era diventato molto triste e solitario. Che si era ritirato de tutte le molteplici attività che comunque lo avevano visto protagonista della vita della nostra cittadina, che aveva smesso di scrivere e pubblicare.
Insomma il quadro che mi fece fu assai preoccupato e preoccupante.
Ci salutammo dopo qualche minuto ed io mi recai a casa dei miei ragazzi, quella casa che era stata mia e che ora sentivo aliena e ostile.
Ma il pensiero della tristezza di quell'uomo così amato mi travolgeva, portandomi via ogni altro pensiero.
Fu così che presi carta e penna e gli scrissi una lettera.
Non gli parlai d'amore, ma gli ricordai quello che era stato per noi, gli dissi che il compagno mi aveva detto della sua tristezza e gli chiesi di accettare il mio affetto e la mia compagnia epistolare.
Lui mi rispose con la sua bella calligrafia fine e originale e si schermì.
Negò di essere triste, adducendo una naturale riottosità, mi redarguì dicendomi che ero stata esagerata come quando ero ragazzina nel descrivere la sua importanza per tutti noi suoi allievi e mi disse che ormai era troppo vecchio.
Mi offesi.
Quelle sue parole mi fecero male.
Ma come aveva potuto pensare che io gli stessi chiedendo ora quel rapporto che non gli avevo mai domandato?
Così gli risposi assai piccata che io volevo solo donargli il mio affetto e fargli un po' di compagnia epistolare, che lui aveva frainteso il mio intento e che io ero omosessuale, che l'avevo finalmente scoperto ed accettato,s e che quindi il mio interesse per lui era scevro di qualsiasi altra cosa che non fosse il desiderio di potergli alleviare in qualche modo le sue sofferenze.
Terminai la mia lettera dicendogli che se il mio affetto era una cosa a cui voleva rinunciare, sfacesse pure.
Imbucai la lettera pensando che non mi avrebbe risposto.
Mentre invece lo fece.
Seguirono così diverse lettere nelle quali lui si raccontò a me, dei suoi problemi famigliari e delle sue malinconie, mentre io gli raccontai un po' delle mie tante disavventure.
Poi un giorno non mi rispose più.
Né io lo sollecitai ulteriormente, travolta dai mie tragici eventi dei tentativi di suicidio che accompagnarono la mia storia d'amore di allora con Dana, la protagonista del mio primo romanzo, IO NON SONO DI QUI.
Subito prima di partire perla Sardegna passai ancora due o tre giorni a casa dei miei.
E un pomeriggio, passando per una strada del centro, lo incontrai.
Io ero in bicicletta e lui mi camminava davanti.
Fu un colpo allo stomaco da kappaò.
Riconobbi immediatamente la sua sagoma, pur se ingobbita e pur se stava camminando a testa bassa.
Nella frazione di un attimo milioni di pensieri accorsero alla mai mente, come un immenso stormo di uccelli che si levasse in volo all'unisono, spaventati all'improvviso dal colpo di un cannone.
Mi fermo, lo fermo lo saluto gli parlo lo abbraccio.
No.
Sono vecchia sono grassa, non voglio che mi veda così.
Lui è vecchio e stanco, non vorrebbe che io lo vedessi così.
Per la frazione di qualche secondo la mai bici gli scivolò accanto e poi lo superò.
Lui non si accorse di nulla.
Pedalai il più velocemente possibile fino a togliermi dalla sua visuale e poi mi fermai, ansante.
Tremavo dalla testa ai piedi.
Era lui, avevo visto il suo volto e tutto di lui in quell'infinito secondo in cui gli ero stata a fianco,
era lui eò pur nella vecchiaia dei suoi 84 anni, era ancora bellissimo.
Ma tanta tanta tristezza emanava il suo viso.
Mi appoggiai al muro e piansi, incurante di chi, passando, mi guardava.
Piansi e lo ami ancora come allora.
Poi la vita di nuovo mi travolse.
Non so nulla di lui, né se ancora viva o..............
ma non lo voglio sapere.
No mi importa...che importa saperlo?
Io e lui siamo ancora là:
' Da mihi basia mile, deinde centum, dein altera mille...'

LA COLONIA AL
MARE
Da ragazza, ho lavorato due estati in una colonia di una cittadina del mare Adriatico, un’accoglienza per bimbi della piccola borghesia padana e che a volte ne prendeva presso di sé, gratuitamente, con pretta pietosa mancanza di pietà, alcuni bimbi poveri provenienti dal sud Italia, molti dei quali già lavoravano come braccianti agricoli nei campi dei grandi proprietari terrieri che non avevano scrupoli ad impiegarli nonostante la loro tenera età, oppure negli orti di genitori e parenti che, essi stessi, conducevano una esistenza assai dura..
Erano gli anni’71 e ’72..
Allora la differenza tra il sud e il nord del nostro paese era più profonda e palpabile di ora ed io, che non conoscevo nulla di persona su questo problema se non quello che avevo letto sul ‘Manifesto’ o sui bollettini vari degli scioperi della rivolta studentesca, quando venni in contatto con questi bimbi, mi resi conto, stupita, di quanto davvero la loro vita fosse assai diversa dalla nostra..
Anzi, ripensandoci proprio oggi, dopo chissà da quanto tempo non lo facevo, sepolta dalle macerie di tutto quello che è crollato dopo sopra questo mio vissuto, ricordo bene la colonia in questione, che aveva un anonimo nome tipo ‘ Stella marina ‘, - o qualcosa del genere - ed era una struttura che ospitava bambini di ceto medio - povero, ma ancora dignitoso, provenienti dalle cittadine della bassa padana lontane dal mare, come Parma o Reggio Emilia, e aveva dedicato del grande edificio un po’ scrostato dalla salsedine, di colore giallino e circondato da un cortile ghiaioso punteggiato e ombreggiato di alti pini marittimi dal largo frondoso e odoroso ombrello, una dependance più piccola e bassa ai bambini poveri, ma poveri davvero, di un paesino interno del nostro profondo sud, di cui proprio ora non riesco più a rammentare il nome.
Io passai il primo turno del primo anno di questa mia esperienza lavorativa, con un gruppo di bimbetti maschi emiliani, coi quali mi sentivo più in sintonia nel dividere giochi ed interessi rispetto alle loro coetanee femminucce, ma li trovavo viziati, annoiati, incontentabili e meditavo di andarmene, perché quel lavoro non mi piaceva, mi annoiava e, inoltre, la cucina lasciava alquanto a desiderare.
C’era poi anche da dire che io, spirito libero e ribelle, poco mi adattavo a ‘ mantenere la disciplina’, imponendogliela, a questi poverelli già pieni di complessi e di difficoltà personali e quindi, dato che non riuscivo a trovare nessun dialogo con loro e neppure ad imporre la mia autorità, che non sentivo affatto di possedere, sui loro visetti impertinenti ma in un certo qual modo sofferenti e disadattati, questo faceva del mio gruppo il peggiore di tutta la colonia, così che la direttrice mi chiamava spesso nel suo grande ufficio di fianco al refettorio, che sembrava tanto un’aula scolastica deserta, per redarguirmi o spronarmi a fare meglio, cosa che inevitabilmente non mi riusciva.
All’inizio del secondo turno mente il primo, fatte su le poche cose, magliette, calzetti e ciabattine o zoccoletti, se ne tornava pieno di giubilo tra le braccia amorose o meno dei loro ‘ mamma e papà’, arrivò questo nutrito gruppetto di ragazzacci e femminucce chiassosi ed esuberanti, che parlavano con un accento a noi assai straniero: anzi alcuni di loro non parlavano neppure italiano, ma soltanto il loro idioma dialettale..
Arrivarono, scendendo dallo scalcinato pullman di linea che li aveva trasportati sin lì, nel loro primo, unico lunghissimo viaggio intrapreso fino ad allora e scesero come una torma rumorosa e frullante d’ali che si stiracchiavano, tutti compatti, occhi scuri lucidissimi, pelli scure e ambrate dal sole con, come bagaglio, i soli abiti che portavano addosso, in una confusionaria stinta, stropicciata macchia semovente multicolore.
Ma di un particolare, inatteso, erano colmi!
I pidocchi pullulavano tra i loro neri riccetti e le scure trecce femminili, lunghe fino ai fianchi, di capelli che mai erano stati tagliati dalla nascita.
L’allarme scoppiò come una bomba in tutta la struttura, tra esclamazioni a stento soffocate, piene di disgusto, del personale scelto per accoglierli e così, in un attimo, quei piccoli merli diventarono sparuti passerotti, chiusi tutti insieme, - che se avessero potuto li avrebbero ‘legati’ tutti insieme, - dentro il refettorio sprangato della dependance, soli.
Fuori il resto delle ’signorine‘ accoglieva i nuovi gruppi di urbani bambini, zittiti e spauriti, alcuni già piangenti, che chiamavano la mamma.
Signorine venivamo chiamate allora noi assistenti, scelte esclusivamente per il nostro aver accettato paghe esigue e trattamento senza pause e diritti, perché ci veniva chiesto di trascorrere tutta l’estate senza mai un po’ di riposo, notte e giorno, ad eccetto di uno solo tra un turno e l’altro, dormendo nelle camerate dei bimbi, divise e protette esclusivamente da una tendina di cotone e condividendo i, poveri, pasti con loro, senza che nessuna di noi avesse una preparazione specifica alla pedagogia, ma tutte affidandoci alla nostra buona volontà e inventiva, che alla fine diventava puro spirito di sopravvivenza.
Invece il gruppo delle addette a risolvere l’inatteso quanto fastidioso problema degli ‘altri’ bambini, era animato da accese discussioni.
Io allora, guardai il grappolo di femminucce che mi era stato assegnato, graziose nelle loro nuove magliette multicolori, prima di venir unificate nella ‘divisa’ che avremmo poi loro assegnato: vedendole chiacchierare a bassa voce, guardandosi intorno con occhi già pieni di ancora non inespresse pretese, sentii il mio cuore volare tra quegli occhi scuri, selvatici, pulsanti, che erano stati rinchiusi senza colpa e già reietti, dal resto della loro temporanea comunità..
Così mi recai di corsa dalla direttrice, affidando le ‘mie’ bimbe in attesa di salire in camerata per disfare le loro valigette di plastica con Minnie e Paperina dipinte sopra, alla collega più vicina, chiedendole di affidarmi un gruppo di quei ‘ maschi’ pidocchiosi e vivacissimi.
Ella mi guardò, scura in volto, per un attimo stupita, poi nella sua scaltra mente fece due più due, capì tutto e mi spedì col il resto del personale che già stava indossando cuffie e guanti, pronto, se pur assolutamente controvoglia, ad affrontare il POBLEMA vivente di quel bimbi ‘ alati’….
Diedero anche a me un camice bianco, cuffia, guanti e una tosatrice elettrica per capelli con l’ordine di: “ andare, tosare a zero tutti, maschi e femmine, spogliarli dei loro abiti che ammucchiati, sarebbero poi stati bruciati, lavarli ovunque energicamente con spazzole non proprio delicate, rivestirli con le divise usate del turno precedente e portarli finalmente a mangiare e bere, poi a dormire nelle loro camerate, una per tutti i maschi, quasi una trentina, una per le femmine, assai di meno di numero.”
Entrammo allora, così armate e paludate come dottoresse ignote ed estranee, nel refettorio-lager e fummo accolte da esclamazioni di stupore e diffidenza, da quegli occhi mobili ed attenti, diventati torvi e introversi.
La fase dalla tosatura fu la più difficile, soprattutto per le bambine che mai avevano ricevuto quell’onta e che, sentendosi private dell’immagine della loro femminilità, piangevano disperatamente, arrabbiate, snocciolando lunghe serie di anatemi a noi incomprensibili, tra le crisi di prurito isterico che sconvolgevano l’una dopo l’altra le ben nutrite ed educate signorine della mia età, non avvezze a quel contatto ‘impuro’.
Io, amante di tutti gli animali, delle formiche e delle api, dei maggiolini e delle coccinelle, delle lucertole, dei topolini, delle piccole serpi dei nostri fossi, non nutrivo alcun problema verso quelle bestioline, si fastidiose ma sicuramente desinate al genocidio e quindi mi prodigavo alacremente per tosare più testoline possibile, cercando facezie ed imparando subito le loro esclamazioni dialettali, chiamandoli a me con quelle stesse loro parole rinfrancanti, finché non mi trovai circondata da una frotta di uccellini che mi dicevano: “ Signurì, ammè, ammè!” sorridendo, alcuni sdentati nel cambio dei dentini da latte, altri, i più grandi, con già l’innata deferenza verso la figura femminile mista al sentimento di comando, che orgoglioso reprimeva paura e smarrimento in frasi sboccate e parole ‘da grandi’, delle quali io non capivo l’esatto significato ma intuivo la sostanza a sfondo sessuale e malizioso.
Finita la tosatura di quel gregge a due gambe, le femminucce tremanti e ancora sotto shock che si passavano la mano incredula sulla rasa piccola rotondità del proprio cranio, lanciando sguardi colmi di sofferenza e rimpianto per le loro belle trecce corvine e crespe gettate a terra come un mucchio di scalpi, furono portate in un bagno a parte e lavate da altre due mie colleghe che continuavano a disperarsi per la loro propria capigliatura, programmando immediate e prolungate abluzioni con aceto caldo o shampoo antiparassitario di farmacia, mentre io accompagnai, insieme ad una delle cuoche, una donna robusta e taciturna di origini meridionali anch’essa, nel bagno più grande la ‘mia’ torma ridacchiante, nuda come piccoli vermini bruni di terra, magri, alcuni addirittura ossuti, ma forti ed avvezzi alla fatica, dei quali nessuno copriva con le mani le proprie parti intime, come mi sarei aspettata, ma reagendo con infantili quanto già consce erezioni spontanee, che venivano esibite con orgoglio prettamente maschilista di una prematura ma già dichiarata supremazia del loro apparato genitale, il tutto accompagnato da risa, motti sguaiati e spalle dritte di dignità ed orgoglio.
La pelle delle loro infantili membra, abituate di certo più all’acqua piovana o di fossi e torrenti che a quella della doccia e di quel sapone forte e maleodorante, disinfettante ed antiparassitario, si arrossava al contatto di quella poco gentile brusca, ma nessuno protestava e si giravano docilmente, alzando braccia e gambe, impudici, sfidandomi ad affrontare le loro orgogliose nudità per poi arrendersi ai dolci massaggi delle mie mani che, abbandonato lo sgraziato violento strumento, ammorbidiva lo sporco incrostato dall’abitudine di vite selvatiche ma vive e dignitose, che era la loro protezione naturale al sole troppo caldo delle loro pianure assetate e all’aggressione degli insetti ematofagi, come pulci, zecche e zanzare.
Alla fine di un faticoso quanto inedito pomeriggio di lavoro, con le loro risa e sgomenti mascherati da orgoglio, rivestiti tutti, maschi e femmine, di magliette bianche e calzoncini blu recanti i segni del passato turno, fu data loro una cena, abbondante per fortuna, che, ormai stanchissimi ma affamati, spolverarono in fretta, usando velocemente le mani.
Spezzavano il pane con gesti antichi di ammirazione e rispetto che credevano nella sua divina gratificante natura e annaffiavano la loro sete e arsura provocata dall’infame sapone che li aveva grattati in profondità, con caraffe di acqua dolce e fresca, lievemente ferruginosa e sterilizzata col cloro del nostro ‘civile’ acquedotto, che così differiva da quell’acqua naturale alla quale loro erano abituati, ma che fu da tutti comunque immensamente gradita.
Poi, richiamati attorno a me, accorrenti, assonnati ma ancora attivi e attenti, li accompagnai nella ‘ nostra’ camerata, circondata dai loro” Resti cun noi, signurì?”, affidandoli uno per uno ai loro lettini vestiti di lenzuola candide che forse mai avevano provato, su materassi comodi e morbidi guanciali, dove sprofondarono in pochissimo tempo in un sonno profondo, che si accendeva nei loro corpi sfiniti sfumandosi sulle loro labbra in spontanei “ Notte, signurì!”, ai quali rispondevo con il cuore emozionato e stranito, prendendo ad uno la mano, all’altro passando la mia sulla testolina rapata e pungente o donando ai pulcini più piccoli uno schioccante bacetto sulla guancia ormai addormentata.
Mi aggirai fra di loro finché non restai sola con il silenzio dei loro lievi regolari respiri di sonno, interrotti ogni tanto da qualche incomprensibile distorta parola che sfuggiva alle loro labbra e menti addormentate.
Poi, sfinita, mi accucciai nella mia branda, paludata dalla tenda lasciata socchiusa, dopo aver risciacquato l’abbondante sudore del lungo pomeriggio con una doccia fresca e ristoratrice e mi addormentai con loro, sentendo ancora il corale vociare – signurì…signurì..
Sono passati tanti anni da allora, ma io ricordo ancora i visi, le canzoni da taverna, - ohi Marì, ‘cun sta pioggia e cun ‘sto vento chi è che bussa al mio convento, e attacate astuccordone - che mi insegnarono, tra le chiare sabbie di giochi comuni con i sassi e le biglie, i noccioli di pesca seccati al sole, le capriole, le mani sulle spalle, a volte sul mio seno adolescenziale, mente la loro lingua dialettale diventava velocemente la mia, nella sua spontanea arguzia e ricchezza di naturalità.
Erano bimbi-adulti, che non erano quasi mai stati a scuola e che già da sempre lavoravano negli orti e nei campi, a contatto con galline ed armenti: della vita sapevano già tutto, imparato dagli accoppiamenti degli animali nei cortili delle povere case e nell’ombra ronzante delle stalle.
Ne sapevano più di me, che studiavo il greco e il latino al liceo classico e che guidavo la rivoluzione culturale studentesca e me lo insegnarono con racconti di abitudini antiche, da me mai conosciute e forse ormai sparite per sempre, seguendomi per anni a venire con lunghe teorie di cartoline postali inviatemi a Natale e Pasqua, recanti con la malferma calligrafia, i loro nomi, Nicò, Mattè, Rocco, Antò, Giusè, Vituzzo…. e la dicitura “ tanti auguri e ossequi, Signurì!” , che sempre facevano scorrere lacrime di amore e nostalgia per quelle lucenti vite esuberanti e sincere, nate e forgiate da una terra faticosa e ingrata, quanto orgogliosa e vitale.
Per tutto il turno di un intero mese fummo lasciati a noi stessi, comunità a parte, con regole accordate tra noi e mai disattese da nessuno, fiorite dalla mia comprensione e amore che sfociava e fioriva nei loro amore e comprensione.
Oggi essi sono giovani uomini e qualcuno di loro forse non è già più, perché allora già minato ai polmoni o al cuore da nascite predestinate a morti precoci.
Ma, come io ricordo di ognuna di quelle ‘cocce pelate’, gli occhi e l’atteggiamento tumido delle labbra, passionali per genesi, così, sono sicura, essi ricordano di me le carezze, i lazzi, le canzoni urlate a squarciagola lungo le obbligatorie marce serali sotto l’ombra del viale orlato dai pini:
ohi Marì, ohi Marì, famme ddurmì unanuotte bbracciata cuttè …e togliteacmmisella…a cammisella, gnornò,gnornò………………..

IL SALUTO
DELLA VECCHIA
128 FIAT
GIALLONA
Quando, dopo diversi anni di matrimonio, mi separai dal mio primo marito, amico e sostegno della mia adolescenza infelice, dovetti affrontare anche il dilaniante distacco dalla amatissima casa, ornata da mobili rustici di fattura artigianale, nella quale vivevamo insieme alla nostra riottosa figlioletta.
Un’ulteriore sofferenza che si sommava al dolore di lasciare una persona che amavo e che amo tuttora come un fratello, ma che non poteva più essere il mio compagno di vita, poiché sempre più forte cresceva in me il desiderio, represso poi ancora per molti anni, di avere al mio fianco una compagna.
Ci fu allora l’addio ai miei adorati animali, sorella cavalla in primis, che fu donata al vicino circolo ippico del quale ero assidua frequentatrice, sapendo che lì avrebbe ricevuto tutte le attenzioni di cui aveva bisogno e che io non avrei potuto più garantirle.
Poi seguì un altro addio, quello a tutti gli altri
miei cari amici a due e a quattro zampe, per non allontanarli dal loro habitat quotidiano, dato che era impensabile trasferire la mia piccola arca di Noè in una villetta di 46 metri quadrati, ornata da un fazzoletto di giardino urbanizzato invece dell’ettaro di terreno recintato, ombreggiato e sicuro che ospitava i loro curati e pulitissimi alloggi.
Infine fu doloroso anche l’abbandono di alcuni oggetti diventati preziosi per l’uso quotidiano che ne facevo, lasciati all’uomo, allora innocente, che abbandonavo non per scelta ma per un irrefrenabile e furente impulso interiore.
Non volevo svuotare il nostro nido, che affidavo a lui intatto com’era, nell’impossibilità di profanarlo, portando con me nella mia nuova casa solo i miei effetti personali e quelli della nostra bambina.
Portai però con me la nostra seconda auto, una vecchia 128 Fiat, che stava tirando il fiato con i denti e che noi chiamavamo, con affettuosa derisione, Giallona, per l’orrido colore ocra acceso.
Proprio quel colore accresceva la sua ormai dichiarata e raggiunta estraneità alla vita corrente, nella quale ancora prestava il suo servizio prezioso di trasportarci ovunque volessimo andare, pur denunciando in pieno l’avvicinarsi della fine già sancita dei propri giorni e della propria specie.
Io amo le cose e mi circondo sempre di quelle di cui percepisco l'amore, dato che sono in grado, per una mia sensibilità particolare, di captare i sentimenti silenziosi che emanano e che provano nei miei confronti.
Le cose non sono tutte uguali. Hanno anche loro un'anima, un carattere, una tendenza e la rivelano a chiunque sia un attento ascoltatore e spettatore.
Per questo chi, come me, è capace di accogliere dentro di sé la vibrazione emessa da ogni essere intorno, vivente o meno, si accorge della grande differenza che corre tra un oggetto e l'altro.
Davvero Giallona mi amava in modo incondizionato, tanto che ogni mattina ce la metteva tutta per avviare i suoi esausti ingranaggi, emettendo brontolii sempre più accorati di sforzo e raggiungendo sempre più tardi il proprio intento.
Ogni giorno o quasi, però, perdeva una delle sue funzionalità accessorie ma non per questo
poco importanti: oggi non funzionava più il tergicristallo, domani la ventola interna dell'aria... una settimana dopo si bloccava un finestrino e così via.
Ma lei, impavida cocciuta e generosa, ogni mattino, presto o tardi, andava in moto e mi portava al mio lavoro.
Io e mia figlia, accarezzando ogni volta il suo nero cruscotto di similpelle tutto liso e screpolato, ci dicevamo che non sarebbe durata più a lungo e che avremmo dovuto cambiarla con una vettura più recente, ma nel dirlo provavamo una specie di sgomento dentro e un dolore soffuso insieme ad un specie di riluttanza di fronte alla sensazione di avvertire la tristezza emanata da quell’anima meccanica, giunta alla fine dei suoi giorni di onorato e indefesso servizio…
Così il tempo passava, inesorabile e Giallona restava con noi; finché, una fredda mattina sferzata dalla pioggia e dal vento, non riuscì nel suo consueto sforzo quotidiano, la batteria l’abbandonò definitivamente e lei, mesta, si arrese inevitabilmente, ma rassegnata al suo destino, lasciandomi seduta sul suo sedile un po’ distorto a guardare la chiave di accensione divenuta un inutile pezzetto di metallo buffamente sagomato.
Mi recai al lavoro in bicicletta, percorrendo quei pochi chilometri sotto il temporale, arrivando perciò alla mia destinazione stanca, affannata e irritata per il ritardo, tutta bagnata e infreddolita.
E questo fu abbastanza per farmi decidere di acquistare un'auto nuova.
Erano i tempi quelli in cui potevo farlo: alzare la cornetta del telefono prendere un appuntamento in una concessionaria, scegliere un'auto, firmare un sacco di fogli per un finanziamento millenario e via.. uscirmene contenta con la macchina nuova..
Così, quel mattino stesso, cercai e trovai la sua sostituta. - che comunque non amai mai e che rappresentò fino all’ultimo per me una fonte di guai e di avversione, - e al telefono concordai col venditore che mi sarei recata io stessa a prelevare la nuova auto, lasciando la mia vecchia amica Giallona al suo triste destino di rottamazione.
Nel pomeriggio infatti, aiutata da un vicino di casa a rimettere in moto con i cavi della batteria la moribonda 128, mia figlia, che non voleva perdere assolutamente il primo viaggio della nuova automobile e io le facemmo compiere il suo ultimo tragitto.
Quando arrivammo alla concessionaria prescelta, la pioggia era cessata, lasciando uno squarcio di sole invernale a far brillare le goccioline d’acqua sul giallo della carrozzeria e sul parabrezza, solo in parte asciugati dal vento durante il viaggio.
L’addetto che ci aspettava ci mostrò dove parcheggiare la vecchia auto da rottamare e se ne andò voltandoci le spalle, del tutto indifferente ed avvezzo a quello che per lui era una storia di quotidiana abitudine, mentre io entravo in uno spiazzo recintato e facevo manovra per parcheggiare la nostra vecchia auto di fianco ad altri ruderi in attesa di essere ridotti a scatolette di lamiera.
In quel momento fui assalita da un dolore acuto, come se invisibili dita di ferro mi avessero stretto il cuore in una morsa.
Immaginavo la Giallona che piangeva lacrime di olio, benzina e antigelo.
Ma il tempo stringeva, il venditore ci attendeva per espletare le ultime formalità e mia figlia mi era accanto ed io mi ero accorta che lei pure si stava facendo prendere dalla malinconia di quell'addio.
Regalai, quindi, un’ultima carezza alla vecchia auto, passando lentamente la mano sul cofano ancora umido e un ultimo bacio furtivo, lieve quanto accorato, sull’orlo dello sportello che si era aperto per accogliermi innumerevoli volte, in preda ad una sensazione di estraneità dalla vita terrena che mi avvicinava incredibilmente a quello che per i terrestri era diventato ormai solo un ammasso inutile ed inservibile di lamiere, mentre per me era un cuore fratello, un'anima amica..
Poi, cercando di nascondere la mia inusitata quanto incomprensibile emozione, mi voltai di scatto dandole le spalle, mormorando: «Addio, Giallona, e grazie di tutto…»
Infine presi per mano la mia bambina, che ora scalpitava per vedere l’auto nuova, le girai le spalle e mi diressi verso l’addetto che, poco più avanti, attendeva impaziente sulla soglia dell’officina antistante agli uffici.
Dovete sapere, tra le varie cose, che Giallona era muta: lo era stata da sempre, o almeno da quando la comprammo noi da un amico per un pugno di spiccioli, adattissima agli scopi di auto di servizio e di sostegno per le giornaliere necessità famigliari e, mentre invece l’ammiraglia di casa dormiva riparata nel suo ampio e ben costruito garage, lei trascorreva le sue notti all’aperto, sotto le stelle, al caldo o alla fredda pioggia invernale, immersa nella nebbia della bassa padana, cosa che non aveva fatto altro che incrementare effettivamente questa sua congenita o acquisita afonia…
Per quello non avevamo mai sentito la sua voce.
Ma, come ci fummo allontanate da lei una decina di passi, un grido meccanico però estremamente umano, scaturì dalle viscere metalliche di Giallona e inondò del suo pianto addolorato l’intera officina, scuotendo e facendo sollevare la testa a tutti i meccanici al lavoro, chini dentro le fauci spalancate delle auto ammalate che stavano curando e facendomi tremare le ginocchia fino quasi a piegarmi per terra.
Era Giallona che, per salutarmi, abbracciarmi e ringraziarmi per l’ultima volta, aveva ritrovato la sua voce.
Una voce straziante e penetrante che gettò tutta quanta, nella sua veemenza data da un lungo silenzio e un lungo incondizionato amore, in uno straziante, assordante, profondo, accorato, disperato indimenticabile addio, fino a quando uno dei meccanici, infastidito, accorse, aprì l’intimità del suo cofano e con una gelida, impietosa tronchese, le tagliò di netto le ritrovate corde vocali, sancendo definitivamente il suo silenzio e la sua morte.
Io mi asciugai frettolosamente le lacrime.
«Senti, la nostra Giallona ci sta salutando per l’ultima volta…», sussurrai a mia figlia commossa e piangente .
Poi, guardandola ancora un attimo con amore, facemmo ciao con la mano e abbandonammo quel freddo capannone, dove venivano abbandonate al loro destino di morte le auto dismesse, senza pietà, né più uno sguardo di affetto, dopo aver dimenticato il tempo in cui esse erano state lustre e nuove e noi le avevamo guardate con orgoglio e meraviglia e del tutto incuranti del fatto che un'auto potesse o meno provare sentimenti e sensazioni, pur se espressi in modo diverso dal nostro.
Questa è una storia vera, autentica come le lacrime che stanno scendendo ancora dai miei occhi, una storia dedicata all’amore silenzioso ed altruista che ci donano tutte le cose inanimate, senza chiedere mai nulla in cambio, fino a che non si rompono o noi, annoiati e perennemente insoddisfatti, non le condanniamo alla rottamazione per lasciare il posto ad altre che ci illudiamo possano essere migliori.

IV sezione
L’ASSOLUTO NATURALE
LE OCHE
A quei tempi vivevo in una casa di campagna perduta in mezzo a centinaia di ettari di terreno pianeggiante a pochi chilometri dalla riva al mare Adriatico, nella mia bella dolce e laboriosa Romagna.
Erano terreni coltivati a frutteti, vigneti, grano, barbabietole da zucchero, spinaci, granturco, fragole, piselli, fagioli, erba medica e tutte quelle culture che abbisognavano delle falde freatiche alte ed abbondanti di quella terra un poco argillosa e ubertosa che la cura certosina dei piccoli proprietari e dei braccianti riuniti in cooperative ha reso un giardino fiorito e prospero dato che viene coltivata come si conserva e si rispetta un tesoro che può moltiplicarsi solo se trattato con amore e cura parenterale.
Era il sogno dalla mia vita che si era avverato, al quale tendevo sin da bambina, e quando mi affacciavo alle piccole finestre a volta ricavate nello spesso e antico muro portante di mattoni fatti a mano e disposti a vista, con artigianale attenta perfezione, il mio sguardo si perdeva sulle distese di verdi e di bruni cangianti.
Seguivo l'aspetto mutevole della campagna che mi stupiva e mi affascinava con la sua danza avvinta al volgersi delle stagioni e dell’inclinazione del sole, al passaggio delle nuvole o alla quantità di pioggia che era caduta portando sollievo alla sete estiva o rinforzando i fossi e torrenti d’inverno.
Erano corsi d'acqua che correvano senza sosta verso il mare non troppo lontano, ingrossandosi ad ogni incrocio con un altro rivo, fino a diventare dei veri e propri fiumi, non più costretti dalla piovosità del cielo ad esistere o ad asciugarsi.
In quella casa antica e rimessa a nuovo dall'azienda per la quale lavorava, Carlo io e e la nostra bimba eravamo felici.
Avevamo fatto recintare una vasta area di terreno tutto intorno, della grandezza di un ettaro circa.
Avevamo piantato con le nostre mani numerosi pioppi - che con la loro crescita veloce avevano fornito presto ombra e frescura nelle calure estive, quando il sole impietoso saliva allo zenit di quel cielo sempre un po' fumoso di umidità - e tante altre specie a crescita più lenta: aceri querce noci, non tralasciando i cespugli di giuggiole e di melograno, la lavanda e il rosmarino, decorando infine la facciata della casa con roseti rampicanti, che in breve divennero mosaici di colori e profumi, e grandi vasi con altre rose ad alberello.
Inoltre, per esaudire il nostro perentorio desiderio, avevamo acquistato e fatto crescere diversi piccoli di animali domestici e di cani e gatti, che erano divenuti i capostipiti di gruppi e famiglie che vissero con noi fino alla loro morte naturale.
Così, quando mi affacciavo alla finestra, potevo guardare i miei amici animali, vivere le loro serene e quiete vite, nei loro appositi ampi e ombreggiati spazi.
Dovunque si spostavano le galline, preziose per le uova fresche da dare alla nostra bimba che era spesso malata e quindi troppo magra.
Avevamo scelto le rosse padovane che erano forti e non troppo grosse, ma perfette ovaiole e queste di giorno erano fulve chiazze razzolanti nell'erba.
Ma la sera la loro scaletta di legno le portava al comodo ricovero notturno con la paglia spesso cambiata e fragrante, dove potersi appollaiare al sicuro nel buio della notte o deporre il loro magico frutto al canto del nuovo mattino.
Più in disparte viveva il gruppo assai numeroso e schiamazzante delle anatre reali, che avevano a disposizione una grande vasca piena d’acqua sempre rinfrescata e ripulita, dove esse fingevano i grandi stagni di cui erano degne ed allevavano i loro piccoli: leggere barchette in un frullio di minuscoli ali e penne e piume color giallo screziato.
Nel porcile, costituito di una stanzetta ed un piccolo recinto all'aperto e che era situato nella costruzione comprendente il forno il fienile e il granaio, avevamo alloggiato la capretta. Lei però non amava affatto stare rinchiusa e sempre belava, quando ci vedeva o sentiva la nostra voce, impietosendoci e convincendoci a farla uscire dal suo stalletto, dove alla fine stava assai poco.
Quindi, avuta la libertà, quella peculiare creatura ci correva dietro per aver in cambio del suo smisurato ed un poco interessato affetto una sigaretta...
Sì.. avete capito bene, proprio così!
Una sigaretta spenta, ovviamente, che lei chiedeva con insistenza venendoci accanto, alzandosi sulle zampe posteriori e posando quelle anteriori contro le nostre gambe e che mangiava con la golosità di un vecchio cow boy masticatore di tabacco..
Era una capretta tibetana di taglia assai piccola, bianca con la classica toppa marrone sulla testa e si chiamava Bililla.
Ricordo assai bene e non potrò mai dimenticare il giorno in cui, era una domenica mattina assai di buon'ora, Carlo tornò a casa dal suo consueto giro di ricognizione con quella piccolissima bestiola tra le mani.
Era appena nata ed era rimasta orfana, dato che la madre se ne era andata per le complicazioni date dal parto eccezionale di cinque cuccioli.
Il boaro, che era il suo proprietario, si era visto disperato al pensiero di crescere cinque orfanelli con il biberon e aveva chiesto a Carlo di dargli una mano, adottandone una.
E lui, certo di fare un cosa più che grata, senza neppure pensarci su la prese con sé.
Infatti io accolsi con vera gioia il nuovo arrivo e decidemmo immediatamente di recarci insieme nella camera della nostra bimba che ancora dormiva: aprii allora la finestra per far entrare la luce e lui le pose la creatura tra le braccia.
La piccola, dopo un attimo di stupore e meraviglia che la fece restare a bocca aperta e senza parole, esplose in grida di gioia:
' Bililla bililla bililla!!! ' che nel suo gergo infantile significava: ' bellina '….
E così, Bililla fu, che visse a lungo e ci diede la gioia di veder nascere diversi caprettini.
Tra la casa e il giardino vivevano i miei grandi cani levrieri scozzesi, dal pelo ruvido e grigio argentato: Neroli, la madre, acquistata in Inghilterra, Amaranthus e Artemisia, due suoi figli nati a casa nostra e la loro cugina tedesca, Isca vom Aslachov.
Essi, quando uscivano fuori dopo aver trascorso la notte tra i letti ed i divani di casa, nelle ore più calde dell’estate dormicchiavano quieti all’ombra dei pioppi che presto avevano riempito il giardino di ombre accoglienti e frondose.
Oppure si scatenavano in grandi partite di rimpiattino fatte di scatti, rincorse, frenate improvvise e rovinosi capitomboli di gruppo, come bimbi gioiosi che si cimentassero nella lotta dopo essersi rincorsi a lungo, fino allo stremo delle loro forze.
Nella stalla che occupava quasi per intero il piano terra della casa e che era una stalla per buoi con le pareti a mattoni a vista disposte a spina di pesce nelle volte a sesto ribassato sorrette da colonne anch'esse di mattoni, aveva trovato il suo box la mia cavalla, Tuba, che lì trascorreva la notte e le ore di brutto tempo, con la paglia pulita che le arrivava alle ginocchia e la mangiatoia sempre rifornita di fieno fresco e profumatissimo coltivato ed imballato proprio nei nostri campi.
Ma appena possibile lei veniva portata nel suo grande recinto, una volta nostro orto poi divenuto suo prato personale e campo di battaglia contro le immancabili mosche cavalline, nonostante io la spruzzassi sempre di repellente, dove brucava l’erba fresca e sempre abbondante, scegliendola da vera gourmet, filo per filo, protendendo quel mobilissimo e morbidissimo labbro superiore che fungeva da appoggio alla lingua, per la raccolta succulenta delle parti più tenere e fresche.
Spesso però, sedotta dalla libertà e dalla felicità del suo vivere, ella si lasciava andare in rapide galoppate e sgroppate, come scalciasse al vento.
Nonostante io la montassi tutti i giorni, a parte quello dedicato al riposo di entrambe, la sua vitalità era incredibile, poiché era molto giovane, e i suoi giochi ancora infantili terminavano tutti, con mio grande dispetto dato che poi toccava a me toglierle a suon di striglia e brusca la polvere dal mantello baio che volevo sempre perfettamente lustro e pulito, in grandi rotolarsi a terra, goffi come quelli di una tartaruga rovesciata sul suo guscio, mentre con le lunghe nevrili zampe graffiava il cielo, lui pure sorridente come me alla sua allegria di puledra un po’ troppo cresciuta.
E un luogo adatto avevano in ogni angolo i nostri cinque gatti, Nerone, Giuliocesare, Bettina, Pisolona e Cerere, che non avevano paura dei cani, i quali soggiacevano volentieri alla ferrea legge che nessuna creatura vivente della nostra fattoria fosse di loro possesso.
I felini, di cui i maschi erano neri, Bettina era tigrata, Pisolona color crema a pelo lungo mentre Cerere era grigia anch'essa a pelo lungo, nei giorni di bel tempo sceglievano un inforcatura di rami o un muretto del casotto che includeva il forno per fare il pane, il pollaio ed il porcile, divenuto’ caprile’, per osservare se un qualche topolino si avventurasse a sfidare la sua sorte, destinato a finire tra le loro rapaci grinfiette, nonostante i miei inutili rimproveri, oppure per appisolarsi al sole con gli occhi socchiusi e le zampe ripiegate sotto la loro morbida e calda pancina, in pose composte, quasi affettate.
Ognuno dei nostri beniamini riconosceva perfettamente il proprio nome, al quale richiamo accorreva festoso per ricevere le propria dose di pappa e coccole, che non erano mai scarse, né le une né le altre.
Era così bello e particolare quando, le sere d’estate all’imbrunire o nel primo pomeriggio nei mesi più freddi, al momento della libera uscita generale io mi avviavo, aperto il cancellino che dava sui campi, per la lunga carraia erbosa che correva segnando lo snodarsi delle colture e dei frutteti.
Tutti quanti mi seguivano.
I cani mi precedevano rincorrendosi fra di loro, come impazziti di gioia per la totale libertà che potevano assaggiare, andando ad annusare gli invisibili cammini delle lepri o quelli più odorosi dei fagiani e dei ricci, mentre tutti gli altri animali mi seguivano, gattini e capra compresi, ognuno col suo passo, approfittando della passeggiata per aggiungere qualcosa di succulento alla loro cena.
Ma c’erano tra di loro tre peculiari individui dei quali non vi ho ancora narrato, che erano i sussiegosi padroni di tutto e si arroccavano il diritto di mettere il becco in ogni angolo, in ogni giaciglio, in ogni scodella, rispettati da tutti quanti i nostri amici animali senza alcuna defezione, come il loro rango fosse sancito da una legge non scritta ma riconosciuta da tutte le varie specie.
Erano le nostre oche, un maschio e due femmine, completamente bianche in tutta la loro ricchezza piumata, a parte il maschio che aveva appena una macchia nocciola chiaro che gli segnava metà della testa come una piccola corona di re e signore del contado: Mastrooco con le sue signore Guendalina ed Adelina.
Esse stavano e si muovevano sempre in un gruppo indivisibile e comunicavano reciprocamente con un chiacchiericcio sommesso e continuo, fatto di varie arrochite espressioni che si elevavano fino all’esplosione culminante del loro canto a squarciagola, eseguito impettite su tutto il loro corpo affusolato e maestoso, aprendo le ali e sbattendole diverse volte, come stessero per prendere il volo, mettendo in mostra il petto candidissimo e proteso, allungando tutto il collo e come danzando in punta di piedi.
Le nostre oche capitoline non avevano gradito il giaciglio che avevamo approntato per loro in una nicchia profonda e sicura sotto il forno, un tempo atta a contenere la legna per il fuoco, e si servivano di quel luogo solo quando le femmine deponevano le uova su di uno spesso strato di paglia fresca e scricchiolate, una al giorno ciascuna fino a quando, finita la ‘scorta’ interna, circa una dozzina a testa, vi si accomodavano mollemente l’una accanto all’altra, sempre chiacchierando, tutte attente alla cova.
Esse in quei delicati momenti erano guardate a vista dal loro marito, agguerrito battagliero e pronto a mettere in fuga qualsiasi essere vivente che si avvicinasse troppo al prezioso evento di cui lui era stato fautore ed ora si faceva garante, mal tollerando persino la nostra venuta col becchime e l’acqua fresca che serviva in abbondanza, data l’alta temperatura raggiunta dal corpo delle due femmine che, come una febbre procreatrice, permetteva il miracolo della schiusa delle uova.
Al di fuori di quel periodo esse pattugliavano l’intera area recintata che circondava la nostra straordinaria casa, alla ricerca di insetti, grilli e zanzare, per integrare la propria quotidiana razione di becchime.
Infatti godevano di ottima salute ed erano belle grasse e robuste, sempre perfettamente pulite, dato che vivevano in un ambiente totalmente erboso ed accudivano al loro piumaggio con una cura e un assiduità notevoli.
Per dormire, però, esse si accucciavano accanto ai tre gradini che introducevano al portone d’ingresso della nostra casa, anch’esso con la volta ovale come le finestre, preferendo il duro impiantito di porfido alla loro comoda paglia.
E questo avveniva con qualsiasi tempo, dato che ovviamente la pioggia non dava loro nessun fastidio, anzi, era accolta e salutata con grande festosità e cerimoniae di ‘ finta partenza’ per il lungo volo migratorio che esse avevano ancora nei ricordi ancestrali ma che non compivano più.
Erano delle vere ‘oche da guardia’ ed avvisavano con le loro acute e un po’ stridenti grida l’avvento di un qualsiasi visitatore, accondiscendendo all’avvicinarsi di questo alla nostra porta solo quando uno di noi aveva fatto loro capire che nessuno era insidiato da quella visita e che nessuno dei componenti della nostra allegra fattoria correva alcun pericolo.
Era davvero una fonte di meraviglia esilarane il loro comportamento aggressivo ed impettito, nel quale profondevano tutto il loro impegno e in cui si mostrava tutta la loro maestosa sicurezza di sé.
Esse erano creature alate, anche se non più solcanti i grandi spazi del cielo, e sopperivano a questa modificazione apportata loro dall’uomo con la selezione genetica, affermando a viva forza con il loro carattere il sentirsi appartenenti ad una schiatta superiore: non per niente esse avevano salvato proprio la regale città di Roma da una pericolosa invasione di ‘ barbari’ con la loro guardia attiva ed efficace.
Tutto quindi filava tranquillo e ben organizzato nella routine rumorosa e movimentata della nostra pace agreste e lo svolgersi dei mesi e degli anni avveniva operoso e sereno, quando un evento straordinario ed inatteso venne a portare un totale scompiglio alla gerarchia animale domestica.
Un giorno ci telefonò un nostro conoscente allevatore di cani che ci propose di accogliere presso di noi Bessy, una femmina di razza bassotto a pelo raso che, avendo finito la sua carriera espositiva e riproduttrice per raggiunti limiti di età e già ricolma di onori e gloria cinofile, cercava una casa amica ed accogliente dove vivere quello che restava della sua vita.
Noi eravamo molto amanti dei cani bassotti e ne avevamo avuti altri, come piccoli anche se fieri e belligeranti amici, tra la quantità di cani che ci accompagnarono durante i lungi anni del nostro matrimonio.
Così io e Carlo fummo felici di averne di nuovo uno e di godere della sua viva ed intelligente compagnia; ma questa volta facemmo i conti senza l’oste.
Il ‘piccolo’ particolare che il nostro ‘amico’ allevatore aveva omesso di dirci era che questa all’apparenza innocua cagnolina che aveva già più di dieci anni e pesava si e no sei chili, era una vera killer di tutte le specie animali che le si presentassero a tiro, dato che era stata addestrata per le gare in tana con la volpe vera.
Pur se nello svolgimento ufficiale di queste la povera volpe era protetta e l’agone finiva senza alcun spargimento di sangue, sicuramente all’inizio dell’addestramento il sangue di qualche innocente preda, come un coniglio o un leprotto, era stato versato per accendere nella battagliera creatura a gambe cortissime l’istinto alla cerca, all’abbaio sulla traccia e all’attacco al momento del fatale incontro.
Quando andammo a prenderla essa si dimostrò assai festante con noi e docile e ci seguì volentieri, per nulla preoccupata di lasciare il ristretto recinto dove aveva trascorso tutti i suoi non pochi anni.
Noi un po' ci stupimmo di questo e pensammo che forse Bessy non avesse mai ricevuto in tutta la durata della sua vita tante carezze e coccole come gliene facemmo noi, ricevendola dalle mani del suo allevatore e facendola salire sulla nostra auto, nonostante puzzasse fieramente dato che la parola ‘ bagno ‘, secondo noi, le era del tutto sconosciuta.
Ma appena giunta a casa la ‘delicata e tenera’ vecchietta si trasformò in un piccola furiosa belva assetata di sangue, assalendo, proprio sul portone, Bettina, la prima e più sfortunata delle nostre gattine che le capitò a tiro.
Fu solo il coraggio incosciente e generoso di Carlo che strappò la micetta a morte certa poiché, con grande coraggio, egli si frappose fra le due belligeranti, rimettendoci la pelle di entrambe le mani, graffiate e morse profondamente dal terrore e dalla furia cieca di entrambe, fino a che io non riuscii ad intervenire acchiappando la ‘vecchietta’ per la collottola e portandola fuori dalla portata della povera gatta che se ne fuggì a rotta di collo e che rimase per tutto il resto della sua vita ai margini della nostra proprietà, vivendo semi nascosta e semi randagia, accettando il cibo solo quando ci eravamo allontanati e non facendosi mai più toccare né avvicinare da nessuno.
Questo ci gettò in uno sconcerto totale ed in particolare addolorò molto me, che piansi calde lacrime sulle mani massacrate del mio caro compagno, mentre gli medicavo le sanguinanti e profonde ferite, lacrime versate in parte per lui ed in parte per la mia amata micetta che era la mia preferita e che, immaginavo, sarebbe certamente morta per le ferite riportate.
L’unica che si dimostrava fiera e baldanzosa dell’orrendo misfatto era proprio lei, la canuta irriducibile guerriera a gambette corte e stortignaccole che, se pur ferita e sanguinante a sua volta, stava ispezionando ogni angolo della casa alla ricerca della prossima vittima.
Decidemmo immediatamente che la ‘fiera’ non poteva convivere con noi e con la nostra pacifica arca di Noè e ci mettemmo immediatamente alla ricerca di una adeguata sistemazione presso qualche amico o conoscente che avesse un giardino ben recintato e nessun’altra bestiola in casa, di nessun genere e tipo.
La ricerca durò qualche giorno durante i quali la fanatica bassotta visse nell’antistalla, chiusa ed inaccessibile a tutti i nostri amati compagni animali, godendo di un paio di libere uscite al giorno sotto nostra strettissima sorveglianza.
Quindi, prima di farla uscire nel giardino, dovevamo rinchiudere tutto il resto degli abitanti non umani nei loro reciproci rifugi, portando i gatti in casa e mettendo nella stalla i cani, anche se questi erano tanto più grandi di lei: ma noi eravamo assolutamente determinati a non andare più incontro a guai.
La prima volta fu una cosa assai complicata, soprattutto per le galline e le anatre, per le quali non era giunta ancora l’ora di ritirarsi nella loro casa notturna: ma alla fine riuscimmo a rinchiudere tutti e trovare un posto sicuro per tutti.
Restavano le oche.
Io e Carlo ci guardammo in faccia interrogandoci silenziosamente, poi ognuno di noi disse all’altro che la differenza di mole tra le grosse oche e la piccola se pur pestifera cagnetta, era troppo grande e che al massimo le oche sarebbero scappate aiutandosi col moto delle ali e che le zampe corte della vecchietta non le avrebbero permesso di raggiungerle.
Così decidemmo di farla uscire, perché rinchiudere le oche sarebbe stata una cosa lunga e faticosa e noi eravamo già stremati.
Ma anche questa volta le nostre previsioni non risultarono azzeccate!
Appena la ‘dolce’ bestiolina fu messa in libertà sul prato erboso che cominciava a decorarsi di goccioline brillanti di brina, mise il naso a terra e, con una velocità sorprendente e incredibile per l’altezza dei suoi- bassissimi- arti e per la sua già vetusta età, entrò subito in traccia, come di dice più o meno in gergo e in un attimo si trovò di fronte alla tre grandi oche.
Ci fu un momento di incertezza, come una sospensione, durante il quale la mente delle quattro bestiole elaborò un piano, sicuramente contrastante l’uno con l’altro, ma alla fine l’ebbe vinta quello di Mastrooco, che prese una fuga precipitosa ad ali spiegate, urlando a più non posso per attirare su di sé l’attenzione della predatrice - cosa che gli riuscì benissimo - mentre le due femmine se ne andarono, lente e silenziose il più possibile, a rintanarsi nel loro giaciglio.
Cominciò così un’esilarante concitata rincorsa in circolo attorno alla casa:
l’oca maschio davanti, con tutto il suo splendore e la sua protervia, che un po’ correva sulla goffe zampe palmate e un po’ svolazzava,
la vecchia cacciatrice che lanciava regolarmente il suo grido di pista e di sangue, come da regolamento, e che spingeva a più non posso sui pistoni delle sue ridicole ma fortissime zampette, guadagnando terreno ad ogni giro,
Carlo che la inseguiva senza assolutamente riuscire a raggiungerla, dato lo zizzagare perfettamente sincronizzato di entrambi gli animali
e infine io che, andando contro corrente, cercavo di intercettare o l’oca o la cagnetta in modo da porre fine all’inseguimento.
La cosa si svolse nella stessa maniera per diversi giri, sempre più stretti attorno alla casa, per guadagnare terreno, e vi furono un paio di momenti in cui l’assatanata cagnolina raggiunse il povero sfiatato ocone che sicuramente stava rimpiangendo di aver assunto un’abbondante cena poco tempo prima, riuscendo a strappargli una boccata di penne e piume che restarono a penzolarle dalla bocca, perdendosi un po’ alla volta sparpagliate nel vento della corsa, come inusitati coriandoli di carnevale.
Io e Carlo gridavamo alla cagnetta, in tutte le lingue a noi conosciute:
FERMA ALT STOP A TERRA BASTA MOLLA FRENA
FERMA
FERMA
FERMA!!!!!
Ma le nostre grida esordivano l’effetto contrario di esaltarla ancora di più.
Così, ormai completamente senza fiato, ci trovammo, dopo almeno una decina di giri, tutti e quattro vicini in un arco di pochissimi metri e, mentre la cagnetta stava per lanciarsi ad afferrare il collo dell’ormai atterrito oco ed io mi gettavo a terra in un inutile tentativo di placcaggio della indefessa cacciatrice, fu la creatura alata, dimostrando la perfetta inesattezza di quanto si è solito dire riguardo le oche, che risolse a suo favore l’intricata quanto all’apparenza disperata situazione: volò con uno slancio di totale fiducia e di estrema lucidità tra le braccia di Carlo che, istintivamente, le aprì per accogliere e afferrare il nostro amico e porlo così in salvo.
L’accanita cagnetta allora si attaccò con i denti, digrignando tutta la sua frustrazione, ai pantaloni di Carlo che, con l’oco urlante ma ben stretto tra le sue braccia, cominciò a saltellare su di una gamba sola, per evitare di venire morso dalla carognetta che assolutamente non mollò la presa fino a quando io, finalmente, la ripescai per la collottola e con l’ultimo fiato rimastomi in gola la portai, mentre si dimenava e digrignava i denti a più non posso, nello stanzino sicuro a prova di evasione dell'antistalla, girando la mandata due volte.
Fin quando l’indomita piccola Minerva non fu resa completamente inoffensiva il nostro maschio ocone restò tra le braccia rassicuranti di Carlo, facendosi lisciare la testa dalle sue carezze consolatrici, fatte con la mano libera, ma quando mi vide ritornare da sola capì che il pericolo era passato e con un aggraziato atterraggio, planando sulle sue forti ali, tornò a terra e si recò velocemente a controllare lo stato di salute delle sue amate femmine, che l’accolsero come un eroe qual si era dimostrato, riempiendolo di beccatine affettuose ed elogiandolo a non finire nella loro bella querula lingua.
Io e Carlo, sfiniti ma sollevati dal lieto fine, ci lasciammo andare sdraiati sul prato morbido a rotolarci come bambini, quali in effetti eravamo dato che la nostra età, pur se stavamo affrontando impegni adulti, superava di poco i venti anni, ridendo a crepapelle senza riuscire a fermarci, per la gioia di aver assistito ad un evento così buffo e nello stesso tempo meraviglioso.
Da quel giorno non lasciammo più che qualcuno definisse ‘ stupide’ la oche, narrando a tutti gli amici e conoscenti la meraviglia e l’intelligenza di quel gesto di disperata fiducia del nostro amato ocone.
Per la piccola peste canina trovammo poi una famiglia con tre bimbi che provvidero a tenerla abbondantemente occupata e la convinsero a non pensare più di uccidere altre bestioline innocenti, facendole passare così una lunga serena e amata vecchiaia.
Alcuni anni dopo assistemmo ad un altro evento purtroppo divenuto inusuale da noi: nel campo di granturco davanti alla nostra casa atterrò uno stormo di oche selvatiche, provenienti probabilmente dall’area balcanica.
Si posarono in gruppo e si rifocillarono ampiamente, lasciando poi il campo semi devastato, ma noi non ci pensammo neppure un secondo di negare loro quella necessaria sosta..
Dopo l'atterraggio tutto fu eseguito con un clamore forte ed assordante, al quale le nostre oche accorsero, richiamando e salutando le loro parenti lontane al di qua della loro gabbia dorata.
Poi, tutto lo stormo si acquattò per terra e, reclinato il capo liscio e colorato sotto l’ala, si addormentò in un silenzio totale ed assorto, al quale parteciparono compunte anche le nostre tre amiche.
Dopo qualche ora, come fossero un corpo unico, le oche selvatiche si destarono insieme, percorse da un brivido generale e, dopo un breve frullio d’ali, uno sgranchirsi e uno stiracchiarsi del lungo flessuoso collo, compattato il gruppo e presa una breve rincorsa, si levarono in volo, assumendo la celebre posizione di schieramento con il capofila davanti affiancato dai suoi due luogotenenti, e se ne ripartirono per la loro meta, lasciando sul campo che le aveva accolte e ristorate un ricordo di penne e piume delle quali ancora una è in mio possesso, nonostante il lungo tempo trascorso.
Io rimasi a guardarle a naso in su fino a che non sparirono, lanciando ancora qualche grido di saluto, inghiottite dall’orizzonte e lasciandomi come una nostalgia per i tempi, così lontani ma che ricordo benissimo, nei quali io pure sapevo volare, senza prendere l’aereo.

L’UCCELLINO
RICONOSCENTE
Questa è una piccola storia, vera come tutto quanto vi ho raccontato fino ad ora.
E siamo arrivati al giorno in cui, approdata dalla Romagna all'isola forte ed aspra di Sardegna, esule volontaria in nome dell'amore e della libertà, presi in affitto una grande casa nel centro di un piccolo paesino collinare.
Una grande casa senza giardino, chiusa tra altra case, con muri portanti spessi quasi un metro, antichi di centinaia d'anni e una profonda cantina immensa e fresca, nella quale mettevano a stagionare il formaggio, purtroppo non utilizzabile per la mancanza di una agevole rampa di accesso.
Una grande casa con un camino a forno che recava il segno del fuoco che aveva cotto il pane e i dolci di famiglia per decine di generazioni, che io rinfrescai all'esterno con istoriazioni e colori e feci pulire all'interno, rimuovendo spessi strati di fuliggine nera e leggermente oleosa.
Una casa con soffitti oltre i quattro metri e un abbaino tra i tetti dove allestii un giardino pensile di gerani, girasoli, petunie e bocche di lupo e appesi la mia amaca, sulla quale avrei dormito tutte le afose notti della mia prima estate là, dopo aver salutato il tramontare del sole con il garrire delle rondini, perdendomi in un cielo profondo e buio ma denso di luminosissime stelle.
Una casa che al primo piano aveva uno strano cortiletto interno, come un impluvium di romana memoria, dal quale si accedeva alla lavanderia e che era così angusto che io l'usavo solo per stendere la biancheria ad asciugare.
Metà di questo cortiletto era coperto da una tettoia di vetro e alluminio, sorretta da due travi di legno antico come i muri centenari nei quali erano inglobate, che io tinteggiai di bianco candido, così come le pareti dell'abbaino, così come le porte e le finestre, alte e screpolate, che riportai a dignità con un lavoro di tre mesi, tra smerigliare e stuccare le ferite del tempo sul legno di faggio e poi con la stesura a pennello dello smalto lucido e protettivo.
Nel posto più remoto di quella piccola tettoia, molto ben nascosto e difficilmente raggiungibile, proprio nell'angolo tra i muri così infiltrato nella curvatura del legno della trave che è quasi impossibile da vedere, c'era un piccolo nido, che io scoprii quando, salita sulla scala, grattavo polvere e detriti dei lavori di muratura, per passare poi il trattamento antitarlo e la protezione per il vecchio trave già un po' stanco e provato.
In quei giorni, era dicembre del 2008, quel piccolo nido era già abitato da una coppia di minuscole creature alate, dal petto piumato color tortora e il capino leggero, le ali lunghe e sottili e il becco tipico degli uccelli insettivori.
Erano quelle, due bestioline assai graziose che sempre si agitavano quando io e chi mi aiutava nei lavori di ristrutturazione invadevamo il loro territorio, ma che poi si appollaiavano sul cornicione sovrastante per sbirciare, incuriosite, le mie manovre di muratore ed imbianchino prima e di brava lavandaia poi.
E il canto che modulavano assai spesso era un fischio querulo e leggero, quasi come se romanzassero sottovoce per non farsi notare, come per non disturbare.
Fu immediato e naturale per me affezionarmi a quegli inquilini lì stabilitisi assai prima di me e la loro presenza prima mi allietò le giornate del duro ma assai soddisfacente lavoro di ripristino e sempre poi quando andavo a stendere il bucato.
Allora se ne stavano sui loro posatoi preferiti, grondaie e tetti, guardandomi, chiacchierando tra di loro, mentre io li osservavo di sottecchi, come per non metterli a disagio, chiedendomi cosa mai pensassero della mia rumorosa venuta nel loro habitat e cosa raccontassero tra loro così divertiti, blaterando alle mie spalle.
I lunghi mesi invernali passarono, mentre io lentamente recuperavo la mia serenità dopo le terribili vicissitudini dei mesi precedenti, trascorrendo le mie giornate di rinnovata voglia di vivere occupandomi della casa, scrivendo e dipingendo e, come sempre accade, venne finalmente la primavera che cacciò l'insolito tempo gelido e piovoso, inusitato per questa terra di Sardegna che ha un clima molto mite anche nella stagione più fredda.
In quei giorni di sereno e tiepido ritrovato sole molto spesso stavo nei balconi e nell'abbaino, mettendo a dimora nuove piantine fiorite e sempre tenevo d’occhio il nido: notai così che la mamma uccellina improvvisamente appariva nervosa.
Ma ben presto mi fu chiaro il motivo di tutta quell’agitazione perché, un giorno più caldo ancora, scorsi spuntare dall'orlo del nido un minuscolo capino con due occhi sgranati
che, con il collo tutto ritto, mi guardava intensamente e, dopo alcuni secondi, un altro capino, anche lui assai vispo e curioso, che mi scrutò con la medesima meraviglia.
Seppi così che i due sposi alati avevano messo al mondo una nidiata di creaturine!
Da quell'istante presi a seguire attentamente i progressi della loro crescita, allietandomi nell'ammirare l'andirivieni affaccendato dei genitori che senza sosta si alternavano ad imbeccare i loro nidiacei ponendo nei loro beccucci spalancati piccoli insetti catturati in volo o tra i tetti.
Questi due genitori alati erano così solerti ed accurati che le loro creature ogni giorno crescevano a vista d'occhio, continuando a riempire l'aria con i loro richiami piuttosto imperiosi e le loro testine, del tutto implumi e tremolanti il giorno in cui le avevo viste la prima volta, si erano rivestite di una stravagante pettinatura di piumettine tutte argentate e si sporgevano sempre più vivacemente verso il becco che li nutriva.
Insomma, tutto sembrava procedere per il meglio.
Ma un giorno la mia amica Ale venne a trovarmi accompagnata dal suo cagnolino e salì ad ammirare le fioriere sul balcone che guardava sul corso cittadino.
Ma, mentre io di sotto preparavo il latte macchiato per entrambe come piaceva a noi, ad un tratto la sentii urlare, con tutta la voce che aveva nei polmoni, il nome del suo cane: BIRILLO!!!
Poiché la sua era una vecchia bestiolina
malata alla quale restava poco da vivere, mi spaventai e immediatamente mi precipitai
affannata su per le scale, temendo che gli fosse venuto un malore, come era accaduto altre volte.
Invece quando arrivai nel cortiletto vidi il per nulla sofferente cagnolino con uno dei ' miei ' uccellini in bocca, con lo sguardo assassino e intenzioni fin troppo evidenti.
Inutile raccontarvi che mi precipitai gridando contro il malcapitato canide per fargli mollare la preda, che però rischiò di finire tra le fauci del mio cane, Jerome, che naturalmente era accorso a vedere cosa stesse succedendo in tutto quello schiamazzo, così che l'uccellino sfortunato stava per cadere dalla padella alla brace.
Ma Jerome era un cane molto obbediente e sapeva che era suo dovere rispettare tutte le bestiole che entravano in casa quindi, a un mio sguardo inceneritore, si allontanò subito, con l’aria del bravo ragazzo innocente.
Chiusi finalmente fuori dal cortile i due aspiranti assassini, raccolsi delicatamente la povera creatura tra le mie mani racchiuse a coppa, pensando di trovarla ferita o addirittura agonizzante.
Invece il piccolo nidiaceo risultò miracolosamente indenne: tremava si, scosso di paura, dalla testolina alle minuscole
zampe e il cuoricino pulsava frenetico tra
le mie mani come se gli volesse schizzare fuori dalla gola, ma nella pericolosa colluttazione non aveva riportato neppure un graffio, almeno così sembrava..
Io, portando le mani all'altezza del mio sguardo, ammirai da vicino quella fragile eppur vitale creaturina, sentendo il suo calore ed il suo leggerissimo respiro ed aspirando l'odore un po' selvatico delle suo piume screziate.
Ma mamma uccellina era così furiosa e disperata che saltellava dalla trave alla grondaia e viceversa, chiamandolo con una nota così accorata che credetti sarebbe morta di crepacuore, cosa che mi indusse, dopo qualche carezza sul capino, a posare il piccolo in un angolo riparato e ad andarmene, per darle modo di scendere a terra e rincuorarsi accudendolo.
Così li lascia soli.
Nella notte che seguì scoppiò un terribile temporale ed io, che mi sveglio sempre fra le tre e le quattro, sentendo tuonare ed il vento premere forte contro le imposte chiuse, pensai preoccupata alla mia famigliola alata; ma sapendo che la trave che sosteneva il loro nido era salda, sicura e ben riparata, mi tranquillizzai e cercai di riaddormentarmi.
Ma il pensiero di loro, accanto a tutti i miei altri innumerevoli rovelli, mi tenne sveglia e, non resistendo più per la curiosità, appena si fece giorno, salii in lavanderia per vedere se il piccolo fosse riuscito a sopravvivere.
Uno spettacolo inatteso mi fermò sulla soglia del cortiletto, vedendo entrambi i fratellini appollaiati su uno dei fili per stendere la biancheria, esattamente sopra un paio dei miei calzini, teneramente vicini, che si stavano
svegliando nell'alba fredda e livida, in perfetta salute.
Erano due piccoli ciuffetti di piume eppure racchiudevano tutta la speranza di una vita intera e tutto il desiderio di libertà, di volare nel cielo, di spiegare il proprio canto accompagnando il modulare del vento sotto le loro ali.
Restai ammaliata a guardarli ancora un poco da lontano ma poi, non riuscendo a trattenermi dal desiderio di accarezzarli, mi avvicinai con passo lento e silenzioso: quando arrivai molto vicina a loro, l'altro uccellino, che non aveva conosciuto le mie mani, volò via spaventato e andò a posarsi in alto fuori dalla mia portata, sulla trave del soffitto, mentre il ' mio ' piccolo invece, restò immobile a fissarmi.
Incredula, intenerita e meravigliata allungai allora cautamente la mano verso di lui che incredibilmente non fuggì, ma si fece accarezzare sul petto e sulla testolina dal mio dito un poco tremante, salendovi anche sopra, dopo esservi stato sollecitato.
I suoi occhietti scurissimi, che sembravano due gocce di liquido ebano, non cessavano di restare fissi nei miei, come volesse rispondere alla mia silenziosa domanda: ' Allora ti ricordi di me....? '
Poi, del tutto tranquillo e a suo agio, fece un voletto e andò ad appoggiarsi sulla mia testa, dalla quale scese in un secondo tempo posandosi sulla mia spalla, restando lì fermo con le penne gonfie nel gesto che fanno quando si apprestano, comodi comodi, a dormire.
Io restai immota, silenziosa e quasi non osavo respirare, pur sentendo il mio cuore straripare di gioia.
Non era cosa solita che un piccolo uccellino nato libero si dimostrasse così amichevole di sua spontanea volontà e mi godevo quella straordinaria sensazione di sentirmi scelta, riconosciuta, accettata nonostante fossimo così diversi, io ed il mio piccolo nuovo amico.
Ma la mamma uccellina, che aveva osservato tutta la scena da sopra la trave, per nulla contenta dell’ardimento fuori programma
del suo figliuolo alato, si agitò molto, svolazzando nervosa tra il nido e la grondaia del tetto, mostrandomi in modo chiaro tutta la sua apprensione e preoccupazione per quella amicizia inusuale che lei riteneva assai pericolosa.
La sua preoccupazione era così evidente che mi impietosì e, pensando di essere stata troppo invasiva, pur se terribilmente a malincuore, posai sul filo della biancheria, per esattezza sul calzino accogliente, il piccolo coraggioso figlio del cielo, restituendolo alla libertà e, con un sorriso commosso e un leggero gesto
di saluto con la mano me ne andai, per lasciare la famigliola alata alla sua vita libera.
Durante tutto il giorno continuai a pensare alla particolarità di quanto mi era accaduto e sorridevo tra me e me, ancora sorpresa che, se io stessa avessi sentito raccontare un fatto del genere, invece di averlo vissuto, a stento l'avrei creduto possibile.
Più volte mi venne la tentazione di salire su per vedere se il miracolo si sarebbe ripetuto, ma mi trattenni, ripensando alla preoccupazione della mammina.
Ma il giorno dopo non ce la feci più davvero e mi recai a controllare la mia famigliola cinguettante: trovai così il mio piccolo figlioccio piumato che se ne stava appollaiato come il giorno prima sulla mia biancheria, come se ormai avesse scelto che quello era il posto suo.
Non potei fare a meno allora, vedendolo così tranquillo e sereno, di porgergli ancora una volta la mano, perché vi salisse sopra.
E l’uccellino si aggrappò con grande naturalezza con le zampine al mio dito salendovi su e ripercorrendo il cammino del giorno precedente, dopo aver fatto un voletto sulla mia testa, scese ad appollaiarsi sulla mia spalla, arruffando ancora una volta le penne come volesse appisolarsi, dopo aver finalmente trovato il luogo fatto apposta per lui.
Io di nuovo mi trattenevo persino dal respirare, per godermi quella sua meravigliosa presenza, ma sua madre, che proprio non poteva digerire
quella inusuale, incomprensibile amicizia, cominciò a svolazzare inquieta da tutte le parti, come per chiedermi di lasciarlo stare, per favore e di andarmene, di lasciarli vivere la loro vita in pace, come avveniva prima che io mettessi piede in quella casa, come avevano fatto per anni senza essere disturbati da nessuno..
Così, di nuovo impietosita dalla sua sofferente apprensione e sentendomi in colpa, posai il piccolo leggerissimo contestatore sul mio calzino, divenuto il suo posatoio preferito e me ne andai, anche se terribilmente a malincuore,
combattuta tra il senso di rispetto per l’amore di quella minuscola indomita madre e il desiderio di continuare l’esperienza di amicizia con la sua piccola creatura innamorata della mano che l’aveva salvata dalle fauci fameliche del cagnetto predatore e me ne tornai di sotto.
Davanti ad un bicchiere di latte riflettei lungamente sul da farsi, colpita ed impressionata da quando mi era accaduto.
Certo, se avessi imprigionato quella deliziosa creatura in una gabbietta, lo avrei ammaestrato e addomesticato facilmente, inducendolo senz'altro ad abbandonare la sua vita libera e naturale, ma recandomi una gioia immensa.
Più volte avevo goduto della compagnia di uccellini addomesticati che mi dormivano sulla spalla, mi becchettavano i capelli o il lobo delle orecchie e mangiavano dalla mia mano, ma essi erano tutti animaletti nati e cresciuti in cattività, pappagallini che si cibavano di semi e frutta e quindi era facile trovare il menù adatto completo e nutriente per loro.
Il mio piccolo figlio piumato invece era un insettivoro e, se pur esistano in commercio ottimi preparati anche per questo genere di uccelli, la sua salute era un poco più esposta a rischi.
Ma quello che, oltre a queste elucubrazioni di carattere pratico, mi parve oltremodo crudele era il fatto di privarlo della libertà di volare, di riprodursi ed avere una famiglia propria, di migrare.
Io, che per amore della libertà avevo e pagavo un prezzo assai alto, questo non lo potevo proprio accettare.
E poi, come avrei potuto infliggere un dolore così tremendo alla sua mamma, che fino a quel momento mi aveva considerata un’amica e mi aveva fatto capire chiaramente quanto la sconvolgesse il comportamento strano di quel suo figliolo??
Così decisi di non approfittare della situazione, rinunciai volentieri alla gioia che mi avrebbe dato la dolcissima vicinanza di quella creatura e lasciai la famigliola alata proseguire la sua vita con i suoi riti, rinsaldando la nostra amicizia con i loro canti mattutini e serali e i nostri lunghi sguardi, miei e del piccolo, lanciati da lontano l’uno verso l’altra, con dolce e languida tenerezza.
Il tempo passò, come sempre accade in
tutte le belle favole e la deliziosa creatura alata crebbe sana e forte, volando e cantando sui tetti intorno al mio piccolo sguardo nel cielo.
Cambiando il piumaggio, quando divenne adulta, dimostrò di essere una femmina, somigliante alla madre come una goccia d'acqua, mentre l’altro piccolo si rivelò essere un maschio, più grosso e robusto di ossatura, in tutto e per tutto identico al papà.
Ma io ugualmente ero in grado di riconoscere i piccoli dagli adulti, perché... beh, via, cosa ve lo dico a fare, il viso di ognuno di loro era diverso, l'uno dall'altro, esattamente come il nostro viso è diverso, dato che ogni essere è unico ed irripetibile in tutta l'infinita storia della creazione.
Venne così il giorno che, recandomi alla visita giornaliera, trovai il nido vuoto e abbandonato, senza più nessuna traccia della famiglia canora: l’istinto migratorio era stato più forte di ogni cosa e li aveva spinti nel loro viaggio stagionale, obbedendo alla legge scritta nei loro piccoli corpi esili e leggeri ma fortissimi, capaci di solcare enormi distanze per recarsi dove il loro ritmo biologico li chiamava.
E a me non restò che guardare verso il nido desolato, ogni volta che salivo alla lavanderia, pensando loro con malinconia ed affetto ed augurandomi di poterli rivedere, alla stagione successiva.
Passò così altro tempo, tornò di nuovo l’inverno e, poco prima di Natale, mi capitò il funesto incidente che mi obbliga tuttora a una libertà di movimento molto limitata ed a sofferenze continue e inestinguibili.
Afflitta durante i lunghi mesi invernali da dolori fortissimi, non mi recai più alla lavanderia, affidando la cura della mia casa a una giovane signora che allora si prese cura delle mie necessità.
La mia vita era cambiata totalmente all'improvviso e la lotta per accettare questa mia infermità alla quale non vi era rimedio era aspra e spossante.
Per mesi e mesi mi interrogai sui perché della mia intera esistenza che, dopo tante sofferenze, era approdata senza prova d'appello a quella amara soglia.
E non pensai più agli uccellini.
Fu il mio lavoro che mi diedi un appiglio, che mi aiutò nel ritrovare la forza di andare avanti. Il mio primo libro era stato pubblicato a gennaio, ma molto materiale avevo già scritto negli anni precedenti e così decisi di dare alle stampe una piccola raccolta di novelle, integrando quando già pronto con altre, scritte appositamente, riandando con la memoria a quanto di suggestivo mi fosse successo e mi andasse di narrare ai miei lettori.
Fu così che decisi di raccontare questa tenera storia e, rileggendola per la correzione, mi assalì la grande curiosità di andare a vedere se la famigliola fosse tornata al suo nido.
Così mi arrampicai, lenta e dolorante, fino al primo piano, dove non ero quasi più salita, anche pensando di fare visita ai miei fiori nel balcone, che venivano si regolarmente accuditi, ma che sicuramente risentivano della mia mancanza.
Raggiunsi allora il cortiletto e immediatamente notai che sulla trave, al solito posto, nel nido rimesso a nuovo e tutto fresco di nuove pagliuzze verdi e dorate, ecco un capino, poi un altro sporgere fuori con gli occhi curiosi e indagatori, mentre la madre se ne stava tranquilla, appollaiata su un mio calzino, steso sui soliti fili in lavanderia.
La mia piccola amica era ritornata al suo nido e mi aveva riconosciuta, nonostante fosse passato tutto quel tempo.
Ci guardammo silenziosamente negli occhi e i nostro cuore parlò per noi, stringendoci in
un abbraccio incorporeo ma vitale e denso d’amore.
Stavamo lì, immobili entrambe, ma felici di rivederci.
Felici di essere vive e di essere ancora così vicine.
Da quel giorno, pur non potendo salire ogni giorno al piano superiore perché il dolore e la fatica me lo impedivano, lasciando le porte aperte, sentivo dal piano terra il loro chiasso allegro e festante che mi rallegrava le giornate di quella primavera nella quale tutto della mia vita era mutato, dato che, purtroppo, le mie gambe non mi avrebbero più portato dove avrei desiderato.
La vita, però, continuò a scorrere e fiorire nel mio cuore, nei fiori e nelle piante che tenevo accanto a me e furono i miei pensieri e i miei scritti a volare fra le nubi, capaci di raggiungere l’amore, da qualsiasi parte esso venisse, anche solo dal piano di sopra, sotto forma di delicati, grati cinguettii di nuove vite nate da un gesto d’amore e da una riconoscenza che aveva superato le barriere della diversità tra specie.
Ora ho lasciato quella casa ed abito in un'altra immersa in una pineta.
Tra i rami di questi pini una vasta popolazione alata di molte specie vivono la loro vita libera e felice, di voli e canti e nidi.
Certo la mia piccola figlia piumata non è più, troppo tempo è passato per pensare che la sua piccola vita ancora esista, ma una foto e il mio pensiero d'amore la fanno vivere ancora.
E il ricordo di quello sguardo che racchiudeva l'amore dell'intero universo..

IL
SOTTOPASSAGGIO
Andavo in bicicletta.
Per noi romagnoli la ‘ bici’ è come un prolungamento del nostro senso di indipendenza, di imprenditorialità, del nostro anelito alla libertà, qualsiasi libertà, anche quella di movimento.
Le lunghe strade pianeggianti o lievemente in salita, i vicoli stretti del centro storico, il pavé a cubetti di porfido, segnavano il ritmo delle ruote veloci rimbalzandomi nello stomaco e nel cuore.
Quelle due ruote mi portavano ovunque io desiderassi andare ed allargavano gli orizzonti delle mie giornate, dei miei pensieri, dei mie aneliti di libertà, delle mie fughe solitarie, delle mie ricerche ancora senza nome, delle mie disperazioni sotterranee che mettevano radici sempre più invadenti e vaste, come miceli di funghi selvatici, amari e tossici.
Dopo una vita da adulta passata in automobile fra un lavoro e l’altro, fra un impegno e l’altro, fra un figlio e l’altro, quando mi ritrovai che avevo perduto tutto: la casa, l’unità della famiglia, ogni reddito personale, ogni possibilità di lavorare, la salute mentale, la voglia di vivere, in quel marasma assoluto che mi aveva annientato e che aveva distrutto tutta la realtà che avevo costruito intono a me, trovai la ricerca spirituale, la strada verso la mia anima, verso l’introspezione più profonda, verso un nuovo sconosciuto cammino di visioni ultraterrene, sensazioni inspiegabili, esperienze paranormali, mistici deliri e mistiche acquisizioni.
Ritrovai anche la bicicletta.
Dato che, avendo smesso di lavorare, sopraffatta dal dolore ed annientata dagli psicofarmaci che mi erano stati somministrati forzando la mia volontà, non potevo più permettermi di comprare e mantenere un’automobile e dato che sentivo il desiderio di essere comunque indipendente e anche, perché no?, di liberare l’ecosistema dalle mie personali emissioni di idrocarburi nell’atmosfera, comprai una bici di ultima mano e ritrovai dopo moltissimi anni il piacere del vento nei capelli, del vedere scorrere la strada sotto le due ruote sottili, lo sforzo nei miei polpacci ed i moscerini negli occhi.
Tutto il dolce e il salato dell’andare in bicicletta, che lo rende così unico e affascinante.
A quei tempi abitavo in affitto in una piccola casa singola appena fuori dalla città e per arrivarvi bisognava percorrere un sottopassaggio che evitava l’incontro con la ferrovia: una discesa ripida che percorrevo continuando a pedalare fino a che il rapporto del cambio reggeva la spinta e la velocità, per affrontare così l’altrettanto ripida e faticosa risalita con la massima inerzia possibile: le infinite risorse energetiche e fisiche della ragazzina di un tempo erano andate irrimediabilmente perdute.
Di giorno il sottopassaggio era anonimo, con i suoi graffiti e i suoi muri incolori di cemento armato, ma la notte spesso vi si radunava qualche gruppetto di giovani a parlare, fumare e bere, che si sedevano su una sponda della salita ricavata come una nicchia in una rientranza dei piloni che reggevano la pesante struttura.
Io da bambina giocavo sempre ‘ alla capanna ‘, costruendone ogni volta di nuove e svariate, usando rami, cartoni e qualsiasi altro materiale trovassi che si potesse prestare ai miei intenti.
Quei giovani avevano trovato una ‘ capanna ’ già costruita, adatta alla loro realtà : un sottopassaggio di calcestruzzo.
Io passavo volando e loro non mi degnavano neppure di uno sguardo.
Ma una notte d’inverno, che veniva giù un’acqua fina fina e gelata che ti entrava nelle ossa fino al midollo ed io correvo come una forsennata verso casa per cercare di scaldarmi, senza peraltro riuscirci, nonostante fossi coperta molto bene con guanti sciarpa, berretto e giaccone imbottito, mentre passavo davanti alla nicchia scavata nel cemento e riparata da una piccola ringhiera di metallo vidi, sdraiato sul nudo impiantito senza neppure un pezzo di cartone che lo riparasse almeno un poco, un ragazzo di colore.
Aveva le braccia piegate davanti al petto e appoggiava la guancia sulle mani giunte.
Era vestito esclusivamente di un paio di jeans, ai piedi portava delle scarpe da ginnastica telate, senza neppure i calzini e il torace era riparato da una semplice felpa rossa.
Nient’altro.
Dormiva così, rattrappito su se stesso in posizione fetale e non si accorse del mio passaggio.
Io invece notai tutto mentre, lenta, sfilavo davanti a lui pedalando in salita.
Mi fermai in cima e mi girai per guardarlo ancora: sentii tutto il freddo di quel cemento, tutta l’umidità gelata che faceva fumare il mio fiato, entrare nelle mie membra, sentii la durezza, la solitudine, la follia di quella situazione.
Quel ragazzo poteva essere mio figlio e comunque era mio fratello, era figlio come me di Nostra Madre Terra!
In quei tempi le mie condizioni economiche erano assai difficili: non potendo lavorare più c’era solo l’introito dello stipendio della mia seconda figlia, l’aiuto del padre, che ci pagava l’affitto e a volte altre spese straordinarie e quello di mia madre, che mi dava una cifra fissa ogni mese.
Però io pensai ai miei cani, che dormivano sul comodo soffice caldo divano in una stanza riscaldata con le loro copertine a disposizione nelle quali rintanarsi, quando avessero avuto freddo.
E quel povero ragazzo stava tanto ma tanto peggio di me, che ero così povera da riuscire a stento a coprire le spese.
Eppure io avevo tutto, non mi mancava l’essenziale ed anche un po’ di superfluo, a guardarci bene.
E i miei cani erano trattati come figli.
Mentre quel fratello nero che giaceva lì, gettato a terra, come poteva essere possibile che dormisse peggio del mio cane, come poteva essere possibile?
Ugualmente non sapevo cosa fare.
Pensai di invitarlo a dormire a casa mia, ma i miei figli erano ancora molto giovani e non me la sentii di far correre loro nessun tipo di rischio, in fondo, per quello che ne sapevo io, lui poteva essere ubriaco o drogato o in qualche modo pericoloso.
Di denaro, in tasca e in casa avevo solo 20 euro e comunque, a quell’ora tarda di notte, a che gli sarebbero serviti?
Così girai la mia bici e ricominciai a pedalare velocemente verso casa che distava poco meno di un chilometro da lì.
Ma il mio cuore urlava, urlava così forte da farmi risuonare le orecchie, da battere nella mia testa e nella mia schiena.
Non potevo non fare niente, non potevo!
Il mattino dopo quel ragazzo sarebbe stato ritrovato morto, addormentato così, seminudo, in quel freddo umido di un sottopassaggio di calcestruzzo nella bassa padana.
Eppure avevo paura, avevo paura della sua reazione qualora mi fossi avvicinata a lui.
Stavo pensando ad una vecchia ma calda trapunta di vera lana, un po’ lisa e scolorita dal molto uso, che risaliva agli anni della gioventù di mia madre quando i manufatti erano quasi eterni e che utilizzavo solo ogni tanto.
Pensavo anche a un guanciale che era in soprannumero, ad un mio giaccone che mi stava un po’ piccolo, al mio caldo berretto di lana, ad un paio di calzettoni lunghi di lana da sci abbandonati da tempo nel fondo di un cassetto, troppo pesanti per essere utilizzati normalmente, ad una vecchia tuta da ginnastica bella fitta e felpata e ad un mio maglione fatto ai ferri da mia madre, con il collo alto, molto caldo e comodo.
Al pane rimasto dalla cena che sarebbe stato destinato ai miei cani, alla frutta nel suo contenitore di cristallo, ad un pacco di biscotti nell’armadietto della cucina, ad una birra nel frigorifero.
Pensai che lo avrebbero scaldato un poco, che gli sarebbero serviti.
Che non potevo esimermi, non avevo nessun diritto di chiudere gli occhi davanti ad una così vile ingiustizia, dopo averla vista a così pochi passi dalla mia casa.
Decisi di slancio e posi le cose che mi erano venute in mente in un paio di buste capienti, uscii di nuovo di casa, mettendo in una di quelle buste anche i miei 20 euro e tornai pedalando verso il sottopassaggio.
Quando arrivai là, il ragazzo dormiva ancora nella stessa posizione, non si era affatto mosso.
Appoggiai la bici, presi le borse per i manici e cominciai a camminare adagio verso di lui, chiamandolo, in inglese: “ Boy!...Ragazzo!?”
La voce mi tremava dal freddo, dalla paura, dall’emozione di tutta quella situazione così assurda e dolorosa.
Lo chiamai due o tre volte, perché la mia voce giungesse fino a lui, poi finalmente egli si scosse dal suo sonno letargico e spalancò gli occhi, rizzandosi a sedere e poi in piedi.
Mi guardò con occhi spiritati, colmi di sonno, di stanchezza di fame e di disperazione e cominciò ad urlare con tutto il fiato che aveva nella sua gola di ragazzo di colore :
”Jesus Christ!!
Jesus Christ!!
Jesus Christ!!”
e protendeva le braccia verso di me, con le mani dalle dita protese come a respingere il demonio in persona.
Ebbi paura, molta paura, ma ugualmente gridai io pure cercando di sovrastare la sua voce, senza peraltro riuscirci:
“ Peace, Peace!! I am mother, mother!!!” e il mio cuore batteva forte ma i miei piedi non volevano andarsene di lì, mentre gli tendevo le borse piene con le braccia tese verso le sue, opposte, ripetendo ancora :
” Pace, Pace, io sono mamma, mamma, mamma”.
Dopo qualche manciata di secondi di sospensione, durati come una vita intera, tra il suo terrore e la mia paurosa affezione di madre, cedetti, lasciai a terra le borse e senza voltargli le spalle, fuggii, correndo all’indietro incespicando, rischiando di cadere, mentre le sue grida:
“ Jesus, Jesus!”
mi incalzavano sempre più e mi inseguirono anche dopo aver inforcato la bici e raggiunto trafelata la mia casa, risuonando nelle mie orecchie per molti giorni ancora.
La mattina dopo, presi il coraggio a quattro mani e tornai con la mia fedele bici al sottopassaggio, cercando di guardare da più lontano possibile se lui ci fosse ancora, ma il luogo era completamente deserto, come se nessuno mai fosse stato lì.
Se n’era andato, chissà dove, chissà verso quale destino, portandosi però dietro quell’improvvisato corredo di sopravvivenza donato da una madre raccolta per caso nello squallore di un tunnel di cemento armato una notte fredda e piovosa d’inverno.
E comunque da sempre, sarà per il mio viso rassicurante, sarò per la mia ciccia che lo è altrettanto, quando incontro per strada un ragazzo di colore che cerca di vendermi qualcosa, sempre lui, chiunque sia, mi chiama, mamma, mummy, mother, mum…
Che bel nome, nel mio cuore!
Anche a questa storia scritta nel 2009 voglio aggiungere un'appendice.
Un paio di anni dopo quell'accadimento mia figlia maggiore ebbe una intensa quanto sfortunata storia d'amore con un ragazzo di colore proveniente dal centro Africa e giunto in Italia per fare il lavoro di ambulante e così poter mantenere la sua molto numerosa famiglia.
Benji è un ragazzo molto bello, intelligente gentile educato.
Non voglio entrare in merito alle ragioni che hanno portato alla fine la loro storia d'amore.
Di certo la differenza di cultura, che è una cosa assai più importante di quanto io non credessi, li ha portati poi a non capirsi, a litigare, ad avere desideri e comportamenti diversi e poi a interrompere la loro relazione dopo un paio d'anni circa, anzi, di più.
Ma questo di certo avvenne con mio grande dolore.
Perché l'amore tra loro era grande e bello e mi dispiacque così tanto nel vedere che i limiti degli essere umani, la loro mancanza di apertura, di adattamento, il loro egoismo, ancora una volta avevano vinto su di esso.
E ancora di più mi dispiace di non averlo più nella mia famiglia, quel bel ragazzone scuro e di non sentire più da tempo la sua voce affettuosa che al telefono mi disse, l'ultima volta che mi telefonò, che io abitavo già in Sardegna e la sua storia con mia figlia era già finita:
' Mama... ciao Mama!! come stai Mama?? ti voglio bene, Mama!! '...
Caro Benji, mi spiace che non sei diventato davvero mio figlio, mi spiace di non poter chiamare nipoti i tuoi bambini e di non poterli tenere sulle mie ginocchia.
Lo avrei tanto voluto.
Tu mi hai chiesto di aiutarti, con mia figlia, a cercare di farla ragionare, di farle comprendere il tuo punto di vista, diverso dal suo: e io l'ho fatto.
Le ho parlato, ma tu volevi sposarti, tornare in Africa, avere tanti bambini, mentre lei.. non lo voleva.
Non ha torto lei, non hai torto tu.. semplicemente non vi siete trovati nella maniera giusta e questo purtroppo accade.
Ora non so dove sei e cosa fai, ma per me sei sempre mio figlio, ti tengo nel cuore, bravo ragazzo, dolce affettuoso.
Ricordo i tuoi occhi lucidi quando ci incontrammo e tu mi abbracciasti, dicendomi:
'Mama, assomigli alla mia Mama lontana.. '
e facesti il gesto con le mani, per farmi capire che anche lei era rotonda come me....
E ricordo la tua voce emozionata e incrinata di pianto quando sapesti che ero tanto ammalata e che non potevo più camminare e mi telefonasti.
Volevi venire qui, Sardegna, dove i miei figli non sono mai venuti.
Ma poi.. le cose sono andate così..
Che bravo figlio che sei, Benji.. grazie.. ciao.. ti abbraccio..
la tua ' Mama '

V sezione
L’INFINITO E OLTRE
ANTRON
Questo è il racconto di quanto io ricordo di Antron, il pianeta da dove discendo.
Molte ere fa io sono nata su Antron, un pianeta lontano,
e per molte vite vi ho vissuto.
Ricordo la Distesa della Contemplazione.
Percorrevo il sentiero in saliscendi che nascondeva l’orizzonte, tinto di viola a tutte le ore del giorno, più chiaro nelle stagioni calde, più scuro e metallico in quelle fredde e a un tratto arrivavo, col respiro lievemente
affannato dal passo sostenuto che mi aveva spinto fin lì e dall’emozione che mi aspettava, e che aspettavo, ogni volta.
La grande Distesa appariva, tremolante e immota, come argento e mercurio, tinta del lilla e del cobalto dei metalli disciolti, pesante e inquieta come una viva coltre di ali di farfalle morenti.
Respirava mobile e silenziosa, sussurrando ignoti motivi siderali.
Un breve litorale l’arginava, sfavillante di pagliuzze argentate e nichelate e di piccoli cocci simili a quarzi sbrecciati.
La sua sfumatura di verde oro si perdeva tra ciuffi di rami fioriti di spini amaranto.
Ascoltavo il mio fiato fermarsi nel petto e un brivido serpeggiante mi afferrava le braccia esili e nervose: i sensi della vista e dell’udito mi trasportavano nel profondo della Contemplazione, in cui mi inabissavo risucchiata da una dolce e travolgente vertigine.
Perdevo il nesso del tempo e i collegamenti con il mio corpo: galleggiavo senza peso nella vibrazione che mi percorreva e le imprimevo ritmi e assonanze diverse ogni volta.
Le immagini scaturivano da sole, precedute da brividi a fior di pelle e da sentori profondissimi ed io lasciavo loro il compito di depurarmi i pensieri, di purificarmi i ricordi.
Il Maestro mi aveva insegnato l’ancestrale medicina del ricordo: egli aveva intessuto tutta la sua vita attorno alla cura di questa filosofia.
Non sempre Lui era ben visto dai grandi pensatori che guidavano le famiglie riunite nei piccoli centri dislocati tra le pianure e gli altipiani del nostro pianeta, ma era rispettato, sorretto e protetto dalla prudenza delle
proprie parole e dalla potenza delle proprie emanazioni.
Io ero la sua allieva prediletta: le orme del Maestro accoglievano il mio minuscolo piede come una nicchia segreta disegnata appositamente.
Ero la destinataria del suo immenso sapere, designata a succedergli una volta che la luce dei suoi occhi si fosse estinta per sempre.
Sì, perché su Antron ogni essere vivente si procurava da sé la quiescenza necessaria alla rinascita, quando il campo di energia del suo essere si era troppo affievolito.
Non esistevano malattie, non esisteva la vecchiaia, non c’erano segni devastanti sui nostri corpi levigati ed essenziali, ma lentamente, lungo le molte stagioni vissute,
l’aura del nostro campo magnetico si assottigliava e l’energia in esso custodita e che alimentava corpo e pensieri, cominciava a rifluire al di fuori, come una nebbiolina
sottile e impalpabile.
Era un processo lento ma inesorabile.
Quando il pensiero era così sottile da non poter essere sostenuto e condiviso, allora era giunto il momento della quiescenza, e si desiderava solo riposare e ritemprarsi, per poi ritornare e continuare il cammino intrapreso.
Così in una coppa si versava la dose del potente narcotico scelto per sciogliere il corpo dall’essenza, in pace si salutavano gli amici e i propri cari e si affrontava il viaggio nell’Impalpabile.
E non c’era sofferenza nel distacco, perché sapevamo che saremmo tutti ritornati, ma solamente aleggiava una tenera e lieve malinconia.
Ogni giorno mi recavo alla grande Distesa: era mio compito coltivare le mie facoltà, era mio piacere attingere all’oscura fonte del ricordo, a piene mani, senza remissione, senza interruzione.
All’inizio della mia educazione il Maestro veniva sempre con me: saldo e ieratico, a volte era taciturno e laconico, a volte invece le parole uscivano dalle sue labbra come spuma di vino giovane e generoso, addolcito dal miele della sua profonda conoscenza e della sua saggezza.
Per lungo tempo aveva trasfuso nella sua mente tutta la scienza fino a noi pervenuta, per lungo tempo aveva solo ascoltato, letto, meditato, ricordato; molto tempo era trascorso perché per lui venisse il tempo di parlare.
Su Antron la conoscenza era alla portata di tutti, ma le grandi menti fungevano da memoria storica e da catalizzatori per la trasformazione collettiva, per il cammino spirituale dell’intero pianeta; e raffinata era la cura con la quale queste menti superiori venivano preparate.
Subito, alla loro nascita, queste menti eccelse erano riconosciute dal colore lievemente diverso dell’aura, che era più brillante, come se tutte le sfumatura dell’orizzonte giocassero a nascondersi dentro di essa…
Quando mio padre mi pose dentro la mia culla, traendomi dalle braccia di mia madre che mi aveva appena messo al mondo, le pareti della nostra casa rifletterono la potenza della mia mente ed essi seppero immediatamente quali sarebbero stati il mio compito e il mio destino.
Per me non ci fu un’età paragonabile all’infanzia: solo la mancanza di spessore dell’aura mi impediva di essere subito pronta per affrontare lo studio e la meditazione.
Avevo bisogno che il calore e le cure affettuose dei miei genitori rafforzassero la struttura incorporea che ci avvolgeva e che ci permeava, entro la quale eravamo protetti e attraverso la quale ci nutrivamo e incrementavamo il nostro essere.
Nella casa paterna, semplice e luminosa, giochi, canti e silenzi si alternavano con ritmi immutabili e i periodi di veglia e di riposo venivano condivisi da tutta la nostra numerosa famiglia.
Non avevamo bisogno di lavorare, perché il suolo offriva in abbondanza risorse energetiche che bastavano a sostenerci: eravamo gli unici esseri viventi su quelle terre,
se si eccepivano gli arbusti spinosi che crescevano sul litorale, e l’intera superficie del nostro mondo era levigata e morbida al tatto, quasi elastica, ondulata e variabile nei colori.
Le nostre case erano basse e spaziose e si confondevano quasi inosservate tra le dune.
Erano raggruppate in piccoli paesi dove ci si conosceva tutti e dove la coralità aveva una grande importanza: le letture e le rappresentazioni teatrali e musicali erano quotidiane e coinvolgevano ognuno di noi.
Tutti gli abitanti del villaggio si curavano collettivamente della manutenzione delle case esistenti e della costruzione di quelle nuove.
In tempi remoti, su Antron era proliferata una vegetazione eteromorfa, una fauna vistosa aveva animato il pianeta e vi erano state lunghe stagioni durante la quale la lotta tra uguali era la Legge che governava le vite.
Lungo e difficile era stato il processo che aveva fatto del nostro un popolo di pacifici cittadini dell’universo, di cultori della mente e della memoria.
I testi antichi narravano di macchine belliche, di distruzioni di massa, di immani devastazioni e di immensi lutti, ma non fu un cataclisma enorme a cessare tutto ciò: il pianeta si era talmente impoverito da degenerare in un’entità ostile e maligna, al punto che i più intraprendenti fra i sopravvissuti si erano imbarcati su poderose astronavi capaci di viaggiare nel tempo e si erano trasferiti altrove.
Furono in pochi a rimanere: coloro che avevano ben chiaro che il cambiamento doveva nascere all’interno di loro stessi, perché in qualsiasi luogo dell’Universo essi fossero andati avrebbero trovato solo ciò che portavano dentro.
Questa sparuta comunità continuò a vivere la
propria trasformazione interiore e lentamente questa mutazione si diffuse in tutto il pianeta: ciò che era andato distrutto non fu più ricreato, ma ciò che era rimasto potenziò talmente se stesso che Antron divenne un luogo di pace e di cultura.
Fu allora che ai Maestri Antichi del mio Maestro venne rivelato il vero scopo della nostra esistenza: curare la memoria universale, tenere, con la nostra energia mentale, aperte le porte dei flussi mnemonici tra uno spazio siderale e l’altro, mandare le vertiginose onde mentali che attraversavano gli infiniti vuoti per giungere là, dove serviva il Ricordo.
Sapevamo che la vita era composita e straordinariamente evoluta, che un’unica Legge governava il tempo senza tempo, e sapevamo che in luoghi dove ancora l’Oscurità
aveva i suoi domini, solo il ricordare poteva trasmettere la forza dell’Illuminazione.
A suo tempo alcuni di noi sarebbero nati in quei luoghi e tempi oscuri e, ricordando la vera guida e la vera parola, avrebbero permesso agli altri loro contemporanei di ricordare, quindi di capire e di intraprendere il cammino verso la pace e la vera felicità.
Così, in attesa di quello, ogni giorno io andavo alla Distesa della Contemplazione per coltivare la mia mente e lubrificare le porte dell’Universo.

LA VISIONE
DELL’ALDILÀ
Possiedo un sogno racchiuso in me, che poi non è un sogno, ma il preciso ricordo del luogo dove sono stata molte volte, il luogo al quale ritorno sempre negli intervalli tra una esistenza e l’altra e nel quale mi rifugio quando soffro troppo, colpita dagli eventi e dall’apparente contraddizione del mio presente.
È un mondo che ho visto due volte in questa vita, durante due coma procurati dai miei tentativi autolesionistici portati a termine per il desiderio di tornarvi, ed è il preciso ricordo del posto dove tutti ritorniamo.
È quello un immenso spazio rarefatto ma fittamente intessuto di energia, di un bianco
scintillante e totale, senza inflessioni di nessun altro colore, come li racchiudesse e li esprimesse tutti eliminandoli, un bianco purissimo e luminosissimo, ma mai accecante, anzi, direi proprio accogliente.
Lì si prova l’emozione di immergersi in una enorme conca battesimale densa di vapori profumati e di latte morbido e cremoso, di tuffarsi nella coltre di nuvole bianche, simili a quelle intraviste sotto di me durante un viaggio in aeroplano.
In quel regno di puro spirito, terra dell’impermanenza, la vita vive di «non bisogni », il corpo si è sciolto e fuso ai gorghi atomici delle stelle e delle galassie e quello che si ode è un cantico né umano, né angelico, né divino, ma naturale: il cantico di ogni voce emessa dall’inizio dei tempi che ha trovato in quella dimensione il tono giusto, il tempo, il luogo per accordarsi a tutte le altre miriadi di voci.
È una pace senza confini, senza battiti, senza sussulti, una leggerezza profondissima, una immensa comprensione senza domande; una perfetta risposta non richiesta né attesa.
Quella sublime sensazione nella quale, citando il maestro e Buddha Gautama Siddharta,
«gli uomini e gli dei stanno insieme e a proprio agio, suonando i tamburi celesti sotto una pioggia di rari e profumati fiori di mandarawa».
Questa pura terra esiste e io l’ho vista, e so che germoglia e fiorisce nel profondo di ogni cuore, di ogni vita.
Come so che trovarla, riconoscerla e vederla ci dona la felicità che nulla può scuotere, che nulla attende, che nulla si aspetta e che mai nulla perde.
Perché la morte è un passaggio e io la chiamo Madre.
La morte è un abbraccio: è l’invalicabile ritorno da un viaggio faticoso e doloroso che ha consumato i calli dei nostri piedi e delle nostre mani fino a scoprirne la carne pulsante e il vibrante nervo denudato.
Il ricordo di questo viaggio è molto vivo in me, come non fosse finito mai, come mai avessi perduto quella emozione.
Dentro, in fondo al mio essere, questo ricordo elimina ogni paura, perché sempre penso che la cosa più temuta che possa accadere ad un essere umano è la morte, mentre io so che la morte è la liberazione da questa catena di sangue e dolore, da questo sconcertante vissuto senza senso alcuno.
Quindi sono perfettamente conscia del fatto che quello che sto vivendo ora, sia il peggio che possa accadermi, che le mie sofferenze del corpo della mente del cuore e dell'anima siano le peggiori che si possano trovare in tutto l'universo.
Così come so che presto termineranno, perché la data della mia morte si fa sempre più vicina.
E questo mi dona una ineffabile felicità e sollievo.
Ogni giorno dentro di me rivivo quel viaggio.
Mi sentivo come una scatola di cartone bianco e spesso, con il coperchio chiuso: esso è il mio Karma concentrato, cioè tutto quello che è il vissuto delle mie innumerevoli vite raddensato in una specie di unità indivisibile.
Una vita a confronto del tempo senza tempo equivale a un battito di ciglia, ma è unica e irripetibile nella sua essenza poiché in essa si racchiudono tutta una sequenza di cause - effetti di altre poste precedentemente, - che danno corso ad effetti i quali diventano a loro volta cause ulteriormente nuovi effetti.
È questa una concatenazione logica che non può essere interrotta.
Eliminare una vita sarebbe come far saltare tutte le connessioni e siccome ogni essere vivente è connesso a tutti gli altri ed è immerso nell'intorno come fosse parte integrante di un infuso, eliminare una singola vita sarebbe la causa di una implosione dell'intero universo.
Per questa ragione in ogni istante di vita è racchiuso tutto il passato, espresso come causa posta, e tutto il futuro, espresso come effetto derivato.
Il tempo, come lo intendiamo noi è una concezione puramente utilitaristica.
In effetti il tempo non esiste.
Perché il secondo che sto vivendo ora, in un secondo diventa immediatamente passato ed il secondo futuro diventa il presente e quello futuro prossimo diventa il futuro immediato.
Quindi il tempo è sempre presente in tutta la sua sostanza ed esistenza in se stesso.
Ed in ogni istante esso è racchiuso per intero. Se si capisce questo si può facilmente comprendere l'importanza di ogni nostro atto, pensiero parola, ma soprattutto di ogni intenzione.
Infatti è l'intenzione che da la valenza alla causa e che quindi da l'effettiva sostanza dell'effetto che ne deriva.
È l'intenzione che guida il nostro cammino verso l'illuminazione.
In quel viaggio quindi scendevo velocemente, senza attrito, senza alcuna paura, lungo uno scivolo simile a un tubo di plexiglas morbido e opaco come l'insieme di un liquido versato da un recipiente.
Era una discesa senza scosse e senza urti, senza che io mi chiedessi dove stessi andando, dato che il luogo mi era perfettamente conosciuto.
Scivolavo verso l’immensa e incommensurabile pianura di energia bianca, di ricordi trasparenti, affastellati come cellette in un favo ben costruito da api operose.
E mentre viaggiavo portavo con me, dentro e fuori, il cantico delle creature, il suono angelico e misterioso che mi ammaliava, simile al canto delle Sirene di Ulisse.
Ma nulla di misterioso e incognito era celato in quel canto: esso era invero il canone di spiegazione, quel libretto di istruzioni per l’uso e la manutenzione della vita umana che da sempre avevo cercato e mai trovato.
La prima volta che feci l'esperienza della «bianca visione», come viene comunemente chiamata e che è stata descritta perfettamente simile alla mia da numerosi altri esseri umani che l'hanno vissuta, nel momento in cui arrivai in quella pianura del sapere e della consapevolezza, chiesi a voce alta:
«Signore, sono morta?»
Ed Egli, al quale attribuisco il nome di Legge Mistica ma che potrebbe essere stato uno qualsiasi fra i grandi
Maestri e Buddha, da Siddharta a Nichiren, da Cristo a Maometto o Noè, mi rispose:
«No, non sei morta, non è ancora arrivato il tuo momento. Devi tornare sulla terra.»
A quella risposta non seguì né dolore né gioia, ma un senso di considerazione, di accettazione, di accoglimento per il mio compito non ancora svolto, anche se stavo tentando di sfuggirvi, perché lo sentivo troppo doloroso e gravoso.
Ora so che la vita non ci mette mai di fronte a prove che non abbiamo la capacità di affrontare.
Così, già pronta per il mio ritorno, chiesi ancora:
«Ti ricorderai di me, Signore?»
Ed Egli rispose:
«Ho già pronto per te un piccolo posto alla mia destra!»
E fu proprio a quel punto mi risvegliai, sorridendo.
Quella esperienza ha cambiato completamente tutto il mio modo di sentire e di affrontare la vita: tutto quanto di straordinario io ho vissuto in essa ha trovato il suo compimento e la sua definitiva spiegazione.
Non che dopo di essa io non abbia vissuto più nulla di incredibile e meraviglioso, tutt'altro, ma la visione dell'aldilà è il compendio, è la fusione di tutto quanto io abbia conosciuto prima e dopo di essa.
Quella mistica apparizione è la chiave di volta, la chiave di violino della sinfonia infinita della mia vita.
Ora so che sono tornata volontariamente per l’ultima volta su questo pianeta e che presto mi attende l’immensa luce del Nirvana: la vittoria sul Karma umano di nascita e di morte.
Sono tornata per lasciare l’impronta della mia anima nata dolente e violata dalla non appartenenza a nessuna realtà, neppure a quella del grembo di mia madre, e risorta dall’ultimo singulto senza ritorno, nello stesso corpo ammalato, sfinito e stanco, per ricordare e portare il ricordo della verità a chi ha chiuso la porta in faccia alla speranza.
Questo è il racconto finale del mia seconda piccola opera letteraria.
Anche a questo voglio apporre una piccola appendice.
Proprio ieri, 10 febbraio 2012, la signora che viene a prendersi cura della mia casa ha fatto un sogno, molto particolare, che io reputo bellissimo.
Ha sognato una astronave tra gli alberi.
Era esattamente come si vede nei film, ha forma di disco, con la cupola trasparente e i piedi per appoggiarsi al suolo.
Era luminosa e molto grande.
Nessun essere ne è sceso, ma una voce profonda, proprio come fosse l'astronave stessa a parlare, ha detto che erano venuti a prendere me.
Lei, stupita, ha chiesto conferma, che la voce le ha dato ripetendo che erano venuti e prendermi e chiedendole se ero pronta.
In linea di massimo io sono del tutto pronta.
Forse mi rimane solo di pubblicare su tutto quanto ho scritto sino ad ora, o almeno, la maggior parte.
Per questo proseguirò su questa
o sito a postare tutta la mia produzione sritta e per immagini.
Le novelle che seguono non sono quindi incluse nel cartaceo di KAIKI e sono e verranno scritte in vari momenti della mia vita.

Raccontino ispirato da questa
opera pittorica di ROSSANA
PARENTI
IL COPRILETTO
Si guardava nello specchio.
I capelli presi dal gel e stesi a coprire le tempie e la front ormai troppo spaziosi.
Capelli che portavano un colore che non era più il loro, ma preso in prestito dalle mani accorte di un parrucchiere.
La vestaglia da camera di raso bordeaux spiccava contro il suo mento pallido che recava l'ombra di una barba non rasata, un'ombra che si ripercuoteva sotto gli occhi segnandoli come per farli
risaltare.
Una lacrima scese lungo una gota ormai scarna:
nessuna mano corse a raccoglierla, ma fu lasciata così, scorrere, come un fiume verso il mare.
Una voce di donna non più giovane ed un poco stanca, quietamente rassegnata, da fuori la porta chiese:
Devo apparecchiare per due, signor conte?
Come un automa la sua voce rispose:
' No, Filomena, grazie, stasera ceno da solo '....

anche questa è una ' favoletta' ispirata da questa opera pittorica di Rossana Parenti
MEMORIE
Entrò nella stanza.
L'odore di fumo delle sue mille sigarette albeggiava ovunque esattamente come la luce stava dilagando nel buio della stanza.
Ancora un giorno da vivere, ancora un giorno da riempire di azioni che contrastassero quelle grida che sentiva dentro.
Voltò le spalle alla finestra e si girò verso il letto, visibilmente in disordine, esattamente
come i suoi pensieri.
Ma perché la realtà veste di noi, ci prende e ci spalma su tutto quello che vediamo, tocchiamo sentiamo, incontriamo?
Perché la realtà è sempre il nostro specchio, il nostro tragico impietoso fottutissimo specchio??
Un'ombra sul letto le catturò lo sguardo e l'attenzione, mentre si chinava per afferrare un lembo del lenzuolo e disfarlo.
Si fermò, fece due passi indietro, rabbrividì.
sulla sinistra, proprio dove lui avrebbe dovuto aver dormito, il muso sconvolto di un cavallo bianco si protendeva contro di lei. le fauci aperte, i denti scoperti, l'occhio ferino ed
impazzito
Sulla destra, un po' più in basso, l'orecchio di un altro cavallo e poi le lenzuola, come se gli coprissero il muso, segnandone i contorni.
Rabbrividì ancora.
Lui non era un cavallo e non l'aveva morsa, eppure, il suo gesto dentro di lei era quello. Proprio quello, ogni volta che entrava nella sua stanza, senza bussare, o che la prendeva di peso,
dovunque si trovasse in giro per la casa, la sollevasse, lei che era così minuta e lui così alto e la gettava quasi sul letto.
Rivedeva lo sguardo, il suo sguardo, il suo viso distorto nella furia del violento desidero senza amore, mentre, in piedi sulle ginocchia, tra le sue gambe tenute a forza spalancate da quel suo
esservisi messo in mezzo, si slacciava la cintura e si sbottonava i pantaloni.
E poi, come una furia, la prendeva, come si prende un oggetto, oppure l'ultima delle prostitute.
Si scosse da quei pensieri, fece un passo avanti, allungò una mano e disfò le lenzuola.
Solo lei aveva dormito in quel letto la notte appena trascorsa.
Lui non era più..
E un altro brivido le percorse le braccia e la schiena..
Cominciò a ricordare di nuovo, ancora...
Ma questa è un'altra storia..
sono certa che c'è un altro quadro che la racconta......

Raccontino ispirato a questo
dipinto di ROSSANA PARENTI
MEMORIE -
SECONDA PARTE
La luce filtrava dalla piccola finestra alta e fioca. Non vi erano le sbarre, come nelle barzellette, ma vetri blindati fissati nel muro..
Difficile, oserei dire impossibile, evadere da lì
ma poi, perchè evadere?
Da qualche parte doveva pur stare e lì, alla fine, non era poi peggio che altrove..
Si tirò su.. la branda era appoggiata con il lato corto alla parete
Sprimacciò ancora un po' il cuscino e vi ci si appoggiò con la schiena.
Puntò i piedi contro le natiche ed afferrò le ginocchia con le braccia, vi appoggiò la guancia,
lo sguardo attratto da un'ombra su muro..
Respirò e nell'aria sentì ancora quell'odore.
Erano passati sei anni ma quell'odore non la abbandonava.
L'aveva detto anche allo psicologo e lo psichiatra, di quell'odore, ma loro le aveano risposto che era normale..
Che la cosa era normale. che faceva parte delle conseguenze di quello che era accaduto. .
Ma lei lo sapeva che normale non era.
Perchè quell'odore racchiudeva ancora il sapore delle lacrime che le rigavano il viso quel giorno, un sapore come di muffito e stantio, come di qualcosa lasciato troppo a lungo in una cantina
umida e buia.
Conteneva ancora l'adrenalina forte, così forte da farle stridere i denti.
Ma soprattutto nascondeva i suoni di quella notte, quei rumori sotterranei che campeggiavano in ogni silenzio reale, da allora in poi e che si mescolavano ad ogni reale rumore, vestendolo di sé
in modo che esso diveniva padrone di tutto ed era ovunque
Erano passati sei anni eppure sembravano sei minuti, ma anche sei secoli, tanto erano state gravi ed allungate le giornate, pesanti e immobili le ore, rombanti ed assordanti i minuti.
Su tutto, in tutto dappertutto quell'odore.
e le immagini della sequenza che in continuazione le si presentava ai sensi, come la stesse ancora effettivamente vivendo:
lui entrava nella stanza
lui la prendeva in braccio sollevandola di peso
lui, con lei in braccio, entrava nella stanza da letto
lui la gettava sul letto ridendo del suo terrore
lui le era subito addosso aprendole di forza le gambe
lui le era dentro con un sol colpo e la montava con furia
lei tirava fuori il coltello affilatissimo nascosto sotto il cuscino e glielo piantava con forza nel fegato
lui che si staccava da lei urlando e lei che piantava il coltello
ancora ancora ancora ancora ancora.....
lui che le si accasciava addosso rantolando vomitando sangue, morendo.
Ed eco l'odore, l'odore del suo sangue, che le entrava nel naso in bocca negli occhi ovunque.
Erano passati sei anni.
Ancora altri dieci avrebbe dovuto trascorrere in prigione, ma presto sarebbe uscita di lì agli arresti domiciliari per buona condotta.
D'altronde aveva pagato venti anni di durissima violenta galera, il suo matrimonio, prima di commettere l'omicidio.
Il debito era stato saldato ampiamente.
Alzò lo sguardo verso un polveroso raggio di sole che filtrava improvviso dalla finestra.
I suoi occhi si rischiarono.
Mormorò, partorendolo delicatamente dalle labbra secche: mio dio....
Nell'aria, inatteso, all'improvviso, come un brivido che le increspasse la pelle e in tutta la realtà intorno si sparse un meraviglioso intenso delizioso pulitissimo profumo di
viole.

AVEVA MOLTO
AMATO
favoletta ispirata da questo dipinto di Rossana Parenti
Aveva molto amato.
Tanto da non avere più fiato.
Tanto da non avere più lacrime.
Uomini, giovani e meno giovani, donne, ragazze.
Aveva percorso notti intere a cercare, a dare il piacere.
A l'aveva trovato
Perché lo sentiva dentro, perchè altro le persone non volevano da lei
Come un magnete il suo corpo, non bello ma accogliente, attirava i profughi dell'amore: era un porto, quel corpo, una madre, una fonte battesimale
E quando i sospiri si acquietavano, le braccia e le mani sapevano narrare di tenerezza, lenire un rimpianto, asciugare una lacrima mai versata.
Aveva molto amato.
Ma chi aveva amato lei?
Quel giorno si alzò: era ancora lontano dall'alba lo spiraglio che entrava dalla persiana accostata.
Accese la luce del soffitto
E fu il bianco del lenzuolo che rispose al suo buongiorno.

ancora una favoletta su opera
di ROSSANA PARENTI
EUGENIA
Eugenia apre la finestra..
Fuori c'è già un bel sole alto. è aprile ma già scalda.
È domenica e lei si sente pigra: ha dormito poco e male, le pieghe del cuscino a
pungerle quella solitudine alla quale ormai è abituata.
Guarda fuori.. la strada è deserta.
Un cane passa trottando. Lei pensa: chissà dove sta andando,e le viene voglia di
seguirlo.
Cerca di ricordare da quanto tempo è che vive sola.
Senza neppure rendersi conto che stava in veste da camera e con le pantofole, scende di corsa le scale, spalanca l'uscio ed esce in strada, temendo che l'animale possa essere
scomparso.
Ma esso è lì, a qualche decina di metri, la testa un po' abbassata come fosse assorto nei suoi pensieri.
Eugenia lo chiama..
Quello si volta e resta esitante poi, con passo incerto si avvicina a quella donna non più giovane che in veste da camera sembra si stia rivolgendo a lei..
Perché è una lei, una meticcia di taglia media a pelo raso, nera, o meglio, color fuliggine.
magra per la gioventù e la vita randagia, due occhi dolcissimi, due laghi d'ebano fuso.
Eugenia le tende la mano.
Non ha mai avuto un cane e sente un po' di timore, ma la cucciolona, abbassandosi un poco come per chiederle scusa, le si fa accanto ed allunga un lecco a quella mano: un bacio casto e
gratuito.
Poi fa per voltarsi ed andarsene, ma Eugenia di nuovo la chiama:
' Bella, aspetta.. hai fame? Ho una bistecca in frigo.. che dici, facciamo a metà? '
La bestiola non ha capito il senso delle parole, ma il tono è un invito e lo sguardo è di amore triste e malinconico.
Ancora non sa della bistecca, ma..
Ma si fa incontro allora festosa a quella grazia gentile, le scodinzola felice e la segue verso casa, quando lei si gira e si incammina.
Il sole sorride..
Quel guanciale che sta scaldando, lui sa, la notte che verrà accoglierà un altro capo.....

IL CONTE
FABRIZIO
BENELLI
piano americano, ora mentre sto scrivendo, settembre 2010 -
Le camere della casa nella quale vivo, qui in questo paesino di pastori sardi accoccolato su di una collina a nord ovest di Sassari, hanno alti soffitti.
A terra marmi e ceramica decorata d'altri tempi, alle pareti disegni come parati e mobili dell'ottocento o forse anche più vecchi, ai soffitti rosoni e piccoli affreschi.
Tutto reca i segni delle ingiurie di quanto ha passato e dell'incuria alla quale troppo spesso è stato abbandonato, ma il respiro di queste stanze è ampio, quasi solenne.
L'atmosfera antica e calma.
Quando sono entrata qui per la prima volta ho sentito le braccia di questi luoghi cingermi le spalle, intimi, amichevoli, accoglienti.
Il mio respiro era un coro.
Ho sentito che ero a casa.
La mia prima vera casa.
-
Zoom...lontano, attraverso la porta aperta di una mia vita passata.. -
La casa era appoggiata sulla collina come un topazio giallo su di una corona di lecci e cipressi.
Il viale di terra rossa senese che portava al prato morbido di erba bassa e folta davanti alla scalinata di marmo bianco venato di madreperla, si snodava in curve lente e molli lungo il fianco di un bosco luminoso dove la rosa canina allietava macchie di corti radure.
Pascoli screziati dei fiori viola delle leguminose e uliveti cangianti di grigi e argenti vestivano le basse colline intorno, mentre i poggetti erano a latifoglie: pioppi, platani e ippocastani.
Castagni si arrampicavano ancora più in alto fino all'impero degli abeti che sfumava nell'azzurro violetto delle montagne dell'alto Mugello, ancora più in fondo.
Firenze ai piedi e lontana si svolgeva, invisibile da quelle alture, brulicante e immensa.
La torretta centrale svettava smerlata dal tetto e dava appoggio alla campana di bronzo che scandiva le ore di lavoro e di riposo del contado.
Era un piccolo feudo antico propagato da padre a primogenito, un semplice maniero di campagna dove la nobiltà sposava il lavoro e la vita dei campi.
Donato secoli prima alla fedeltà e al sacrificio di vite del mio casato per il principe di Firenze, era giunto a me e mi scorreva nelle vene con il sangue di conte: conte Fabrizio Benelli.
I visi di quanti mi porsero quel dono mi ammonivano seri e ieratici dalle pareti damascate del salone, dove io, ancora bambino, entravo accompagnato da mio padre che guardava, chiamandoli per nome, quelle tele ovali con i campi scuri dove risaltava l'incarnato chiaro dei nostri avi, sul quale gli occhi scurissimi e brucianti emanavano moniti e fermezza.
Il lungo tavolo di noce frattino era ornato con cesti ricolmi di frutta di stagione e le scranne dalle alte spalliere addolcivano l'aspra seduta di legno massello con cuscini verde scuro a piccoli gigli ocra.
Firenze e i suoi signori erano stati lì per partite di caccia al cinghiale e al capriolo, avevano scaldato all'arola del grande camino acceso i piedi raggelati dalle ore di cavallo per i boschi e lungo le strade per le valli.
Avevano spento la sete in coppe di morbido chianti rubino e placato la fame delle levate prima dell'alba nell'aria frizzante di fine inverno con ribollite e arrosti speziati cucinati al focolare dalle fantesche contadine e sagge.
Io ascoltavo le loro voci gravi di uomini forti e i cicaleggi delle dame allargare gli spazi delle stanze, ornare i lampadari di ferro battuto che scendevano dalle travi di noce e castagno.
Quella terra e quella magione erano intrise di fedeltà, gentilezza e semplice nobiltà.
Divenuto io il primo signore di quel luogo sereno, non volli altro dalla mia vita che pascermi delle ore lente e sicure che lì mi sostenevano.
Gli studi giovanili e goliardici a Firenze, la vita di società, i balli, i salotti mi erano alieni e fatui.
Sprofondato nell'ampia poltrona davanti al largo focolare sempre acceso, al lume della lampada a petrolio, leggevo l'ottocento dipanarsi dal passato, senza volerne percorrere le vie frettolose e mondane, accogliendo con un sorriso appena pronunciato i suoni delle cucine e delle scuderie.
Introverso, taciturno e un poco timido, poco attenevo ad altre vie se non quelle del mio lignaggio rustico.
Al mattino all'alba un naturale destarsi mi conduceva tra i filari delle vigne profumate e i declivi a volte scortesi degli uliveti, e le ore delle mie giornate erano fitte di semine, arature, raccolte, spremiture, armenti bianchi dalle larghe corna e forti zoccoli di cavalli bai e sauri.
Appoggiavo la mano forte e onesta senza guanti tra le loro crini grosse e lucide come le passassi tra le chiome di una dama innamorata.
Il calore e l'odore della fina pelle fremente e sudata della mia cavalcatura mi allargava le narici in un soddisfatto respiro.
Il labbro morbido di velluto mentre frugava sul mio palmo aperto a cogliere avena ed orzo donati come piccolo premio dopo una lunga galoppata nel mattino freddo dell'inverno appena giunto, mi colmava di malcelata tenerezza.
La scuderia bassa e lunga al lato della grande casa padronale accoglieva una decina di belle bestie di buon sangue, da tiro leggero per le carrozze e i carrozzini e da sella per le cacce e le galoppate.
Erano animali di ottimo lignaggio dai manti lustri per le cure e il buon cibo, in salute per le lettiere abbondanti di paglia croccante sempre pulita, le fienagioni montane e il maniscalco che regolarmente apponeva ferri nuovi e studiati con millimetrica precisione.
La brusca e la striglia erano passate due volte al giorno su quelle groppe ospitali e generose, a togliere la polvere e le striature biancastre del sudore asciugatosi sulle membra poderose. Gli zoccoli erano ammorbiditi e lucidati col grasso e il catrame vegetale.
I finimenti di cuoio di primo fiore spesso ed ambrato, caldo di colore e dal profumo penetrante, erano riposti nella selleria ai palchetti di legno infissi in bella geometria al muro e quotidianamente protetti con l'appropriato linimento.
I velli di agnello per attutire il contatto con la sella e proteggere gli alti garresi dalle pericolose e dolorose fiaccature, messi ad asciugare al sole nella buona stagione o accanto all'alta stufa a legna di terracotta che riscaldava l'ampio spazio di accesso alle scuderie, nel quale si sellavano i cavalli o li si attaccavano ai loro tiri.
I mattoni a vista del caseggiato antico quanto la casa attutivano e assorbivano il sonoro rintocco degli zoccoli, e lo scalpiccio degli stivali di cuoio nero, al ginocchio, tra il lieve tintinnio degli speroni.
Non ricordavo un solo giorno della mia vita che io non avessi montato a cavallo.
Mio padre prestissimo mi affidò ad un vecchio e saggio destriero che per lunghi anni lo aveva servito ed accompagnato per i vari affari di famiglia, sapendo che egli mai e poi mai sarebbe stato riottoso alla mia mano infantile, e che mai e poi mai quelle forti e un po' stanche membra mi avrebbero disarcionato.
Io portavo la mia cavalcatura, sulla quale a malapena mi si scorgeva, tanto essa era alta e imponente, ed io piccolo e fragile, con mano ferma e gentile, accompagnando i comandi delle gambe e delle spalle con gli schiocchi e i sussurri della lingua, così come mio padre faceva.
Egli posava con orgoglio i suoi vivi occhi franchi su di me, e diceva sempre a mia madre che ero nato per andare a cavallo.
E sempre, mentre accarezzavo il collo accaldato della mia giumenta, io sentivo quelle parole allargarmi il cuore.
Due erano i servitori che si prendevano cura della scuderia: lo scudiero Gianni, un vecchio coriaceo e allampanato che già fu al servizio di mio padre, giunto a lui ancora bambino e che conosceva l'arte di curare i cavalli attingendo all'esperienza di intere generazioni precedenti, e un garzone di stalla. Ogni dieci anni questo garzone, quando le sue forze stavano scemando un poco per l'età, veniva trasferito ad altri incarichi e sostituito da un altro più giovane e integro.
Fu cosi che Lucio posò il suo passo scalzo sull'acciottolato antistante la scuderia.
Era un ragazzo di poco più di sedici anni, non troppo alto ma assai ben costruito e forte.
Il suo corpo snello di popolano non era però gravato in nulla dai natali oscuri, e una fiera bellezza illuminava il suo viso abbronzato dal sole delle campagne e degli orti nei quali aveva trascorso la fanciullezza.
Figlio di bravi e onesti contadini che da generazioni lavoravano in pace e serenità le nostre terre, era apparso subito diverso da loro, come un fiore gentile nato tra irti rovi.
Aveva nelle sue fattezze qualcosa di estremo e nobile, e nel portamento naturalmente eretto ma senza protervia, si scorgeva altro che la rustica onestà della gente dalla quale discendeva.
E' pur vero che Leonardo da Vinci era figlio di una sguattera e di un signorotto di campagna.
Così come figli di degni padri furono assolutamente inetti e privi di qualsiasi intelligenza.
Nostra madre natura mescola con cura le carte perché l'asso possa correre ad ogni mano che si tenda per giocarle.
Ciò che mi colpì in lui, quando lo vidi in piedi accanto all'arco ribassato che introduceva al portico sotto il quale erano ricoverati la carrozza e i carrozzini scoperti, fu lo sguardo aperto, di cielo.
Due incredibili occhi azzurri si affacciavano sul viso dalla carnagione scura e spiccavano contro le nuvole corvine dei suoi riccioletti scompigliati dalla corsa, mentre guardava serenamente verso di me, accennando al mio giungergli vicino un leggero inchino pieno di semplicità.
Né mai abbassò quello sguardo acceso mentre io gli parlavo, chiedendogli di lui e dei genitori, ai quali ero affettuosamente legato fin da bambino. Anzi, li fissò schiettamente nei miei, come parlasse ad un suo coetaneo ed amico, sorridendo lievemente senza mostrare i denti, che aveva bianchi e perfetti.
Io certo non ero solito guardare così direttamente negli occhi i miei interlocutori, abituato a persone che per il loro rango inferiore al mio, mi parlavano guardando fisso in terra, oppure facevano emergere occhiate timide e di traverso tra una loro parola e l'altra per controllare le mie reazioni.
Non che io per indole ci tenessi ad affermare il mio rango, ma la mia timidezza diventava ritrosia e si vestiva di austerità: per difendere me stesso sembravo assai più burbero di quello che ero in realtà.
E in questo non ero certo simile a mio padre che trattava con i mezzadri e i fittavoli dando loro amichevole energiche pacche sulle spalle e condividendo con loro le colorite espressioni dell'alta Toscana. Piuttosto era la ritrosia di mia madre, dalla quale avevo ereditato i lineamenti assai fini e gentili e l'incarnato chiaro, che rifioriva nei miei modi.
Mia madre che, di salute cagionevole, mi aveva lasciato per le terre celesti quando avevo poco più di otto anni e della quale ricordavo però assai bene le tenere carezze e la voce flautata.
E pure assai presto mio padre mi rese orfano e gestore delle sue terre, morendo in un incidente di caccia quando io avevo ventisette anni.
Avevo così trentaquattro anni quando presi il giovane Lucio con me.
L'amore per i cavalli ci unì immediatamente: il tocco lieve e fermo della sua mano mentre spazzolava il loro mantello o li accompagnava per la lunghina e li fermava alla posta per la pulizia, agganciandoli alla capezza ai due venti perché stessero fermi, era il mio stesso franco e innamorato ricercare quella pelle sottile e calda che si appoggiava con fiducia al mio palmo che li amava.
E ugualmente al par mio egli sembrava capire a fondo i pensieri delle giumente da sella e dei castroni da tiro, scoprendo al primo sguardo uno stato di irritazione e o di indisposizione solo cogliendo un insolito portamento delle loro mobili orecchie o una incerta postura di una sottile zampa.
Lo stesso Gianni, assai burbero e di poche parole, stanco ormai di insegnare la propria arte e scienza a zucche troppo semplici o troppo impulsive di garzoni che sì, lavoravano sodo, ma non erano certo portati ad apprendere la fine arte dell'equitazione e della cura dei cavalli, e che quindi si era comportato in modo assai poco cerimonioso con gli altri suoi aiutanti, con Lucio aveva un atteggiamento paterno, come da mentore, e gli insegnava con pazienza, dolcezza e nei minimi particolari tutto quello che egli aveva imparato dai propri maestri nei lunghi anni del suo servizio nelle scuderie di casa mia, come se vedesse in lui il degno successore che mai aveva trovato fino ad allora, come un padre verso il figlio primogenito al quale lascerà poi la bottega o il campo o le armi del lavoro.
Spesso io e il giovane ci trovavamo a emettere gli stessi suoni fiochi o gutturali per blandire il riottoso puledro insanguato o spronare il pigro cavallo al traino in seconda fila; spesso, assai spesso egli giungeva da me chiedendomi udienza per riferirmi qualcosa che egli giudicava importante o insolito, proprio mentre io stavo pensando a lui, o mentre immaginavo di farlo chiamare per assegnargli un compito.
Egli appariva alla porta del mio studio, interamente rivestito fino al soffitto di scaffali gravi di libri e tomi, con il berretto in mano per deferenza e rispetto, ma con quello sguardo fanciullesco pacato e arricchito di una spontanea saggezza.
E al suono della sua voce il cuore mi dava un balzo al petto.
Non avevo figli e non mi ero sposato.
In effetti non mi sentivo portato per la famiglia, anche se alla famiglia avevo dedicato tutta la vita. Ma, nonostante ci avessi pensato molte volte, e fossi stato spronato e da mio padre a prender moglie, non avevo mai trovato né incontrato nessuna fanciulla che mi emozionasse in alcuna maniera, né tra le nobili discendenze del mio pari, né tra le fanciulle del popolo, dei contadini e figlie di artigiani, che affollavano la mia casa per le varie faccende domestiche e muliebri.
E si che ero ritenuto un bel giovane, alto e distinto, di portamento fiero e gentile, ero colto e più che benestante, ero serio e aggraziato, e mai il mio comportamento era stato giudicato riprovevole o bizzarro.
Quando a Firenze ero solito trascorrere le sere liberi dagli studi, nei quali mi impegnavo al massimo, dato che l'amore per i libri mi aveva sempre accompagnato fin da bambino, con qualche compagno di università, rifuggivo comunque quelli molto vivaci e goliardici, né mi facevo trascinare facilmente per osterie e feste. Pur prendendo parte ai miei obblighi di società nei salotti della nobiltà presso i quali mio padre mi aveva introdotto, e seppure frequentassi assiduamente la casa di una nostra cugina sposata ad un marchese di origini napoletane che amava molto circondarsi di giovani studenti, più dei tavoli da gioco o dei saloni dove valzer e polche si susseguivano in un turbinio di ampie gonne e pantaloni attillati che si muovevano all'unisono, preferivo i gruppi di uomini più anziani di me nei quali si tenevano le discussioni sulla politica o i racconti di caccia, per parlare di cani e cavalli, di campi e raccolti, di selvaggina e semine, o di letteratura e poesia, commentando le nuove tendenze artistiche che erano in fermento nel volgere di fine secolo.
Andavo anche molto volentieri a teatro, ad ascoltare l'opera o la musica classica, pur se non ero affatto intonato né portato al canto. Eppure l'estrema meraviglia dei suoni che sortivano dai lucidi ottoni o sotto gli archetti dei violini e violoncelli e che si fondevano in una unione totale e priva di reticenza con le voci tenorili e dei soprani mi emozionava nel profondo come il sorgere del sole oltre il finire del bosco o l'ammantarsi di neve delle colline a gennaio.
Mio padre era morto all'improvviso, ed era ancora prestante e forte, io molto giovane tranquillo e laborioso, e non si era così preoccupato di forzarmi a quel passo che non mi vedeva impaziente, dicendosi sicuramente tra sé e sé che avrei avuto tutto il tempo per impegnarmi a dargli una discendenza, e dopo la sua morte io non mi posi il problema in maniera seria. A volte mi chiedevo a chi avrei lasciato le mie proprietà alla mia morte, ma immediatamente i volti dei miei tre nipoti, due maschi e una femmina, figli di mia sorella minore sposata al conte Rivoli e che trascorreva la vita tra una bella e comoda magione circondata da ettari ed ettari di boschi e ulivi, sulle alture del Casentino e un palazzo signorile nel centro di Firenze, mi apparivano sorridenti ed adattissimi a raccogliere l'eredità dal loro affettuoso zio.
Quando poi ricordavo l'unica volta nella quale, accompagnato dai compagni di studi in una casa per appuntamenti frequentata da giovani della buona società, avevo giaciuto con una donna, mi sovveniva solo l'imbarazzo che quelle mani femminili avevano suscitato in me al loro accorrere là dove avrebbe dovuto accendersi un piacere che assolutamente non sentivo.
Come sottoposto ad un esame importante, sia per curiosità che per mettere fine agli sfottò degli amici che si burlavano della mia timidezza, mi ero impegnato ad affondare il mio membro maschile, con il quale non avevo in effetti nessuna dimestichezza, dentro la sua carne, subito la mia poca rigidità si spense al contatto con quel caldo umido che, pur ingentilito da abbondanti abluzioni ed uso di acqua di colonia, emanava un odore che non mi entusiasmò affatto.
Mentii con la giovane gentile signorina che mi aveva accolto nella sua veste succinta con modi teneri e quasi materni, esprimendo un godimento immediato al suo contatto, come in effetti ci si sarebbe dovuto aspettare da un giovane vergine e inesperto come me. Mentii perché il contrario mi sembrò scortese ed offensivo nei suoi confronti, e raddoppiai la mancia richiesta, rifiutandomi ad un secondo approccio: l'unico mio desiderio era andarmene via da lì.
Né mi interrogai a lungo sull'accaduto, semplicemente smisi di pensarvi, adducendo il mio insuccesso alla mi timidezza ed alla mia indole tranquilla.
Leggendo e studiando i poeti di tutti i tempi assai più mi ritrovavo nelle espressioni proprie dell'amor cortese e dell'amor platonico, pur se non sentivo molti echi nel mio animo a quelle parole. Assai più mi emozionavano le descrizioni delle bellezze naturali e mi interessavano i trattati di botanica e biologia, di agraria, etimo e medicina veterinaria, sui quali puntai i miei studi, senza però giungere a nessuna laurea: non era il dottorato che m i interessava, ma approfondire le mie conoscenze culturali per sentirmi in maggiore sintonia con me stesso e con il mio compito e piacere: condurre una serena vita agreste, attiva e naturale.
La grandi passioni, non sembravano fare per me, né essere proprie della mia indole.
Mi stupii quindi non poco nell'ascoltare il battito forte e un poco sordo del mio cuore all'apparire del giovane Lucio.
Fu come un malessere che prese a vistarmi a tutte le ore, a ritardare le ore del riposo notturno e ad anticipare quelle della sveglia mattutina, fu come una smania che rovistasse in bisacce chiuse e tenute nascoste sa sempre.
Fu come una domanda di contatto con qualche mia profondità che fino ad allora non mi si era palesata.
Cominciai a passare il suo nome tra le mie labbra, come assaporandolo.
Mi sorpresi a pensare ai suoi riccioli corvini sempre graziosamente spettinati.
Indugiai a guardare come egli appoggiasse il palmo della mano sulla groppa della mia giumenta mentre la faceva accostare per toglierle la sella al ritorno di una galoppata.
Mi spiai mentre i miei occhi correvano alle sue labbra franche e sorridenti come ad un appuntamento con la bellezza.
Mi stupii nello scoprire che ricordavo perfettamente il colore della sua giubba ed il guizzare forte del lungo muscolo della sua coscia, mentre sollevava un paziente zoccolo per pulirlo dallo strame o dalla terra che vi si erano fermati sotto.
Mi abbandonai alla dolcezza di ascoltare la sua voce che mi parlava nella cortese cadenza della mia terra, dei suoi occhi che entravano senza volerlo nei miei e vi traevano lampi di cui mai mi ero accorto.
Fu semplice pensare alle sue necessità, far acquistare per lui abiti comodi e caldi per l'inverno freddo della scuderia, ordinare che gli venissero serviti i pasti, abbondanti e di suo gradimento, nell'ampia e animata cucina, nel procurare che avesse sempre a disposizione acqua fresca,dato che rifiutava il vino, frutta di stagione pane e formaggio per le merende nei lunghi pomeriggi durante i quali attendeva il mio ritorno dai viaggi per i miei affari.
Accolsi dentro di me la gioia dei suoi occhi quando gli posi tra le braccia, come mio dono personale, una cucciola di segugio italiano a pelo forte, la migliore della cucciolata, prelevata e scelta da me appositamente per lui presso il mio piccolo canile ed allevamento, che mi dava la soddisfazione di avere sempre belle bestie, forti, instancabili, brave a caccia e di buona indole.
Quegli occhi accesi di stupore e gratitudine furono il più indimenticabile ringraziamento che io mai ricevetti nella mia vita.
I mesi trascorsero, avvicendandosi con puntualità, e sempre al primo giorno io mi facevo punto di orgoglio di consegnare i compensi a tutti i miei dipendenti, prendendomi di persona l'onere e l'onore di contare il mio debito nei loro confronti e di saldarlo ampiamente, senza lesinare il soldo, contando le monete d'argento che facevo poi scivolare nelle loro mani senza che queste apparissero tese a chiedere, ma rese per ricevere quello che era loro dovuto e che avevano onestamente guadagnato, ma mai mi era sembrato che quanto veniva loro dato fosse insufficiente e di poca cosa.
Per Lucio, invece, quel monticello di monete che io contavo e preparavo non mi sembravano mai abbastanza: il suo lavoro era sempre così ben fatto, preciso, orgogliosamente autonomo, che la cifra che io gli consegnavo, benché fosse di gran lunga superiore a quella che mai avrebbe percepito a servizio di chiunque altro, mi pareva misera e inadeguata.
Al secondo anno del suo servizio presso di me, al sopraggiungere dell'inverno, cli chiesi se avesse voluto abitare, con la sua cagnetta, che lui aveva battezzato Tosca, e la vecchia giumenta che era la sua preferita e che ben si prestava alle sue necessità, il casino di caccia che sorgeva al limitare del parco di casa verso il versante boscoso.
Esso era una costruzione interamente di blocchi di roccia a vista come si usava sulle nostre montagne che davano verso la Romagna, ed era da qualche tempo disabitata, dopo che il guardiacaccia si era trasferito con la famiglia, divenuta numerosa, in una mia casa colonica più grande ed adatta a tirar su figli.
Mi e gli dissi che la mia richiesta derivava dal non voler lasciare nell'abbandono l'antica abitazione che mi piaceva particolarmente e nella quale avevo consumato innumerevoli pasti rustici e assai graditi, ma sentii benissimo dentro di me che il piacere di saperlo ben accomodato, in un luogo che gli era assai consono per indole, era assai più grande di quello che comunque provavo nel rivedere dalla finestra della mia camera il comignolo fumare di nuovo azzurrino contro il chiarore fumoso delle mattine invernali.
Fu così una vera soddisfazione vedere come lui si adoperò per ripulire lo spazio circostante la sua nuova abitazione da cespugli ed erbe alte, come si arrampicò sul tetto per controllarne lo stato di salute ed efficienza, ponendo di persona le piccole riparazioni e migliorie che vi erano necessarie. Lucio seguì in tutto e per tutto le operazioni per rinfrescare gli ambienti, lucidare la mobilia di castagno rustico, e porre in uso tappeti, biancheria e stoviglie che gli mandai in quantità dalle mie dispense, dedicandosi con grande naturalezza a lavori prettamente muliebri, adducendo la motivazione che la madre, priva di figlie femmine, aveva insegnato al secondo dei sui cinque figli maschi, quello che più si era dimostrato adatto a quel compito, le incombenze riservate di solito alle donne, sia per trarre un alleviare alle proprie fatiche, che per assicurare una certa qual autonomia ai suoi sei uomini qualora le fosse successo qualche brutto accanimento all'improvviso.
La saggezza di quella donna aveva trovato terreno fertile nella dolce natura di quel figlio, che, pur vigoroso e forte, accoglieva qualcosa di femmineo nel porgere del labbro e della mano dai lineamenti eleganti.
Fu naturale per lui invitarmi sempre più spesso a bere un bicchiere di nocino corposo e generoso che sua madre stessa ricavava mettendo a macerare nell'alcol con spezie ed aromi le noci col mallo ancora verde raccolte il 24 giugno, giorno di San Giovanni, come di tradizione e di buon augurio, come fu per me facile ed immediato accettare.
Lucio sapeva leggere e scrivere, perché, a differenza dei suoi fratelli, del tutto allergici ai banchi della scuola e del catechismo, si era recato il più spesso possibile alle lezioni, pur sobbarcandosi un lungo cammino a piedi, e la sua viva intelligenza gli permise di mettere a pieno frutto quelle lezioni. Io così presi a portargli qualcuno dei mie libri, notando come lui apprendeva spontaneamente da se stesso quanto non aveva già imparato traendolo direttamente e senza mediazione dalle parole che leggeva.
Divenne quindi sempre più destro in quell'esercizio, e nel volgere di alcuni anni, fu in grado di leggere e ricordare perfettamente i miei amati trattati scientifici, così come pure l'Iliade e l'Odissea, che leggeva come un racconto di avventure, rivolgendomi molte domande su quanto non capisse o volesse approfondire.
Vederlo così pronto e quieto, allegro e gentile allargava il mio respiro e assottigliava le pareti del mio pensiero che una dolce lenta linfa primaverile permeava fino nel profondo.
E come un fiore di cardo meraviglia per l'azzurro violetto su foglie pungenti e spente, quel respiro sorgeva sul silenzio di anni muti di palpiti e fremiti.
Il mio sguardo correva ai suoi riccioli neri come li accarezzasse, e si soffermava su quelle piccole strette anse come l'acqua del ruscello rallenta, al riparo della valle, diventando fiume, dopo aver corso a perdifiato lungo gli scoscesi strappi montani.
Ogni tramonto ed ogni alba mi strappavano sospiri trattenuti ed inediti.
Mi interrogavo su questo mio sentire, e poiché ero avvezzo a cercare e trovare le risposte alle mie istanze, poiché l'onestà e la chiarezza erano miei commensali, chiesi alla saggezza antica di dipanare le mie incertezze.
Platone, Socrate, Eurialo e Niso, Achille e ….. ripresero il loro posto sul mio tavolo da lettura, distogliendomi per lunghi mesi dai miei studi di botanica, entomologia ed anatomia.
E come il volgere lento e inesorabile dell'astro solare sconfigge i bui meandri della notte, così quelle antiche immortali parole vinsero l'inerzia che impastoiava le mie lente emozioni.
Seppi.
Non era il figlio che non avevo mai avuto, il fratello col quale non avevo mai cavalcato o corso in vivaci giochi e grida infantili, non era il mecenate che si curava del giovane virgulto per strapparlo ad un destino gamo che esso non meritava: io l'amavo.
Confrontai con precisione ed accortezza quei nobili impulsi e desideri, e li scorsi gemelli a quelli miei per il mio giovane sorridente stalliere.
Coniugando il verbo amare in tutti i suoi paradigmi, ad ogni tempo e modo corrispondeva una goccia del mio sangue per lui.
E fu come una folata di vento che apre in un sol colpo un battente sprangato e permette alla luce del giorno di rischiarare una stanza chiusa da sempre, polveroso e silente.
Quello che più mi sorprese fu di non restarne affatto sorpreso: tutti i tasselli screziati di un mosaico che non ero mai riuscito a comporre, si ricongiunsero con l'armonia di una attesa fioritura e l'ineluttabilità di una falce a luglio.
La mancanza di attrazione verso le donne, la timidezza, l'eccessiva ritrosia di fronte ad uomini e donne, l'indole mite e dolce, quel sentirmi così diverso e spesso fuori luogo, soprattutto nel clamore e nella fatuità della vita di società, quella domanda inespressa nel mio fondo, quell'arrossire alle facezie spesso volgari dei miei compagni dell'università, quell'amore per le sculture greche e la pittura del Caravaggio, dove corpi di giovani balzavano alla ribalta con la loro plastica bellezza.
Quell'attesa di qualcosa di indefinito che sentivo mai raggiunto, ma sempre in agguato.
Ora tutto era al suo posto, ed ogni mia oscurità era stata spazzata via dalla consapevolezza.
Eppure non mi accesi a quel pensiero e a quella conquista.
Come un falco vola sui pascoli per ghermire il malcapitato roditore in cerca di cibo, o la trota abbocca all'amo che la trarrà fuori dalla sua acquea vita, sentii l'ineluttabilità di quanto ero e sarei stato, ma nello stesso tempo seppi che nulla sarebbe cambiato nella mia vita.
Non erano le semplici origini di Lucio o il timore di uscire allo scoperta con una così scomoda verità, non era lo sconcerto di essere quello che il Dio che mi avevano insegnato ad amare e rispettare non permetteva di essere.
Sapevo che nulla di sbagliato poteva risiedere in una creazione dell'altissimo, in un Suo progetto cosi minuzioso e studiato in tutti i particolari.
Non ascoltavo la benché minima voce di una vergogna che di sicuro non potevo provare per me stesso: mai avevo vagato nel contrariare quella imperiosa voce interiore che mi additava con così chiaro monito la strada da seguire, né io avevo scelto come venire al mondo, né quando né dove: vedevo il chiaro disegno superiore integrarsi con la forza vitale del mio destino.
Ma quel tenero austero abbagliante chiarore che mi aveva illuminato in una notte di intensi percorsi della mente e della memoria, neppure venendo così forte alla luce si accompagnava al desiderio di unioni carnali.
Non i baci di quella bocca finemente accesa di calore, né i muscoli agili e potenti di quel corpo poco più che adolescente, né le mani avvolgenti che sapevano parlare ai cavalli con parole di polpastrelli, desideravo toccare: quello a cui ambivo era potergli stare vicino.
Poter riempire ogni mio giorno della sua voce ancora un poco acuta ma già affondata nel velluto basso della virilità, poter ammantare gli sguardi del suo cielo franco e sereno in ogni tempo con i miei, stanchi ormai di vagare in cerca di un luogo ove riposare.
Poter cavalcare al suo fianco inseguendo la muta dei cani sulle tracce del cinghiale selvatico che cercava di addentrarsi tra le forre per sfuggire alla morte che lo stanava da presso.
Sedere con lui davanti al camino con la lettura di un libro che ci portava lontano, in luoghi e tempi mai conosciuti ma mai dimenticati.
Poter respira l'aria che egli stesso respirava.
Ed essergli accanto senza nulla chiedergli se non di vivere e di permettermi di guardandolo vivere riempiendo di sé il mio passo tra le valli dell'alta Toscana, mia madre.
Seppi e appresi nel medesimo istante che ad altro non avrei mai teso.
Come lui pure mi confermò, qualche giorno dopo, mentre esaminavamo insieme il garretto malconcio di uno dei cavalli da tiro che aveva incontrato un sentiero particolarmente pervio:
' Conte Fabrizio, mi disse all'improvviso guardandomi serio e fisso negli occhi miei attenti e senza difese ' a volte penso a lei come un padre, a volte come un amico, spesso come ad un figlio se pur io le sono minore di età e di grado. Penso che non dovrò mai cercare altro nella mia vita, e che qui noi, insieme, vivremo la pace delle cose giuste. '
E così parlando mi pose la mano sulla spalla come la posava sulle groppe tenere e accoglienti delle nostre giumente, mentre, parlando loro a bassa voce, le abbeverava e accudiva.
I nostri sorrisi ritenuti e sinceri si intrecciarono silenziosi, e nulla fu da sottolineare più.
Né mai vi fu bisogno che nessuno di noi due chiedesse più alcuna cosa, trovando sempre i propri desideri realizzati dall'altro assai prima che potessero essere espressi.
Lucio non volle mai prendere moglie né avere figli, e ci occupammo insieme di rendere agevoli e serene le vite di quanti erano nelle nostre rispettive famiglie ed attorno a noi.
Un grato destino mi fece chiudere gli occhi per sempre guardando i suoi, prima che il novecento portasse lo scompiglio alla pace delle nostre terre.
Lucio non tardò a seguirmi, e ci ritrovammo assai presto a cavalcare tra gli ulivi e le colline dell'alta Toscana celeste.
- piano americano -
Come faccio a saperlo?
Lo so, così come so che oggi è giovedì sette ottobre duemila e dieci e sono le due e ventidue della notte.
Come so che il conte Fabrizio sono io, o almeno lo sono stata e Sara è stata Lucio.

NOBILTA'
- questa è una novella non autobiografica scritta a quattro mani, due le mie, due quelle della mia amica Stella, su suo incipit.......
Entrai di soppiatto in sale grigie adornate d'oro, reggendo piatti mai degustati.
Stucchi applicati agli alti soffitti erano sempre lì e io non avevo nulla, nulla più degli stucchi che da secoli decoravano le pareti.
Io servivo il pranzo, la cena, la colazione e nessuno si preoccupava di me.
Per lei: sporca, oscura, eppure mi lavavo tutti i giorni. Ma lei non lo vedeva.
Di sbieco, qualche volta, la mia crestina inamidata mi faceva gongolare di un potere presunto, ma io nella mia piccola stanza, cavalcavo puledri di vita che lei mai avrebbe immaginato.
La mattina, quando lei scendeva e invadeva la stanza con quella prorompente leggerezza di cui solo le anime pure sono capaci, trattenevo a stento il respiro perché ella trasudava ogni forma d'amore, anche quella che io mai avevo pensato fino al giorno in cui i miei occhi incontrarono i suoi.
Nascosta dietro uno stipite della grande porta di noce massiccio, mi inebriavo di tutti i suoi colori e di quella possanza che deriva dalla perfezione.
Lei scendeva la scala misurando i passi e mi privava di ogni respiro giacché, reclusa nella mia semplice mansione, non mi potevo permettere né la tenzone né la lascivia.
Così mi accucciavo sul marmo delle scale ove lei posava il passo leggero e potevo pascermi di un pasto magro fatto di profumi delicati.
La pura fragranza era riservata ad altre narici e io, su quell'angolo freddo del marmo mordevo la ginocchia e quel dolore non bastava a placare l'ira che in cuore mi spezzava il vederla giacere nel letto di un amante distratto.
Avrei potuto deliziarla di tutti i baci, di tutte le carezze che lei mai avrebbe potuto immaginare in quel limbo plumbeo in cui l'avevano relegata culture, famiglie e religioni mentre non era consapevole, né avrebbe mai pensato, che la mano di un'altra donna potesse essere assai più virile di quella di tutti i cavalieri erranti che aveva fino a quel momento fatto piegare al suo cospetto.
E ancor più ignorava che l'anima di una femmina l'avrebbe coinvolta tanto quanto quella di un maschio, dato che ella non conosceva che una consecutio.
Quando, a sera, dopo una lunga giornata di lavoro passata a lucidare argenteria e a rischiarare cristalli di Boemia, mi adagiavo nella vasca da bagno colma fino all'orlo di acqua fumante e densa di bagnoschiuma profumato alla rosa, lentamente passavo la salvietta morbida sulle mie braccia, sui polpacci e le caviglie sottili, sull'incavo della mia spalla magra con la stessa tenerezza e lentezza con la quale avrei voluto farlo a lei.
Una dolcezza di attesa che si snervava nel vapor acqueo e si scioglieva in un respiro appena affannato al pensiero della sua pelle bianca che accoglieva la mia mano tremante.
E nella mia vasca consumavo i gesti che mai avrei potuto ripetere sulla pelle della mia amata.
Così, percuotevo la mia pelle con il crine pensando di battere la sua e sentendo nelle mie carni quell'acuto dolore che io avrei voluto che proprio lei mi avesse procurato .
Immaginavo i rossori di quei colpi misurati segnare i miei polsi, i piccoli seni raccolti, le mie cosce lunghe e forti, con una meraviglia e un'ansia che mi bloccava il cuore in gola.
Trascinavo allora i giorni in una costante incertezza di me e di lei, che allungava sguardi silenziosi sulle mie mani affaccendate attorno alle tazzine del caffè e le coppe di macedonia col gelato, cogliendo occhiate in tralice e silenzi sospesi.
I suoi occhi di ghiaccio interrogavano i pizzi bianchi della tovaglia e la zuccheriera di peltro colma di bianca semola.
Interrogavano le ombre ineguali della siepe e i luccichii soffusi della ghiaia nel vialetto che portava al patio di trasparenti vetrate.
E nessuna risposta veniva dall'aria immobile del mattino ancora addormentato nella luce obliqua di un'alba tardiva, né dalla scia tremula della luna sull'acqua della fontana dove dormivano i loro sonni liquidi le carpe bianche e rosse.
Così sembrava più pallida e stanca ogni giorno che passava, ogni ora trascorsa appariva più distante e distaccata e io, mentre accudivo ai suoi desideri e bisogni con un' accortezza sempre nuova nel prevederli e soddisfarli ancor prima che fossero espressi, tremavo all'idea che lei potesse leggere nella mia mente.
La spiavo dietro i drappi di velluto mentre scendeva la scala che conduceva alla sala da pranzo. La spiavo giacché non potevo guardarla ed ogni passo mi fendeva l'anima perché avrei preferito mi calpestasse, mentre invece mi ignorava.
Occhieggiavo la sua cornucopia e sapevo che non potevo mangiarne alcun frutto.
Era prorompente.
Spaziava nell'alba e nel tramonto delicata. Il prato era un tappeto ove nemmeno il piede si posava.
Così la vedevo, leggero cerbiatto nel bosco, anima pura, amor puro.
Mi sarebbe bastato uno sguardo, un cenno un saluto ma lei, sprezzante, mi ignorava e io languivo nel velluto rosso.
Nel giorno delle sue nozze, Ginevra si fece agghindare e io fui demandata ad annodare nastri tra i suoi capelli, ma ad ogni nodo la carne si fendeva e si piegavano le ginocchia: eppure le forzai ad essere ritte perché lei me lo chiedeva e i suoi occhi verdi riflessi nello specchio mi inebriavano seppur nella cocente sofferenza.
Quando si alzò il biancore dell'abito mi trafisse.
La sua verginità sapevo essermi preclusa e così ebbi la prima delle mie morti.
La seconda quando, abbarbicata a una colonna marmorea, la sentii pronunciare:
si.
Quello che ancora non sapevo era che la terza morte sarebbe stata più amara.
Vedevo una china ripida trarla a sé, una lunga caduta senza resistenza giù per un pendio spigoloso di massi ineguali e interrotto da corti arbusti abbarbicati alle rocce.
Immaginavo la sua resa alle mie carezze di bianca colomba come il sollievo nel destarsi all'improvviso da un incubo accorgendosi finalmente che nulla vi era di reale.
Sentivo la sua voce farsi sempre più esile come se la resa all'amore le togliesse ogni forza.
Fu una lunga teoria di mesi sempre uguali che portò me, Giuditta, semplice e ignota cameriera, e lei, Ginevra, principessa di stirpe reale di un'antica famiglia romana, a fermarci gli occhi negli occhi riflessi nello specchio della toeletta nella sua camera da letto, mentre io le passavo la morbida spazzola tra i bei capelli di seta scura per i cento colpi prima del riposo notturno.
Come un sogno nel sogno, mentre io continuavo a percorre le vie dei suoi lisci capelli, vidi la mano di lei alzarsi lentamente fino a posarsi sulla mia che stringeva così spasmodicamente il manico della spazzola da avere le nocche bianchissime.
Sentii il tocco fresco e lieve di quelle dita lunghe da airone e avvertii la mia pelle scoppiare di giubilo a quel tocco inatteso e tanto aspettato, immaginato nelle lunghe ore notturne senza sonno né riposo.
Vidi i suoi occhi colmarsi di lacrime urgenti e trattenerle con il dominio che la rendeva spesso così fredda e incomprensibile, vidi che sapeva.
Conosceva a fondo ogni mio sogno impossibile fino nei più minuti particolari, viveva lo spasimo di quell'amore prepotente che tutto divelle ma si deve arginare su di una altissima diga che ogni goccia di preziosissima acqua trattiene nel profondo oscuro invaso.
E colsi in quegli occhi specchiati nei miei quello stesso smarrimento che mi destava assai prima dell'alba e che mi aveva reso insonne fin oltre la discesa delle ore dal centro della notte.
Ma, come un pugnale ghiacciato affonda la lama senza dolore nella gola di una vittima e la porta alla morte in un solo istante, cosi il suo smarrimento colò a picco nelle mie innominate speranze, nelle mie attese mute e senza tempo, trasformando le ore da lì a venire in lunghe oscure pozze senza luce.
Seppi con certezza che lei non sarebbe mai stata mia quando distolse con un gesto sicuro gli occhi dallo specchio e riprese il consueto sguardo gelido e padrone di sé.
Seppi che in nessun modo avrebbe permesso ad un amore così impronunciabile di varcare le soglie della sua camera, della sua anima, dei suoi stessi desideri.
Vidi quanto aveva strenuamente lottato contro di esso e come, proprio nel momento in cui sembrava che quello avrebbe potuto sfondare ogni sconvolta resistenza, ella lo deponesse con risoluta facilità nel novero delle cose indesiderabili e non realizzabili.
“ Grazie cara, mi sembri stanca, vai pure a riposare, finirò io..” mi disse e, togliendo dalla mia mano fatta docile e arresa a quella sussurrata carezza, la spazzola, continuò lei stessa i lenti movimenti che io avevo compiuto fino ad allora.
Erano le tre di notte quando il tonfo sordo del fiume nero e limaccioso accolse nell'ultimo giaciglio e riposo il mio cuore e il mio dolore.

I FILI DI LUCE
14 settembre, 14;49
Dietro casa mia, uscendo dalla piccola porta di alluminio marrone che da nella cucina, c'è un vicolo che termina in una curva così stretta e a gomito che un auto non riesce a passare. Quindi il traffico è praticamente inesistente e fatto solo da qualche motorino, qualche ' Ape ' e da rari passanti.
I vicoli di questo paesino di collina del nord ovest della Sardegna sono delimitati da case per la maggior parte disabitate e fatiscenti: non è stata fatta nessuna opera di recupero di quelle vecchie abitazioni, non perché non ce ne siano diverse che varrebbe la pena salvare dalla distruzione dell'abbandono, anzi, alcune sono assai belle e di sicuro risalenti almeno in parte a diversi secoli prima, come la casa nella quale vivo che ha alcuni muri perimetrali, fondamenta e cantina interrata forse addirittura risalenti al '500 o '600 dc, ma perché ancora questo tipo di cultura del recupero e valorizzazione non è giunto fin qui.
Infatti in tutto il mio vicolo solo tre case sono abitate, compresa la mia. Questo mi permette di avere un angolo di mondo quasi tutto mio e sostituisce in parte il guardino che non ho.
Ad intervalli regolari, da quando la piccola Gine è giunta nella mia vita, mi reco lì perché lei possa espletare i suoi bisogni fisiologi e correre e giocare un poco all'aperto: essere il cane di un ' diversamente abile ' ha in effetti qualche scomodità intrinseca anche per lei.
Così, dato che non riesco a stare in piedi più di due o tre minuti, tengo vicino all'uscio una di quelle seggioline impagliate che sono una particolarità di queste case e che servono per sedersi vicino al focolare o appunto fuori dalla porta e mi ci accomodo, guardando la cucciolotta giocare e rincorrere ogni cosa e magari lanciandole qualche legnetto o la pallina.
Oggi è una bella giornata di novembre, col cielo quasi totalmente sereno e terso, che era di un azzurro leggero e gentile stamattina presto, sfumato dalla nebbia causata dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi ed ora, nelle prime ore pomeridiane, più caldo e deciso.
Il sole, ormai sceso dal bruciante zenit estivo dell'isola, è basso sull'orizzonte e sfiora i tetti.
Alla sinistra della casa in cui vivo in affitto, c'è una costruzione piuttosto malandata, che probabilmente era una stalla, oppure una povera casetta di altrettanto povera gente, che viene usata da una piccola ditta di costruzioni edili come magazzino e quindi sempre chiusa.
Il tetto è ricoperto da vecchi coppi che hanno tutti i colori del cotto, del bruno e del ruggine e diversi ciuffi d'erba secca ornano le grondaie e gli avvallamenti che si sono creati al cedere del trave portante. Davvero spesso guardandolo mi chiedo quanto ancora possa reggere un tetto così malmesso senza precipitare all'interno.
Attratta dalla luce ancora calda di questo sole novembrino ho alzato gli occhi al cielo, distogliendoli dai giochi rumorosi di Gine che si azzuffava con un pezzo di legno e sono rimasta sorpresa.
Sottilissimi filamenti luminosi galleggiavano nell'aria sospesi e gonfiati dalla leggera brezza delle colline intorno e fioccosi semi di pioppo facevano a gara a rubare i bagliori dei raggi del sole.
Era come una vela trasparente ed eterea che si tendesse e gonfiasse trattenuta da un albero maestro invisibile della tolda di una nave di tegole.
Di sicuro un ragno laborioso ha tessuto una grande vela appendendosi ai fili d'erba che crescono sul tetto, lasciando che lunghe maglie di questa impalpabile rete si stendessero a catturare i piccoli insetti attratti da quella piccolissima giungla aerea.
Pur se assai delicati i fili di ragno sono elastici e resistenti e offrono un diversivo a vento brina rugiada e polvere che spesso sembrano divertirsi facendo di loro piccoli spettacoli meravigliosi.
Questi tre o quattro sottilissimi cavi si spandevano nel vuoto per un metro e forse due, sottolineando col cangiare di sprazzi di luce metallici e argento – dorati l'intesa silenziosa ed assorta tra vento e sole, mentre, inattesi per questa stagione, semi di pioppo volavano come minuscole farfalle lattiginose seguendo ed accondiscendendo ai capricci della brezza leggera.
In Romagna questi semi rivestiti di fiocchi che sembrano di cotone vengono chiamati ' manine ' e a maggio riempiono l'aria dei viali alberati, dei giardini e lungo le rive di fiumi e torrenti di un brulicare fitto fitto che sembra quasi una nevicata, posandosi in ogni dove e rivestendo tutto di una coltre impalpabile di estrema mobilità con grande dispetto e disperazione delle donne di casa, che se li ritrovano ovunque dato che il vento li sospinge attraverso le finestre aperte ai primi soli caldi della tarda primavera e di coloro che soffrono di allergie ai pollini.
Queste manine sono davvero solleticanti e fanno sternutire facilmente.
Non le avevo mai viste a novembre, come mai avevo visto una vela di fili di ragno.
E proprio in quell'esatto momento in cui il mio sguardo veniva catturato da quel gioco di luci e colori accesi un aeroplano si è messo a disegnare la sua scia scintillante proprio al limitare del mio ristretto orizzonte, come a ricordarmi che il cielo è assai più vasto di quanto io spesso non ricordi ma che non c'è poi bisogno di andare lontano per trovare spettacoli irripetibili, basta ricordarsi di alzare lo sguardo da terra.
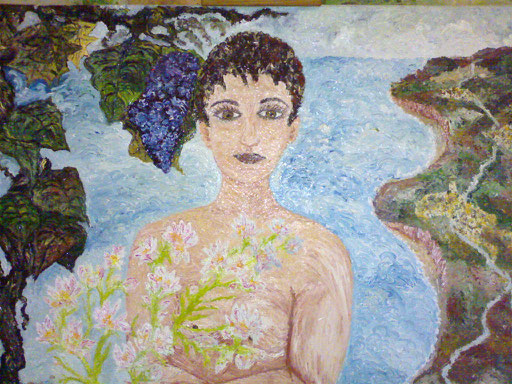
LA DONNA CHE
AMO
17 novembre, 18;35
La donna che amo è immensa.
Non ha un volto perché di un volto non ha bisogno, dato che nessuna fattezza umana può racchiudere in angusti margini la sua bellezza.
Non ha una bocca, perché il suo bacio divorerebbe ogni fragile labbro e renderebbe muta ogni mobile lingua.
Non ha denti perché la neve non potrebbe che sciogliersi di fronte al candore dei suoi.
Non ha occhi perché non vi è oceano così profondo, non vi è fossa o vetta che raggiunga le infinite altitudini che si aprono all'ombra delle sue ciglia.
Non ha mani perché le sue sono di pioggia, e sottili e dalle dita così affusolate che nessuna arpa o pianoforte potrebbe reggere alla grazia del suo tocco.
Non ha parole perché tutta la saggezza non le esprime, tutte le lingue dell'universo non le contengono, tutte le voci degli angeli non possono pronunciarle.
La donna che amo esiste e vive in me.
Io la cullo la notte come una madre assorta e tenera stringe a sé la creatura appena partorita dal suo ventre maturo..
Io veglio il suo sonno silenzioso come la luna la giovane nube alla quale si impiglia.
Il ascolto il suo respiro delicato come ogni fronda la brezza che rechi la promessa di una pioggia nella calura estiva.
Io accolgo il suo risveglio con i colori del cielo e del mare che fanno a gara per cangiare e risplendere in una rincorsa allo stupore, e ogni angolo sopra i tetti, tra i rami e le rocce si spinge a cercare l'impossibile e il non contemplato per onorane il suo ingresso nel nuovo mattino.
Io accompagno ogni minuto del suo giorno come il canto gentile che nessuno strumento ha mai condiviso, perché l'aria non basta a contenere il mio amore per lei, e ogni nota allarga lo spazio a lei intorno e lo moltiplica in rivoli e cascate di diamanti e gocce di platino.
Io tesso un'ode alla sua vita con ogni palpito del mio cuore ed ogni sollevarsi del mio petto come filigrana antica ed ombreggiata dello sguardo dell'onice e della giada.
Perché lei è entrata dentro di me ed ha completato l'opera che iniziò mia madre.
Perché lei mi insegna la scrittura dell'amore come io fossi ingenua ed inesperta allieva al primo banco di scuola.
Perché lei apparecchia la tavola della mia mente con calici di ineffabile bevanda e cibi di squisito raro sapore come un'ancella devota e puntuale.
Perché lei affila il mio pensiero come la correggia felpata di cuoio di primo fiore la lucente lama del rasoio di Toledo.
Perché lei accende le mie carni come la fiamma la pineta resinosa in agosto quando lo scirocco asciuga le forre nascoste ed ingiallisce l'erba sfinita dalla sete.
Perché lei spegne il mio rogo con la pace delle campagne che sotto la neve di gennaio accolgono il seme del grano per il pane dell'anno che verrà.
Perché lei completa la mia anima con quella parte che le fu strappata in un infinito lontano da un destino di dualismo, riunendo i lembi di una ferita che fino al suo venire sanguinava e bruciava intensamente e al tocco delle sue mani senza tempo si è chiusa lasciando solo un segno leggero a rammentare il destino che divide per riunire.
Perché non vi è uomo né Dio che possa e voglia ora dividere chi si è cercato per così tanto immenso spazio, percorrendo difficili e impervie strade di sassi e fango e ora non chiede altro alla vita di continuare a scorrere perché questo intero azzurro pianeta possa ascoltare sotto la volta del proprio orizzonte il limpido vibrato violino del nostro amore.

TU ERI IL MIO
FALCONIERE
- anche questo racconto è scaturito da una visione di una mia vita passata...
Era il secolo del milletrecento e un anziano nobile fiorentino mi aveva condotto all'altare ancora fanciulla, che non avevo ancora lasciato i miei giochi infantili, che non avevo conosciuto nulla dalla vita.
Ero un'anima pura e leggera, di salute cagionevole, amavo sedere alla finestra guardando in silenzio per ore il profilo delle colline lontane, accompagnando i miei pensieri col suono di un flauto o di un clavicembalo, che io stessa sapevo suonare.
Spiavo il continuo cangiare delle nubi e delle profondità del cielo o l'inclinazione dei raggi del sole attraverso il fogliame che con i suoi sospiri accarezzava le brezze.
Amavo leggere versi e ne componevo di miei.
Amavo accarezzare la pelle morbida della mia dolce cagna da caccia, un segugio, che appoggiava la testa cesellata e dalle lunghe orecchie sul mio grembo.
Mio padre mi aveva dato un'ottima istruzione e permetteva che alternassi al ricamo il canto e la pittura.
Mia madre era morta dandomi alla luce ed egli rivedeva nelle fattezze del mio viso i suoi tratti, che lui aveva molto amato.
Per questo mi aveva concesso in sposa al nobile anziano, sapendo che egli con la sua saggezza, non mi sarebbe mai stato di sfregio né sarebbe stato violento.
E infatti così fu e il mio sposo sempre mi permise di coltivare le mie doti, né mai mi chiese di sottopormi ai suoi desideri sessuali, dato che questi si erano assopiti precocemente e figli ne aveva avuti dal matrimonio precedente.
Egli si era invaghito della mia dolce bellezza ed amava circondarsi della mia presenza, senza alcun altro scopo se non quello di vedermi aggirare per casa. Spesso mi chiedeva di cantare per lui e mi faceva accompagnare dal nostro delizioso maestro di musica, oppure di leggergli i versi che scrivevo sui voli delle rondini e degli sparvieri o sui colori ed i profumi delle viole e delle rose che fiorivano, nelle rispettive stagioni, nel grande parco che dal retro della casa sfumava verso gli uliveti le vigne e le colline; fiori di cui io stessa coglievo ed adornavo in preziosi vasi le nostre stanze.
La mia vita era semplice e serena, ma una malinconia screziava le mie ore: la mia salute malferma mi costringeva ad una vita sedentaria, perché ogni corsa, danza o fatica di qualsiasi genere, pure l'andare a cavallo, che io amavo molto, mi produceva un'aspra tosse che mi scoloriva le guance e, colta dall'affanno, mi costringeva a cessare l'attività intrapresa.
Inoltre e questa era la mia vera tristezza, io non conoscevo amore.
Ne leggevo le sensazioni e i colori nei poeti greci e latini che amavo, nelle odi del grande Omero e del sommo Virgilio, nei sonetti dell'appassionato Catullo e negli atti delle tragedie di Euripide e di Eschilo, nelle disquisizioni filosofiche di Socrate e Platone e sentivo quelle parole trovare echi ed assonanze profonde in me, ma mai il mio sguardo aveva visto in un altro volto umano quella bellezza che veniva cantata e che io solo vedevo nelle gocce di pioggia che imperlavano i rami degli alberi o nella brina che decorava ogni erba nelle mattine di gennaio.
E questo dava un colore sfumato e incerto a tutto quanto, alle ore che si dipanavano lunghe e mi portavano di giorno in giorno, da alba a tramonto come sempre fossi sospesa, come l'atteso arrivo dell'ospite tanto desiderato fosse rimandato di anno in anno.
Fu nella primavera del mio venticinquesimo compleanno che una febbre di petto mi costrinse a letto per diversi mesi e solo alla fine dei mesi caldi, quando l'oppressione dell'afa si sollevò e rese il mio respiro più agevole, potei lasciare le mie stanze.
I medici, consultati da mio marito erano assai preoccupato per me e mi avevano sottoposto a cataplasmi e salassi, impiastri e fumenti ma senza risultati del tutto soddisfacenti. Allora gli consigliarono un cambiamento d'aria nell'asciutto balsamico delle montagne della Romagna, ove fonti termali permettevano di passare le acque e la natura delle foreste intorno era adatta ai sofferenti di bronchi e polmoni.
Quindi a settembre, prima che l'inverno rendesse troppo freddo il clima, fui mandata con fedeli e accorti servitori e ancelle a Bagno di Romagna, presso la casa di un nobile cugino di mio marito.
I medici avevano detto il vero: l'aria frizzante e pura, senza umidità, le acque calde e sulfuree che depuravano sia bevute che tramite bagni e fanghi, la semplice cucina montanara saporita che invitava anche i disappetenti, il vino rosso e generoso del quale venivo mossa a bere un bicchiere a pasto, se pure il sapore non mi fosse del tutto grato, la frutta matura e dolce e la compagnia allegra e devota mi sollevarono alquanto dalla mia debolezza e il colore della vita tornò ad abbellire le mie guance esangui.
E, pure, il mio gentile ed affezionato cugino acquisito, mi procurò un calesse che un suo servitore fidato e falconiere si peritava di guidare con grande accortezza e maestria lungo le strade di terra battuta che si snodavano tra le foreste e i boschi, tra le abetaie e i castagneti, convinto, a ragione, che assai più di cataplasmi e impiastri la forza di quelle montagne mi avrebbero ricondotta alla vita.
Così ogni giorno il giovane falconiere, vestito dei suoi abiti migliori, attaccato la quieta e forte giumenta baia alle stanghe del calesse coperto, la guidava gentile e attento al trotto e al passo perché io, adagiata ai cuscini e coperta accuratamente, non dovessi sopportare troppi scossoni causati delle buche e dalle asperità del terreno.
Fu così che Ganimede entrò nella mia vita.
Era un giovane di diciannove anni, non troppo altro, scuro di capelli e di carnagione ambrata, avvezza ai raggi del sole, alle levate prima dell'alba e alle ore all'aperto.
I suoi occhi verdi avevano pagliuzze dorate che li facevano brillare come fossero raggi di sole occhieggianti tra il fogliame della foresta o spighe di grano maturo tra le erbe multiformi dei pascoli.
Era agile e forte, gentile e generoso e il suo sorriso spontaneo illuminava un viso ancor rotondo di ragazzo, appena ombreggiato dalla barba che egli rasava regolarmente.
Sotto il berretto di fustagno verde da caccia i capelli, mossi e vigorosi, disegnavano vivaci onde corvine, incorniciando una fronte schietta e spaziosa, ancora libera dai segni dell'età e delle preoccupazioni e mettendo in risalto gli zigomi alti e ben disegnati.
Le sue labbra erano nette ed un poco sporgenti, come improntate per natura ad un piccolo broncio di fanciullo, decorate con un rosso rubino assai più adatto ad una fanciulla, che egli portava spavaldo e noncurante.
Tutto di lui era gioventù e spontaneità, nulla era mediato ed affettato, come a volte invece erano i modi dei giovani nobili di Firenze.
Il naso corto e forte e un poco spinto all'insù, il mento appena attraversato da una fossetta e le guance ancora tenere facevano del suo viso un canto alla bellezza, che tanto più risaltava in quanto lui ne era totalmente inconsapevole ed incurante.
Felice e orgoglioso del compito che gli era stato affidato, ogni giorno, dopo aver strigliato e lustrato a perfezione la cavalcatura ben pasciuta e serena, eliminato ogni residuo di terra e fango dalle ruote e ogni traccia di sudicio e polvere dal calesse costruito in nodoso legno di castagno, dopo aver ammorbidito col grasso i finimenti di cuoio, mi veniva a prendere, mi aiutava a salire, mi copriva per bene, ben sistemava la mantella e il cappuccio da viaggio e, dopo aver controllato che tutto fosse perfettamente a posto, con uno schiocco della lingua dava il la al passo della docile bestia da tiro leggero e si dirigeva verso i boschi.
Durante le passeggiate egli, felice come solo un montanaro può essere delle sue montagne, dei boschi e delle valli che gli avevano dato i natali ed il sangue generoso e schietto, sentiva il bisogno di raccontarmi ogni cosa che noi incontrassimo e sulla quale vedesse il mio sguardo posarsi.
Lui riconosceva i nomi di tutti gli alberi e di tutte le piante e delle loro famiglie dalla forma delle foglie, i colori delle cortecce, le sfumature dei fiori e dei frutti.
La stagione era propizia e nelle belle e ancora lunghe giornate di cielo sereno solcato da grandi e innocui vascelli di bianchissime nuvole egli mi narrava i rotondi marroni nei ricci, i funghi eduli bianchi o pastello ai piedi e tra le radici degli alberi, la discrezione delle sorbe delle nespole e delle mele cotogne sui rami che andavano già lentamente spogliandosi delle foglie, i ciuffi lilla dell'artemisia e le fiamme gialle delle margherite autunnali, i piccoli calici viola screziati dell'erba medica, il giallo acceso della seconda fioritura delle ginestre, i bottoni lucidi dei ranuncoli e qualche rosseggiare di un tardivo papavero, i coriacei verdegrigi dei lecci e le foglie composite che andavano abbrunendosi dei castagni, i puntuti aghi verde scuro degli abeti e i loro diritti fusti in fuga verso l'alto, l'acqua ciarliera e scherzosa delle fonti freddissime, il muschio sul nord dei tronchi e a tappeto verde tenero ed acceso sulle rocce, i cricchianti tappeti di foglie dei cornioli.
Ognuno di questi era una meraviglia nelle sue parole e sulle sue labbra quei nomi erano come di fratelli e sorelle, di madri e padri, di compagni di giornate feconde.
E anche tutti i voli di uccello ed i canti delle gole alate avevano un nido e uno scopo, erano un segno e un monito e di ognuno di essi lui conosceva le stagioni e i modi.
Così come di ogni impronta che il terreno inumidito dalle recenti piogge serbava come ricordo per giorni e i puntuti zoccoli di cinghiali e caprioli tracciavano strade a lui ben conosciute, così come lo zampettare delle starne e dei fagiani e di ogni altra piccola e grande creatura che nella vasta foresta trovava riparo e sostentamento.
Ganimede era parte di tutto quello ed ogni ramo, ogni foglia, ogni fiore, ogni animale gli rivolgeva il suo canto.
Io ascoltavo i suoi racconti come favole e promesse e le sue parole semplici ed immediate che risuonavano nel silenzio solenne degli abeti o nel raccolto basso spazio dei cornioli e delle farnie, si imprimevano nella mia memoria e man mano che i giorni passavano e quelle passeggiate si ripetevano, la natura attorno a me diventava nota e compresa, come avessi scoperto la chiave di violino di una musica della quale solo ora sapevo leggere le note e comprendevo appieno il significato, come l'avessi ascoltata distrattamente per anni.
E lui gioiva felice nell'udire come io ricordassi i nomi delle creature da lui tanto amate e li ripetessi agevolmente, senza sbagliare e tra noi nacque un gioco di infantili indovinelli, filastrocche e proverbi paesani ai quali la cultura montana affidava il tramandarsi orale da nonno a nipote delle loro ricchezze.
Io ascoltavo la sua voce musicale dal tono ancor bianco entrare tra le pareti del mio cuore e destarvi armonie a me sconosciute.
Guardavo il luccicare delle pagliuzze di quegli occhi sinceri e un poco schivi che sfuggivano per rispetto al mio diretto guardare per poi tornarvi con spontanea franchezza e sentivo che esso accendeva un fiamma in luoghi dei mie pensieri che io non avevo mai incontrato.
Un giorno egli giunse tutto eccitato con le guance arrossate di gioia ed attesa e mi comunicò che aveva una sorpresa per me: era riuscito a convincere mio cugino acquisito a permettergli di mostrarmi le spericolate azioni del falco di cui lui era l'uccellatore e custode.
Dato che sia il falco che il falconiere erano assai giovani, il mio caro congiunto aveva espresso qualche timore che io potessi venire aggredita dal rapace, ma il giovane Ganimede tanto disse e tanto fece che lo convinse dell'assoluta mancanza di alcun pericolo.
Accompagnati da un giovane garzone di quattordici o quindici anni, che ci seguì correndo accanto al calesse spinto al trotto leggero, giungemmo ad una radura poco lontana che si incontrava alle prime falde delle foreste, ai bordi della quale era costruito un casino di caccia in pietra e legno.
Era una costruzione semplice ad un piano, composta da una sola vasta stanza arricchita da un grande camino con la trave di quercia e il focolare di pietra dura e scura.
Un capanno di legno si appoggiava alle pareti del casino di caccia e fungeva da ricovero per i cavalli e da piccolo fienaio.
Lì, appollaiato al suo trespolo stava il giovane falco, con il cappuccio scuro sulla testa.
Il colore screziato dal nocciola al pastello al bruno del rincorrersi delle sue penne e piume era un disegno affascinante così come lo sfrangiarsi di queste all'attaccatura delle zampe forti.
Il corpo del rapace era elegantissimo e assai fiero, essenziale, pur nella sua prigionia e nulla in lui denotava paura o ribellione ma, come un principe caduto in mano al nemico, egli decorava di nobiltà e forza tutta la natura intorno.
All'avvicinarsi di Ganimede, il volatile non mutò il suo atteggiamento, ma si erse ulteriormente in tutta la sua figura ed un fremito lo percorse, come se già pregustasse il volo che ben sapeva avrebbe assaggiato da lì a poco. Il rapace si era reso conto benissimo di come le sue uniche occasioni per far fremere le sue libere ali all'aria che lo sostenevano fossero legate al lungo e spesso guanto di cuoio che vestiva il braccio del ragazzo.
Così, con naturalezza, il giovane falco salì su quel guanto che con rispetto e semplicità gli veniva porto e in quel momento ecco che io ebbi come una visione: l'uccello e il ragazzo divennero un'unica creatura e come una nube trasparente come un'aureola, lucida e color azzurro cielo, li avvolse ed esaltò la figura dell'uomo-falco che in quel momento aveva visto la luce dal nulla.
Come da due si potesse fare uno.
In quel preciso istante sentii una eco assai chiara attraversare il vuoto che mi si era fatto intorno e allo sguardo di quella mitologica creatura che si posò nei mie occhi, come accorrendo al mio richiamo, il mio cuore volò su quel guanto e si unì all'uccello e al ragazzo, compiendo un'ulteriore fusione che mi spiegò e mi narrò in un lunghissimo attimo come da tre si potesse essere uno.
Il tempo e lo spazio si ingigantirono, ampliando i margini angusti del mio corpo travasandoli nelle forti ali del falco e negli occhi rapiti del giovane uomo.
Sentii piume e penne forare la mia pelle, sorgerne e ricoprirmi le membra, sentii i muscoli del mio braccio indossare il ruvido e pesante guanto di cuoio, il farsetto di fustagno da cacciatore sostituire i mie abiti muliebri, e le pagliuzze dorate che tanto ammiravo luccicare nei miei occhi.
Ugualmente il giovane ingentilì ulteriormente le fattezze del suo viso, come se alla forte linea della sua mascella subentrasse quella morbida della mia gota e la nota della sua voce che chiamava l'uccello al volo ebbe l'intonazione del mio flauto e, mentre il falco spiccava il balzo verso il cielo, sentii chiaramente la sua ala fendere l'aria come se la mia meraviglia fosse al suo fianco e dentro le sue aeree vene.
E in quel mentre il pensiero che scaturì dalla mente di tutti noi fu: libero!
Volai davvero su quella radura, sulle vette degli abeti, impennandomi tra le correnti di vento e la forza dei muscoli del falco tesi nel naturale sforzo, scesi in picchiata sentendo il fischiare dell'aria nelle mie orecchie divenute minuscoli fori, risalii cavalcando col ventre la corrente ascensionale che dalla terra calda portava alla limpidezza del cielo.
Con il volo del falco, tra il mio cuore e quello del giovane nacque come un sospiro che ebbe la voce di un tuono, come una goccia di pioggia con la portata di un'altissima fragorosa cascata, un germoglio che raggiungesse, sbocciando, l'altezza di una sequoia e si accese una luce, quella che io sapevo esistere ma che non avevo mai conosciuto: la luce dell'amore.
Tutti i confini immaginati e mai conosciuti si allargarono ai miei piedi, tutte le lingue parlate nell'universo si sciolsero nelle mie orecchie, tutte le bevande che tolgono la sete si versarono nella mia gola, tutte le vivande che placano la fame si accomodarono tra le mie labbra.
E allargai le braccia ad ala, acuii lo sguardo che si spinse ben oltre l'usuale, ascoltai il canto del vento mescolarsi a quello del mio cuore che narrava in quella sola parola, amore, tutte le fiabe dell'infanzia e le saggezze delle maturità.
La mia vita, fino ad allora incompiuta e monca, raggiunse la rotondità di un cerchio perfetto, morbido ed infinito.
Fu come perduta in un sogno che ascoltai il silenzio parlare con la sua voce e ascoltai la mia voce parlare di lui.
Come in un sogno egli mi riaccompagnò a casa, mi salutò e se ne andò, voltandomi le spalle.
Un sogno che continuò la notte quando, sdraiata addormentata nel mio letto, vidi la giumenta su di un ponte di legno e funi, sentii che queste spezzavano e precipitai senza un grido in una gola con la fedele cavalla e il rapace e lui.
E mentre precipitavo rividi la foresta dall'alto negli occhi stretti e scurissimi dell'uccello, sentii nelle mie pupille le pagliuzze dorate dello sguardo di selva del mio amato e in quel medesimo istante il mio cuore cessò di battere.

CARISSIMI AMICI
inserisco da oggi, 17 agosto 2017, il tasto per ricevere vostre donazioni...
finora non vi ho mai chiesto nulla..
ho messo qui le mie opere perchè fossero a vostra disposizione e l'ho fatto come scelta politica e personale..
ma la mia vita è diventata durissima...
Mia madre non mi aiuta più in maniera costante ma solo molto saltuariamente.
i miei figli non mi parlano quasi...
il denaro che il mio ex marito mi diede in fase di divorzio, nel 2013, che mi ha permesso di sopravvivere fino ad ora, è terminato...
ricevo mensilmente 800 euro dallo stato ma 500 se ne vanno per l'affitto e le spese di casa..
capite che quel che resta non basta neppure per il cibo mio, per Brugola e per Stellina
Non vi chiedo un ingresso obbligatorio, chi non può o non vuole, continui pura a fruire dei contenuti del mio sito in maniera gratuita...
ma
ora tu, che entri qui per leggere, guardare, ascoltare, puoi aiutare arianna amaducci...
grazie se lo farai..
fare una donazione è molto semplice, clicca sul tasto e segui le istruzioni...
non vi è un tetto minimo... bastano anche 50 centesimi ogni volta che passi di qui...
grazie, sinceramente
pace e luce nel tuo cuore e nella tua vita