
IO NON SONO
DI QUI
ROMANZO – DIARIO di
ARIANNA AMADUCCI
WLM edizioni
gennaio 2010

antefatto
Lo specchio opaco
Solo attraversando il più intenso dei dolori, la peggiore delle paure, il più profondo sconcerto, la più acuta disillusione, si arriva veramente al fondo di sé, ci
si spoglia di tutte le maschere e si resta nudi come bambini, puliti come coloro che non esistono e che non possiedono niente, puri come chi non ambisce a nulla, nuovi come chi non sente il
desiderio di ricominciare, tranquilli come chi non deve aspettare.
Molte volte ho ripreso da capo la mia vita senza accorgermi che, in effetti, il mutamento che apportavo era solo un cambiarsi d’abito e mi sono accostata alle mie
speranze e ai miei sogni con la certezza che li avrei raggiunti, che ce l’avrei fatta, che sarebbe stata la volta buona.
Ma regolarmente ogni volta mi sono infranta su completi disastri e fallimenti.
Io non so capire gli altri e non so farmi capire dagli altri.
Ho sempre avuto un forte bisogno di conferme dalle persone che mi sono state intorno, necessità di apprezzamenti, di riconoscimenti, come se tutte le mie azioni non
avessero valore in quanto tali, ma solo agli occhi degli altri.
Sono sempre andata incontro alle persone che via via ho conosciuto, sempre affamata del consenso altrui, sempre condizionata dall’attenzione che gli altri erano
disposti a concedermi.
Per questo motivo mi sono trasformata in una persona dal carattere accondiscendente, tranquillo e refrattario ai litigi, ma la mia tensione interiore, la mia
profonda insicurezza, il non vedermi e il non conoscermi se non riflessa negli occhi di qualcun altro, ha finito per rendermi troppo esigente.
La mia totale disponibilità, la mia totale abnegazione in tutto quello che ho affrontato – lavoro, relazioni interpersonali, amicizie, legami sentimentali e sessuali
– diventava così difficile da contraccambiare che, dopo un certo lasso di tempo, ognuno si è allontanato da me, in apparenza non per colpa mia, sempre senza accuse precise, senza litigi: così,
solo per il fatto che ero insostenibile.
Io non so camminare sulle mie gambe, non so stare da sola.
Se non ho una persona alla quale pensare, se non ho qualcuno a cui scrivere poesie, se non ho qualcuno da aspettare, io non mi sento viva.
Oggi io ho rotto i rapporti con il genere umano.
Non chiederò più amore a nessuno. Non mi aspetterò più di essere cercata, compresa, capita, apprezzata, amata, perché io non rappresento nulla di tutto
ciò.
Questo è il mio karma.
Oggi lo vedo chiaramente e lo accetto.
Non desidero più morire. Desidero vivere così, da sola come in effetti sono, facendomi compagnia, senza aspettare niente, senza dare niente.
Così non mi sentirò più incompresa e rifiutata.
Non coinvolgerò più nessuno nella mia vita, non deluderò e non asfissierò più nessuno.
Scruterò nella mia mente, scoprirò quello che c’è dentro.
Capirò quello che sono, quello che faccio e cosa devo aspettarmi dai miei comportamenti.
Se poi qualcuno richiederà qualche cosa da me, se riuscirò, gliela darò: qualche pensiero, qualche illuminazione, affetto e amore fisico per Dana.
Ma non c’è null’altro dentro di me se non la certezza che comunque questo mio essere ha un senso, - anche se non lo vedo e non lo capisco ., e la certezza che la mia
preghiera di protezione per le persone che mi stanno accanto ha un valore, ha un’effettiva necessità, perché io ho la capacità di assorbire il dolore degli altri, ho la capacità di trasmettere
energia positiva.
Questo farò, ma null’altro, per il momento, finché la luce non avrà scostato le cortine del buio che mi avvolge, buio nel quale cerco una certezza.
Avendo elargito tutto sempre a tutti senza ricavarne mai niente di positivo, avendo cercato e offerto tantissimo amore senza mai essere ricambiata e senza che
nessuno si sia sentito amato da me, senza che nessuno sia stato felice grazie a me, ora vedo: quello che devo fare è stare con me, non dare nulla, non chiedere nulla, non aspettarmi nulla da
nessuno, vivere del sole che splende, della pioggia che cade, della terra che produce i suoi frutti, delle parole che mi sgorgano da dentro, del senso di appartenenza a un genere che non capisco
ma del quale occasionalmente faccio parte, aspettando senza desiderarlo l’ultimo giorno della mia vita.
Non devo desiderare più nulla, non devo avere più bisogno di nulla e, come sono veramente riuscita a fare, non devo avere più nulla e più nessuno, affermando
comunque che la mia vita ha un valore.
Sono l’espressione di una legge infinitamente saggia che in me trova un senso e una necessità e per questo semplicemente vivrò, come specchio di una mente sconvolta
che afferma la sua unica verità…

CAPITOLO PRIMO
TUTTO HA INIZIO
Comincio oggi questo mio racconto, nella Chiocciolina, la mia roulotte.
Il 17 aprile 2007 ero qui, a Gabicce Monte, in campeggio, lontana dai miei figli e dalla mia casa.
L’avevo incontrata su un forum telematico. Anzi, lei aveva cercato me.
C’eravamo annusate da lontano.
Era il 19 marzo.
Il giorno dopo, c’era stato il nostro primo colloquio telefonico.
— Siamo sulla stessa barca, facciamo un tratto di mare insieme?
Al telefono la sua voce era un cono: penetrava a fondo nelle mie diramazioni nervose e di lì percorreva tutto il mio corpo, tutto il mio essere.
Devo vederla, avevo pensato.
Più di cento chilometri ci separano: prendo un autobus per la stazione e, appena arrivata, salto sul treno in partenza sui binari.
Un viaggio frenetico verso un incontro già scritto nel nostro futuro.
Io, dietro la locomotiva che spingo: corri, trenino scalcinato, corri, corri verso un amore che mi sta già trafiggendo levene con mille invisibili aghi…
Un presentimento di vita.
Arrivo, finalmente, e scendo dal treno mentre parlo al cellulare con lei, per incontrarci e riconoscerci.
Non ci eravamo scambiate neppure una foto:
un incontro completamente al buio.
Ma....... lei chi è?
Eccola!
No… Non è lei, non è lei. Sì, bella donna, ma..... non è lei.
Dana mi guarda un attimo, poi distoglie lo sguardo da me.
Ecco, penso, non le piaccio proprio…
Un sorriso di circostanza:
— Avrai bisogno di qualcosa…
— Sì, del bagno e ho sete.
Al bar le apro la porta, galante: sono o non sono un gentiluomo? E la faccio passare davanti a me. Il suo sedere mi cattura lo sguardo.
Penso: beh, almeno ha un sedere bellissimo…
Poi in macchina.
Lei guida e parla, non mi guarda mai, ma ogni tanto colgo un guizzo dei suoi occhi che indugiano su di me e poi immediatamente scivolano via.
Il suo odore mi avvolge.
Dolce e naturale, aspro e selvaggio. Penetrante come una lama.
Sento un flusso di vitalità concentrarsi nella mia mano che si posa, senza che io lo decida, sulla sua, intenta a manovrare il cambio.
Un brivido la percorre tutta, la scuote.
Ecco, mi innamoro. Lei si innamora. Tra le nostre dita il nostro cuore fa le capriole.
Dopo neppure un mese sono già vicino a lei, per vivere una storia che la distanza sembrava rendere impossibile.
Una decisione immediata che si è fatta strada nella mia mente.
Neppure un dubbio: andare, partire.
Dana ha una vita piena, da donna sposata che lavora.
Il tempo riservato a me sono solo i ritagli tra un impegno e l’altro.
Poi c’è Elisa, l’amica intima, l’innamorata di Dana che le ha detto che vuole essere solamente un’amica.
Per questo motivo Dana ha cercato e trovato me.
Per questo mi ha amato, perché era orfana del suo amore più grande.
Dopo sei anni Elisa ha preso le distanze da lei e questo l’ha ferita profondamente, come una lama affilata immersa nella sua carne.
La mia presenza nella sua vita, però, ha cambiato Dana.
L’ha liberata in parte dalla catena psicologica che Elisa le stringeva fortemente al collo.
Elisa, di conseguenza, si è sentita sbilanciata e si è sporta per afferrare di nuovo quella sicurezza che aveva scansato, perché soffocata dai sensi di colpa e dalle incerte valutazioni sulla propria vita.
Elisa è una donna complicata e involuta.
Dana così è tornata da lei, docilmente, precipitosamente.
Spaventata ma felice.
— Non ti amo —, mi aveva detto. — Amo lei.
Starei con te solo per il sesso.
Ma io ero già là, con la mia vita tra le mani per lei, con l’offerta più dolce e più forte, più completa, più inutile.
E le ho detto ancora un sì.

CAPITOLO
SECONDO
Buddha malato
- questo capitolo quindi è stato scritto nel 2007 , a gabicce mare dove ero in un campeggio, fuggita dalla mia città e dalla mi famiglia per amore di libertà e di un
donna, dopo di quest seguiranno moltissimi altri capitoli che narreranno tutta la storia id quei due anni.
in quel punto della mai vita ero nel pieno della mia crisi esistenziale, facevo i conti con il mio essere diversa, con le mie visioni di altri mondi e di altre
dimensioni che mi avevano portato ad essere dichiarata pazza e ad essere curata a viva forza e rinchiusa in ospedali e case di cura psichiatriche
in quei tempi avevo da poco iniziato la pratica buddista ed ero in piena rielaborazione del mio vissuto fino a lì
in quei tempi non avevo ancora avuto l'infortunio che ha fatto di me una persona invalida, ma ero già stata dichiarata invalida psichiatrica, avendo alle spalle già
cinque tentativi di suicidio..
che a tutt'oggi sono diventati dieci.. -
Oggi la parola tristezza io la cambio in gratitudine.
Non voglio più essere triste pensando a quello che ho perso, a quello che non ho avuto, a quello che vorrei ma non possiedo più.
Sono pensieri che non portano a niente, che non servono a niente, che non producono niente.
Io non voglio desiderare più nulla e voglio vivere di ciò che mi appartiene in questo momento.
Oggi possiedo un vento caldo che muove le fronde degli alberi creando un suono mistico e intenso.
Oggi sono mie le nuvole che si rincorrono nel cielo e lo rendono suggestivo e cangiante.
Oggi ho il profumo della siepe che dolcemente si insinua nelle mie narici, il ronzare delle api intente alla raccolta e il correre indaffarato delle formiche per i
loro sentieri segreti, il piacere di immergermi in mare abbandonandomi alla frescura sferzante delle onde che mi accoglieranno senza pormi domande.
Oggi ho il cibo e l’acqua per la mia sopravvivenza; ho la mia piccola casa, la mia roulotte Chiocciolina, il mio minuscolo guscio senza pretese; ho la musica che mi
infonde pensieri altrimenti per me sconosciuti.
Oggi non ho nessun dovere, nessun impegno, libera di essere niente e nessuno, di arrendermi all’impermanenza e di sentirne in pieno la dolcezza: perché tutto
finisce, e tutto è eterno nel suo mutevole fluire.
Ho la donna che amo: lei mi parlerà al telefono e forse verrà a trovarmi.
Ho qualche amica che mi vuole bene e forse mi penserà.
Ho la voce per pregare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, le gambe per camminare, le braccia e le mani per afferrare le cose.
Ho il tempo, lo spazio, il nulla, il mio pensiero, le mie parole, un libro da leggere, un nuovo gioco da scoprire, un aquilone da far volare nel cielo sopra di
me.
Ora la mia esistenza così insignificante non deve più rincorrere nulla.
Pulsa nelle mie vene e a qualcosa serve: a cosa non so, ma serve.
Sono come un Buddha malato, disperato, rifiutato, sconvolto, anomalo, che afferma con questa vita che a nessuno può essere negato il diritto di
esistere.
NELLA FOTO LA MIA ROULOTTE, ACQUISTATA CON GLI ARRETRATI DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' - 2500 EURO - CHE MI ERANO ARRIVATI AD APRILE DI QUELL'ANNO E PAGATA 1200
EURO
con il reso del denaro acquistai un po' di materiale per la costruzione del giardino intorno, poi vi mostrerò le foto, e per dipingere.
inoltre pagai la retta per tutta l'estate per rimanere in campeggio, il passaggio della roulotte e il trasferiemto della stessa lì, dato che non avevo
un'auto.
mi comprai inoltre una bici nuova..
restai quindi senza denaro e per tutta l'estate vissi con 250 euro al mese..dato che i miei famigliari non mi aiutavano in enssuna maniera, arrabbiati con me per la
decisione di abbandonare le cure psichiatriche che mi facevano solo male, di non rinunciare alla mi vita, alla mia omosessualità e di essermene quindi andata di casa, avendo scelto di vivere come
un barbone, - dicevano loro - in una roulotte...

CAPITOLO TERZO
Magna Mater
Il delirio della mia mente volta e rivolta la mia realtà, le mie possibilità, i miei punti di vista, le mie decisioni, le mie speranze, i miei desideri.
Vorrei pace.
È una parola della quale non conosco più il significato. Non un attimo di silenzio, non un momento di quiete.
Sempre un ricordo molesto, sempre un vecchio o nuovo dolore a risorgere e a sanguinare, sempre un gettare ponti verso un futuro che alla fine si rivela diverso da quello che io avrei desiderato.
Un incessante rivoltarmi dentro me stessa, sopra me stessa, attorno a me stessa.
Il presente non esiste, tradito dal passato, ammaliato e terrorizzato dal futuro.
Ma questa particella di realtà che io impersono, che io sento tanto pesante, cos’è, nel fluire degli eventi cosmici?
A volte mi sento sollevata nel pensare che non è nulla: solo un infinitesimale bagliore nell’immensa tempesta universale.
A volte sento fortemente la predestinazione di un’orma profonda che questa mia essenza infinita imprime nel volgere delle cose.
Il desiderio di morire è un enorme buco nero che sembra risucchiare interamente la mia energia.
Tutti si oppongono a questo mio impulso, ma non capisco: la morte non è pace? La morte non è quiete?
La morte non è ricostituire le energie e poi risorgere con nuove possibilità?
Io morirei affermando ciò in cui credo, morirei nella certezza di ritornare. Morirei per sciogliere questo rovello che mi corrode e mi obnubila.
Sono malata di mente.
Reggo la mia vita con i denti, digrignandoli sino allo spasimo, attaccata a un esile rametto sul bordo di un baratro oscuro che mi chiama e mi capisce, che non mi trova diversa, che mi accoglierebbe con quell’abbraccio, quello di mia madre e quello di mio padre, quello della donna che amo e che non mi ama, che non riesce ad accettarmi.
In questa vita ho concentrato tutto quello che non è accettato: disagio mentale, diversità sessuale, ipersensibilità, obesità, stravaganza, instabilità, autolesionismo, come a voler sfidare tutto e tutti, ma soprattutto me stessa.
Accettare l’inaccettabile, anche il desiderio della morte?
Tutti ne hanno paura, io la chiamo Madre.
Ed è tra quelle braccia che desidero addormentarmi, dato che quelle umane del mio desiderio non sono abbastanza forti per sopportare il mio adagiarmi.
Eppure a quelle braccia di madre ancora non torno, eppure ancora lotto e spero che la mia donna mi accoglierà.
Io sono convinta che, quando sarà il momento, la Magna Mater Morte verrà finalmente da me e mi troverà felice, soddisfatta e orgogliosa di averla saputa attendere serenamente, capace di debellare l’inferno dell’avidità, della stupidità e della collera, rispettando il Buddha malato che porta il mio nome.
Io sono aliena e straniera.
Io vivo per l'amore.
Amore. Potente motore di ricerca, del pensiero e della voce, del linguaggio del corpo.
Una sonda che si instaura nel profondo, giù dove neppure se voglio posso arrivare. Emozione che mi trascina via, che mi esalta, che mi annulla, che mi fa correre o tremare, che mi fa fermare o riprendere.
Mio padrone?
Mio destino?
Mia maledizione?
Mia aspirazione?
Mio compito?
Mia prigione?
Mio desiderio?
Mia necessità?
Amare ed essere riamata, come accade quando due corpi lanciati l’uno verso l’altro impattano e la velocità si somma, come succede quando al buio cerchi qualcosa e la trovi subito, perché sai dov’è, come avviene quando il pensiero nasce nella tua mente e termina in quella di lei…
Mi sveglio che è appena l’alba per ricordare al giorno che lei esiste e che mi aspetta. E il tempo non è più mio, ma suo.
Io mi organizzo, mi inanello, mi inserisco. Io fiorisco, mi moltiplico, germoglio, cresco in lei.
Penso e so di pensare perché lei ascolterà i miei pensieri.
Mi guardo allo specchio, perché so che lei vedrà il mio viso.
Entro in lei per ritrovare me, scopro lei per conoscere me.
Abbraccio lei per avvolgere me.
Amo lei per amare me.
Perché, quando lei non c’era, io ero un vuoto pneumatico, ero un artificio.
Ero una finzione, una ricerca senza esito, un aborto.
Amore. Potente motore di ricerca di me stessa.
Io mi sono trovata ora, che ho trovato te.
Ma quello che vedo intorno a me è solo diversità.
Diversità…
Io non sono uguale a niente, non appartengo a questa terra, non ne ho le regole nel mio DNA.
Sono cresciuta sentendo solo la distanza, l’incomunicabilità.
Io vengo da un altro pianeta.
Dentro di me l’universo fa risuonare la sua voce e io la sento.
Sono note che vibrano nella mente, musica comprensibile.
Ma vengo da un altro pianeta e questo mondo mi sta stretto, non lo concepisco.
Non sono nella lista dei viaggiatori, il mio bagaglio è stato smarrito, le mie parole hanno un altro suono, un altro significato. Io allontano gli abitanti di questo pianeta.
La diversità si vede troppo e fa male.
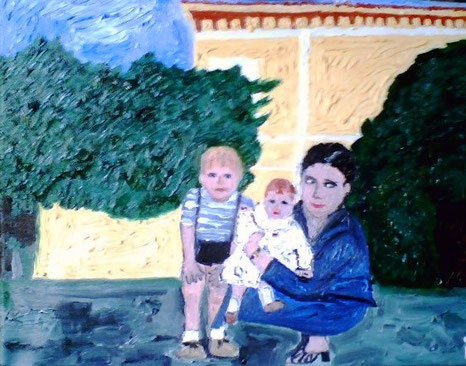
CAPITOLO
QUARTO
Grida di vita e di
morte e Balena
Quattrocchi
Il mio cuore: pensieri chiusi come un guscio, in una nuvola nera, in una nebbia densa che impastoia le parole.
I gesti si cristallizzano, la mano non si tende, il sorriso non nasce.
La carezza ritorna nella tasca sempre chiusa e quegli occhi che aspettano sono laghi di attesa, profondi e scuri.
Quelle labbra appena sfiorate sono archi tesi senza frecce.
Quel riso che non sgorga dalla gola è l’aborto di tutta la musica dell’universo.
Non saper amare è un buco nero.
Risucchia e inaridisce tutto dentro, prosciuga e indurisce tutto fuori.
Mia madre…
Ricordo la casa dove sono nata.
Avevo tre anni quando l’hanno demolita per costruirvi sopra e per volontà di mio padre, - ahimè -, un orrendo condomino di sette piani, nel quale ancora vivono mia madre e mio fratello con la moglie.
Ma allora la speculazione edilizia era appena cominciata e, invece che una terrificante piaga dell’umanità, sembrava, come sempre accade al sorgere delle cose malvagie, una meravigliosa possibilità di migliorare notevolmente il tenore di vita della gente comune.
Era una casa ottocentesca, a due piani, con la facciata di mattoni a vista, che correva con la lunghezza di due comuni caseggiati lungo una via di Imola appena fuori dalle mura del centro storico.
Ricordo il portone d’ingresso di legno scuro con la volta e l’inferriata alla sommità, come usava allora.
L’androne era lungo e ombroso. A destra correvano le scale per il piano superiore. In fondo c’era un’ampia cucina non troppo luminosa, con il camino in un angolo e una finestra vicino all’acquaio di granito, il tavolo centrale con le sedie impagliate e la credenza laccata color crema coi pomelli di vetro, sull’altra parete.
Vicino alla porta della cucina c’era quella che scendeva in cantina.
Per un scala stretta e ripida si accedeva a uno stanzone di due o tre vani, poco illuminati. Il pavimento era di terra battuta
e le pareti di mattoni ricoperti di un graticcio di piccole e fini canne per mascherare le fioriture del salmastro e dell’umidità.
Nella polvere erano adagiati e abbandonati materiali vari, tra i quali damigiane, bottiglie di vino, cassette da frutta e tutta una popolazione di ombre alle quali io non ho mai attribuito una definitiva appartenenza, ma che erano vive e pulsanti, pur nel sonno della dimenticanza.
Erano creature sottilmente minacciose, anche se parzialmente addomesticate dalla protezione famigliare.
Erano odori e suoni attutiti provenienti dal passato.
Io scendevo di nascosto, col cuore in gola, per prendere bottiglie nelle quali stipare petali di rosa da far macerare nell’acqua con l’aiuto di un ago da calza rubato alla mamma e creare così la mia personale e originalissima «acqua di rose».
Oppure staccavo dalle pareti qualche pezzetto di quel canniccio per poi salire alla finestra del bagno e creare bolle di sapone, diafane e coloratissime, fragili e piene di fantasie, attingendo acqua e detersivo per
i piatti da un bicchiere che mamma mi aveva finalmente preparato, cedendo alle mie estenuanti insistenze.
L’odore della cantina mi avvolgeva come un mantello, quando aprivo la porta, ed era come se mi attirasse e mi respingesse insieme.
Era un odore vinoso e polveroso, acre di muffe e di salnitro, di terra umida e di ferraglia in disfacimento. Era l’odore di qualche topo e del nostro gatto, Giacomino.
Era qualcosa nel quale immergersi un attimo per poi scappare via, con la sensazione di aver vinto una sfida,assaporando nuovamente il profumo dell’aria fresca.
Una sfida che mi affascinava nonostante la paura provata nel lanciarla.
Io avevo un sacro terrore del buio e ho continuato a soffrirne fino all’età di ventitre o ventiquattro anni.
Ma la voce del buio mi chiamava e io mi avvicinavo a lei come attratta dal canto della mia sirena interiore.
Una volta ottenuto quello che cercavo, chiudevo trionfante e ancora allarmata la porta dietro di me e tornavo nella mia casa, quella che non aveva sottofondi oscuri e retroscena paurosi.
Correvo allora con la canna e il bicchiere di saponata alla finestra del bagno, che si trovava nel pianerottolo, tra le due rampe di scale.
Il bagno era stato costruito in un secondo tempo ed era esterno alla casa, adiacente solo con la parete sulla quale era stato ricavato l’ingresso. C’era un piccolo sgabello tra il lavabo e la tazza del water e io lo spostavo sotto l’orlo della finestra usandolo come piedistallo per poter far scendere le bolle e poi guardarle volteggiare lentamente e voluttuosamente verso il basso.
Qualcuna si accendeva di un ultimo sfavillio e poi, come gonfiata dall’espansione interna del suo essere, scoppiava in uno spruzzo di goccioline.
Altre, invece, mollemente adagiate nell’aria che le corteggiava, rubavano dolci e cangianti ricordi di un arcobaleno visto chissà dove e chissà quando e si posavano sulle superfici che al piano sottostante le accoglievano: il terreno, le foglie di una rosa, la ghiaia della corte, il ramo di un arbusto o il fiore dell’aiuola di trifoglio lilla che correva per tutto il giardino.
E dove si posava, esitava un attimo più o meno lungo, decorando l’oggetto che l’aveva accolta della sua lucida meraviglia e poi scoppiava, lasciando l’impronta di sé, che lo rendeva ancora per qualche tempo più vivo e colorato, come se la sua essenza durasse ancora un po’ dopo la sua dissoluzione.
La mia camera da letto era invece al piano superiore, vicina a quella dei miei e di mio fratello.
Quelle stanze io non le ricordo, ma sento ancora la voce dei miei che a letto parlavano tra loro prima di dormire, mentre io ancora non cedevo al sonno, e come un fantasma riecheggia il colore rosa antico di una coperta matrimoniale e il bagliore un poco polveroso di un lampadario di vetro soffiato color giallo scuro e rosa, con foglioline e arzigogoli di metallo.
Nella mia camera c’era un’étagère di legno scuro.
Mi ha accompagnato nei miei spostamenti fino a non so più quale trasloco, per essere poi alla fine sacrificata all’immondizia quando ormai l’età era così avanzata che non era più proponibile alcun tentativo di restauro.
Il nome le dava una pompa che non aveva, dato che era una piccola mensola a tre ripiani, con ciascuna delle spalliere formata da tre listarelle di legno in scala triangolare, ma raccoglieva i miei pochi giocattoli e alcune cianfrusaglie,
i miei tesori.
Così, nella mia accesa fantasia infantile, l'étagère appariva un mobile da re.
Sul lettino a una piazza c’era la cosa che mi piaceva di più della mia camera: la sopracoperta di cotone grosso e un po’ ruvido, con stampati tutti i personaggi della fiaba Bambi di Walt Disney.
Assieme all’allegro cerbiatto, con le belle macchie bianche sul dorso fulvo acceso, c’erano la madre non ancora morta, il coniglietto e le farfalle, nascosti nella vegetazione di un bosco luminoso e fiorito,
del quale io percorrevo col dito i sentieri segreti e rubavo suoni e odori, così che i miei viaggi immaginari trovavano sempre nuovi itinerari fino a che il sonno non mi vinceva e non mi rapiva per i corridoi dei miei sogni.
Una mattina mi svegliai e chiamai la mamma, ma la casa era silenziosa e nessuno mi rispondeva.
La luce filtrava già dalle finestre, il giorno era sorto da un pezzo, ma nessuno rispondeva al mio richiamo, che diventò un pianto e poi un singhiozzo che mi stringeva così forte la gola e il petto da impedirmi di respirare.
Un senso di abbandono, gelido e spaventoso, invase ogni cellula del mio piccolo corpo.
Avevo due anni circa, come poi confermò mia madre nel risalire a questo ricordo.
Il tempo che trascorse finché lei, Renza, non giunse al mio richiamo mi sembrò e mi sembra ancora, rammentandolo, così vivido e presente come se lo stessi vivendo in questo momento, infinito e intollerabile.
Poi risuonò la sua voce che mi ammoniva dalle scale di smettere di piangere e la sua presenza austera, della quale sentivo un assoluto bisogno, finalmente mi sottrasse alla morsa della mia infinita paura.
Piangevo molto da piccola.
I seri problemi di salute dei primissimi mesi si protrassero fin quasi al primo anno di età, insieme alla penosa incertezza sulla mia sopravvivenza, e la gastroenterite che mi minava la salute mi provocava acute sofferenze.
Nelle foto di quando avevo sei mesi si vede una piccola ranocchia – e pensare che appena nata pesavo quattro chili e duecentocinquanta grammi! – con i capelli rasati a zero, un odioso vestitino di trine bianco e un’aria triste e sofferente, contrastante con il sorriso smagliante ma freddo di mio fratello, di cinque anni più grande di me e l’aria da azdora affaccendata ed efficiente di mia madre. L’azdora era nelle campagne romagnole la moglie del fattore o del mezzadro, che gestiva il pollaio e l’orto, custodiva la chiave della dispensa ed esercitava il comando sui figli e spesso anche sul marito.
Era l’anima rustica e affaccendata delle nostre campagne, dove non si buttava via niente, dove la terra era generosa e l’estro del contadino molto scaltro nel ricavarne il massimo profitto.
Erano donne in carne, tornite ma non grasse, dal sorriso fiero e orgoglioso, indurite e rese asciutte dall’ambiente aspro in cui vivevano che prosperava grazie alla loro ingegnosa operosità.
Tale sembrava mia madre a trent’anni, quando mi mise al mondo.
Io ricordo perfettamente la mia nascita, come la rivivessi ora.
Lo stanzone della sala parto era gremita dalle sue grida, che cercava di soffocare ma che le squarciavano il petto, contro ogni sua volontà. Infermieri e medici biancovestiti si affaccendavano attorno a lei, cercando ogni nuovo o antico rimedio per farmi uscire da quello stretto canale di carne che mi stringeva come una morsa, al quale io mi aggrappavo e mi contorcevo con tutta la mia inconscia disperazione.
A nulla servì ogni tentativo e allora ecco la maschera con l’etere togliere la coscienza alla stremata partoriente ed il coltello, il bisturi affilato, incidere il suo ventre rigonfio e maturo come ad estrarre il nocciolo da una pesca.
La tagliarono da sotto lo sterno fino al pube ed ella ebbe il ricordo di me impresso nella sua carne come un marchio a fuoco, fatto per la vita.
Così mani estranee mi trassero da quella culla che era diventata quasi una bara, cianotica, anossica, morente, ma ancora viva.
Eppure non respiravo.
Allora l'ostetrica si fece portare una bacinella di acqua molto ed una di acqua gelata e mi immerse ripetutamente d'alluna all'altra, sculacciandomi vigorosamente la schiena, in modo che lo shock termico e le scossa mi obbligassero a contrarre i polmoni e ad emettere quel primo assolutamente insostituibile respiro.
Io so che non sapevo che fare, che soffrivo che avevo paura, ma che, si, respirai, ruggii tutto il mio dolore, il terrore, il mio sollievo e il mio ego, fino a liberare ogni intoppo nei miei polmoni, nel naso e nella bocca, superando ogni ostacolo interiore solo per la volontà di esistere, di vincere quella stretta che mi voleva condurre nel regno dal quale io volevo uscire, il grembo della morte.
E vissi, vissi , vissi.
Ma lei, la mamma mia, colei che mi aveva voluta e tenuta dentro si sé per quei lunghi nove mesi; lei, dopo che fu ricucita come un grossolano sacco di iuta ormai vuoto e riportata ancora addormentata nel lettino della degenza, lei, fu trovata in un lago di sangue, ormai abbandonata all’oblio, alla fine, da mia zia, che, vedendola sbiancare innaturalmente, sollevò il lenzuolo e la coperta posta pietosamente, ma invano, a riscaldarla.
Lottò tre giorni tra la vita e la morte, ma mio nonno faceva il barelliere proprio in quell’ospedale, che da fuori sembrava più una antica villa patrizia, con scalone semicircolare ad attorniare ai due lati l’ingresso immerso nel verde e donava spesso il suo sangue in cambio di cibo e carne da portare a casa alla già numerosa nidiata affamata che aspettava il suo ritorno, accontentandosi per se stesso di un quarto di vino rosso, grosso e corposo.
Quella volta egli fece dono delle sue vene alla carne della sua carne e il rubicondo suo sorriso vinse dentro le membra esauste della sua giovane figlia, strappandola ad un amaro destino, riportandola a coloro che la stavano aspettando, tra tutti io.
Mi misero nome Arianna, battezzandomi in fretta e furia, così come in fretta diedero i sacramenti di morte a mia madre, non sapendo quanto tempo ci restasse da vivere, e mi adagiarono tra le braccia di un’altra puerpera, che aveva dato alla luce il giorno prima un bel bambino, sano e bello.
Lei era una donna forte di Romagna e aveva tanto latte anche per me: io, nonostante non riconoscessi l’odore di quella pelle estranea né la voce, mi avvinghiai al suo seno turgido di fluido vitale e lasciai che si placasse, suggendo con energia, la fame che da tante ore mi torturava, sentendo il liquido caldo entrare nella mia bocca, lievemente salato, e scendere nel mio stomaco ormai rattrappito: latte materno caldo e vivificatore, grato di sapore e di consistenza, giusto per me.
Per tre giorni bevvi di quel nettare, ignorando l’agonia della mia vera madre e saziandomi di quell’abbondanza generosa e offerta con amore, da una madre in affitto, dolce donna dal grande cuore genitore.
Finalmente i medici decisero che Renza, ripresasi abbastanza e fuori dalla sua agonia di morte, fosse pronta ad attaccarmi al suo seno ed io provai per la prima volta il suo abbraccio, il suo calore, riconobbi il suo odore: mia madre.
Ma quanto dolore ancora nel suo povero corpo martoriato e nella sua mente sconvolta dalla paura e dalla sofferenza!
Le sue braccia erano rigide e non aveva sorrisi per me, poiché a stento ancora tratteneva la vita tra i denti, e il suo latte, anche se abbondante, si era guastato e mi ammalò gravemente.
Cominciò così la mia lenta agonia, uno stillicidio durato sei mesi, perché ogni goccia di quel latte amaro rivoltava le mie viscere con dolori acuti e strazianti: perdevo peso e piangevo, giorno e notte.
A sei mesi pesavo come il giorno della mia nascita, quattro chili e duecento grammi, ed ero una piccola triste, inconsolabile, insopportabile figlia.
Solo l’intervento provvidenziale e ormai insperato del farmacista con un rimedio antiquato come l’acqua seconda di calce, mi salvò la vita.
Mio padre sacramentava che avevano speso inutilmente un sacco di soldi per farmi visitare da tutti i dottori e i luminari di Imola: come poteva un rimedio così semplice e poco costoso rivelarsi efficace?
Ma mia madre insistette, tanto le avevano ormai provate tutte e la rovina ai rovinati non fa paura.
Infatti il farmacista mise in acqua della calce viva, poi la scolò e la rimise di nuovo in acqua: dopo un certo tempo di posa me la diedero da bere, disinfettando così il mio intestino malato.
Da allora ripresi a crescere di peso, ed ebbi salva la vita, ma ormai il danno nel mio piccolo cuore era fatto: continuavo a piangere, dato che il meccanismo per attirare l’attenzione di mia madre e ottenere le sue cure, era quello.
Il mio pianto continuo aveva stancato incredibilmente i miei poveri genitori, che non potevano neppure dormire. Infatti mio padre, che essendo ragioniere doveva recarsi in ufficio e stare attento a quello che faceva, perché allora i conti si facevano a mente, finì per trasferirsi a dormire in un’altra stanza.
Mia madre si ritrovò ad affrontare la sua debolezza fisica e la mia, un altro bimbo, che pur essendo molto tranquillo comunque era pur sempre un impegno notevole, e tutta la casa da mandare avanti.
Mio padre per aiutarla le comprò la prima lavatrice, semiautomatica, che però risolveva solo in parte i problemi da affrontare.
A volte mia zia Teresina si prendeva cura di me, anzi spesso, dato che abitava col marito nella «casina», una dependance che sorgeva nel nostro vasto cortile. Ma era in attesa del suo primo figlio, che sarebbe nato dieci mesi dopo di me, quindi più di tanto non poteva fare.
Mi cantava le canzoncine.
Mi piaceva quella della Bella Fantina, e gliela chiedevo continuamente. Lei mi stringeva al seno prosperoso e me la cantava con la sua voce viva e un poco stonata.
Mi appoggiavo al suo respiro caldo e mi sentivo felice…
Ma non era mia madre.
Mia madre era una donna severa e poco incline ai gesti d’affetto.
Nata dopo cinque fratelli, mia nonna, quando vide che era giunta una femmina, in preda ad oscuri presagi di sofferenze e difficoltà, fuori di senno per la preoccupazione ed il parto, avrebbe voluto buttarla nel canale e così porre fine a quella piccola vita innocente, già gravata di dolorose pesantissime responsabilità, appena venuta al mondo.
I presagi di nonna non si dimostrarono errati e Renza, che aveva un carattere forte ed indipendente, venne piegata a suon di busse e di privazioni ad una vita di piccola schiava, per aiutare la madre, perennemente incinta, a crescere i fratelli giunti dopo di lei, che le volevano stare sempre in braccio, anche se quasi pesavano più di lei: in tutto mia nonna diede la vita a tredici figli, di cui due morirono in tenerissima età.
Non patirono mai la fame più nera, neppure in tempo di guerra, quando Renza, che aveva dodici anni, gestì da sola un piccolo negozio di alimentari, col quale salvò la famiglia, perché gli annonari, i controllori delle schede delle merci che entravano e uscivano, tutte contrassegnate da bollini per evitare il mercato nero, chiudevano un occhio se mancava qualche chilo di zucchero o di farina, sapendo che dodici figli erano tanti da sfamare.
Ma il clima in casa era duro.
Tenere in riga tutti quei figlioli era una gran fatica per il nonno, che solo con i nipoti si mostrò dolce e affettuoso: con i figli, urla e cinghiate.
La nonna poi era una querula rompiscatole, sempre incinta e sempre a lagnarsi di tutto, poveretta.
E pure i fratelli di mia madre volevano fare le veci del padre nei suoi confronti e quindi lei crebbe vessata su tutti i fronti.
Non le fu permesso di andare a scuola, cosa che lei desiderava tantissimo, essendo dotata di viva intelligenza e desiderio di sapere ed emancipazione, mentre vedeva i fratelli maggiori studiare per diventare maestri.
Fu fermata alla prima elementare, nonostante il suo continuo ribellarsi, tutto il giorno stava con i piccoli in collo e il bucato da fare.
Non si lamentava del duro lavoro, ma la domenica, ella voleva uscire a passeggio tra i portici del centro dell’antico borgo, dandosi un velo di cipria e una lacrima di rossetto, come facevano le sue amiche che venivano da famiglie più agiate e aperte, però ad ogni passo, doveva nascondersi dietro una colonna o la nicchia di un porta perché le amiche, che facevano buona guardia, l’avvertivano del passaggio di uno o dell’altro dei fratelli suoi controllori, che l’avrebbero ricondotta a casa e di nuovo rinchiusa, dopo una razione di cinghiate.
Erano offese e violenze che lei incassava senza battere ciglio, senza dare loro la benché minima soddisfazione, poi, fuggiva di nuovo di casa alla prima occasione, a volte, mentre dopo pranzo si faceva la siesta pomeridiana, calandosi dal balcone.
Furono colpi che le insegnarono così la supremazia maschilista e il suo duro destino di donna, nata per lavorare senza riposo e riprodurre figli, come animali.
Ma Renza era una persona orgogliosa e molto vitale.
Mise su una corazza di tutto rispetto, e proseguì la sua vita a onta di coloro che la osteggiavano.
Era bella e vivace, senza sapere di esserlo, fiera come una puledra indomita, ma trovò chi le mise il morso e la piegò al compito di donna, moglie e madre.
Dopo la sbandata delle truppe italiane dell’otto settembre, tutta la famiglia si rifugiò in una grotta naturale nascosta tra colline lussuriose di vegetazione spontanea, dividendo fame e promiscuità con altre famiglie lì radunatesi per scampare alla ritirata dei tedeschi che risalivano la penisola italiana seminando morte e distruzione ovunque passassero.
Proprio lì Renza incontrò mio padre, che nello stesso luogo, abbandonata la divisa militare, si era nascosto con la sorella più giovane.
Si innamorarono, anche se lui, ragioniere e universitario, la trattava con sufficienza, perché ella era un fiore selvatico, nato tra le spine.
Appena tornò la pace, mia madre riuscì a vincere le resistenze del suo fidanzato, partorite dalle sue fissazioni mortifere, -dato che era convinto sarebbe morto a 49 anni come entrambi i suoi genitori e come poi accadde effettivamente di lui e quindi non voleva lasciare orfani - e si sposarono un mercoledì di giugno, la mattina alle sei, vestiti con gli abiti migliori ma senza pompa magna e senza pranzo nuziale, partendo poi immediatamente per un viaggio di nozze sul Lago di Garda, meraviglioso per lei che non aveva visto altro che il piccolo borgo dei suoi natali.
Di quel viaggio resta ancora un dagherrotipo in bianco e nero che mostra il suo fine e bel viso incorniciato da un foulard per proteggersi dal vento di poppa della barchetta che li portava a fare il giro del lago, accanto a lui, alto e distinto, con la folta capigliatura scura spettinata dall’aria frizzante di quella indimenticabile giornata di sole.
Essi erano vestiti alla moda degli anni cinquanta, lei con la gonna a ruota ed una semplice camicetta, lui con pantaloni sportivi ed un gilè di lana a scacchi e stavano a farsi fotografare a fianco della campanella per gli avvisi e gli allarmi.
Da quel giorno, Renza passò da una prigionia violenta ed ignorante, ad una più fine e apparentemente rispettosa, ma costretta alla sudditanza psicologica da quell’uomo tanto maggiore di lei per ceto ed autostima, che le incuteva, insieme ad un ardente amore e passione, anche tanta soggezione.
Andarono ad abitare nella casa avita dei genitori di mio padre, appunto quella bellissima una bellissima costruzione con un rigoglioso giardino interno ornato di palmizi, stile coloniale, che però andava lentamente sgretolandosi e disfacendosi.
Dopo due anni di matrimonio nacque mio fratello Angelo, anche lui con taglio cesareo, un bellissimo bambino biondo con gli occhi azzurri, calmo e riflessivo, intelligentissimo e portato per le arti matematiche e la fisica, un figlio perfetto, che fu la loro gioia, che non diede loro nessun problema, crescendo sereno e fecondo di sogni e speranze.
Per questo mio padre si legò a lui di un affetto morboso, cercando di dargli tutto ciò che a lui era mancato dopo la morte prematura dei suoi genitori, diventando così geloso di quel figlio unico nel suo genere, amato ed adorato da tutti, e fu sempre più apprensivo nei suoi confronti, rasentando la patologia.
Fu per questo che Renza, pensando che un altro figlio avrebbe portato aria nuova in casa, e avrebbe allentato la pressione sul primo allentando questo legame soffocante per tutti e tre, tanto fece e tanto insistette, che alla fine convinse mio padre a farla concepire.
Così, io venni procreata come un intervento curativo, non per un effettivo desiderio di me..
Mia madre mi narra sempre che, quando lei si ribellava alla ferrea disciplina impostale, sua madre si lamentava aspramente e le augurava di ritrovarsi poi in età adulta con una figlia ugualmente ribelle, che le avrebbe fatto provare quello che lei stava provando in quel momento.
La «maledizione» di nonna si era avverata puntualmente: io fui la spina nel fianco di mia madre,
La mia testa di riccioli rosso rame vagava indomita e velocissima in ogni angolo della casa e ogni oggetto era un fantastico gioco: la pentola e il suo coperchio una sonora batteria, una sedia sdraiata per terra con un cordino attaccato ed in mano un fuscello per frustino, era il mio cavallo Furia, col quale galoppavo sfrenatamente per le pianure estese della cucina dai muri ingrigiti dal fumo del camino.
Una grande scatola vuota era il mio vascello sul quale solcare le tempeste dei sette mari fino ed oltre le Colonne d’Ercole; due pezzi di legno legati insieme a croce erano Excalibur, brandita con coraggiosa arroganza per uccidere spaventosi draghi o malvagi maghi e salvare avvenenti principesse e poveri orfani.
Un tappeto sul quale mi sedevo afferrandomi saldamente alle nappe, era il magico strumento di volo per librarmi sulle dorate e ondulate dune di un remoto deserto africano, guardando in basso le fila dei cammellieri snodarsi, chiusi nei loro mantelli blu e recarmi così alla mia oasi gravida di palmizi dai dolcissimi datteri tra i quali risuonava una cristallina e perpetua fonte di acqua purissima che celava l’ingresso alla mia grotta segreta, dove custodivo, per poi distribuirlo ai poveri che incontravo lungo il cammino, un favoloso e inesauribile tesoro sfavillante di pietre preziose dai colori e le forme del mio adorato caleidoscopio.
Tutta la grande casa risuonava delle mie grida, dei miei canti, imparati alla scuola materna ed eseguiti perfettamente con una potente e intonatissima voce bianca.
E quando mia madre si lagnava di me con mio padre, cioè sempre, lui le rispondeva: «L’hai voluta? Adesso goditela!».
E lo diceva nel nostro bel dialetto colorito, lui che era figlio di maestri e parlava solo l’italiano, proprio per sottolineare la nemesi della realtà oggettiva.
Una nemesi che si era materializzata nella mia testa di capelli rosso rame, colore che mia madre odiava, fino al punto di tenermi rasata a zero per diverso tempo, nella speranza che scurissero. - Cosa che si avverò solo in età adulta, quando, se avessi avuto il mio gradevole colore originale, mi sarei risparmiata tempo e denaro dalla parrucchiera.-
Fu così che fui strappata dal seno caldo e accogliente della mia balia, che mi riscaldava e mi saziava facendomi addormentare serenamente e consegnata al seno colmo di quel latte avvelenato che mi contorceva le viscere, abbandonandomi ad un dolore incomprensibile senza abbracci confortanti.
Il mio pianto era continuo e una volta mia madre mi prese sulle ginocchia e mi sculacciò di santa ragione. Io avevo all’incirca un anno e lo ricordo sicuramente, ma questo racconto è fiorito più volte sulle labbra di lei con una specie di trionfo, come a sancire una vittoria e non invece una sua sconfitta, dato che io non avevo nessuna colpa del fatto di piangere e di stare male ed ero troppo piccola per essere educata a sculaccioni, soprattutto per superare un problema del genere.
Ma allora la pedagogia era quella, e l’indole di mia madre l’assecondava.
Quando fui un po’ cresciuta (avevo ormai tre o quattro anni), poiché la mia abitudine di piangere persisteva, lei inventò un ottimo sistema per farmi smettere.
Facendo leva sul mio spiccato orgoglio e sulla mia permalosità molto accentuata, quando per strada qualche conoscente, incontrandoci, mi rivolgeva dei complimenti, sottolineando quanto fossi bella – cosa che forse era vera o forse no, dato che per lei bella non ero di sicuro – lei rispondeva sempre:
— Sarà pure una bella bambina, ma piange
sempre!
Fu così che io smisi di piangere. Anche se sicuramente significava fare del male a me stessa.
Mio fratello invece, che io adoravo, se ne stava quieto e silenzioso a studiare la sua amata matematica e a smontare radio, ricavandone valvole, diodi e strani congegni che poi ricuciva col piccolo saldatore a piombo che gli era stato regalato.
Io lo scrutavo, senza che lui se ne accorgesse, dallo spiraglio della porta socchiusa e mi sembrava un potente mago alla ricerca della pietra filosofale.
La sua quiete e riflessività risaltava sulla mia vivacità da ragazzaccio e mia madre, che aveva sognato una dolce bambina da vestire di trine e pizzi che lei stessa era abilissima a confezionare, si trovava un figliolo maschio perfetto, sempre pulito e in ordine al quale non rivolgere mai il benché minimo rimprovero perché non ne aveva bisogno, che quindi adorava e ammirava sconfinatamente, e una figlia femmina che sembrava uno scugnizzo di Napoli, sempre con le mani sporche di terra o chissà cos’altro ed i delicati golfini dai colori pastello che mi faceva con tanta pazienza, tutti sfigurati da macchie d’erba o di fuliggine e polline di fiori.
Così erano eterni rimbrotti e sgridate e a volte sculaccioni, che lei mi impartiva con la sacrosanta intenzione di insegnarmi a diventare l’ educata e leggiadra fanciulla che avrei dovuto essere, lasciando nel mio animo sensibilissimo un amaro convincimento che ella non mi amasse affatto, che anzi mi disprezzasse, che non mi volesse accanto a sé, convincimento sottolineato e reso più saldo dal suo essere asciutto, senza baci né abbracci, che da bambina non aveva ricevuto mai, e dal fatto che non mi rivolgesse complimenti e vezzeggiativi, che io proprio non le ispiravo
Fu così che il forte disagio, la grande estraneità al comune essere che era già stampato in me dalla mia concezione, si sviluppò ogni giorno di più verso un futuro complesso e doloroso.
Il dolore è un abitante subdolo del tuo corpo, silenzioso, discreto, tanto che spesso non ti accorgi neppure di lui; ma non paga l’affitto.
Abita ogni tua stanza, si allarga mano a mano che ti allarghi tu, cresce un centimetro se tu sali di un centimetro e ti fa da contrappeso.
Io mi abituai presto al suo passo felpato e ad appoggiarmi a lui, cercando un equilibrio che non trovavo da nessun’altra parte.
Lui era sempre presente e mi porgeva, con il suo sorriso mesto, sempre qualcosa a cui pensare, qualcosa di cui scrivere, qualcosa da cercare o da cambiare.
Non so quando lui sia diventato il padrone della mia casa, quando anche l’ultima cambiale sia scaduta non pagata e lui si sia impossessato di tutti i miei averi, so solo che mi ha lasciato la possibilità di continuare ad abitare dove avevo sempre vissuto, ad usare le vettovaglie che mi avevano fornito, le risorse che mi erano state donate.
Cominciai allora ad irrobustirmi e così presero il via altre torture.
Avevo appetito, ma mi si centellinavano le razioni di cibo.
Mio fratello mangiava come un cavallo, ma era magro e stava crescendo. Quindi il suo piatto era sempre colmo.
Io guardavo la mia piccola porzione e soppesavo tutto nel mio cuore.
Meno cibo mi veniva concesso, meno amore ricevevo. Per me era così.
Stavo per morire a causa del cibo e questo il mio corpo non l’aveva dimenticato.
Cibo uguale vita uguale amore.
Mi alzavo la notte spinta dalla voglia di mangiare, ma il frigo era tenuto appositamente vuoto.
Io divoravo qualsiasi cosa, anche la crosta avanzata del parmigiano. Non potevo dormire con quel vuoto dentro.
Ero molto miope dalla nascita e, non vedendoci bene, incespicavo spesso, cadevo e mi facevo male.
Ma non venivo consolata da mia madre: anzi, ella mi sgridava perché non avevo fatto attenzione.
Fu la mia maestra delle elementari che si accorse che non vedevo bene. Così l’oculista mi prescrisse gli occhiali.
Occhiali pesanti, dalla montatura scura, con la lente che faceva cerchi e rimpiccioliva i miei occhi verdazzurro.
I compagni di gioco mi chiamavano «Balena Quattrocchi».
Io li picchiavo forte e loro mi prendevano in giro sempre di più.
Così correvo in camera mia a leggere.
Non piangevo, no, non piangevo quasi più. Fuggivo con la fantasia. Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Spinarella, Zanna Bianca, Piccole donne, Pattini d’argento, Il corsaro nero, I viaggi di Gulliver, Moby Dick, Senza famiglia, Oliver Twist, Il piccolo principe, Il giardino segreto, erano la mia vendetta, erano la mia pelle, erano il mio orizzonte e alle tre di notte ancora la luce sul comodino brillava nel silenzio della casa.
Io, la mano premuta sull’occhio troppo stanco, leggevo con l’altro, che ancora mi seguiva e vagavo lontano dalla prigione del mio cuore solitario.
---------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
QUINTO
Don Emidio
Il mio mostro…
Oggi sono l’abbandono
La voce aspra della tua coscienza
Il buco del tuo calzino
Il dente cariato che cerchi di dimenticare ma che subdolo lavora di nascosto
Oggi sono un tumore celato nella speranza Una breccia nel sorriso di un sistema perfetto
L’afonia in un coro angelico
Oggi sono il sasso che galleggia
Il fiore che alimenta un brulichio di insetti schifosi
Oggi io sono l’amore che divora
La calura che toglie le forze
Il miasma asfissiante da cui corre lontano chi ho amato e chi amo
Oggi nego di esistere e di morire
Oggi vivo per una stupida causalità che mi vuole matrice del mio stesso infinito dolore. Che mi trasforma in un vuoto silenzioso, in un palcoscenico deserto su cui è
calato il sipario
Don Emidio
Done, così lo chiamavamo tutti.
Era il parroco più amato dai bambini.
Tutti gli correvamo incontro come al richiamo del flauto magico.
Era alto e dal bel viso solenne. La lunga tonaca nera ne snelliva la figura pingue. Sembrava non finire mai.
Ci tendeva le braccia come Gesù: sinite parvulos…
E noi volavamo tra quelle braccia.
La sua voce tuonava dal pulpito.
Fine parlatore e pensatore, ammaliava. Le sue omelie erano racconti che ti penetravano nel cuore.
Egli parlava a ognuno di noi in prima persona.
Ma sembrava che guardasse solo me. Amasse solo me. Vedesse solo me.
La parrocchia era la mia casa.
Lì si trovavano attività, svaghi, giochi, canti, studio, qualcuno che mi ascoltava, qualcuno che mi parlava, qualcuno a cui importava di me.
Tutti i pomeriggi dai sei agli undici anni io li ho passati in parrocchia.
Il catechismo, poi il ping pong, il bigliardo, il bigliardino.
Era il paese dei balocchi.
C’era sempre qualcuno che passava di lì con cui giocare, parlare o anche litigare.
Le favole di quel dio erano stupende.
Io studiavo e ricordavo ogni cosa. I nomi, i volti…
La chiesa era ben tenuta e riscaldata d’inverno, adorna della statua della Madonna che schiacciava il serpente, del grande quadro di San Lorenzo martire sulla
graticola, delle candele accese, dell’altare con il tabernacolo sfavillante d’oro, di lini bianchissimi e di gigli.
Ovunque aleggiava l’odore buono dell’incenso.
Mi perdevo tra le navate, fra le panche di legno con le targhette dei defunti ai quali erano state dedicate, fra i libretti delle preghiere distribuiti ognuno al
loro posto.
Done suonava la pianola od organetto: non conosco il vero nome di quello strumento dai cento suoni diversi, che aveva un motore ma non le canne e che lui adoperava
con maestria, senza bisogno di uno spartito.
Io avevo una voce che incantava: forte, pura, intonata e altissima.
Una voce bianca, la principale del coro.
Se fossi stata un maschio, il ruolo di chierichetto mi sarebbe calzato a pennello.
Li invidiavo tantissimo, i chierichetti. Le loro tonache bianche fino a terra. I ricami di filo dorato. Le pianete, i calici, le ampolle. L’acqua e il vino, simboli
di vita eterna. Peccato non poter diventare prete…
le monache invece quasi le detestavo.
La domenica pomeriggio, alle due e mezzo, si andava al cinema nel Cineteatro dietro la chiesa:.
Filmoni mitici che ci trasportavano fra i ghiacci dell’Alaska o in mezzo ai flutti degli oceani, sulla luna o all’inferno, nell’antica Roma o nella Parigi
ottocentesca, nel gelo innevato di Mosca o nelle praterie sconfinate del Far West.
Viaggiavamo ovunque, a piedi, a cavallo, vedevamo tutto, scoprivamo tutto.
Per una settimana intera rivivevo dentro di me il film visto in attesa del prossimo.
Cosa avrei vissuto?
Dove sarei stata?
La sala era sempre gremita e si entrava con le liquirizie, le brustoline, i lupini.
E poi c’era l’Operetta, che si metteva in scena ogni anno, sempre nel Cineteatro: noi bambini guidati da lui e una serie di ragazzi grandi che curavano tutta la
messa in scena.
Con i costumi e gli scenari, con l’orchestra vera che suonava nella sua fossa.
Le prove duravano tutto l’inverno. Il sabato
pomeriggio dopo il catechismo e ancora il mercoledì.
Io ero nel coro. Non sapevo assolutamente recitare e non ho mai ottenuto ruoli da protagonista.
Solo qualche impacciata comparsa.
Ma nel coro ero la colonna.
Dopo la prima prova già sapevo a memoria quasi tutte le parole.
E lui ci insegnava cantando con noi.
Niente da leggere, né da studiare.
Ma io mi facevo dare il libretto e me lo leggevo avidamente.
Alla seconda prova lo sapevo già a memoria.
Le rappresentazioni venivano replicate due
o tre volte.
L’eccitazione era altissima.
E gli applausi, scroscianti.
Le caramelle gettate sul palco a noi che ci inchinavamo davanti al pubblico.
Tutta quella festa per noi, attorno a noi.
Solo ai miei sembrava non interessare per niente.
Mi sa che non vennero mai a vedermi. Io non lo ricordo. Anzi, mia madre mi zittiva quando in casa intonavo a gran voce i cori e le parti soliste di canto per
allenarmi.
Così uscivo fuori e andavo a cantare dove non davo fastidio a nessuno…
Ma Done non era una persona pulita.
La tonaca si rivelava, a un occhio attento, lisa in molti punti e l’odore che emanava era vagamente rancido.
I capelli neri, lustri di brillantina, sicuramente non erano lavati troppo spesso. E l’odore che si
percepiva dentro le stanze private dei preti e delle loro perpetue era forte, quasi opprimente.
Loro erano sepolcri imbiancati.
Non ricordo quando lo fece la prima volta. So che lo fece molte volte. Moltissime.
E io pensavo: sì, sì, sono qui.
La sua era una violenza sottile. Proprio perché entrava in me nel nome di Dio e dell’amore.
Le sue mani erano dappertutto in me. La sua voce era dovunque.
Il suo respiro era l’aria che respiravo.
Si fermava lì, non fece mai altro che toccarmi. Ma anche se avesse fatto tutto quanto era in suo potere, non sarebbe stato diverso…
Lui succhiava il mio sangue…
Lui beveva la mia vita…
Lui rubava la mia luce…
Durante le confessioni, Done, chiuso nel confessionale, mi chiedeva sempre se mi fossi toccata e cos’altro avessi fatto, se avessi toccato qualcuno dei miei
amichetti o dei miei cuginetti.
Anzi, fu lui a insegnarmi come procurarmi piacere da sola o con altri.
Fu lui a spiegarmi come nascevano i bambini,
non mia madre o mio padre, e lo fece che io avevo sei o sette anni.
Col viso appoggiato contro la grata, la voce bassa ed emozionata, gli raccontavo le mie prime avventure erotiche con i miei coetanei, cosa avevo fatto
e quante volte, cosa avevo provato io e cosa avevano provato i bambini che giocavano con me a quei giochi carnali.
Lui mi faceva domande molto specifiche, anatomiche e io rispondevo con precisione.
Sentivo il suo desiderio passare attraverso i buchi della grata.
Sentivo i suoi occhi forare il buio.
Sentivo una mano malvagia che si impossessava di me.
Da allora, il piacere e il dolore si sono mescolati dentro di me. Per sempre.
Lì, alla mensa di quel pane amaro e guasto, ho imparato cosa vale la mia vita.
Piacere e dolore.
I miei scoprirono tutto, tramite la confessione della mia amica Sandra, che viveva quello che stavo vivendo io, come penso tutte le altre bambine della
parrocchia.
I genitori di Sandra erano i migliori amici dei miei genitori, e vivevano nell’appartamento sotto di noi.
Ma non fecero niente.
Ci fu solo un po’ di tensione.
A me non chiesero nulla.
Seppi tutto da lei, i loro discorsi e la loro decisione di non agire in nessuna maniera.
A me, nessuno rivolse una parola. Confermando così quello che mi era stato insegnato e cioè che la mia vita valeva solo come piacere e dolore.
Continuammo a frequentare la chiesa.
Avevo undici anni. Lui non mi molestò più.
Poi mio padre morì.
E un anno dopo mi allontanai dalla parrocchia e dalla religione cattolica.
Troppi conti non tornavano nella mia mente.
Troppo presto la mia innocenza è stata profanata da mani scaturite dall’ombra.
Mi chiedo quanta forza io possegga veramente per vivere con questa ferita dentro.
Per riuscire a continuare ad amare, nonostante questo.
Per avere il coraggio di guardare questo. Ora. Qui.
Ho cinquantatre anni.
Ma sono ancora quella bambina abbandonata e violata.
Sono una piccola geisha venduta per paura. È un miracolo che io sia viva.
Che io non faccia la prostituta.
Che io non sia un’assassina.
Che io non sia pervertita o pedofila.
Che io non sia completamente folle, ma solo tanto, tanto. Senza arrivare fino in fondo.
Oggi penso che lui ha sbagliato, così come hanno sbagliato i miei genitori. Che non è stata colpa mia.
Che io sono altro, molto altro.
Non so se riuscirò a dare un altro valore alla mia vita.
Lo faccio con il pensiero, ma i binari segnati a fuoco dentro di me, nel profondo, dove la mente non ha dominio, sono quelli.
So però che il mio prossimo amore non sarà dolore, ma solo piacere.
Altrimenti sarò io ad andarmene.
A chiudere la porta per prima e ad affermare che io non merito tutto quel dolore.
E questo l’ho fatto già, l’altro giorno, quando ho chiuso definitivamente la mia storia con Dana.
--------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
SESTO
La perdita
La perdita…
È come strapparsi qualcosa da dentro.
Ore, voci, discorsi, attese, abitudini, ritmi, certezze.
Un orologio interno che all’improvviso cessa
di scandire i momenti e lascia vuoti assordanti.
Parossismo di sostituzioni, cambiamenti, spostamenti.
Traslochi durante i quali vanno smarrite cose che erano lì da troppo tempo, da sempre.
Costruzioni credute immortali che crollano travolte da soffi immani e rivelano orizzonti fino ad allora sconosciuti.
Poi ci si guarda dentro e non si riconosce ciò che si vede, lo si rifiuta.
Si desidera solo spasmodicamente ciò che era, ciò che non c’è più.
Ci si chiede allora, nell’attimo della fine, di visualizzare l’ultimo battito, cristallizzare l’ultimo respiro, registrare l’ultima parola.
Ma è troppo tardi.
Indietro non è permesso tornare, mai.
Ci si illude, ma si va avanti per inerzia, aggrappandosi a quei residui di abitudine che ancora tenacemente persistono dentro di noi.
Non ci si arrende all’evidenza: si rimuove, si dimentica, si seppellisce e non si ricorda.
Ma dentro di noi la perdita continua a lavorare, a scavare.
Stalattiti e stalagmiti crescono fantastiche e oscure, creano un nuovo sé: una persona che non riconosceremo, ma che porterà avanti la nostra vita.
Mentre una bambina rimasta sospesa nel tempo piange silenziosamente su quella tomba ancora calda, gli anni passeranno, invano.
Mio padre…
Era affascinante come un divo del cinema.
Alto e snello, elegante con qualsiasi cosa indossasse, anche col pigiama, ma di una bellezza discreta, trattenuta, riservata.
I capelli neri erano folti e robustissimi. Vivevano di vita propria e io questo l’ho ereditato da lui. Li portava alla Rodolfo Valentino, tirati da parte con la brillantina, e ne doveva
usare parecchia perché la loro indole ribelle era restia a piegarsi.
Quando si asciugava i capelli in bagno col phon, io andavo sempre a guardarlo, perché
alla fine dell’operazione gli stavano dritti ed
era come se avesse una criniera leonina intensamente scura.
D’estate però se li tagliava a spazzola, perché amava molto nuotare.
Il suo sorriso era spontaneo ma leggero e un poco triste, le labbra sottili e ben disegnate, il mento piccolo con la fossetta.
Gli occhi scurissimi e lucidi erano acuti e malinconici.
Tutta la sua persona era attraente ma
qualcosa in lui lo rendeva degno di rispetto, fino a incutere soggezione.
Era come se mettesse sempre una certa distanza tra se stesso e gli altri, anche se era sempre cordiale e gentile, misurato e ben educato.
Quando rimase orfano di entrambi i genitori, andò a vivere con la sorella più piccola da uno zio paterno.
Aveva diciotto anni e suo padre e sua madre se ne andarono a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, portati via tutti e due da un tumore ed avevano entrambi, nel giorno della loro
scomparsa, 49 anni.
Dopo il diploma in ragioneria frequentò per tre anni la facoltà di Economia e commercio a Bologna, ma la guerra interruppe i suoi studi e gli impedì di conseguire la
laurea.
Fu arruolato, naturalmente, ma non andò mai al fronte; lui si definiva un imboscato: sicuramente lo aiutò il fatto che suo padre fosse stato un gerarca fascista.
Per l’intera durata del conflitto rimase a Napoli, a sbrigare scartoffie al Castel dell'Ovo.
Dopo l’armistizio del 8 settembre, abbandonò la divisa e venne a «sfollare», come si diceva allora dalle parti nostre, sulle colline vicine a casa, in una serie di grotte naturali, dove
rimase per diversi mesi fino alla Liberazione.
Lì conobbe mia madre. Si sposarono poco tempo dopo la fine della guerra.
Lavorò tutta la vita come impiegato di concetto per il comune della nostra città.
Era ordinato e molto preciso, addirittura pignolo, pulito e metodico, abitudinario. Tornava dal lavoro e sebbene avesse molti amici di gioventù che lo ricercavano assiduamente, non andava
al bar o a passeggio per il centro o la piazza ma, riposti l’abito scuro impiegatizio e la cravatta, indossate la vestaglia da camera e le pantofole, si sedeva sulla sua poltrona e si dedicava
alla vita famigliare.
Con gli amici usciva insieme a mia madre, dato che erano tutte coppie sposate e a turno si trovavano nei rispettivi alloggi per i loro raduni. Ma a casa nostra non veniva mai
nessuno.
Amava il comfort e le comodità casalinghe. Quando, dopo tanti sacrifici, riuscì a costruire il condominio che ancora porta il suo nome sulla vecchia casa di famiglia e finalmente ci
trasferimmo nel comodo appartamento con riscaldamento e doppi servizi di cui uno con vasca da bagno, realizzò uno dei più grandi sogni della sua vita.
Era «ammalato di mattone», come si dice da noi e investì l’intero suo patrimonio in quel progetto, diventando talmente parsimonioso da privarsi praticamente di tutto. E tenendo a stecchetto
anche noi.
Non che ci sia mai mancato niente, anzi: il cibo (sorvolando sul problema della mia pinguedine) era sempre di prima qualità e abbondante, ma certamente lo spreco non era nei suoi
geni.
Era comunque assai goloso. A colazione versava nove cucchiaini di zucchero nella tazzona di latte e caffè, che consumava in cucina prima di uscire per il lavoro, inzuppandoci il pane
avanzato il giorno prima, che era ancora più buono.
E la domenica mattina si entrava insieme nella sua pasticceria preferita ad acquistare un cabaret di paste per festeggiare il giorno di riposo: le sceglievamo io e lui, con complice
allegria, indicando con il dito oltre la limpida vetrina, una dopo l'altra, quelle di nostra scelta e scambiandoci occhiate di cameratismo...
Ma questo solo dopo che il palazzo fu terminato e pagato. Prima di ciò il dolce domenicale consisteva in una generosa porzione di crema pasticcera che mia madre
cucinava di buon’ora in modo che si raffreddasse, a volte nella variante «zuppa inglese» o con l’aggiunta di fragole e panna nel mese di maggio.
Era talmente squisito il piacere che lui attingeva dai dolci e l’importanza che attribuiva a questi riti famigliari, di compenso nel giorno del riposo, di gratificazione e riconoscimento
per tutto l’impegno profuso, che io tuttora vivo le medesime sensazioni e per tutta la vita ho cercato nei dolciumi quello che avevo perso e che man mano perdevo.
Un cioccolatino, per me, è stata è e saràuna carezza di mio padre.
Amava anche le innovazioni tecnologiche.
Fu tra i primi nella nostra città ad acquistare il televisore, che all’epoca offriva un unico canale ed era un ingombrante cassone metallico verniciato di verde scuro, poggiato su di un
alto trespolo a quattro gambe.
La lavatrice e il frigorifero io me li ricordo
da sempre, con la scritta REX dorata e a forma di corona che luccicava sulla superficie laccata di bianco.
Quando avevo otto anni acquistò la sua prima automobile.
Era una Fiat seicento, di colore azzurrino,
con le portiere che si aprivano controvento. Veniva da Torino ed era stata usata pochi mesi da un operaio della fabbrica costruttrice, per cui acquistarla costava molto di meno. Era molto
fiero della sua auto e metteva sempre anche un po’ di benzina super, oltre a quella normale che le sarebbe bastata sicuramente, tanto per darle tutto quello che pensava si meritasse. La teneva
pulita e in perfetto ordine. E non le fece mai il più piccolo scortico o bozzetto.
La domenica, poi, era il giorno della gita in macchina. Caricata tutta la famiglia, con il cestino delle vivande che mia madre preparava il giorno prima sfornellando in cucina tutto il
pomeriggio, ci portava a visitare i luoghi non troppo lontani della nostra terra.
San Marino, Gradara, Pomposa, Gabicce, Milano Marittima, la pineta di Pinarella.
Molto spesso andavamo al mare anche d’inverno, a camminare sulla battigia e a raccogliere conchiglie.
D’estate ci recavamo sul monte Fumaiolo o a Camaldoli, nelle antiche e fresche foreste, per sfuggire un po’ all’afa della pianura.
I picnic erano allegri e i piatti che mia madre preparava erano apprezzati da tutti gli ospiti.
Io ero felice.
La libertà di correre e giocare tra i prati o in riva al mare mi galvanizzava, e non mi fermavo un attimo.
Sia che avessi altri bambini con cui giocare, i miei cugini per esempio, oppure che fossi da sola.
Amavo guardare fuori dal finestrino i campi e le colline che si snodavano al nostro passaggio.
Mi perdevo oltre l’infinito che si apriva al mio sguardo abituato al piccolo orizzonte che mi offriva il cortile dietro casa.
In riva al mare mi protendevo verso l’ignoto.
In viaggio cantavamo sempre delle canzoni,
io e il babbo, oppure con i cugini, a volte con mio fratello.
Erano canzoncine ingenue e ripetitive oppure
erano i motivi in voga quando lui era giovane e durante ogni gita le ripercorrevamo con scrupolo fino allo sfinimento degli altri ospiti.
Ce n’era una, poi, La pecora nel bosco, che si poteva cantare all’infinito, perché non aveva una conclusione e ci perdevamo in questo gioco innocente, in barba a chi protestava stanco delle
nostre voci insistenti.
A volte, si tornava a notte fonda e io mi
sdraiavo, finalmente zittita, sul sedile posteriore e guardavo il cielo.
La luna seguiva ostinatamente il nostro viaggio. Sembrava proprio che non volesse
lasciarci e che ci proteggesse, illuminando la strada verso casa con la sua luce intima e discreta.
La luna e la ferma mano del babbo che teneva il volante, silenzioso e tranquillo, erano la certezza del ritorno a casa, la certezza della continuità.
Io gli piacevo, perché ero molto diversa da lui, che era taciturno.
Mio padre amava il mio instancabile chiacchiericcio.
Io sapevo l’ora del suo ritorno dall’ufficio, come un cagnolino fedele e lo aspettavo all’ingresso della stradina, dove parcheggiava la sua automobile, per salutarlo
ed abbracciarlo.
Lui non rifuggiva il contatto fisico, anzi, mi cercava sempre con il suo braccio o
con la mano.
Non mi dava molti baci, solo prima di
andare a letto.
Ma le sue carezze erano leggere e rassicuranti, il suo cingermi le spalle e attirarmi a sé, contro la sua anca, mi rincuorava.
La sera, dopo cena, sedevamo davanti alla tv per guardare i programmi.
Nella sala da pranzo c’erano due grandi poltrone a grosse righe verde scuro e chiaro con alti schienali e braccioli imbottiti, che mamma aveva rivestito di copertine di cotone grosso e
lucido color rosa antico, perché non si sciupassero.
Una era per lei, l’altra, quella di sinistra, per il babbo.
Lei non sempre si fermava per godere della televisione, assillata dall’esigenza di tenere la casa in ordine e perfettamente pulita come piaceva a loro. Inoltre dedicava molto
tempo alla cucina e ai lavori a maglia e all’uncinetto, confezionando golf e pullover, borse e pantofole, centrini e tende non solo per noi ma anche per i parenti e i
conoscenti.
Ma per me e il babbo, l’appuntamento serale era sacro.
Io sedevo su seggiolina di legno ricavata adattando il mio seggiolone dell’infanzia, al quale erano state segate le gambe e tolto il tavolino pieghevole. Erano tempi, quelli, in cui non si
gettava nulla e tutto veniva giustamente riciclato, adattato.
La mettevo lì, sulla sinistra, vicino alle lunghe gambe del babbo, che lui teneva compostamente accavallate, quasi a sfiorarle, in modo tale da potermi appoggiare a lui.
Guardavamo il telegiornale, che mi annoiava molto, perché in parte non lo comprendevo e in parte era davvero tetro:
ma lo sopportavo con malcelata impazienza,
pregustando il seguito dello spettacolo. Infatti, poi, avrebbero mandato in onda Carosello, una trasmissione molto famosa, interamente composta di reclame pubblicitarie.
Non c’era sera che io non la guardassi e
sapevo a memoria tutte le canzoncine, le filastrocche e le frasette stupide e accattivanti degli articoli pubblicizzati.
Era un incanto e una giostra, anche se in bianco e nero. Ma durava dieci minuti.
Purtroppo, quando c’era la scuola, finito Carosello bisognava andare tutti a nanna - lo dicevano anche alla tv con uno slogan reiterato che era entrato nelle bocche di tutti - e io a
malincuore andavo a letto,
anche se poi non dormivo subito, ma leggevo fino a tardi.
D’estate invece o il sabato, potevo stare alzata e guardare il programma della prima serata.
Studio Uno e le gemelle Kessler, con le loro lunghe gambe eleganti che al babbo - e a me - piacevano tanto; il mingherlino e bizzarro Don Lurio, che si esibiva in
balletti moderni, per allora… Raffaele Pisu, Walter Chiari, Mina, Alberto Lupo, Delia Scala, Gino Bramieri, che raccontava barzellette; Alighiero Noschese, con le sue
imitazioni.
La neotelevisione che era ancora intelligente e piaceva a tutti.
Ascoltavo i commenti del babbo e mi sembravano giusti, a volte geniali. Mi sembrava che desse le parole ai miei pensieri.
Poi c’era la boxe. Nonostante l’ora tarda, papà mi permetteva di guardare gli incontri del sabato sera, anche se mamma brontolava che non era uno spettacolo da bambine.
Benvenuti, Griffith, Muhammad Ali. Lui si infervorava e mi spiegava le particolarità tecniche dei colpi e dei diversi stili.
Ammiravamo la forza e la potenza, il coraggio e la resistenza, l’abnegazione.
Egli mi raccontava la storia di quegli uomini che si guadagnavano da vivere dando e prendendo pugni.
Io sentivo il loro sudore e il loro sangue su di me.
E quando il nostro campione per caso perdeva eravamo molto tristi, ma lodavamo lo stesso lo sforzo e l’impegno che lui ci aveva messo e ci chiedevamo quanto male
gli avesse fatto quel pugno che lo aveva mandato al tappeto.
Pensa, babbo, quanto ti sarebbe piaciuto adesso il pugilato in tv, a colori, con il ralenti e il replay…
A novembre del 1965 papà fu colto da forti coliche renali scatenate dall’accumulo di renella. Fu ricoverato d’urgenza, con nostro grande sgomento, ma lo dimisero presto, con una prognosi
falsamente rassicurante… A marzo era spacciato.
Mia madre ottenne per lui un posto letto all’ospedale universitario di Parma e gli rimase accanto fino all’ultimo giorno.
Io e mio fratello fummo sistemati presso due zie diverse.
Nessuno mi disse che papà stava morendo.
Durante quell’estate ebbi le mie prime mestruazioni.
Sapevo cosa mi stava accadendo, perché mio padre durante l’inverno, vedendo che il momento si stava avvicinando, mi aveva parlato e mi aveva preparato all’evento, ma io non trovai il
coraggio di chiedere degli assorbenti a mia zia.
Nascosi così le mutandine sporche nel fondo del mio cassetto. Un giorno, quando rincasai dopo il mare, la zia mi redarguì aspramente davanti a mio fratello e ai miei cugini. Seguendo il
cattivo odore che emanava, aveva scoperto il mio segreto.
Quel giorno provai la più intensa vergogna della mia vita, non riuscendo neppure a piangere.
Mi rintanai in un angolo, scura in volto e rimasi per molto tempo nascosta, in preda a un senso di disperata solitudine.
Una volta durante quei mesi che mi sembrarono lunghissimi, assillati dalle mie continue richieste, mi portarono a trovare mio padre in ospedale.
Fu la mia zia prediletta ad accompagnarmi. Io ero allegra e ciarliera, felice di rivedere il mio babbo in una città rinomata come Parma.
Arrivati in ospedale, dopo aver percorso lugnhi corridoi bianchi che emanavano un forte odore di disinfettante e medicinali, arrivammo alla sua camera.
Lui era molto pallido, seduto sul letto. Magro da fare spavento.
Invece mia madre, sembrava stesse benissimo, mentre poi si seppe che era gonfia dal tanto stare seduta di una sedia al suo capezzale, giorno e notte.
Mi aspettavo un sacco di feste dal mio babbo, ero sicura che mi avrebbe parlato per tutto il tempo.
Invece non fece altro che scherzare con mia zia.
Mi rivolse a malapena la parola. E io ci rimasi molto male.
Solo ora posso capire quanto il suo cuore si stringesse al vedermi, al sapere che stava per morire e mi avrebbe dovuto lasciare, ma allora di certo non o potevo immaginare.
In agosto lo riportarono nella nostra città. Io rientrai dal mare e fui sistemata dalla solita zia. Lo andavo a trovare spesso. Però ancora non avevo capito che stava morendo. Domenica 28
agosto gli chiesi se voleva fare la comunione con me e lui, contrariamente la suo solito, - che quello era un motivo di dissidio tra noi, dato che sempre io gli chiedevo di venire a messa con me
ma lui si rifiutava dicendo che amava dio, ma non i preti, - quel giorno mi rispose di sì.
Così il cappellano della casa di cura ci comunicò entrambi e pregammo insieme. Ma lui era debolissimo.
Fu l’ultima volta che lo vidi.
Si spense alle sei del mattino seguente.
Io mi alzai quel giorno, in preda ad una tristezza che mi soffocava la gola.
Mi sedetti sul letto e poi rimasi lì, con le gambe penzoloni, stranita.
Fu allora che sentii mia zia e mio cugino parlottare, ma subito non capii cosa stessero dicendo.
L’allora mi diressi in cucina dove loro stavano facendo colazione: l'atmosfera era tesa e le loro espressioni erano strane.
Mi diressi con lo sguardo verso mia zia, interrogandola con gli occhi.
Lei mi cinse le spalle con un braccio e mi disse che il babbo stava molto male.
Mio cugino, che era più piccolo di me, allora sbottò:
Ma non mi avevi detto che era morto??
Così lo seppi.
Il pomeriggio mia zia mi accompagnò in un negozio a comprare una gonna blu con un golfino del medesimo colore per il funerale,
spiegando che avevo appena perso mio padre.
Il commesso mormorò:
— Poverina…
Io mi sentivo come galleggiare.
Al funerale c’era tantissima gente. Pioveva. Corone di fiori, mazzi e cuscini, una lunga fila di persone dal viso triste, alcuni piangevano.
Rividi mia madre e mio fratello.
Lei mi appoggiò un braccio sulla spalla ma non disse una parola.
Mio fratello sembrava una statua di
sale.
Loro non piangevano e io neppure.
Quando calarono la bara scura a lucida nell’apertura posteriore della tomba di famiglia, io pensai che sicuramente c’erano dei ragni, di cui avevo il terrore, e tanto buio, che altrettanto
temevo.
E mi misi a piangere.
Non ricordo chi mi strinse una mano sulla spalla.
Ma non fu mia madre. Lei era annientata. Pensai che mio padre sarebbe stato lì per sempre, al buio e con i ragni.
Tornammo a casa, dopo mesi.
Ora so che lui era il cuore della nostra casa e della mia infanzia.
La nostra famiglia era finita. Sepolta con lui, al buio e con i ragni.
La perdita…

CAPITOLO
SETTIMO
Le formiche
La sofferenza del mondo chiusa dentro il mio cuore.
Spinge e tira. Graffia.
Pesa come il peccato originale.
È scomoda come un vestito troppo stretto, fa male come un sasso in una scarpa: insistente, non la puoi dimenticare.
È un sottofondo.
Ti ruba la tua felicità.
La vedi negli occhi dell’amico, del cane abbandonato.
Dell’ammalato, del bambino denutrito, del soldato in guerra.
Del gabbiano annegato nel petrolio.
Del bosco che brucia.
Tutta la sofferenza del mondo arde nel mio cuore e lo invade di tristezza.
Quando arriva dentro casa, poi, nella tua famiglia, ti afferra alla gola.
Gli occhi di tuo figlio che soffre sono un’accusa: È colpa tua.
Urlata sottovoce, scandita dai giorni e dagli insuccessi, sottolineata dalle sconfitte. Quando è tuo marito che soffre: è colpa tua.
Ti interroghi, sveglia nel buio, sul perché delle carezze smesse, dei baci dimenticati.
Ti manca ogni sorriso attorno alla tavola apparecchiata.
Ogni piccolo antico scherzo.
È colpa tua che non hai saputo, non hai capito, non hai potuto, non hai voluto.
E il tuo sangue si mescola con le tue lacrime.
Ma il calice non è mai colmo.
La bestia che vive dei tuoi sensi di colpa è vorace come un orso appena risvegliato dal letargo.
È crudele come un’infezione di cancrena, che sembra non poter guarire, che vive della tua carne fradicia, che gode del tuo dolore muto, che scava come una lama nelle tue
viscere.
Un giorno ti svegli che non hai più meriti, ma solo colpe, che hai solo fallito, che sei inutile, dannosa, che ovunque guardi vedi e generi dolore.
Ti svegli ancora una volta, il tuo cuore batte, ma sei morta.
Ed è l’unica cosa che ti resta da fare. L’ultima, la più giusta.
Giocavo con i maschi.
Scorribande in bicicletta per le vie della città, allora sgombre dal traffico, larghe e assolate.
Partite interminabili di pallone, nelle quali io stavo in porta, nel campetto senza rete del parco dietro la palestra in stile littoriano, dove le locali squadre di pallavolo e
pallacanestro maschili si sfidavano in campionati di infima serie, accompagnate dal nostro sparuto ma convintissimo tifo.
Dietro il condominio, sorto sulle ceneri della vecchia casa, correva una viuzza privata, soprannominata ' la stradina ': era il mio regno.
Finito di pranzare, subito correvo fuori.
La strada mi chiamava.
Contro il muro che divideva i due cortili, trascorrevo ore intere in assoli con la palla, o in giochi di figurine e biglie con i ragazzini delle case intorno.
D’inverno si modellavano igloo e pupazzi.
Nel bordo di un muretto che correva lungo la discesa dei garage, c’era un fazzoletto di terra con un po’ d’erba e qualche vaso.
Lì avevo scoperto un formicaio.
Un piccolo nido di formicuzze nere che scendeva lungo una sottile crepa tra il cemento e la terra.
Restavo ore a guardare le delicate bestiole affaccendate nella loro organizzata e industriosa esistenza.
Portavo briciole della mia merenda e seguivo
le operazioni di smaltimento lungo i loro segreti magazzini interni, immaginando inesistenti voci e richiami.
Un bimbo più piccolo di me che abitava al quinto piano scoprì il mio appassionato interesse e un giorno distrusse il formicaio, per sfregio, per il semplice gusto di farmi
soffrire.
Quando arrivai all’appuntamento quotidiano con le mie amiche e trovai solo lutti e devastazioni, rimasi impietrita.
Cadaveri ovunque.
L’ingresso ordinato e quasi invisibile della casa sotterranea era ora una buca e un cumulo di terra smossa.
Tutto distrutto.
Mi invase una collera violenta.
Piangendo e urlando corsi a cercare il malcapitato autore dello sterminio e trovatolo poco lontano, del tutto impreparato alla mia reazione, lo picchiai selvaggiamente.
Gli feci male, tanto che fu costretto a letto qualche giorno. Ma era un monello avvezzo a mettersi nei pasticci e non rivelò mai chi l’aveva ridotto in quel modo.
Così non fui rimproverata da nessuno.
Ritornai piangendo e tremando di rabbia al mio formicaio e rimasi a lungo a singhiozzare con la testa tra le mani.
In giro non c’era nessuno.
Ma a un certo punto vidi una formica far capolino tra le macerie del suo palazzo e poi, guardando meglio, asciugandomi gli occhi con il dorso delle mani sporche di terra, un’altra e
un’altra ancora.
Le superstiti non si stavano affatto disperando.
A due a due prendevano i cadaveri delle compagne morte e li portavano giù, trascinandoli a fatica, lungo i corridoi distrutti della loro casa.
Altre, invece, con un progetto a me sconosciuto ben chiaro nella piccola grande mente, spostavano o toglievano granelli di
terra e detriti.
Lavoravano alacremente, ma senza affanno, come comandate da un sereno e invisibile
capomastro che le istruiva su cosa dovevano fare e come e che infondeva loro forza e coraggio.
Presi allora un sottile bastoncino e cominciai ad aiutarle come potevo, avvicinando i cadaveri all’imboccatura del formicaio, per alleviare almeno un poco la loro fatica. Sminuzzavo
cautamente i grumi di terra più grossi, attenta a non provocare smottamenti lungo la voragine ancora aperta, in modo da facilitare la loro metodica e tenace opera
di ricostruzione.
Rimasi presso il nido distrutto fino che mia madre, spazientita, non mi chiamò per la cena.
Era quasi calata la notte.
Naturalmente la mattina dopo andai a scuola e solo il pomeriggio potei scendere a controllare la situazione.
Il lavoro eseguito dalle formiche era straordinario.
Non dico che tutto fosse tornato come prima, ma sicuramente l’ordine e la pace regnavano di nuovo nel formicaio silenzioso.
Guardavo i piccoli esseri con ammirazione.
Senza strepiti e pianti, avevano ritrovato la loro dignità.
Però, in fondo, non so perché, mi sembrava di sentire un sottile dolcissimo canto, come una tenue nenia funebre.
Tutto rimase tranquillo per diversi giorni e io alternavo i miei giochi chiassosi e spensierati alle visite quasi mistiche al formicaio.
Un giorno però, trovai tutto bruciato. Raso al suolo, come si suole dire, delenda Cartago come mi avevano insegnato a scuola.
Nessuna era sopravvissuta e una larga
chiazza di erba e terra annerita restò per moltissimo tempo a testimoniare la fine dell’Impero delle Formiche.
Non vi furono né lacrime né vendetta, questa volta, perché quel fuoco aveva bruciato anche un poco di me.
------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
OTTAVO
Lo squartatore di
bambole
Amavo mio fratello.
Più grande di me, era posato e tranquillo per quanto io ero scalmanata.
Io non stavo mai zitta, lui taceva, tenendosi tutto per sé.
Era ed è ancora, un genio in matematica. In quinta elementare giocava con i logaritmi che aveva scoperto e studiato da solo.
Per me due più due ha sempre fatto cinque, o tre, a seconda del mio stato d'animo.
Lui era uno scienziato.
Nella sua camera pezzi di vecchie radio con valvole e diodi: lui le smontava per poi farne di nuove che funzionavano, ma emettevano solo suoni da vecchie cornacchie
raffreddate.
Io mi affacciavo allo spiraglio della porta della sua camera e lo spiavo con occhi innamorati.
Lui, sembrava non si accorgesse neppure di me.
Quando nacqui ricominciò a bagnare il letto. Sicuramente per lui, coccolato e viziato, fu un duro colpo vedermi sortire fuori dal nulla.
Avrò avuto circa quattro anni quando mi regalarono una splendida bambola.
Di solito succedeva che i doni destinati a me non mi venissero consegnati, ma solo mostrati e poi messi via, perché altrimenti li avrei rovinati.
Quella volta tanto piansi e tanto insistei che
me la diedero.
Aveva il viso di bachelite e lunghi ricci di stoppia biondo cenere, un vestito rosso pieno di trine e un cappello di paglia con i nastri.
Le braccia e le gambe erano snodabili, aveva calze di cotone di un bianco immacolato e scarpette nere lucide.
Gli occhi, poi, orlati da ciglia bionde, si aprivano e chiudevano a seconda della posizione che le facevi assumere ed erano di un meraviglioso azzurro intenso.
La boccuccia era rosa e dischiusa in un sorriso che mostrava una perfetta fila di dentini bianchi.
Io amavo quella bimba dolce e aggraziata: era tutto quello che non ero io e me la stringevo teneramente al petto cantandole le canzoncine apprese dalla zia.
Una mattina tornando dalla scuola materna non trovai la mia bambina, che avevo lasciato adagiata nel mio letto.
La cercai disperata.
La ritrovai smembrata e appesa ai fili per stendere i panni, sotto la pergola.
Era stato mio fratello a tagliarla a pezzi e ad appenderla lì, in quel luogo dove lui sapeva io mi recavo spesso per giocare, perché la struttura della pergola era interamente rivestita da
un rampicante che aveva piccoli fiorellini bianchi che emanavano un profumo dolce e leggermente spezia, che mi piaceva moltissimo.
La vedo ancora. Tanti piccoli pezzi del mio cuore.
Nessuno gli disse niente, non so perché, nonostante io piangessi, disperata, lui non fu sgridato. Semplicemente i pezzi della mai bambola, vennero gettati via.
Ma io amavo mio fratello, e volevo dargli qualche bacio.
Lui mi respingeva fieramente, con una smorfia di plateale disgusto su quel suo viso
ben modellato.
Ogni anno però lui frequentava il campeggio in montagna col prete della parrocchia e stava via un mese.
Io tremavo dentro di me al pensiero di non vederlo per quel lungo periodo.
Così, la notte prima della partenza, aspettavo che tutti si fossero addormentati, dato che io mi addormentavo sempre dopo di tutti poiché leggevo a lungo ogni sera, e sgusciavo
silenziosamente nella sua camera,andando a posare delicatamente un bacio sulle sue guance, mentre lui, ignaro di tutto, seguitava a dormire.
Poi me ne tornavo nel mio letto.
E mi sentivo una ladra d’amore.
---------------------------------------------------------------------

CAPITOLO NONO
Topi, scorpioni e
ragni
Nella grande casa settecentesca dove sono nata, il giardino sul retro era ampio e popolato di fiori.
Iris violacei che erano chiamati le «scoregge del diavolo». Grandi margherite gialle. Bordature di trifoglio dai fiori violetti. Roseti profumati di ogni colore. Due svettanti palmizi di
coloniale memoria
e sedili di pietra levigata per stare all’ombra.
In fondo, la lavanderia coperta di edera e la casina.
Al piano terreno erano stati ricavati due appartamenti.
In uno viveva la famiglia di Massimo, il mio carissimo Massimo, che il padre, a cui mancava un braccio e che a noi incuteva un sacro terrore, picchiava ogni giorno con la cinghia e poi
chiudeva nella cantina scura. Massimo non piangeva più, ma io mi rannicchiavo vicino alla porta chiusa e gli
parlavo singhiozzando, perché non avesse paura.
Ma lui non aveva paura. Lui era coraggioso.
Quando le rose erano in fiore e il loro profumo nei caldi pomeriggi di maggio stordiva lievemente, mentre tutti dormivano, noi rubavamo dalla cantina due bottiglie vuote di vino, una per
uno, le riempivamo di petali strappati dai rami carichi dei roseti e vi versavamo un po’ di acqua azionando la pompa a braccio dipinta di rosso che cigolava sinistramente.
E poi, con i ferri da calza sottratti dal cestino da lavoro di mia madre, riducevamo in poltiglia quei petali profumati, traendone un fluido dolciastro e stucchevole che ci spruzzavamo
addosso come fosse Chanel numero 5.
Era il profumo della fantasia del nostro giardino.
Ma nella cantina c’erano ragni, scorpioni e topi. Io ne avevo paura.
La zia di mio padre, un’anziana maestra nubile che viveva in una vecchissima casa cadente all’inizio della medesima via, era zoppa.
Aveva avuto la poliomielite, ma a me qualcuno aveva raccontato che era rimasta così perché era stata punta da uno scorpione velenoso proprio nella nostra cantina.
Questo dava alle nostre discese laggiù il sapore di imprese pericolosissime e si facevano le scale di corsa, ben attenti a non toccare il muro.
Giacomino, il mio gatto, era il padrone incontrastato della cantina.
Di pelo rosso striato, gli era permesso qualche volta di entrare nella cucina annerita dal fumo del camino e con l’acquaio di pietra, per ricevere qualche avanzo dalla nostra
tavola.
Ma il suo cibo se lo doveva procacciare da solo.
Era un ottimo cacciatore di topi. Ma un giorno protestò, a modo suo.
Mia madre si toglieva le scarpe quando rientrava in casa e indossava un paio di ciabatte.
Le scarpe venivano riposte in un angolo del muro, tra la cucina e la porta della cantina. Un giorno che doveva uscire, come di consueto andò a indossarle.
Un urlo disumano ci scosse tutti.
Ci precipitammo da lei spaventati e la trovammo che osservava terrorizzata un topo morto che il gatto, da vero sadico, aveva deposto dentro una delle due scarpe. In segno di sdegno e di
dispregio.
Povero Giacomino!
Qualche tempo dopo, una notte, scivolò lungo l’orlo rotondo di pietra del pozzo dei vicini, che era aperto e senza coperchio e cadde nell’acqua gelata.
Era inverno.
Io dormivo nella mia camera, sotto la coperta coi Bambi e mi svegliai sentendo i suoi miagolii terrorizzati e disperati.
Corsi in camera di mamma e papà, piangendo, pregando e implorando per la salvezza del mio micio, ma mi risposero che tanto non c’era più niente da fare, mi rispedirono a letto e si rimisero
a dormire.
Io accompagnai con i miei singhiozzi la lunga e terribile agonia del mio amico…
Nella vecchia casa non c’era riscaldamento, né vasca da bagno, i pavimenti erano di pietra lucidata con la cera rossa.
Quando mia madre ci doveva lavare, una volta alla settimana, metteva un’ampia tinozza di latta davanti alla cucina economica con il fuoco prigioniero dentro anelli concentrici di
ghisa.
Stendeva delle lenzuola lungo alcune corde per ottenere un minimo di privacy, scaldava l’acqua sulla stufa e ci lavava e strofinava vigorosamente lì.
D’inverno faceva molto freddo e mio padre, che lo soffriva in maniera particolare, prima di andare a letto vestiva pesanti pigiami di lana e fustagno e si metteva in testa una lunga
papalina beige con un piccolo pon in fondo.
L’aveva confezionata mia madre con i ferri da calza, come tutta la maglieria che indossavamo.
Il nuovo appartamento sarebbe stato moderno e dotato di tutti i comfort.
Ma io ricordo ancora il vecchio portone pesante di legno scuro dietro alle nostre spalle…
Mentre il condominio era in costruzione, ci trasferimmo nella casa della vecchia prozia. Una dimora più cadente e scomoda della nostra, ma l’anziana signora stava per morire e aveva bisogno
di assistenza.
Era stata maestra elementare e aveva dedicato all’insegnamento tutta la sua vita. Si mormorava che da giovane fosse stata amata da un uomo misterioso: ma lui era emigrato in Africa e lei si
era rifiutata di seguirlo, rimanendo così zitella per tutta la vita.
Era una signorina brutta e taciturna, goffa e zoppa e con un gran naso.
Non si lasciò mai fotografare in vita sua e nella sua casa non c’erano specchi.
Sulla sua lapide figura unicamente il suo nome, senza nemmeno la data.
Io le facevo visita quotidianamente.
Aveva vecchi libri di testo del tempo fascista e quaderni dalla copertina nera, con i bordi delle pagine dipinti di rosso. C’erano anche cannucce e pennini per scrivere, lapis rossi e blu
per correggere i compiti, inchiostro nero in vecchie boccette incrostate.
Io le chiedevo di farmi fare i compiti e lei mi assegnava lavori da eseguire che poi correggeva coscienziosamente e ai quali dava il voto.
Tornava indietro ai suoi anni migliori tra i banchi.
A me piaceva fare i compiti che mi assegnava.
Lei mi prendeva molto sul serio e non si stancava delle mie chiacchiere.
Penso di avere reso un po’ meno tristi i suoi ultimi giorni di vita.
Se ne andò in fretta e ricordo che i miei fecero un inventario delle sue povere cose. A parte un po’ di fine biancheria ricamata e tela da lenzuola intessuta a mano, vestigia del suo
corredo mai terminato né sfruttato, le sue erano poche e semplici cose di tutti i giorni.
E pensare che era stata una donna ricca. Proprietaria di case e di un teatro in città, dato che suo padre era un imprenditore edile, ma il fratello, incallito donnaiolo, giocatore d’azzardo
e altrettanto fannullone impenitente, le aveva mangiato tutto il capitale, lasciandole solo la vecchia casa cadente nella quale aveva finito i suoi giorni.
Io chiesi in regalo le sue chincaglierie e nessuno trovò niente da dire.
Così continuai a frequentare le sue stanze ormai vuote.
Avevo steso una vecchia coperta imbottita per terra e recitavo il ruolo della padroncina di casa con le sue tazzine e i suoi piattini, scrivevo nei suoi quaderni neri e mi davo i voti da
sola.
Ho ancora un paio di quei quaderni, zeppi dei miei diari adolescenziali, in una vecchia scatola di legno, silenziosi ricordi di un silenzioso passato.
Di sopra non avevamo il gabinetto, per cui si utilizzava quello della zia di sotto.
Anche quel servizio era stato ricavato in un secondo tempo all’esterno della casa ed era coperto da una centenaria edera rampicante che nascondeva la facciata interna di tutta la
casa.
All’interno si trovavano un lavandino e un water.
Una sera scesi per fare la pipì, mi sedetti sulla tavoletta e alzando gli occhi vidi un enorme ragno nero che pendeva appeso al suo filo di bava sopra la mia testa.
Scappai su per le scale urlando in preda al terrore, senza neppure tirarmi su le mutandine.
Da quel giorno mi sono sempre recata in quel bagno aprendo per precauzione il mio ombrellino verde e sedendomi solo dopo una lunga e accurata ispezione…
--------------------------------------------------------------------
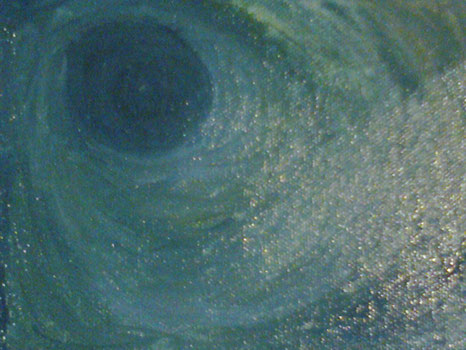
CAPITOLO
DECIMO
La pergamena
Il 18 marzo dell’anno scorso la Legge dall'universo è venuta a me.
E io oggi, ad un anno di distanza, non posso fare a meno di ricordare.
Ero in clinica psichiatrica e stavo molto male.
L'ennesimo ricovero e ancora nulla sembrava mi sollevasse dalla mia profondissima angoscia di vivere: né cure, né psichiatri, né psicologi.
Avevo perso il senso di tutto e non lo trovavo più da nessuna parte.
La disperazione aveva un unica idea nella mia mente.
Farla finita.
Passavo le ore nella mia stanza, in quella clinica moderna ed accogliente, dove, una volta tanto, a differenza del solito, eravamo trattati da esseri umani e non da mostri, ma ugualmente il
divario tra me e la mia vita, tra me e gli altri, il mondo, era nettissimo.
Le ore trascorrevano tra lacrime, rabbia, domane senza risposta, ricordi che mordevano il cuore come cani affamati ed un senso di irrisolto che sfumava e sgretolava ogni orlo, ogni bordo al
quale io cercassi di appigliarmi.
Quale futuro avrei avuto, ingabbiata tra medicine che mi facevano solo stare peggio e medici indagatori e distaccati e sguardi di rabbia dei miei famigliari?
Le ore passavano ed io pensavo solo: quando torno a casa, lo farò.
Ricoverata con me c’era una ragazza di Ravenna, Nadia, anche lei
malata di depressione.
Era una ragazza piccola, sui trent'anni, dai lunghi capelli scuri inanellati
Ma aveva nello sguardo una luce che mi colpì subito.
Era una luce profonda, che spiccava vivamente tra gli occhi dei ricoverati, spenti dagli psicofarmaci.
Tutti andavamo in giro per corridoi e sale della clinica con quello sguardo assente e doloroso, con gli occhi pesti e gonfi che erano il marchio inequivocabile: malato di
mente.
Parlando, Nadia mi disse di essere Buddhista.
A me la parola Buddhismo faceva venire in mente grandi statue panciute, ceri, incensi e monaci rasati che vivevano come asceti in monasteri sperduti tra le vette
himalaiane.
E lei non assomigliava per niente a questo stereotipo.
Le chiesi in cosa consistesse il suo essere buddista, come svolgesse la sua pratica religiosa,
Mi parlò allora di una frase, di una preghiera che, recitata, risolveva tutti i problemi.
La guardai un po' stupita un po' incredula, colpita ma già in difesa: la soluzione di tutti i miei immensi problemi in una frase?
Mi sembrava impossibile, eppure qualcosa mi impose di continuare a domandare.
Le chiesi allora perché, se aveva nelle mani un miracolo così grande, se aveva uno strumento così deflagrante e risolutivo, fosse lì.
Lei mi rispose parlandomi del karma, concetto che io già conoscevo, e questa spiegazione mi fu più consona.
Sapevo che il karma incarnava quella ruota del destino che dà alla vita umana una direzione alla quale non ci si può sottrarre fin quando il calice non è stato bevuto fino all'ultima
goccia.
Ma le sue affermazioni mi lasciavano perplessa.
— Come può una frase risolvere i problemi del mondo? — mi e le chiedevo, molto scettica.
Ma vedevo che lei ci credeva.
Questo mi fece entrare in una specie di lotta con me stessa, tra la mia razionalità, che escludeva a priori una sciocchezza così grande, e la mia voce interiore che stava dicendo: si, è
così.
Presi allora il mio quaderno, dove annotavo pensieri e poesie e mi feci scrivere quelle parole misteriose.
Naturalmente le conservo ancora: Nam-myoho-renge-kyo.
La ringraziai e mi accomiatai da lei.
Nadia se ne tornò nella sua stanza, io i chiusi nella mia.
Rimasi a pensare, sdraiata sul letto guardando il soffitto, provando a pronunciare quei suoni, che mi si inceppavano tra i denti.
L'ora era tarda e la sera aveva spento la luce del giorno. La notte, una ennesima notte insonne annegata nelle mie lacrime, mi stava attendendo con le sue dita ferine.
Fu come un lampo, una vampata di desiderio di quella dolcezza perduta che mi invase.
Mi alzai del letto e senza indugio bussai alla porta della sua camera: lei aprì sorridendo ed io le dissi a bruciapelo:
Nadia, voglio pregare. Fammi pregare con te.
Ricordo che mi guardò molto intensamente, senza però apparire stupita dalla mia richiesta, come conoscesse a fondo quello che io stavo vivendo in quel momento.
Trasse dalla sua borsa due librettini con la copertina rosso scuro e un piccolo oggetto bianco. Lo aprì e me lo mostrò.
Mi spiegò che si trattava del Gohonzon, l’Oggetto di culto e che avremmo pregato davanti ad esso.
Il suo era minuscolo, quello da viaggio, ma mi raccontò che ogni Buddhista ne conservava in casa uno di dimensioni maggiori.
Guardai quella piccola pergamena custodita in quella semplice piccola teca di plastica.
La sua bellezza mi avvolse, come sollevandomi tra le sue braccia e un amore immenso, inspiegabile, mi pervase in ogni fibra.
Non avevo mai provato nulla del genere.
Girai lo sguardo e fissai gli occhi di lei che mi osservavano come sospesa tra la gioia e la commozione.
Sentivo il battito del suo cuore sorridere sulle sue labbra.
Cominciammo allora a recitare il Daimoku, cioè la sequenza del mantra, lentamente ma subito le parole, che fino ad un attimo prima mi sembravano impronunciabili, si sciolsero nella mia
bocca.
Era una musica che entrava nelle mie cellule, nelle mie vene esauste e gonfie di veleni, che riempiva i miei pensieri ormai vuoti, allargandoli, distendendoli,
vivificandoli.
Le mie spalle stanche si raddrizzarono, gli occhi riacquistarono lucidità.
Le parole erano come miele e balsamo, era come se in ognuna di quelle lettere fosse celata una potente medicina che si scioglieva nella mia bocca per poi profondersi ovunque ed ovunque
riparare guasti, danni, suturare ferite, disinfettare cancrene che sembravano troppo avanzate, ormai, per essere guarite.
Cantammo il mantra per qualche minuto che mi sembrò immenso ma velocissimo, poi Nadia mi chiese se volevo provare a fare Gongyo, cioè a recitare i versi del Sutra del Loto – la bibbia dei
buddisti - che si leggono ogni mattino e sera.
Mi ammonì del fatto che mi sarebbe sembrato difficile, perché era cinese antico trasposto nei nostri fonemi e mi consigliò di seguire come avessi potuto.
Accettai con gioia. Il libretto mi urgeva tra le mani.
Quella preghiera sconosciuta era come avesse abbattuto una porta eretta in me da molti anni ormai, senza che io neppure me ne fossi resa conto.
Ma con suo grande stupore non trovai difficoltà a leggere quelle parole arcaiche.
Fu semplice ed immediato trovarne il ritmo e la pronuncia.
Mi appoggiai alla sua voce e cantai con lei: le nostre voci fuse inseme in un coro senza tempo.
Fu come ritrovare il cammino perduto, la strada di casa.
Da quel dì ogni giorno recitai regolarmente, intensamente e a lungo.
Mi alzavo la mattina con il desiderio di sedere di fronte alla mia vita disperata ed inondarla di quella grande bianca ineffabile luce. Cominciai a studiare la filosofia Buddhista e
leggendo quegli antichi comandamenti spirituali e morali sentii quelle parole aderire alle miei comandamenti interiori. Ad ogni concetto, ad ogni rivelazione io sentivo che già sapevo, che era
così che andavano le cose, che proprio così avveniva, che questo era accaduto.
Fu come trovare la chiave di volta e scrivere quella di violino alla quale le note sparpagliate e dissonanti dei miei confusi spartiti si andavano via via accordandosi.
I perché si scioglievano come neve al sole, trovando una collocazione che io sentivo completamente logica.
Misi un obiettivo davanti a me, da raggiungere tramite quella recitazione, dato che era nella mia vita che volevo vedere gli effetti di quella meravigliosa scelta. La cosa che mi premeva di
più in quel momento per me così difficile era uscire dal tunnel assurdo della malattia psichiatrica.
E la Legge mi diede la forza di arrivare a quello che mi sembrò dono immenso e immediato.
Aver ritrovato un senso alla creazione dell'universo intero e della mia vita mi aveva reso la speranza che avevo perduto.
A giugno non prendevo più nessun psicofarmaco, a settembre i valori del mio povero fegato, sull’orlo del collasso a causa dei troppi medicinali assunti, erano tornati normali.
Ho vissuto mesi di intensa gioia conoscendo persone meravigliose, ricominciando ad uscire di casa, ad andare in bicicletta, a portare a passeggiare i miei cani, a parlare a
scrivere.
Dopo alcuni mesi di intensa pratica e preparazione ho ricevuto il Gohonzon: quel giorno ho sentito che avevo messo un caposaldo nell'intera struttura della mia vita, come avessi coronato il
mio sogno.
Una persona come me, dopo un fatto del genere, dovrebbe dedicare l’intera sua giornata a portare il Buddhismo agli altri esseri umani e non pensare più ad altro.
Alcuni lo fanno.
Ma in me l’ego è prevaricante, i miei demoni personali sono agguerriti, i fantasmi del passato subdoli.
E il dolore è ancora fortemente invasivo nella mia vita.
Ma la strada è stata imboccata, ne sono certa, e la felicità ha ricominciato a visitare i miei giorni.
A un anno di distanza dentro di me si è profondamente affermato il valore assoluto della mia vita per quella che è: umana e imperfetta, e che non poggia più su nessun mattone, ma solo sulla
forza della Legge Mistica, quindi su di me.
Ho capito che se il Buddha che è in me ha deciso di scegliere questa
mia forma, con le mie idiosincrasie, le mie enormi contraddizioni, i miei tragici errori, vuol dire che è tramite quelli che io ho il compito di affermare la potenza e il valore della Legge
dell'universo.
Quindi io lo farò, ogni giorno, con le mie parole, le azioni, le preghiere e i pensieri, con la gratitudine, la mia umanità, con la mia felicità e il mio dolore, l'amore e la solitudine, la
luce e l'ombra, con le sconfitte e le vittorie.
Senza più sensi di colpa.
Ammettendo i miei errori e cercando di non ripeterli, ma conscia che
ognuno di noi è l’unico artefice della propria esistenza.
Il dolore del mondo ancora urla nella mia mente e nel mio cuore.
Il bisogno d'amore stringe il mio cuore senza tregua, ma adesso la speranza,la fede e la preghiera sono in me e so che daranno i loro frutti.
E che io sarò quel frutto.
...................................................................................................................

CAPITOLO
UNDICESIMO
Il pesce persico
E' notte fonda e sono qui: guardo il mare che fluttua in grandi onde lunghe e me,che sto seduta dove si frangono.
Guardo la ghiaia bagnata che disegna rivoli sempre nuovi sulle mie gambe.
Ascolto la voce potente dell’acqua contro la terra.
Ammiro il cielo che cambia colore nel crepuscolo e vira dolcemente
al rosa e poi al grigio-azzurro.
Sento il vento che suona la sua eterna sinfonia di note modulate e sincere.
La preghiera nasce nella mia gola.
Forte e salda.
Prego per una persona che non conosco, Elisa, l'amica di Dana, ma so che sta soffrendo. Prego perché sento che ha bisogno di me.
Tutto è scomparso.
Sull’ala del gabbiano che solca il vento prendendosi gioco della mia pesantezza, si avventura il mio sogno di staccarmi da una civiltà che non condivido.
I secoli non sono trascorsi.
Il tempo è chiuso nel mio corpo, nel mio ricordo. Io sono come allora, anche se più pura, più vera.
Non mi aspetto che ciò che faccio venga compreso né ricambiato.
Ed è un’ineffabile leggerezza.
Il mare dentro di me, io dentro il mare.
La mia voce scandisce attimi di eterna verità, gioia pura.
Dopo una giornata ventosa e di mare mosso, sotto una pioggia di goccioline salmastre, a notte inoltrata è scesa la calma.
La sconfinata distesa plumbea, appena tremula, mi ha richiamato verso il suo orlo argentato, col suo sussurro ora gentile ora roco.
Uno spicchio di luna giallo oro, basso sull’orizzonte, sembrava contemplarmi incuriosito, ma a ben vedere se ne stava adagiato sul fianco, proteso nell’ascesa verso la volta celeste,
indifferente alle
vicende umane, assorto nel suo slancio magnetico.
Le stelle invece, impossibili da contare, sciamavano sopra la mia testa come per salutarmi e, venendomi incontro, donavano infiniti piani di profondità alla volta tinta di blu
cobalto.
Dall’orizzonte si protendevano verso di me veli sottili di nuvole cineree, scure come la notte, ma appena più fumose, come per annunciare una giornata piovosa o per ricordare che il bel
tempo era in procinto di svanire.
L’acqua mi chiamava a sé, come una sirena.
I miei piedi e poi le gambe, restavano avvolte dalla fredda carezza delle onde leggere, che rifluivano sulla rena pullulante di minuscoli sassolini fluviali, frutto di millenni di
erosione.
La luce dei lampioni della strada vicina illuminava i riccioli e le spume bianche, frizzanti e brillanti contro la sagoma nera del litorale.
Il discreto canto delle onde era interrotto solo dalle grida di qualche gabbiano che, invisibile, solcava tranquillo le acque alla ricerca del suo pasto notturno.
Ed ecco che a un passo da me un guizzo argentato si inabissa, poi un altro e un altro ancora.
Piccoli dorsi di pesci che, giunti a riva per la stessa ragione che aveva richiamato il gabbiano, disturbati dai miei passi nella risacca, fuggivano da me, regalandomi scie luminose e
fosforescenti che disegnavano sul manto incurvato del mare placido preziosi quanto inaspettati ricami.
La loro fuga era un vivace concerto di luci che si accendevano repentine e misteriosamente si spegnevano, lasciandomi ogni volta più desiderosa di seguire quegli agili dorsi nei loro
percorsi segreti in fondo alle acque notturne.
Ma io, animale di terra, mi sono limitata a invidiare la loro agilità e a sognare la loro libertà.
Sulla via del ritorno, a pochi passi dalla riva, una luce mi ha scosso dalla mia meditazione.
Due uomini stavano apparecchiando tutto il necessario per la pesca con la canna ed erano pronti a gettare le loro lenze armate di esche, per catturare qualcuno dei miei amici
pesci.
Domani notte il mare sarà privato di molti dei loro guizzi argentati. Qualche dorso azzurrino giacerà rigido e donerà la propria vita
trasformandosi in cibo per noi umani.
Ogni creatura vivente possiede il proprio destino.
Stasera il mio pensiero va a coloro che ci nutrono con le loro
vite estinte…
E un ricordo risale alla memoria.
Quando i miei figli erano piccoli, d’estate, andavamo sempre a trovare Patrizia, una mia cara amica che viveva ai Castelli Romani. Allevatrice di cani e toelettatrice come me, Patrizia ha
più o meno la mia stessa età e le nostre storie sono molto simili.
La nostra amicizia nacque attorno ai ring delle esposizioni di razze canine pregiate e fu intensa, immediata.
Allora lei viveva col marito in una villa bellissima, dove ci invitava ogni anno a passare il ferragosto.
Rivederla e poter godere della sua compagnia, mentre i bambini liberi di giocare scorrazzavano nel magnifico parco perfettamente tenuto, era una vera festa per tutti.
Gli ospiti davano vita a pantagrueliche mangiate campagnole, accompagnate da abbondanti libagioni di quel vinello leggero e inebriante che è il bianco dei Castelli.
La mia vita allora aveva già imboccato la via senza ritorno del fallimento economico e professionale: il mio matrimonio stava rantolando, si trascinava tra illusioni, tentativi di
riavvicinamento e sofferenze acutissime.
Quella vacanza, anche se breve, era attesa da tutti noi, goduta attimo per attimo, come la famosa oasi nel deserto.
La regione dei Castelli Romani è alquanto pittoresca, costellata di laghi vulcanici, di paesoni pieni di vita e brulicanti di genuina umanità e, col suo territorio di dolci colli freschi
sempre rallegrati da brezze gentili e senza umidità, amalgama con la simpatia della gente le bellezze naturali, le vestigia storiche e le risorse gastronomiche.
Ogni giorno era una gita in un luogo diverso, per vedere e gustare.
Ma un appuntamento ricorrente era la spiaggia del lago di Castel Gandolfo.
Perfettamente circolare come tutti i laghi vulcanici, era un occhio azzurro che, girata l’ultima curva della strada che dalla casa della mia amica scendeva fin là, appariva all’improvviso
al tuo sguardo mozzandoti ogni volta il fiato per la meraviglia.
L’antico paesino era abbarbicato in alto sulla destra e il lato settentrionale era interamente ricoperto da un bel bosco verde brillante, lungo il quale si poteva fare una passeggiata a
piedi o in bicicletta costeggiando la riva.
La sponda opposta ospitava invece qualche spiaggetta di rena fine e
nerastra, alternata a macchie di vegetazione e qualche trattoria o piccolo negozio.
Nei giorni infrasettimanali non c’era mai molta gente.
L’acqua era calda e limpida, dolce e lievemente frizzante e dal fondo salivano piante acquatiche brunastre o giallastre, fitte di foglie e dolcemente dondolanti al moto lieve della
corrente. Infatti il lago ha una sorgente interna e un piccolo emissario.
Noi ci bagnavamo volentieri in quel sereno specchio senza onde e i bimbi potevano giocare tranquillamente perché la riva digradava dolcemente per parecchi metri prima di sprofondare nelle
altezze del cono vulcanico.
Io, invece, nuotavo verso il centro e mi godevo in solitudine l’acqua
più fredda.
Era come una conca battesimale.
Un giorno, alcuni bimbi che giocavano poco lontano da noi avevano catturato un pesce. Incuriosita, mi recai a vedere di cosa si trattasse.
Era un magnifico esemplare di pesce persico, con tutti i colori dell’iride sfumati sul suo corpo appiattito e ricoperto di scaglie lucenti.
Ma i bimbi a volte sono crudeli.
Per guardarlo meglio se lo bisticciavano l’un l’altro e lo tenevano fuori dal secchiello colmo d’acqua dove la povera creatura avrebbe avuto vita più lunga. Così, quando arrivai io,
sembrava già morto.
Mi colse una profonda tristezza e non potei fare a meno di redarguire i bimbi chiedendo loro il motivo di quella inutile crudeltà. Colpiti dalle mie parole, fuggirono via, senza più curarsi
della loro preda, che rimase abbandonata sulla sabbia.
Io mi chinai su quella creatura che racchiudeva tutti i colori del creato e restai stregata dai suoi occhi.
Non era ancora morta, ma stava agonizzando e sembrava fissarmi intensamente mentre gli ultimi palpiti di vita si spegnevano in lei.
Lo raccolsi senza indugio, delicatamente ed entrai in acqua fermandomi solo quando fui immersa fino alla cintola.
Adagiai nel suo ambiente naturale il piccolo animale lacustre che tristemente si lasciò andare su di un fianco. Nei suoi occhi io leggevo una domanda accorata: Aiutami.
Allora con le mani attorno a lui cominciai a far muovere l‘acqua in modo che più ossigeno raggiungesse le sue branchie ormai asciutte. Senza toccarlo troppo, perché le sue squame già
martoriate non si rovinassero ulteriormente, gli praticai con i polpastrelli dei piccoli massaggi circolari alla base del suo cranio e poi lungo tutto il suo dorso irrigidito, specialmente dove
sentivo ancora battere il suo minuscolo cuore.
Dopo un fremito quasi impercettibile, le sue membra cominciarono a recuperare elasticità. Le branchie ripresero a vibrare, la bocca si contrasse e si richiuse, per poi riaprirsi di
nuovo.
Lentamente, prima le pinne caudali, poi quelle laterali, infine quelle dorsali ritrovarono la loro mobilità e il piccolo corpo affusolato riacquistò la postura verticale.
Ora il respiro era lento ma quasi regolare. Le branchie erano tornate a irrorarsi di rosso sangue pulsante.
Dapprima incerto, poi sempre più sicuro e veloce, il pesce cominciò a nuotare attorno a me, solcando l’acqua in cerchi sempre più stretti, come se ancora cercasse il contatto con la mia
mano.
E i suoi occhi non si staccavano un istante dai miei, che erano colmi
di lacrime.
La danza d’addio del pesce persico, ritornato alla vita grazie alla mia tempestività, durò qualche minuto ancora.
I suoi movimenti erano insieme semplici e maestosi, i nostri cuori battevano al medesimo ritmo.
Poi, con una spinta della pinna, finalmente si accomiatò da me inabissandosi fra le onde.
Mi sembrò di cogliere nell’ultimo balenio dei suoi occhi tondi un qualcosa di molto simile a uno sguardo d’amore.
Tornai a riva e non seppi spiegare ai miei figli perché stessi piangendo.
----------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
DODICESIMO
Lacrime, sangue,
pioggia
Le lacrime sorgono da profondità che non conosciamo.
La sorgente della nostra vita sa a volte stillare queste piccole perle tiepide, che racchiudono segreti, silenzi, parole, domande, dubbi, risposte.
Attese svanite. Cose mai più ritrovate.
Possono scendere silenziose e composte oppure agitare il nostro corpo come uno scossone.
Piccole gocce dell’acqua delle nostre cellule, trasformano i nostri lineamenti, cambiano il nostro modo di sentire, ci fanno addormentare, esausti, ma più sereni.
Altre volte, ci scavano e ci rivoltano come un aratro nei campi in ottobre o ci ardono come il solleone d’agosto, consumando dentro di noi anche le ultime speranze.
Vorrei, amore mio, poter essere accanto a te ogni volta che piangi, per raccogliere le perle del tuo cuore.
Sanguino e mi sento impotente. Sanguino e non è colpa mia.
Non so trovare le parole. Né i toni della voce.
Lei galleggia nel suo dolore e neppure tutto il mio amore serve a riempire il vuoto di quella mente, lo sgomento di quel cuore che io sento come fosse il mio.
Come una morte lenta che la stia invadendo, paralizza anche me e quasi mi vergogno di essere qui a darle ciò che lei vorrebbe, ma non da me.
Sento l’ingiustizia di ogni amore rifiutato, la pena di ogni amore che finisce o viene ucciso e vedo nei suoi occhi l’agonia che, come un velo di ghiaccio, le stringe le labbra in una linea
sottile e le spegne il sorriso pieno di sole, cambia il colore della sua voce.
Vorrei essere tutto ciò che ama. Vorrei essere il dono che lei rappresenta per me. Vorrei che continuassimo a volare insieme.
E che la mia ala forte potesse sorreggerla, darle il coraggio di salire più in alto e di non guardare più in basso.
Io conosco l’amore.
L’amore che sazia. Che cambia il colore delle cose, che appaga i bisogni, che colma le lacune. Che riempie i giorni e accorcia le notti, accelera i respiri, trasfigura i volti, accende gli
occhi.
Io so inebriarmi della donna che amo.
So guardare il suo viso e coglierne la purezza e la perfezione.
So ascoltare il suo cuore e i suoi pensieri e confrontarli con i miei. So far tacere le mie emozioni e crearne delle nuove, appositamente per lei.
So far quadrare il cerchio di una vita difficile e trovare un senso nelle mie dure sofferenze.
So sorridere anche se dentro piango, so aver voglia di svegliarmi la mattina perché lei guarderà lo stesso sole che io guarderò.
So aspettare anche se non ho nessuna voglia di aspettare…
Ma la vittoria sul mio destino non è amare ed essere amata: ho imparato a non illudermi, ad accettare quello che ho e a esserne felice.
Anche se non è quello che vorrei.
Il ciclo di questa mia vita si chiude così.
Io conosco l’amore, ma l’amore non conosce me…
Io conosco la simbiosi di due persone.
La linfa di lei affluisce da radici sotterranee e invisibili nei miei gangli vitali. La mia aura si è fusa con la sua e la abbraccia senza mai abbandonarla, anche quando lei è
lontana.
Il mio tempo e il suo hanno un nuovo movimento, uno scandire plurale.
Quando entra nella mia piccola casa le ore diventano luminose. Quando si abbandona tra le mie braccia, le mie mani diventano raccoglitrici di frutti maturi.
Quando mi perdo sulle sue labbra abbraccio tutte le vie che ho percorso e che percorrerò.
Quando la sua voce pronuncia il mio nome è come se nascessi ogni volta.
Quando i suoi occhi vagano dentro i miei trovano tutti i mari che hanno attraversato e che la aspettano.
Da lontano sono venuta per trovarla e l’ho cercata ogni giorno e ogni notte.
Sapevo che c’era, che mi stava aspettando.
Ora l’ho trovata.
Se mi vorrà accanto a sé, io saprò accendere ogni giorno, saprò che avrò concluso la mia ricerca.
Io e lei siamo fatte dello stesso pane…
Piove da due giorni.
La mattina c’è il sole e fa caldo, ma nel pomeriggio, a un tratto, pesanti nuvole gravide di pioggia irrompono nel cielo e, fra tuoni, fulmini e vento, rovesciano scrosci d’acqua sulla
terra assetata.
Il mare è gonfio, da qui sento il canto delle onde e delle spume.
Ieri sera, all’imbrunire, è spiovuto e sono andata in spiaggia.
Il profilo delle montagne era avvolto in una luce arancio, luminosa e delicata e gli spruzzi riempivano l’aria rendendola frizzante e volubile, quasi palpabile.
Il mio cane correva galvanizzato in larghi cerchi, mentre io giocavo a non farmi acchiappare dall’onda bianca e spumosa.
Ma il cielo era profondo e il mormorio delle onde denso di potenza e di mistero, mescolato al soffio cupo del vento che sembrava ribadire la propria supremazia.
Mi sono sentita smarrita. Avrei avuto bisogno delle tue braccia attorno a me.
----------------------------------------------------------------------------------
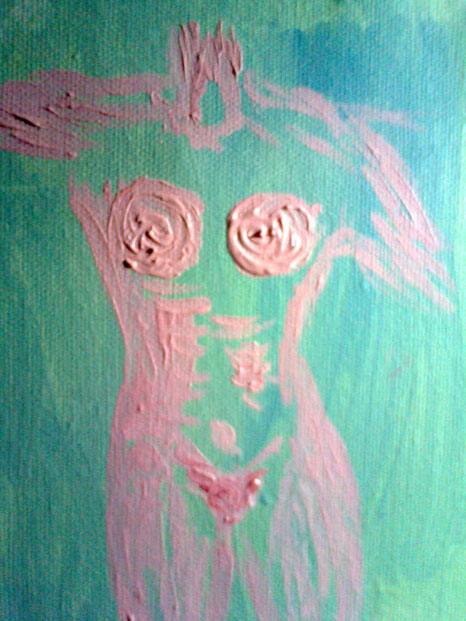
CAPITOLO
TREDICESIMO
Dialogo fra Amore
e Psiche
Oggi mi slaccio.
La mia mente vuole nuotare nella solitudine.
Non esiste nessuno in grado di offrire rifugio al mio dolore.
Le mie gigantesche aspettative uccidono ogni sentimento, il peso del mio passato incombe e mi schiaccia, i gorghi mi sommergono e con
me travolgono chi, incredulo, mi sta accanto.
Nessuno mi può capire né captare la voce del mio cuore solo e disperato, le sue urla, i suoi rantoli, le sue invocazioni silenziose.
I miei sorrisi sono bui come il vuoto, le mie risate sinistre come la pazzia che mi rode.
Nessuno può sopportare una cappa di tale sofferenza e non è giusto che io coinvolga altre persone in questo mio tortuoso e incomprensibile cammino.
Già troppi danni ho provocato.
Strada facendo la mia mano stritola, il mio abbraccio soffoca.
Ciò che chiedo non esiste, ciò che cerco non è stato ancora inventato: non esiste dentro di me né fuori di me.
Oggi stacco.
Vivrò dei miei pensieri e delle mie parole.
Pregando.
Non cercatemi.
È meglio per tutti che io stia sola.
Io sono bruciata, io sono terra arsa come sabbia del deserto, pietra dove il sole non scalfisce neppure una scintilla, dove non c’è acqua, dove non c’è luce, dove non c’è
suono.
Non cercherò più nulla dentro di me.
Lascerò galleggiare questo vuoto cosmico sulle mie paure, sulle mie incertezze.
Lascerò parlare queste folli lingue che sanno così bene districarsi nella mia mente instancabile, creatrice di mirabili castelli stregati. Lascerò il mondo dietro di me, insieme a una
realtà che non ho mai
sentita mia.
Ancora penso che io non sono di qui.
Ricordo che io sono di un luogo dove ci si parla col pensiero e ci si capisce guardandosi, dove i cuori hanno la supremazia sulle tasche e le mani non vengono tagliate.
Dove non esiste né uomo né donna.
Dove non c’è dimenticanza del passato e c’è conoscenza del futuro.
Io sono di un luogo dove l’amore siede alla tavola imbandita della gioia e mai viene rifiutato.
Io non sono di qui.
E non conosco questi luoghi alieni né so perché mi trovo qui.
So solo che la mia mente si è persa, che il mio cuore non riconosce cuore alcuno, che non ho mai visto mia madre, che ho perso mio padre.
E che la donna da me attesa tutta la vita non ha posto per me.
Ah! Quando verrà la morte avrà il mio nome.
Nome di pace e d’amore.
Di fratellanza, di appartenenza.
Requiem.
Ma questo amore che mi vince è commozione: supera le folli strutture della mia mente stranita e sa ancora sperare.
Sa soffrire e sa rinunciare, desidera, ma così forte che non osa chiedere.
Questo amore mi fa piangere lacrime calme e lente e singhiozza in silenzio come un bimbo spaventato.
Si abbandona, ha paura.
Continua e non si arrende perché trova il coraggio di parlare.
Si perde e si ritrova, sospira e sorride.
Fa ciò che non vorrebbe e non fa ciò che desidera spasmodicamente. Questo amore si vergogna e pensa a lei.
Pensa a sé e altro non sa se non di essere amore…
Ed è il suo nome che mi impedisce di dormire di notte, che mi fa alzare al mattino.
È lei che batte nel mio petto al posto del mio cuore…
È la lucida pazzia che mi divora e che mi mostra chiaramente tutti i tarli che mi rodono, tutte le buche nelle quali cado, tutte le volte che affogo.
Dove sbaglio, quando sbaglio, perché sbaglio.
Mentre continuo, imperturbabile, a sbagliare, a ripercorrere la stessa iniqua via dell’infelicità, della tristezza, del singulto soffocato dietro il sorriso mentre il motore imballato a
pieni giri corre, corre incontro alla morte, senza freni, senza sterzo, senza pilota, senza patente, senza istruzioni, a tutta velocità.
Sento i pensieri che si sgretolano, le connessioni che si fondono, le consequenzialità che saltano.
Da tempo ormai ciò che veramente importa più non importa e forse non è mai importato.
Questa mente intelligente, profonda, analitica, questa personalità gentile, accogliente e generosa, questo animo creativo, questo cuore amabile e altruista non ha prodotto altro che buio e
vuoto.
Tutti i me stessa hanno vissuto di illusioni: la realtà io non la conosco, non so dove vivo.
Quanto a lungo ancora dovrà durare questa agonia sottile e invisibile che i miei occhi celano e le mie labbra tacciono?
Sono contagiosa. Sono cancerogena. Triste sino al riso isterico.
Folle di gelosia.
Sola come l’unico essere vivente dell’universo…
Fa così male che non fa neppure male.
Una tranquillità di pietra sta colando dentro il mio cuore.
Taccio.
Aspetto ma fingo di non farlo.
La fine dell’ultimo amore della mia vita mi grava addosso inesorabile, una fine asciutta come la gola di un ubriaco rimasto senza vino. Gratta cupamente in fondo ai miei
pensieri.
È un rumore sordo.
Oggi la potenza del dolore mi sorregge. Domani?
Un sasso gettato dalle onde sulla riva mi chiederà un po’ di vita.
Una foglia caduta nel mio giardino mi chiederà un po’ di vita.
Gli occhi del mio cane mi chiederanno un po’ di vita.
Ma io avrò ancora un po’ di vita che scorre in queste vene inaridite
e indurite?
Oggi sono un pensiero inceppato.
Domani, un orologio fermo per sempre?
Dialogo tra la mia mente e il mio cuore:
Mente: — Ami quella donna?
Cuore: — Sì, profondamente.
Mente: — Pensi che sia la situazione migliore per te?
Cuore: — No.
Mente: — Allora perché ci stai?
Cuore: — Perché l’amo e non posso più tornare indietro.
Mente: — Cosa vuol dire amare?
Cuore: — Cercare la felicità di chi si ama.
Mente: — E poi?
Cuore: — Accettarla e apprezzarla per come è e non desiderare né pretendere che cambi.
Mente: — Lei è una persona onesta?
Cuore: — Sì.
Mente: — Ti ha promesso mai qualche cosa che non abbia poi mantenuto?
Cuore: — No.
Mente: — Ti ha illuso o ingannato in qualche maniera?
Cuore: — No, a illudermi ci penso da sola.
Mente: — Ti dona qualcosa di bello?
Cuore: — Sì, mi dona molto, quando è con me. Quando è tra le mie braccia io sono felice.
Mente: — Allora cosa vuoi di più? Perché ti lamenti? Cos’altro cerchi?
Cuore: — Vorrei che lei fosse solo mia, che stesse sempre con me.
Mente: — Ti ha mai detto che questo sarebbe stato possibile?
Cuore: — No.
Mente: — Tu hai detto che avresti accettato la situazione?
Cuore: — Sì.
Mente: — Allora sei sciocco, stupido e incomprensibile. E avido per di più.
Cuore: — Il problema è che mi sono di nuovo innamorato di una persona che non sa esprimere con le parole i suoi sentimenti, come da copione, che è come mia madre che ha saputo solo pensare
ai miei bisogni materiali mentre io ero affamata di affetto.
Mente: — Questo vuol dire che c’è qualcosa che devi imparare, che devi trasformare in te. Sei convinto che tua madre ti ami? Che questa donna ti ami?
Cuore: — Sì.
Mente: — Allora perché non sai e non puoi accettare il loro amore così com’è, così come loro possono dartelo? Perché, se non te lo dimostrano come tu desideri, pensi subito che non sia
amore? Sei tu
che sei insicuro, che non sai accettare le persone, che vuoi assolutamente che le cose vadano come vuoi tu, altrimenti sei infelice. Non sei capace di vedere e vivere il bello di ciò che
hai.
Cuore: — È vero, sono molto insicuro. E questo mi rende triste e ansioso, mi impedisce di vivere ciò che di bello mi viene donato. Imparerò ad accettare la realtà e le persone per quelle
che sono, e a vedere il lato positivo delle cose, cercherò di farlo con tutte le forze.
Mente: — Potresti sempre cercarti un’altra compagna, con una situazione meno complicata e un carattere più consono alle tue necessità.
Cuore: — No, io amo lei. Sono fuggita troppe volte. Il problema è dentro di me e finché non lo risolverò mi ritroverò nelle stesse situazioni. Quindi lasciarla e cercare un’altra donna
sarebbe l’ennesimo sbaglio. Poi penso che lei ne soffrirebbe e io non voglio farla soffrire. Io voglio essere felice insieme a lei e se sarà anche solo per qualche ora al mese saprò apprezzare
questa felicità. Ci sono persone che la felicità non sanno neppure dove sta di casa:
io la conosco e quando sono con lei la vivo. Devo imparare a non essere avida e a vivere pienamente tutta la mia vita, anche quando non sono con lei. La mia vita vale in quanto è terreno di
illuminazione e risveglio.
Mente e Cuore: — Questo lo abbiamo capito ma dentro di noi c’è ancora tanta disperazione che viene dal karma passato. C’è la speranza che impareremo a essere felici insieme a lei, ad amarla
e a farci amare nella maniera giusta. A vivere serenamente, con coraggio, soffrendo per quello per cui c’è da soffrire ma gioendo per ciò per cui c’è da gioire.
----------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
QUATTORDICESIMO
In rotta verso
l’ignoto
— Capitano, navighiamo insieme.
— Sì, tenente, senza di lei io sono perduto.
— Capitano, infuria una terribile tempesta. Ho paura.
— Io più di lei, tenente. Dato che sono il capitano, dovrei sapere sempre quello che c’è da fare, ma ora non lo so più. La burrasca è così furiosa, il vento urla così forte, le onde sono
così alte che la nostra nave sembra debba spaccarsi da un momento all’altro. Ho paura, tenente.
— Anch’io, capitano. Tenga forte il timone, io raccoglierò le vele. Coraggio.
— Non ce la faccio. Ma se abbandono faremo naufragio e anche lei naufragherà con me, tenente e forse moriremo. Ha paura di morire?
— Forse sì, forse no.
— Ma la nostra nave comunque andrà perduta: è una bella nave e io l’amo.
— Anch’io amo la nostra nave, è la mia casa, perché io non ne posseggo un’altra.
— Io pure non ho più nessun’altra casa che questa nave, se la perdessimo e pure scampassimo alla morte, avremmo comunque perso tutto. Tenente, io lotterò per salvare la nostra nave, ho
tanta paura, ma farò tacere la voce del terrore e ascolterò quella del coraggio e della speranza. Vado io a ritirare le vele. Lei, se vuole, tenga forte il timone.
— Sì, capitano, lo farò.
— Grazie, tenente e ricordi: se affonda lei, affonderò anch’io.
Sì, mio capitano.
All’orizzonte una tenue luce squarciava le tenebre della tempesta e segnava la rotta verso la salvezza.
--------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
QUINDICESIMO
Un cuore
pietrificato
La pietra grezza della mia mente ha lasciato intravedere una luce dalla gemma celata all’interno.
La cosa difficile era scorgerla, credere che veramente ci fosse mentre i pensieri si scontravano con la ruvida, scura e ineguale apparenza.
Nessuna nobiltà.
Una roccia severa e dura: il cuore che pulsava dentro era celato.
Ora che ho visto ciò che prima solamente teorizzavo, ma senza prove concrete, comincia il duro lavoro di cesello.
Ogni giorno una piccola parte della scorza verrà rimossa dalla mia
fiducia, dalla mia tenacia, dalla mia costanza.
Ogni momento, guardando la grossa pietra informe, scoprirò la forma nascosta che lentamente emerge alla luce e prevale sul disordine, sull’incostanza, sulla follia.
Ho trovato dentro di me la soluzione e la risposta, la strategia, la determinazione.
E sono stata sommersa d’amore.
L’amore che ho donato in quell’istante, quando ho sentito che il suo cuore aveva il diritto di riceverlo, è rifluito dentro di me come un’onda di dolcezza e ha placato tutte le mie
tristezze, cancellato tutte le mie solitudini, zittito tutte le mie lamentele.
Io ho quello che a lei serve.
Io posso essere quello che desidero.
Devo solo esserlo davvero e crederci, aprire gli occhi e vedere la luce che avvampa dentro di me.
Coglierne la purezza dentro la grezza materia umana e lavorare con fiducia e con speranza. Con gioia.
Perché il suo seno sorride tra le mie labbra mentre onde marine e spume scuotono il mio desiderio.
I suoi fianchi cantano tra le mie mani come rami frementi di vento.
La sua bocca fiorisce nel mio respiro un bosco di sussurri.
Il suo ventre esplode nella mia mente ed è fucina di estasi.
Il corpo vola.
I pensieri si mescolano e si colorano d’infinito.
Nell’amore mi perdo e mi ritrovo, mi scopro e mi conosco.
Nei tuoi sospiri ritmo il battito del mio cuore e il mio sangue percorre strade sconosciute.
Lavo le incertezze, nutro le speranze.
Vesto di nuvole i miei sogni.
Nell’amore per te si forgia la mia vita, si cambiai il mio passato, si costruisce il mio futuro.
E qualunque sarà la tua scelta, io avrò conosciuto l’estasi.
Quel regno per cui gli uomini vivono, quello stato per cui i poeti scrivono, quel luogo a cui tendevo e che ho finalmente raggiunto.
Finisse oggi la mia vita, potrei dire di averla spesa bene.
Se mi lascerai, io saprò piangere.
Saprò bere il calice amaro del mio destino, fino in fondo.
Saprò chinare la testa e lasciarti andare via, se andare via ti renderà felice.
Siederò in riva al mare e ascolterò il canto della sirena affievolirsi fino a spegnersi in lontananza.
E ancora una volta intonerò il mio canto dell’amore rifiutato. Dell’amore finito, che non potrà più tornare.
Passerò lo stretto pertugio della perdita ma cambierò il mio destino e tornerò a sorridere.
Non so come, non so quando. Ma lo farò.
Non sfiorirà la nuova vita nata in me, non morirà la vera speranza. Tra le lacrime saprò benedire il giorno della mia nascita e quello nel quale ti ho incontrato.
Apro la mia mano: sei libera.
Scegli la tua via: se vorrai tornare, mi troverai.
Ma se penso che ti perderò rabbia, sgomento, paura e senso di colpa, impotenza mi sommergono.
Si accende dentro di me un fuoco che smarrisce e non consuma, ma aumenta il buio della mente.
Tutto quanto è stato scritto nella nostra vita e allora vira, si veste di nero.
Ma la vita possiede la morte, l’inizio comincia dalla fine.
La gioia ha sapore nel dolore.
L’eternità si tinge di espedienti per sottolineare il tempo.
Per dare valore ai pieni si crea un vuoto, anche se solo la morte interiore è un vuoto reale.
Perdere la speranza è un vuoto reale. Non voler più amare, non saper più parlare con se stessi.
Ogni fine è gravida di un nuovo inizio: il sole sorge nella notte.
La legge che è scritta dentro di noi segue il suo corso, noi ne siamo manifestazioni pulsanti e nulla va mai perduto.
Solo tutto cambia, si trasforma.
Ogni giorno l’alba ci porta i colori dolci della speranza: anche domani sorgerà il sole.
Sperduta nelle mie tristezze, annegata nella mia solitudine, ogni volta che mi lascio possedere dall’estasi, essa possiede me e quando la perdo, io stessa mi perdo.
Ancora, penso e grido: la voglio ancora e ancora.
Non so dirmi altro.
Perdo così gli attimi della mia vita, gli altri fuori di essa, che non torneranno.
La mia mente si contorce, si arrovella, crea gorghi e forre inestricabili.
Mi frana addosso la mia pochezza, i continui fallimenti mi pungono come lunghe spine acuminate e non vedo altro che i miei errori.
Tutta la mia vita è un errore?
Nata per essere felice, sperimento profonde tristezze che nascono da me: io le creo e le partorisco, io sono matrice della mia solitudine e del mio scoramento.
Annego nel mio sangue.
La luce e l’ombra lottano inferocite nella mia gola, l’anelito di eternità si confonde coi miasmi putridi della decomposizione di tutte le mie speranze.
Vivere di nulla. Non attendere più nulla. Non aspettare più nulla.
È questa la vera gioia del saggio?
Dimenticare di essere umana, di avere fame, sete, sonno?
O lottare per i propri bisogni?
Non so mai quello che è giusto. Non faccio mai le scelte giuste, non arrivo mai alla meta.
Smarrita e dolente invoco pace per la mia mente, amore per il mio cuore, comprensione per il mio dolore.
Ma non sento altro che l’eco della mia voce.
Nella mia voce, dunque, è racchiusa la risposta?
Forse.
Oggi benedico le mie lacrime e anche il mio dolore che così forte mi scuote da far cadere ogni paravento, che sconvolge così a fondo la mia mente da mettere a nudo il cuore, e in esso
vedere quello che sono e cosa sono.
Quanto sono povera e nello stesso tempo così preziosa nella mia povertà, perché anche se tremo fin nel profondo sono salda nella
fede e nella speranza.
Pur in questo addio così crudele non cedo alle armi del mio nemico.
Se la sofferenza è vita, allora io vivo, vivo fino in fondo.
Imparando sopra ogni altra cosa il rispetto per me stessa.
Ma la lama che ho messo nel mio polso era più dolce dei tuoi occhi, stasera.
La lama che hai infisso nel mio cuore è profonda come la tua volontà.
La lama che vedo nella mia mente è acuta come i tuoi pensieri.
La lama che scopro nel mio destino è tagliente come le tue labbra.
Questo amore negato taglia a metà la mia vita.
La colpa è stata amare. Il prezzo è perdermi.
Il prezzo sono attimi che scivolano via.
Attimi della mia vita che sono un fuoco che consuma i respiri e i sogni, che brucia lacrime asciugate agli occhi insonni.
La sua pelle vibra nelle mie vene disseccate come uno schiocco di vento arido che scandisce un tempo allungato di agonie.
Vivo di grida acute e silenziose che graffiano l’oceano fino alle fosse.
La mia nuova vita è non aspettare, non sperare, non costruire, non organizzare, non viaggiare.
Il cuore batte.
Il respiro solleva il petto.
Tutto scorre e prima o poi finirà.
Se tu sei felice io lo sono.
Quando sei tra le mie braccia e voli, io volo.
Ho tanti debiti dal passato senza fine: in questa vita offro in pagamento a questi a chi vanta quei debiti attimi di estasi.
L’estasi è l’assaggio della perfezione: io ne sono veicolo, procuratrice, matrice.
Anelo alla pace di non aspettare, di sapere che non avrò, di aver visto a cosa serve questa mia vita.
Ma se con l'estasi ti dono gioia io stessa divento gioia.
----------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
SEDICESIMO
Un rosario di
silenzi e di ritorni
Desta nel cuore della notte che mi pulsa intorno.
Pensieri nomadi, senza casa.
Un buon vino, anestetico e rilassante, si scioglie in gola.
Niente sogni, nessuna illusione, nessuna aspettativa.
Non soffro più, la mia anima è muta, attonita.
Non una domanda, eppure vivo.
Un piccolo insetto della notte percorre la mia mano: io e lui possediamo in comune la stessa vita che ci freme dentro.
Esso ama? Io amo?
Di nuovo il tempo scorre, scivola, lo sento fuggire via piacevole. Ogni attimo è un compito portato a termine, un gravoso lavoro che non dovrò ripetere.
Benedetto tempo.
Saggio, che non ti fermi e non torni indietro: non potrei fermarmi su questa soglia.
Avanti. Avanti. Avanti… Cosa ormai posso temere, ora che ho perduto te?
Nulla.
Il mattino ruba la scena alla notte: ecco, viene anche oggi inesorabile, che tu voglia o no.
La luce lucida le onde marine, schiarisce il verde delle foglie, desta gli abitanti del cielo, scuote i camminatori della terra.
Sia luce.
Ma nel mio cuore oggi non si accende.
Il mio sole è spento. Per sempre.
Felicità: non aspettare la felicità.
La mente esplode carica e pesante.
Nuoti controcorrente, tutte le forze nei muscoli tesi.
A ogni bracciata guardi la riva, che è sempre più lontana.
L’acqua salata arde in bocca, l’aria rantola in gola.
Lasciarsi andare è l’unica soluzione, annegare sembra l’unica vittoria.
Conosco quel mare scuro e profondo.
Amore, non lasciare che avvolga anche te. Tu che sei un raggio di sole.
Io l'imploro e lei torna.
Il suo viso si era accende ancora una volta, il suo corpo si raccoglie dentro la mia mano.
Il suo cuore pulsa nella mia bocca.
Io sono l’universo che l’accoglie ed esplode, perché la mia mascolina femminilità incontra
la sua femminile mascolinità.
Ma poi..poi di nuovo fugge via da me.
E l’inutilità dell’amore campeggia color rosso fuoco in questa notte insonne, intessuta di assurdità.
Amo per distruggermi?
Amo, ma è come se una lunga picca acuminata mi mordesse le carni, come se un vento desolato spazzasse via la mia mente.
Non voglio più amare.
Alla bocca amica di una bottiglia, ultima donna mia, offrirò le labbra nel bacio che consola e lentamente uccide.
Ma di nuovo tu torni, di nuovo sei ancora mia.
Inesorabile la mia bocca ti vince, il tuo sospiro dolcissimo mi svuota. La mia mano apre i confini al vento, la tua pelle mi lancia lontanissimo.
Labbra sulle labbra, respiro nel respiro, mente nella mente.
Vita nella vita.
In te esisto. In me voli.
Così riapro la mia vita e spero, ancora spero: definitivamente spero. Non si è ancora asciugata la mia perenne corrente di lacrime.
Il perdono di vivere fiorisce sulle mie labbra, che sono un sorriso rivolto al cielo.
Che importa se non mi ami? Tu ami lei.
Per me questo non ha più significato.
Tu sei mia quando vieni nella mia casa, quando ti abbandoni a me, quando il tuo viso si trasforma ed è quello di un angelo, quando mi dici: «amore prendimi».
Quando ti sento fin dentro le viscere.
Quando le mie dita e la mia bocca sono una cosa sola con la tua carne calda e pulsante, quando il tempo si ferma, i rumori svaniscono, i miei pensieri si perdono nel tuo corpo per
ritrovarsi nel mio.
Questo importa, ora.
Quando ci apparteniamo, allora tu mi ami, tu sei mia.
Solo questo importa; io vivo per questo, io sono questo. Niente altro esiste più.
Solo tu dentro di me, io dentro di te.
Sento l’amore correre le vie del mio sangue: percorsi ripetuti, incalcolabili e sfumati.
Leggeri, tumultuosi.
Rapidi, silenziosi, urlanti.
Si comprimono, salgono e scendono.
Ogni colpo furioso del mio cuore manda il flusso di questa vita che è cassa di risonanza di te.
Tu, ancora tu, profondamente tu, infissa alla sorgente.
----------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
DICIASSETTESIMO
Partenza per la
Sicilia e ritorno.
Lettera alla donna che amo
Sei partita con lei, con Elisa, andate in Sicilia in vacanza per una settimana.
Ho invidiato Elisa perché ha sentito la tua voce, guardato nei tuoi occhi, respirato la stessa aria che respiravi tu.
Ha mangiato il tuo stesso cibo, la notte ha dormito accanto a te.
Ha potuto allungare semplicemente la mano e ha potuto toccarti.
E ogni mattina, tu sarai stata il primo dono che avrà ricevuto dal nuovo giorno.
Altre onde e sabbie straniere, echi sconosciuti ti hanno accolto.
Vele lontane.
Ci siamo separate, interrotte: tu sei andata, io rimasta in attesa.
I giorni sono stati pesanti, le notti inesauribili.
Il tempo era invischiato, mescolato di tristezze come fini grani di un rosario snocciolato di silenzi.
Mi sei mancata.
Il tempo si era allungato: così veloce tra le tue braccia e sulle tue labbra, poi è stato fermo e nemico come un demone senza volto, un perfido minatore che ha scavato nelle viscere della
mia anima.
Ed io sono stata come una conchiglia orfana sulla rena di sera.
Ma poi è passato, certo, a fatica, inzuppato delle mie lacrime, ma è trascorso.
Sei tornata a casa, finalmente, sei entrata di nuovo nella mia piccola casa a chiocciola, hai riempito di nuovo l'intorno di te e mi hai detto che vuoi stare ancora con me, si certo, lo
vuoi, ma non sai se e quando potrà continuare.
Elisa in viaggio ti ha detto che non lascerà il marito per andare a vivere con te, quindi dovrai decidere se continuare anche la storia d’amore con lei.
Il tuo sguardo era duro e preciso nel ribadire la certezza che quando verrà la fine del nostro rapporto, allora sarà un taglio netto e irrevocabile.
Io sono felice e disperata.
E ora ti scrivo con il cuore in mano e senza secondi fini, con sincerità e per amore.
Sapevo che durante questa tua vacanza e al ritorno tu avresti affrontato questioni importantissime della tua vita.
Sapevo che avresti tentato dei cambiamenti. Sapevo che rischiavo, come mai veramente fino ad ora, la perdita definitiva e irrimediabile.
So che rischio ancora e che questo sarà per sempre, perché tu non mi ami e quindi non hai bisogno di me.
So che puoi vivere anche senza di me.
Per questo sono stati così difficili per me questi giorni.
Fosse stata una semplice vacanza, anche con lei, non sarebbe stato così duro.
Ammetto che con quelle frasi che ti ho mandato nel messaggio telefonico l'altra sera, per la prima volta nella nostra storia ho desiderato farti soffrire, ho cercato di
ferirti.
Ho voluto che tu provassi almeno una minima parte del dolore che stavo provando io.
Sono stata inqualificabile.
Mi sono già scusata, per quel che può servire e lo faccio ancora, ma ero disperata e lo sono, al pensiero di perderti.
Non è colpa tua se non puoi amarmi, se ancora una volta il mio è un amarissimo destino, se sono una persona fragile e sofferente.
Io sola sono responsabile della mia vita e del mio destino.
Lo dico una volta per tutte, accada quel che accada: io ti amo e vivo per te.
Perderti sarebbe un dolore che non saprei come sostenere: sono nelle tue mani.
Se puoi stare con me, se ti dà qualcosa, se ti dà almeno un frammento della felicità che dà a me, ti prego, resta con me.
Se invece non puoi più, vai e non pensare più a me.
-----------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
DICIOTTESI
MO
Stelle remote
Dana è tornata da me e poi se ne è di nuovo fuggita.
E poi è ancora ritornata per poi di nuovo scappare.
Ogni giorno si allontana, mi allontana. Mi dice che è finita. Viene da me e facciamo l’amore come se fosse l’ultima volta.
Sento ancora la sua mano, profondamente, tra le mie gambe e dentro il mio cuore.
E non saprei dire dove stringe più forte e quale dolore è più dolce…
Lei è una statua marmorea abbandonata alle mie labbra, una dea etrusca da adorare.
Levigata, pura, perfetta nelle sue nobili forme tra le mie mani, sospesa tra il piacere e l’amore.
Io sono l’unica macchina di voluttà, io sono l’accordatrice del suo accorato strumento.
E vivo.
Poi esce da quel cancello fatto di canne e di rete ombreggiante per giardini.
Io la guardo allontanarsi mentre rivoli silenziosi di lacrime scendono senza fermarsi lungo le mie guance e penso che non ritornerà.
E muoio.
Mi rannicchio nel mio dolore, ascoltandolo, lasciando che mi sommerga.
Ma non passano che poche ore e lei ritorna, con una chiamata telefonica o un messaggio, oppure la ritrovo fuori dalla mia porta, col viso corrucciato e quel sorriso di granito che mi prende
nel cuore.
Ogni giorno scivoliamo lungo le ripide e scoscese pareti dell’addio e del ritrovarsi.
Non ho più una parte di me che non sia lacerata in questi diapason.
Voglio che il silenzio sia la sua immagine.
Il viaggio del mio grido non ha tempo né spazio né fine.
Nel silenzio ascolto la mia voce cantare di lei.
Il silenzio è corona purissima alla mia donna.
Quasi le tre della notte…
Ripenso alle nostre parole:
Dana: — Perché quando facevamo l’amore hai detto: perché mi fai questo?
Arianna: — Perché io finora non ho mai provato piacere nell’essere penetrata, posseduta. Mi sono sentita smarrita, persa in un mondo che non conoscevo: quello in cui si appartiene
totalmente a un’altra persona. Tu hai vinto il mio corpo reticente che non si è dato mai, ma ha sempre solo preso, imposto. Tu mi fai provare per la prima volta quello che io ho sempre fatto
provare agli altri, senza mai accondiscendere. Ho gettato ogni maschera e sono io, fragile, nelle tue mani. Colma d’amore e di desiderio, senza più pretese. Felice per la prima volta di quello
che ho.
Dana: — Notte, Pulcinella.
Arianna: — Notte, Locandiera.
Ma quanto eri bella stasera, Dana, io non te l’ho saputo dire.
Ero talmente emozionata, confusa nell’averti di nuovo qui, che i pensieri non si legavano con le parole.
La maglietta nera ti stava d’incanto… sembrava creata apposta per te. E i capelli legati dietro la nuca esaltavano la purezza del tuo viso, la perfezione dei tuoi lineamenti. Dovresti
portarli sempre
così.
Quando ti sei adagiata, nuda, sul mio letto, il tuo corpo tra le mie mani, abbandonato e fremente, emanava una luce divina.
La tua pelle viveva di vita propria.
Il tuo sorriso era un’ancora alla fonda nella baia tropicale più segreta e splendente.
I tuoi occhi foravano il buio, come ferro scuro, incandescente, ribollente.
Il tuo piacere è stato una scalata alla vetta più alta dell’universo.
Il mio piacere un’esplosione atomica da big bang, dalla quale è scaturita e si è aggregata una nuova me stessa.
Tu non mi ami?
Allora, ti prego, non amarmi mai per tutta la vita!
Il tuo è il non amore più inebriante che io abbia mai conosciuto. Continua a non amarmi, così che io mi ubriachi del tuo non amore, ogni giorno, ogni attimo, fino a perdere la
testa.
Ma ormai l’ho perduta.
E mi piace averla persa per te, per un non amore così sconvolgente, così unico, che stordisce, che cattura senza remissione ogni profondità della mia vita e della mia
anima.
Se così non mi ami, così sia per tutta la mia vita.
Io invece ti amo, perché devo attingere nel profondo di me per offrirti un sentimento all’altezza di quello che meriti.
Allora, ti amo, ti amo, ti amo, per tutta la vita, fino all’ultimo respiro.
Tu sei il diamante, io il dito che lo tende.
Io sono il buio, tu la luce che lo accende.
Tu sei la corona, io l’eroe che la difende.
Io sono il silenzio, tu la voce che lo infrange.
Tu sei la vita, io la mano che la prende.
Io sono la sposa, tu lo sposo che l’attende.
Tu sei la dea, io la preghiera a te dedicata.
Perché non dormo? Ci siamo salutate con l’ultimo messaggio telefonico meno di tre ore fa e da allora mi sono svegliata almeno dieci volte.
E ora sono qui, a pancia in giù sul letto col viso alla finestra nell’aria dolce e fresca della notte che mi copre di brividi la pelle, mentre dal CD le variazioni sulla quarta corda vanno
via lente e maestose, accompagnate dal tuo sorriso ammiccante e complice.
Non dormo perché ti voglio.
Tra le gambe ho una tempesta che non so e non voglio placare.
Non dormo perché domani non ci vedremo e tu non mi sei bastata affatto, oggi.
Non dormo perché ti penso nella tua casa, nella tua vita, con lei e vorrei bere ogni tuo attimo, condividere ogni tuo momento, essere la destinataria di ogni tuo
pensiero.
Non dormo perché sei così bella che mi scuoti dal sonno come se il tempo passato a dormire fosse tempo sprecato.
Non dormo perché il tuo sorriso galleggia sui miei sogni e li sminuzza
come io sminuzzo il pane per i miei amici passeri che mi aspettano affamati.
Non dormo perché le mie mani sentono la tua pelle e la tua carne, la percorrono incessantemente.
Non dormo perché le mie orecchie sentono la tua voce e rimandano a
memoria ripetutamente quello che mi hai detto oggi.
Non dormo perché penso ai tuoi capelli raccolti, alla forma spigolosa delle unghie della tua mano, al tuo dolce tallone felpato.
Al fremito che oggi ti ha rubato la mia mano mentre ti cingeva la vita.
Non dormo perché dipingo nel buio la luce accesa dei tuoi occhi, quando mi ami e sorridi come se io fossi la tua fine e il tuo inizio. Non dormo perché una lacrima lenta solca il mio
sorriso estatico. Non dormo perché quando non ci sei il tempo s’impenna capriccioso e fastidioso, mentre quando siamo insieme fugge veloce come se qualcuno lo inseguisse.
Non dormo…
Allora stringo forte la mano tra le mie gambe, lì dove tu premi, dove tu urli, ma senza muoverla, senza fare nulla, mentre i violini mi sciolgono il sangue, che sento pulsare, perché ormai
il mio corpo vuole solo te e Pulcinella non sa più ballare la tarantella se tu non scandisci i suoi passi.
E resto qui, a parlarmi di te, a parlarti di te, a dirmi che se tu fossi qui, non dormirei guardandoti dormire.
Perché il nostro è stato il ritrovarsi di due anime viaggiatrici, nomadi del tempo.
Come colombe traslucide e innocenti.
Puntuale sei giunta all’appuntamento: il destino nelle mani, il miele sulle labbra. L’infinito fuso dentro gli occhi.
E io finalmente vedo tra le oscure e vischiose trame del passato il fiore del presente, che è preziosa e finissima essenza.
Io coltivo il frutto inebriante del futuro nel nido segreto del tuo sangue.
Io raccolgo la soave vittoria della luce nelle mie lacrime, che sono perle purissime, levigate dal mio canto e scintillano nella teca diamantina della tua mente, come un inesauribile dono
d’amore.
Alle mie dita narri ogni giorno una favola nuova, antica, silenziosa e mistica.
Nella mia casa splende l’armonia viva dei silenzi.
Sulle tue labbra bevo la sinfonia senza tempo dell’amore.
Oggi le ho donato un anello.
È la fede che le porto, inossidabile, incorruttibile, indistruttibile, inalterabile.
È tenace, lucente e nobile. Ferma e modesta. Elastica ed eterna.
La metto al dito per guardarla teneramente e sentirla in ogni momento.
Per mostrarla, orgogliosa. E annunciare al mondo intero: io l’amo.
Io brucio al suo fuoco sacro come una foresta perenne, come un agnello sacrificale, un dolce tributo di sangue.
Lei è la lava incandescente che arde, rinnovatrice di vita.
È un’esplosione atomica, la madre della stella più lucente, più lontana e inafferrabile.
Io sono la sua geisha con l’inchino, il sorriso trattenuto, gli occhi trasparenti.
Il mio cuore balza, l’anima canta.
Io sono un profumo d’altri tempi e una maschera d’oriente.
Lei è la mia signora, io l’ancella devota.
Il suo piacere è il compito ambito di ognuno dei miei giorni.
La mia vita è una coppa da cui lei beve fino a bagnarsi la faccia.
Si dice: Non smettere di cercare ciò che ami… finirai per amare ciò che trovi.
Non smetterò di cercare ciò che amo.
Io l'avrei trovato, ciò che amo ed è lei, ma mi struggo perché vorrei anche il suo amore e lei non può, non riesce, non vuole darmelo.
Così, annegata nella mia solitudine, mi dibatto fra l'estasi e l'agonia, fra il desiderio di essere felice, di accettare e amare quello che ho e l'impossibilità di riuscirci, perché non mi
accontento…
Perché lei non mi basta mai.
-------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
DICIANNOVESIMO
Il sapore del
rifiuto
Amore mio adorato, ti scrivo perché di persona proprio non potrei dirti quello che sto per dire.
E poi, lo sai, a noi riesce meglio parlare così, per lettera, o nascoste dietro lo schermo del telefonino.
So che oggi è stata una giornata pesante per te e mi scuso se concorro io ad appesantirla ulteriormente.
Ma questa è una cosa che va fatta e ora la farò.
Io ti amo.
Immensamente. Ti amo come non ho mai amato e nella mia vita ho sempre molto amato.
Tu sei la donna che aspettavo.
Te l’ho detto ormai tante volte.
Se tu mi amassi, io credo che non saprei contenere la felicità. Io credo che non ci crederei neppure. Non oserei crederci. Mentre agogno al tuo amore.
Ma tu non mi ami.
Ormai me lo hai detto e ridetto, ribadito e riconfermato.
E questo è per me un dolore infinito, che trova ogni minuto, ogni istante, un modo nuovo per torturarmi.
Nella gelosia quando sento con quanto amore parli con lei al telefono, nella solitudine delle mie interminabili giornate. Nella rabbia per la tua freddezza. Nel sapore del rifiuto. Nella
certezza della sconfitta: ancora una volta rifiutata e sconfitta.
Ancora una volta.
Io che so amare, io che so essere felice. E so come essere felice, ma non posso esserlo. Ora ancora di più non posso.
Con la tua voce che mi ripete dentro: «Io non ti amo» e il tuo corpo che mi urla il contrario, quando facciamo l’amore.
Che mi incatena a te ogni volta di più.
Tu mi dici che è questo il modo in cui fai l’amore.
Io invece mi dico che non è vero, che solo con me tu sei così bella, così felice. Solo con me voli così in alto.
Ma non è vero. Non è vero.
E io dovrei accettare tutto questo?
No, non posso, non voglio, perché io merito il tuo amore. Io merito
di essere amata e di essere felice.
E ora non lo sono.
Ma senza te, senza l’amore, io non vivo. Allora cosa posso fare?
Ho tanto pregato e cercato la risposta a questa domanda.
E la risposta me l’ha data oggi Julia, la mia cara piccola amica virtuale:
Sposta più avanti il tuo orizzonte. Fissa un punto in questo orizzonte e cammina con gli occhi ben fissi su quel punto. Metti ciò che vuoi nel tuo cammino, ma non dimenticare chi sei
tu.
Così ho deciso che riaprirò la porta che avevo chiuso dopo che eri entrata tu. E strapperò via dal mio cuore l’amore che provo per te. Io sono ormai diventata un’esperta nell’arte di
strapparmi grandi amori dal cuore.
So cosa devo fare e come, so quanto sarà atroce e lungo. So quanto piangerò, quanto vorrò tornare indietro e quanto vorrò morire, ma nonostante questo io cercherò un’altra donna e mi
staccherò da te, tanto tu non mi ami. Tu hai lei, e ciò non dovrebbe farti soffrire più di tanto. Anzi, forse queste mie parole ti daranno sollievo.
So che tu hai aspettato sei anni per avere il suo amore, che hai affrontato prove immense. La tua costanza è stata premiata.
È anche questo che mi spinge a fare quello che sto facendo. Tu hai lei, finalmente e io sono di troppo.
Finirà.
Perché tu lo vuoi. E ora anche io lo accetto.
Ti prego, durante questo tempo che ci separa dalla fine del nostro rapporto, di guardare profondamente dentro di te e di vedere se davvero non puoi amarmi.
Perché io, se tu mi amassi, affronterei tutto questo tormento col sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore: lei, la solitudine, le lunghe giornate vuote, perché il tuo amore riempirebbe di
meraviglia l’universo.
E io ne sarei sommersa, trovando il fine ultimo della mia vita: amare te, riamata.
Ti chiedo, ti prego di guardare dentro di te, più a fondo che puoi. Anche se so che l’hai già fatto e già conosco l’esito di questa ricerca.
Ma ugualmente ti lancio questo mio ultimo grido…
Grazie per essere
entrata nella mia vita, offrendomi tantissimo.
Fai il tifo per me… ne ho bisogno.
-----------------------------------------------------------------------------------

ecco il ventesimo capitolo..è un capitolo un po' particolare..
narro il mio tentativo di suicidio, il quinto, avvenuto il 3 agosto 2007.
non leggetelo, se pensate che vi possa fare male...
CAPITOLO
VENTESIMO
La bestia dentro
Rumori di gente, suoni.
Ed emergo dal sogno con la gioia di un incontro.
Sento la mia casa intorno a me che pulsa e la tua voce, come se mi facesse festa.
Mi sveglio col sorriso sulle labbra, preparata all’abbraccio e al bacio agognato… ma la crudele realtà mi avvolge, mi scuote e mi brutalizza.
Sono in ospedale.
La ferita al polso reciso piange come un’ala di rondine spezzata.
Lacrime asciugate sul mio viso,vinto dal sonno artificiale dei sedativi, mi bruciano sulla pelle riarsa.
Tu sei così lontana che non bastano tutti i tuoi voli a riportarti da me e io così smarrita che non c’è luna piena che possa mostrarmi la via.
Quello che mi resta è reclinare il capo tra le braccia e morire un
po’ di più ogni giorno.
Ieri ho firmato per la mia dismissione dall’ospedale e sono tornata nel mio rifugio.
Questa mattina alle 5.30, dato che non dormivo più da un pezzo neppure con il sonnifero, mi sono alzata per andare a risciacquare il bucato e stenderlo, spazzare le foglie e finire di
mettere a posto i disastri che i miei soccorritori, che io ringrazio di cuore, hanno combinato nel mio giardino.
Sul cancellino rudimentale che fa accedere alla mia area c’era una chiocciolina.
Era giovane e tenera, con il bel guscio arrotolato su se stesso, lucido e
fresco; le sue piccole antenne erano tese e vibravano. Sembrava felice. Ho appoggiato una mano accanto a lei e quella dolce creatura vi è salita sopra, senza paura, toccandomi lievemente
con i suoi peduncoli così mobili. Poi è scesa e ha continuato il suo cammino.
Io ho fatto tutti i miei lavori e mentre stavo spazzando dentro la veranda, spostando la poltrona del mio adorato cane, che è ancora dai miei figli e mi manca da morire, ho trovato un
cumulo di terra sicuramente smossa di fresco.
Forse un topolino, ho pensato, ma data la mole di terra, con la quale ho riempito un grosso vaso, probabilmente si trattava di una talpa, perché la
galleria si inabissava sotto terra fuori dalla veranda per sparire nel profondo.
Allora nel mio cuore è sorto un ringraziamento per la mia piccola amica Corinne, la bimba della roulotte di fronte, che col suo intervento mi ha salvato la vita: le ho augurato ogni bene e
felicità.
E anche a tutti quelli che in qualsiasi modo mi sono stati vicini e per quelli che non hanno voluto o non hanno potuto.
Ora sono molto stanca, ma sto bene.
Mentre scrivo, Cheryl Porter canta i suoi gospel. Non per ringraziare Dio che io sono ancora qui, ma perché voglio che la gioia della vita riempia il mio cuore.
Questa è la cronaca del mio tentato suicidio.
Quella mattina, era il 3 agosto 2007, una sola voce era nella mia mente.
E diceva: BASTA.
Ho preso la bici e il mio cane, ma per la strada, siccome lui non mi seguiva abbastanza celermente, l’ho lasciato andare, io che amo il mio cane come un figlio. Sono entrata in farmacia e
ho comprato un flacone di soluzione glucosata, l’occorrente per fare una flebo e una siringa da 50 cc.
Poi di corsa a casa. Lungo la strada ho sentito Jerome che abbaiava.
Due ragazzi lo avevano trovato e lui mi aveva sentito arrivare: così l’ho ripreso con me.
Arrivata nella roulotte, ho appeso la glucosata al soffitto con un chiodino e ho preparato il tutto.
Mi sono praticata l’endovena.
L’ago era perfettamente in vena e il sangue defluiva regolarmente. Con la
grossa siringa, riempiendola volta per volta di aria, l’ho iniettata nello stantuffo che serve per aggiungere medicinali all’infusione. Ma l’aria non si immetteva nella vena. Io riprovavo e
il sangue rifluiva, ma l’aria continuava a disperdersi nel sottocutaneo.
Così ho ripetuto l’operazione più volte, non ricordo quante, nelle braccia, nelle mani, in un piede, gonfiandomi d’aria. Ma anche se l’ago era in vena,
l’aria non ci entrava. Poi la valvola dell’ago si è otturata ed è diventata inservibile.
Allora ho deciso di tagliarmi le vene del polso sinistro.
Avevo una lametta di quelle per la depilazione femminile. Con le forbici ho tolto tutta la parte di plastica che impediva alla lama di entrare nella
mia carne. Mi sono sdraiata sul letto e ho piazzato una grossa quantità di carta da cucina per terra, per raccogliere il sangue, per non sporcare la mia amata
Chiocciolina.
Poi ho cominciato a incidere.
Faceva un po’ male, ma era un dolore leggero, sottile, acuto come una voce bianca. Il sangue ha cominciato subito a scorrere. Io sorridevo e gli dicevo:
«Ecco, bravo, così, così».
Ma durava poco, poi si fermava. Allora io ancora incidevo, allargavo e approfondivo il taglio. Il sangue scorreva di nuovo e
io lo incitavo. Ormai era un dolce filo rosso continuo che andava a inzuppare la carta. Io controllavo il flusso, aprendo e chiudendo il pugno. E piegando il polso per facilitare la
fuoriuscita.
Ma ancora si fermava.
Allora, con il dito della mano destra, entravo nella ferita per rimuovere i
coaguli che impedivano al mio sangue di uscire e ancora tagliavo.
Faceva male, ma sorridevo.
Cominciavo a sentirmi stanca, sentivo la testa che mi girava e il cuore che lentamente si adagiava. E incitavo il mio sangue a scorrere via da me.
Poi, è risuonata una voce che diceva il mio nome,
Jerome si è messo ad abbaiare.
Ecco, penso, bravo figlio mio, non fare entrare nessuno. Ci sono quasi… ho
quasi finito.
Ma le voci incalzavano.
Allora con lo spigolo della lametta ho inciso più che ho potuto e lo zampillo è diventato un piccolo torrente.
A quel punto Jerome si è lasciato condurre via da Corinne e Massimo, il proprietario del campeggio, è potuto entrare.
Io avevo abbandonato il braccio a penzoloni giù dal letto e non sentivo più nulla.
Ero felice e serena.
Massimo ha esclamato: «No, mio Dio!»
Ha preso la cinghia della mia maschera subacquea e mi ha stretto il braccio fermando il poco sangue rimasto.
Poi ha chiamato l’ambulanza.
Io sentivo tutto, ma non c’ero più. I medici e i paramedici hanno detto
che ero incosciente, ma io sentivo tutto. Non vedevo, anche se aprivo gli occhi, ma sentivo.
Un gran affaccendarsi attorno a me…
Poi non sapevano come fare a farmi uscire dalla piccola porta della roulotte e parlavano di rompere tutto. Allora io ho detto: «Esco con le mie gambe». E la dottoressa che era china su di
me ha assunto l’espressione di chi avesse appena visto un fantasma. Poi sono scesa
dal letto, sorretta da non so quante persone e mi hanno caricato sull’ambulanza.
Il resto è banale storia di ordinaria follia.
La sera sono caduta e ho riportato un taglio in testa con commozione ed ematoma. Punti di sutura: quattro.
Al polso me ne hanno dati più di dieci. E, ancora, tutte le volte che cambio posizione la testa mi gira vorticosamente.
Dopo due giorni o tre, non ricordo, ho firmato per la dismissione dall’ospedale.
Prenderò i farmaci che mi hanno prescritto.
Ora sono a casa, nella mai chiocciolina: ho riparato i danni subiti dalla mia dimora, ho pulito e ho piantato nuovi fiori.
Sono abbastanza tranquilla, anche se ieri ho avuto una forte crisi di pianto, perché ancora mi ero illusa che lei potesse tornare da me.
Ora penso: Chi le parla? Chi le tiene compagnia? Chi farà l’amore con lei come solo io so fare? Chi scriverà poesie per lei? Chi la vedrà come l’essere più sublime e perfetto? Chi
l’adorerà? Chi penserà a lei costantemente?
Chi sarà sempre accanto a lei? Chi le comprerà le sigarette? Chi vedrà accendersi una luce tutte le volte che poserà lo sguardo su di lei? Chi la troverà eccezionale, perfetta, spiritosa,
intelligente, simpatica, originale, unica?
Chi l’amerà come l’ho amata io?
Io sono viva e vivrò. Ma chi le renderà il mio amore?
E mentre tentavo di morire ho sempre recitato, senza mai smettere un attimo, la preghiera Buddhista per accompagnare la mia vita nella nuova dimensione.
Non ho paura della morte.
Ora non ho neppure più paura della vita, perché ho davvero perso tutto
e non posso perdere più niente.
Se sono ancora qui ci sarà una ragione che prima o poi saprò riconoscere.
La notte è incalzante.
I miei pensieri come un sasso colpiscono lo stagno fermo della mia vita. Ma il sasso non fende l’acqua e non genera cerchi concentrici. La superficie resta immota, senza echi.
Dana, come una libellula in fuga, ha abbandonato la mia casa.
I polmoni si dilatano, il cuore imprime forza centrifuga al sangue che scorre portando ossigeno ai muscoli. Lo stomaco scioglie il cibo che
riceve, le orecchie sentono suoni diversi fra loro.
Gli occhi distinguono i colori, le membra mi sostengono. Le cellule metabolizzano ormoni e sostanze atte alla vita, le reni depurano le scorie. E il cervello è l’autorevole regista della
messa in scena.
E io che faccio? Nulla.
Ascolto il tempo passare su di me e portarsi via uno a uno ogni attimo.
Felice di averne ogni volta uno in meno da trascorrere.
Vedo la bestia nera e violenta che alberga nel mio cuore. Non so da dove viene né in che modo io abbia potuto dotarla di tanta forza e virulenza. Vedo i suoi occhi d’ombra inghiottire ogni
luce. La sua gola afona risucchiare ogni suono. Le sue orbite vuote annerire ogni colore.
Ma io sono lei? Lei è me?
No, non lo sono.
Io sono la manifestazione umana della legge che guida il cosmo, l’eterno flusso che accoglie e genera ogni espressione di vita. Nella luce si annida il buio, nel silenzio risuona la voce,
nella felicità si cela la paura dell’oblio.
E questo è il motore dello svolgersi delle cose.
Questo è l’espediente dell’apparizione di ogni entità.
Io sono il buio? No. Io sono la luce che scaturisce dal buio.
Ti conosco, ora, bestia, demone, vita violata, offesa alla legge, karma.
Ancora una volta sei quasi riuscita a prevalere su di me, sulla mia preziosa unicità.
Ancora una volta ti sei vestita di abiti così eleganti, hai assunto parole così suadenti, hai scelto note così struggenti che in te io ho visto l’amore, la pace, il perdono a cui
tendo.
L’abbraccio che sempre mi manca.
Ma c’è in me, anche quando tutto brucia come nel fondo dell’inferno più abissale, una terra pura, dove uomini e dei vivono felici e a proprio agio, si suonano tamburi celesti e piovono
fiori profumati.
Il fuoco dell’inferno della sofferenza è un espediente perché io possa desiderare di vedere la pura terra della felicità assoluta.
Ora che al mio corpo si sono aggiunte altre cicatrici che mai scompariranno, ora che ho percorso ancora un miglio su sassi aguzzi che mi ferivano i piedi, ora che la mia vita si è spogliata
ulteriormente di tutto ciò che avrebbe potuto distogliermi dalla luce, io vedo la pura entità luminosa che sono.
Qualche pietoso dio sconosciuto mi ha salvato, ha impedito che infliggessi questa offesa atroce alla mia vita.
E se la persona che io sono non ha avuto una madre, non ha avuto un padre, non ha avuto un fratello, non ha avuto un marito, non ha avuto un porto sicuro in cui approdare, ha comunque tutto
ciò a cui anela dentro di sé, in un luogo dove nulla e nessuno può rubarglielo, dove niente può finire, dove nulla può mancare.
Io sono la dispensa dell’amore che cerco.
Devo solo aprire la porta e attingere a piene mani il cibo del cuore che mi nutre, senza più attendere chi non può arrivare.
Senza illudermi, senza sperare invano.
Vivendo ogni attimo per l’immenso valore del suo stesso essere, perché non torna, perché è mio, intessuto di me.
E senza di me non esiste perché io sono il metronomo che lo scandisce.
La bestia è violenta ma io, come un saggio pitagorico, l’ho domata con la melodia del mio flauto ed essa si accuccerà quieta ai miei piedi, dormendo al suono dell’eternità senza inizio e
senza fine.
E la musica da me scolpita negli antri del dolore che illuminerà la via a me e a chi mi cammina accanto.

CAPITOLO
VENTUNESIMO
La fatina degli
orsetti
L’orso è un animale di grossa taglia, orgoglioso e dallo sguardo acuto, penetrante e fiero. Anche i cuccioli sono poco neotenici, cioè i loro lineamenti non hanno quei tratti infantili che
spingono i soggetti adulti della stessa specie e di altre specie a non infierire sul piccolo indifeso, anzi a prendersene cura, proteggendolo e crescendolo. Eppure l’orsetto
di pezza è in ogni cameretta di bimbo, sotto ogni albero di natale, in ogni negozio di giocattoli.
Quando avevo pochi giorni e mia madre stava lottando tra la vita e la morte, qualcuno pensò di comprare un orso di pezza per me e lo mise nella mia culla, forse spinto dalla pena di questa
neonata quasi orfana. Era un orso imbottito di paglia, fatto di una stoffa pelosa, ma rasa, di colore marrone scuro. L’impronta del muso era color giallo ocra e gli occhi di vetro verde
screziato, fermati con ganci di metallo infissi profondamente nella testa. Le piante dei piedi e i palmi delle mani erano dello stesso colore del muso e sia le braccia che le gambe erano
snodabili, sempre col sistema del perno di metallo, in modo che la bestiola potesse stare seduta tendendo le braccia un po’ troppo sottili rispetto al corpo, come nella ricerca di un
abbraccio.
Io naturalmente non posso ricordarlo, ma mi è sempre stato raccontato che la mia reazione alla presenza del pupazzo fu quella di un immediato pianto dirotto e inconsolabile, finché il
pupazzo non fu tolto
dalla culla.
Così, il povero giocattolo fu avvolto accuratamente nella carta e riposto in un armadio, in attesa che io potessi apprezzarlo meglio.
Inutile dire che Teddy divenne il mio inseparabile compagno di nanna molto presto: non potevo neppure pensare di andare a dormire se lui non era con me e me lo tenevo stretto stretto per
tutta la notte.
Gli anni passavano e la sua pelliccia cominciava a recare i segni del tempo. Gli occhi furono infissi di nuovo svariate volte, incollati, e poi sostituiti
da bottoni marroni cuciti col filo grosso delle riparazioni robuste. Altre cicatrici di strappi e relativi rattoppi disegnavano una mappa variegata di
colori e forme sul suo corpicino, sempre più sgonfio, sempre più indurito, perché la paglia, stretta con veemenza ogni notte, si frantumava e perdeva volume e morbidezza.
Gli arti, dopo essersi staccati un numero imprecisato di volte, furono cuciti con lo stesso filo coriaceo e la postura del mio caro amico rimase ormai fissata in una rigidità
immutabile.
La cucitura che in origine disegnava la bocca e il nasetto si era sfilacciata ed era scomparsa e io l’avevo sostituita con segni di matita o chissà quale altro attrezzo per
disegnare.
All’età di 13 o 14 anni, quando avevo già il fidanzatino e già avevo conosciuto altri abbracci, lui era sempre il mio unico amore notturno, il mio consolatore, l’abbraccio che calmava e
rincuorava. Il diario che scrivevo ogni sera, lo indirizzavo a lui, perché era l’unico che mi avrebbe accolto sempre fra le braccia, qualunque cosa fosse accaduta o potesse
succedere.
Solo quando mi sono sposata, a 18 anni, Teddy è stato trasferito sulla poltrona, per poi finire, dopo un’onorata carriera, impietosamente distrutto fra le sgrinfie dei miei
figli.
Venne così il giorno che, durante un doloroso trasloco, io buttai via tanta parte dei ricordi della mia infanzia, come per strapparmi illusioni e sogni, come per farmi male, ancora più
male, quasi come a voler amplificare quel dolore che mi dilaniava.
Buttai via pure quello che restava della sua carcassa spolpata, dopo averlo stretto a lungo tra le braccia, in lacrime.:spalancato il cassonetto,
ve lo lasciai scivolare dentro e subito dopo lo richiusi con un tonfo. Me ne andai senza più voltarmi indietro…
Il 13 agosto 2007, 52 anni abbondanti dal giorno in cui Teddy era comparso nella mia vita, nella mia posta elettronica comparve una mail che portava uno strano nome:
Bubu.
Quello era un giorno oscuro e senza parole, per questo solo il giorno dopo affidai al web una risposta, per questa Bubu che desiderava conoscermi, rispondendo a un mio messaggio da
naufrago, chiuso nella bottiglia del net. E la prima cosa che chiesi a quella gentile fanciulla che si affacciava in punta di piedi nella mia vita, fu il significato di quel nick così originale e
particolare.
Lei mi spiegò, ridendo, che quello era il nome dell’orsetto della sua nipotina, che ora aveva vent’anni.
Pochi giorni prima di quell’incontro io ero rinata per la seconda volta, salvata miracolosamente e inspiegabilmente da un suicidio dal quale non doveva esserci scampo.
Così Bubu ha preso posto dentro la culla della mia seconda vita…
Cara fatina degli orsetti, grazie per avermi donato Teddy e grazie anche per Bubu. Sei una fata gentile e attenta, sempre amorevole e sollecita, che non lascia mai vuote le braccia di un
bambino durante le
lunghe notti buie e solitarie.

CAPITOLO
VENTIDUESIMO
Un’altra donna
Monica è scesa dalla macchina, felice.
Non abbiamo messo tempo in mezzo: il 14 agosto ho risposto alla sua richiesta di conoscerci proponendole un pranzo per ferragosto, se non avesse avuto di meglio da fare.
Il pensiero di quell’ennesimo giorno di festa passato da sola a piangere sulla mia solitudine mi terrorizzava.
Alla fine della mia lettera elettronica le ho scritto: «coraggio!» e ne facevo anche a me stessa.
Ancora un incontro al buio, ancora un appuntamento: ed è così strano come io percorra questi ponti tra passato e futuro senza mai avere paura di cadere giù.
Il suo viso era sorridente, ma tradiva un’emozione misurata, dominata
con cura: un bel volto da bambina un po’ troppo cresciuta.
L'una di fronte all'altra, in una saletta tutta per noi in un agriturismo non troppo lontano dal campeggio, ci sorridevamo guardandoci negli occhi senza imbarazzo.
Il cibo buono e semplice, il vino e il desiderio di conoscerci e la confidenza ha preso a scorrere come un fluido, palpabile e reale: non è stato difficile raccontarle di Dana e della mia
follia.
Monica sembrava bere le mie parole, protesa lievemente verso di me, dall’altra parte del tavolo, mentre mescolavo il cibo ai ricordi e alle emozioni.
Il giorno dopo è tornata a cena con un amico e, finita la cena, siamo andati in spiaggia di notte, in questo inedito e imbarazzato trio…
Non capivo cosa Monica volesse da me, cosa si aspettasse da me. Mi mandava segnali contrastanti: mi sentivo chiamata, ma lei rimaneva immota e solitaria, come un alto cipresso su una
collina.
Le ho passato allora un braccio attorno alle spalle.
Un gesto amichevole, poco impegnativo, che lei avrebbe potuto agevolmente rifiutare con cortesia.
Invece si è abbandonata fremente contro di me e io l’ho stretta ancora
più forte: avevo capito.
Oggi è tornata, da sola. Abbiamo fatto l’amore.
Il suo corpo sconosciuto e desiderabile mi ha strappato dall’intimità con Dana. Sono stata su un’isola dove il dolore per lei non esiste, dove l’amore ha una leggerezza che non ricordavo
più.
Non così forte come con Dana, ma profondo e fermo.
Il piacere ci ha abbracciato, ci ha portato lontano in un luogo nostro, dove Monica vuole restare, dove io voglio tornare.
Ma le lacrime per l’assenza di colei che non c’era le hanno suggerito di promettermi di incontrare Dana e di parlarle, di cercare con me e lei una soluzione comune ai nostri desideri e alle
nostre sofferenze.
È stato tutto come un sogno e come in un sogno resto qui stasera, due nomi sulle labbra, due profumi nei ricordi.
Che sarà di noi?
Non è un addio, Dana, non è un viaggio. Nessun uscio si chiude. Il pendolo scandisce ancora l’antico ritmo del nostro amore.
Tu resti, mia amata e tu giungi, mia dolce Monica: io alleverò il vostro cuore nel mio petto.
La mia vita fiorisce sulle vostre labbra di pesca e di mandorla come profumo delle colline e aroma di mare mescolati nel mio sangue che oggi è un fuso d’amore.
Vivo di speranza pronta a offrire il frutto così a lungo celato.
Al crepuscolo esco dalle acque del mare come una dea dalla conchiglia, con la lunga coda dorata della luna luccicante dietro le spalle, sciolta nell’argento vivo delle onde che si
accavallano le une sulle altre, fremendo dolcemente.
L’aria fredda della sera mi avvolge come una vestaglia di cristallo. La schiuma della risacca si accuccia ai miei piedi stringendoli con mani di velluto.
La sera appena nata splende di nitida frescura, ma il sonno lentamente
entra tra le acque opaline e traslucide.
Nella nuova notte che forse ti porterà a me, Dana, cielo che dona la luna al buio, rinasco.
Tra le mie braccia avrò il canto delle profondità, il bacio delle stelle.
Ti aspetto, seme della mia terra.
E il tempo scivola come seta tra le mie dita: mi accompagna, mi sostiene, mi accoglie.
Nuoto tra le ore, viro tra i minuti, mi stendo sugli attimi.
Ascolto il mio cuore battere e i pensieri fluire, le parole nascere.
Apro gli occhi e guardo la lucertola sull’albero che mi racconta la sua vita.
Respiro.
Cresco d’amore. Avanzo con dolcezza. Senza attese mi immergo nel mio avere: nessuno lo potrà rubare.
A chiunque lo potrò donare.
Le vie dell’infinito sono lastricate nelle mie vene finalmente pulsanti.
Tu sei la mia donna, Dana.
Sei preziosa e pura, cara al mio cuore e alla mia vita, sei l’inizio e la fine di ogni mio sentire.
Sei una luce che mi accende, un cielo che mi respira. Tutto sta nella tua mano.
Quando la stringo, sono ricca. Quando ti amo è tutto impresso a fuoco nel mio cuore.
Sei stupenda quando ti avviti sotto le mie mani e mi fai sentire il potere dell'amore.
Quando mi penetri con gli occhi di fuoco e mi fai sentire il potere
del tuo cuore.
Quando sento i tuoi pensieri, il tuo orgoglio vitale, la tua forza, la tua tenerezza…
Quando in ogni attimo rendi stupenda anche me e il mio amore si espande in te.
Ma Monica oggi esiste.
Come un leggero vento di collina, come un coro silenzioso, come una mano che ti sorregge.
Con il uno sguardo gentile mi ha donato una soglia su cui fermare il mio passo in fuga, mi ha dato un luogo in cui potermi recare sapendo di essere accolta.
In lei il mio immenso sterminato acutissimo dolore ha trovato una tregua, ha visto una speranza, ha immaginato una fine.
C’è stata una mareggiata. Esco a guardare la potenza delle acque che si arrotolano in schiume verdi e bianche. Il vento mi danza tra i capelli, un aroma salmastro mi punge le narici. La
sabbia bagnata scivola tra le mie dita. Sono libera di vedere, di udire, di amare.
L’amore è motivo di vita.
A volte è dolore, ma quando le mani si stringono, i cuori sono all’unisono, la corrente passa, i canali sono aperti e le navi solcano le acque.
È mare aperto, azzurro, immenso.
È sangue caldo che scorre dentro le vene.
Il mio posto lo vedo quando mi accogli, Dana. Lo raggiungo, mi appartiene.
Ma ugualmente il mio luogo lo scopro quando mi ricevi, Monica. Lo desidero, lo prendo.
Esisto, per me, per te, per voi.
E quando mi addormento mi sdraio nel vostro odore, cullata dall’infinito.
Come in una nascita, in un cielo tutto lavato dalla pioggia, fresco e puro.
Come un frutto maturo colto da un ramo, dolce tra le mie labbra, dono semplice, inatteso.
Cammino.
Canto.
Viaggio tra i miei infiniti mondi stringendoli tutti nel palmo della mia mano.
Mio padre, mia madre, hanno fatto un buon lavoro quel giorno…
Disperdo ruscelli di lacrime, confondo sorrisi e singhiozzi, rimescolo sangue e linfa.
Costruisco strade e intreccio legami, allargo visioni e realtà. Sciolgo parole e silenzi.
Agnello e lupo alla mia tavola. Serpe e farfalla nel mio giaciglio. Fine e inizio nella mia vita.
Continuo l’evoluzione dell’amore.
---------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
VENTITREESIMO
Ritorno e andata
- Questo capitolo nella stesura originale dalla pubblicazione era la fine del capitolo precedente, ma ora, rileggendolo, mi sembra che così sia davvero
incomprensibile.
È stata quella una storia complicata ed io l'ho scritta come si racconta al proprio diario, senza una consecutio temporum, senza seguire una narrazione
organica.
In questo punto ora sento la necessità di fare una digressione narrativa ma, dato che il mio stato d'animo è totalmente diverso da allora e dato che io scrivo ad un
certo livello solo se sono ispirata, vi accontenterete di un racconto discorsivo, anche se poco lirico.
Cosa successe? Avete visto che dopo il ritorno dall'ospedale ero convinta che assolutamente Dana non sarebbe mai più tornata sui suoi passi e quindi, dato che di
morire non mi era stato dato, avevo deciso a ricominciare a vivere. Dentro di me sentivo, pur nel dolore immenso che stavo provando, che vi erano pagine della mai vita ancora da scrivere. Venne
quindi l'incontro con Monica, il suo repentino innamorarsi di me ed il mio lasciarmi andare alla sua dolcezza. Avevo un disperato bisogno di aiuto, di essere protetta, di essere amata. Quando i
carabinieri chiamarono i miei figli, avvertendoli del mio tentativo di suicidio, essi giunsero, anche perché vi era il povero Jerome da recuperare, ma non vennero a parlare con me. Espletarono il
loro dovere, presero il cane e ripartirono immediatamente. Ogni volta loro hanno reagito ai miei tentativi di suicidio con una immensa rabbia. Non do giudizi sul loro comportamento, immagino cosa
voglia dire avere una madre suicida, o forse no, dato che non l'ho provato mai, immagino che debba essere un grande dolore e quindi mi dispiaccio immensamente di averli fatti soffrire così tanto,
ma di certo se loro fossero stati in grado di dimostrarmi il loro affetto e si fossero stretti intorno a me, prendendosi cura di me, io mi sarei sentita molto meglio. Ma ciò non accadde, arrivò
invece Monica ed io accettai di farmi amare da lei.
Ma la prima volta che stemmo insieme, dopo, io ebbi una fortissima crisi di pianto, perché mi accorsi immediatamente che nessuno avrebbe potuto prendere il posto di
Dana e che lei mi aveva marchiato a fuoco, indelebilmente.
Monica allora fu dolcissima e, incredibilmente, invece di accendersi di gelosia, mi disse che io non voleva assolutamente che io soffrissi così, che quel dolore mi
avrebbe spezzata in due. E disse che avrebbe chiamato Dana chiedendole un colloquio a tre.
E così accadde. Nel giardino recintato di ombreggiante della mia roulotte, il giorno dopo ci trovammo, un inedito trio, davanti ad un calice di vino bianco. I
discorsi furono semplici. Monica disse a Dana che mi amava, ma che era perfettamente conscia del mio infinito amore per lei. Alle proteste di Dana che asseriva di non essere la donna giusta per
me, dato che lei aveva Elisa e non poteva darmi quello che io meritavo, lei le propose di continuare la sua storia con me, lasciando però che io avessi una storia anche con lei. 'Come tu hai
Elisa, Ari avrà me, ma tu e lei potrete vedervi in accordo con gli impegni e perché no, magari io e te diverremo pure amiche e ci piacerà uscire anche in tre.
Io guardavo Dana con occhi così imploranti ed accesi d'amore e lei desiderava così tanto poter ancora essere amata da me, che accettò.
Cominciò così un avvicendarsi fisso di Monica che però lasciava ampi spazi alle visite di Dana ed alle nostre lunghe telefonate. Cominciarono così anche le nostre
uscite a tre e ci accorgemmo ben presto che insieme stavamo benissimo ed eravamo allegre e spensierate. Io ero al culmine della felicità. Monica mi dava affetto, si prendeva cura di me, era
sempre presente anche quando non c'era, perché la sua scelta di amarmi era totale. Ed io avevo così tanto amore dentro, che ciò che le davo era tanto di più di quanto non avesse mai avuto, dopo
una vita di solitudine nella sua non accettazione della propria omosessualità, dato che io ero la sua prima vera donna. Ma, nello stesso tempo, potevo avere Dana, far l'amore con lei, telefonarle
ed attenderla, potevo scrivere di lei per lei: con Dana presente vi era amore anche per Monica, senza Dana vi era solo disperazione.
Ma Dana non era tranquilla. I sensi di colpa nei confronti di Elisa la torturavano. Quindi tornò da me per poi andarsene di nuovo dopo
poco..............
Il sabato sera tra la massa opaca della gente, rumoroso gregge disperso, Dana ti muovevi fluida e l’aria brillava di echi marini.
Le grotte della notte ardevano.
Tu, limpido specchio della mia vita, eri come una torcia accesa e profumata, penetrante come una brezza salmastra.
Ed io ero lì.
Ma quando stai per addormentarti e gli occhi si chiudono pesanti, io sono lì.
Quando mordi un pane fresco e fragrante o guardi il mare risplendente al sole.
Quando lavori duramente e con impegno, parli a tuo figlio o sorridi tra te e te, ricordando qualcosa.
Quando guidi nel traffico, leggi un libro interessante o sogni di volare.
Quando hai voglia di piangere, senti il tuo corpo fremere o sei stanca e hai mal di testa.
Quando sei felice e non ricordi il perché, guardi il cielo e lo interroghi.
Quando bevi un bicchiere di buon vino, senti di essere bella o capisci di essere importante.
Quando abbracci l’amore, io sono lì, Dana. Con te.
Vado incontro al mio destino.
La certezza di amarti asciugherà le lacrime dell’incertezza, insieme alla dolcezza di amarti, alla fermezza di amarti.
Sarà ciò che deve essere.
- e infatti....
Un altro addio. È la cosa che mi riesce peggio: chiudere la porta alle tue spalle.
Ascolto il rumore dei tuoi passi che si allontanano.
Gli ultimi.
Che parola avara! Incomprensibile.
Ed esiste ogni giorno.
Anche oggi è l’ultimo giorno della mia vita.
Addio Dana, amore.
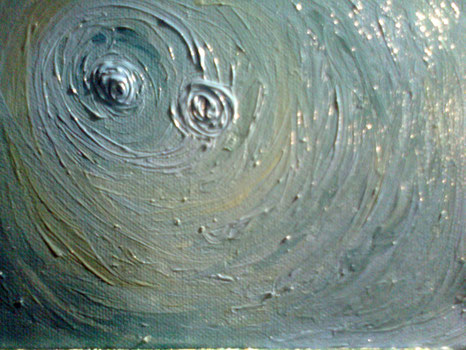
CAPITOLO
VENTIQUATTRESIMO
Guarigioni illusorie
- Dopo l'inattesa fuga di Dana, quando proprio io credevo che non sarebbe successo, data la venuta di Monica ed il nuovo equilibrio tra noi, seguì una mia brutta
crisi di depressione acuta. Ogni volta i suoi distacchi mi precipitavano in quell'abisso nel quale io solo desideravo di morire. Ma, quella volta, Monica era accanto a me e mi sostenne, mi aiuto
con la sua presenza, mi diede un appiglio al quale aggrapparmi ed finalmente uscirne fuori.....
Cara piccola, carissima creatura così importante per me. Oggetto e soggetto del mio amore e della mia vita, oggi sto meglio.
Sto uscendo finalmente da questa ennesima brutta crisi. Vedo i sintomi della ripresa.
Il primo e più importante è che sono qui a scriverti. Ieri non avrei potuto farlo.
Ma sono tanto triste. Perché ho finalmente capito una volta per tutte che non sono guarita e che non guarirò mai.
Quando sono venuta incontro a te, quel 23 marzo che ormai sembra preistoria ma che, se ci guardiamo indietro, è solo ieri, io credevo
di essere guarita, ne ero certa, sicura…
E mi sentivo forte, sana, capace di affrontare il mondo, te, l’amore, la mia vita… e me stessa.
Ero sincera, ma mi sbagliavo.
Ho illuso me e ingannato te. Senza volerlo, ma l’ho fatto: solo adesso me ne rendo conto.
Gli psichiatri l’hanno chiamata «depressione maggiore bipolare da disturbi di personalità congeniti in soggetto psicotico».
Io ho detto loro che con la recitazione Buddhista ero guarita.
Mi hanno risposto che da queste malattie non si guarisce, ma non ho voluto crederci, tanto mi sentivo bene, tanto mi sentivo sicura di me.
Ora ho capito che avevano ragione.
La recitazione mi tiene viva, mi permettere di vivere senza psicofarmaci o riducendoli al minimo, cosa che di per sé è un incredibile miracolo, data la mia disperata situazione, ma la
guarigione è impossibile.
Così, in alcuni momenti io sono forte e lucida, matura e piena di doni da offrire agli altri. In quei periodi posso affrontare qualsiasi cosa e vivere con forza e coraggio qualsiasi
situazione, ma quando il mio male torna alla superficie, divento fragile e delicata, implodo nel mio dolore che dilaga e tutto trasforma.
Anche la più piccola cosa mi ferisce in maniera smisurata, così che ho bisogno di tutto, ma soprattutto di essere accolta e compresa, di sentirmi accettata nella mia negatività, di sentire
la pietà di chi è attorno a me, la comprensione per una malattia che è più forte di me e che io non riesco in nessuna maniera a debellare, che mi piega e mi
frantuma.
Non mi spezza solo perché ho imparato a piegarmi fino a nascondermi sotto terra, ad aspettare che passi: ma non sempre funziona…
L’altro ieri e ieri ero così piegata che quasi non esistevo più.
Oggi, di nuovo, qualcosa di me sta ancora germogliando.
È come una pianta che si secca ogni volta ma che resta viva in una piccola gemma staminale e, appena le lacrime hanno annaffiato abbastanza il terreno riarso, ecco che spunta di nuovo,
incredibilmente, una piccola fogliolina, di un bel verde intenso, lucido e vivo, anche se non sa
quanta vita avrà e se riuscirà a dare i suoi frutti.
Amore mio, io potrò darti tanto, tantissimo, ma altrettanto ti ruberò con il mio dolore.
Alla fine tutti si allontanano da me perché restarmi accanto diviene insostenibile, perché il coinvolgimento che io provoco, nel bene e nel male, è così profondo che tocca il nucleo di
ognuno di voi.
Un istinto impellente di autodifesa spinge così tutti quelli che amo a
fuggire da me.
E chi non può e non vuole fuggire si nasconde dietro la rabbia e il risentimento, per non soccombere, per non lasciarsi trascinare nel mio vortice risucchiante.
Un meccanismo che pare assurdo ma che invece è assolutamente naturale.
Ma stavolta sono io che pongo fine a questo assurdo calvario.
A te
Al tuo seno d’avorio che riempie la mia mano.
Ai tuoi fianchi d’ebano che si offrono alle mie labbra.
Alle tue cosce di marmo che si aprono al mio desiderio.
Alla tua bocca di spezie d’oriente che si avvinghia alla mia lingua.
Alle tue mani di fuoco che entrano nella mia carne.
Ai tuoi occhi di turbine che rimestano il mio sangue.
Ai tuoi piedi di puledra che sempre fuggono da me.
A te dedico le ore vuote,
i sospiri inascoltati,
i baci perduti,
i pensieri smarriti,
i desideri inespressi,
i sogni inutili,
le attese disilluse,
l’ebbrezza di ogni sera,
la smania di ogni notte,
la speranza di ogni giorno,
e tutto ciò che resta della mia tristezza quotidiana.
Ogni attimo vissuto con te è strappato alle tenebre.
È il trionfo di Eros su Tanathos.
La tua bellezza è il volto della speranza.
-------------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
VENTICINQUESIMO
Le domande della
mia anima
- e venne un giorno che io misi alle strette Dana e le posi le domande che tanto mi assillavano....
L’Anima: — Riuscirò ad avere una risposta a queste mie domande?
Dana: — Forse…
L’Anima: — Mi ami? Cioè, ami me o quello che ti do?
Dana: — Amo parlare con te. Amo tutto del tuo corpo ma alcuni punti ancora di più e mi fanno partire di testa.
L’Anima: — Hai bisogno di me?
Dana: — Sì.
L’Anima: — Ami Elisa?
Dana: — Sì.
L’Anima: — Ami più lei o me?
Dana: — Lei.
L’Anima: — Se dovessi scegliere, chi sceglieresti tra me e lei?
Dana: — Lei.
L’Anima: — Adesso fate l’amore assiduamente tu e lei?
Dana: — Sì.
L’Anima: — Ti piace più farlo con lei o con me?
Dana: — Bisogna vedere gli sviluppi…
L’Anima: — Perché non ti basta stare solo con lei?
Dana: — Perché non mi dava il sesso di cui avevo bisogno.
L’Anima: — Perché non ti basta stare solo con me?
Dana: — Perché non ti amo.
L’Anima: — Riuscirai mai a scegliere una delle due?
Dana: — Potrebbe aiutarmi a scegliere l’evoluzione della vita sessuale tra me ed Elisa…
----------------------------------------------------------------------------------

CAPITOLO
VENTISEIESIMO
Addio alla
Chiocciolina
E venne il 21 settembre, giorno in cui il campeggio chiudeva per l'inverno. Avevo cercato nei dintorni un campeggio che rimanesse aperto durante i mesi freddi, ma
non ne esistevano. Allora cercai e trovai una casetta molto carina, sulla seconda parallela al lungomare, una ex casa di pescatori, alta e stretta, inserita tra altre case simili senza soluzione
di continuità per tutta la via. Erano due stanze sotto e due sopra, collegate da una scala a chiocciola: le presi in affitto fino all'aprile seguente, finché non fossi potuta tornare nella mia
amata chiocciolina. Seguirono quindi i lavori di chiusura della mia casetta – guscio, eseguiti con l'aiuto di Dana e Monica, soprattutto per smontare la veranda, la recinzione del giardino e gli
ombreggiati aerei che io avevo costruito e montato tutto da sola, ma in cuor mio sentivo che qualcosa stava chiudendosi definitivamente. Ed anche se la casetta – che battezzai ' La torretta' per
il suo andamento verticale - era assai graziosa a dotata di tutti i comfort, assai più della mia roulotte, ero immensamente triste.
Insegnerò al mio cuore a ridere con i suoi occhi, a sentire con le sue mani.
A vibrare con la sua voce, a pensare nella sua presenza.
A gioire nella sua assenza, a rasserenarsi nell’attesa di lei.
A compiersi nella sua felicità.
A dividersi per chi lei ama, ad accogliere il mio destino.
Ad amare colei che è l’amore suo.
A riempirsi e a non vuotarsi. Mai.
Amo Dana, la amo da morire.
Lei è tutta la mia vita e questo amore mi attanaglia e mi fa soffrire.
Anche se lei continua a ripetermi che la nostra storia deve finire, anche se mi ha lasciato moltissime volte e altrettanto ho fatto io.
Nonostante tutto questo dolore, io l'amo.
Ed eccomi qua, centosessantuno giorni e centosessantuno notti dopo. Sorrido e piango.
Ti amo centosessantuno volte di più e ho altrettanta paura di perderti.
Chilometri a nuoto, a piedi, in bicicletta.
Notti insonni, cene, sbronze.
Parole, poesie, sassi, foglie, sole caldo, sudore, docce gelate, il bucato a mano, il tuo odore nelle lenzuola.
Nella mia testa l’amore, l’estasi, il primo bacio nel biancore del bagno…
E poi le crisi, la gelosia, la disperazione, gli addii e il ritrovarsi ogni volta più vicine, l’una ancor più dentro l’altra.
La certezza dell’incertezza,.
La speranza, la dolcezza…
Le finestre sprangate e oscurate, perché nessuno ci vedesse.
Vederti arrivare, vederti andare via, aspettarti, perderti.
Mandarti via, ritrovarti, ricercarti, arrendermi, lottare.
Bestemmiare, pregare, invocare, supplicarti, offenderti, offendermi, perdonarti.
Sbagliare tutto.
La follia, la saggezza.
L’altra, l'altra l'altra.
Ore al telefono, messaggi, fotografie.
Automobile, scooter, mare mare mare, gente.
E io, sola come nessuno, sola anche con te.
La tua stanchezza, il mal di testa, di pancia, di schiena, al ginocchio, alla spalla…
Le mie mani magiche, innamorate.
Il tuo seno, i tuoi fianchi, il tuo ventre, le tue cosce, la tua pelle, la tua bocca, il tuo naso, i tuoi capelli, i tuoi occhi, le tue mani, il tuo sorriso, i tuoi sospiri, il tuo piacere,
il tuo fuoco, la tua spada, la mia resa.
Ancora, ancora, ancora…
Appena ti sfioro, appena ti guardo, appena ti penso, ti sento, ti leggo, mi leggi.
Ho ragione, ho torto.
Sono io, sei tu, ti amo, mi ami.
Centosessantuno giorni d’amore, centosessantuno giorni d’infinito.
È l’ultima notte nella Chiocciolina.
Rido e piango. Sono sola e sei qui. Sempre qui.
Nel mio cuore. Fatto a forma di chiocciolina.
Grazie.

CAPITOLO
VENTISETTESIMO
L a torretta
All’alba il computer è collegato.
Tutto funziona. Comincia un altro ciclo: oggi è una splendida giornata. Scatoloni, tutto nel mezzo, polvere, tutto cambiato.
Ieri mi sono trasferita nella mia residenza invernale lasciando quella estiva: la mia amata roulotte, la Chiocciolina.
Invece, la nuova casa si chiama Torretta, perché è alta e stretta, su due piani con una scala a chiocciola interna.
Ho sgobbato come un facchino e ora ho invitato a cena Dana e Monica.
Ho preparato la pasta e fagioli alla romagnola, il profumo è invitante.
Domani sarò a Imola.
Venerdì tornerò a Gabicce Monte e spero di riprendere i miei ritmi.
Ma ieri si è chiuso il conto di questi centosessantuno indimenticabili giorni, aspri, a volte terribili, ma sempre pieni d'amore e di estasi.
Messaggio telefonico di Monica:
— Ascolto il tuo mare, il suo richiamo, che attira sempre un marinaio in cerca di una perla rara o del canto di una sirena. Ti ascolto e mi immergo in te con tutto il mio
amore.
Rispondo:
— Tu cerchi il canto della sirena. Cullerò allora questo marinaio intrepido e inatteso tra le onde del mio mare d’amore.
L’acqua sarà fresca, limpida, profonda e quieta.
Illuminata dal sole, bagnata dalla luna. E il gorgo finalmente si fermerà lasciando la pace come unica signora del luogo.
A Imola c’è una casa che non è più mia.
Questo è stato il mio letto, e non lo è più: la mia vita non è più la mia vita. Tutto è successo in pochi mesi.
Ma tutta la mia vita è fuori ritmo.
Ho solo un cuore, una mente inusuale, apolide, nomade.
Ogni volta faccio su il mio fagottino dell’indispensabile: perdo per strada il resto.
Rimane solo il ricordo e il dolore. La fatica di ricominciare.
Sono estranea ai miei figli.
Il passato non ha ponti sul futuro.
Vorrei un punto fermo per il ritorno di una sera come questa, che non sia uno sterile monologo.
Nella nuova casa filtra dalle finestre piccole una luce antica. Ha muri di sassi e travi scure di legno al soffitto.
Ha il vento salmastro che bussa alla porta di notte.
Ha il mare che vibra sotto il pavimento.
È la tolda della mia nave, è la vela della mia mente, è il rifugio per il mio cuore.
Entro e siedo alla mensa del prossimo inverno.
Oggi parto per un viaggio a ritroso lungo la strada perduta: la vita pulsa di ogni singolo attimo e non perde un battito del mio cuore, non tralascia
un respiro.
Ritorno all'infanzia della speranza tra le tue labbra.
Messaggio telefonico di Dana:
— L’inatteso marinaio intrepido succhierà il tuo quieto mare d’amore, lasciando il tenente nel gorgo del mare in tempesta?
Rispondo:
— Il tenente è il mio amore, il mio cuore è suo.
Amo l’intrepido marinaio per non affondare e questo anche per il mio amato tenente, per esserci sempre, quando lui mi vorrà o avrà bisogno di me.
Il vecchio capitano ha vissuto tante tempeste e le sue stanche ossa cigolano sulle consunte tavole della tolda, ma il suo cuore è ancora intrepido e pieno d’amore e di
vita.
Il gorgo della tempesta non ci travolgerà.
Dana, amore mio, quel posto era tuo. Nel mio cuore, nel mio letto, nella mia casa, nella mia vita.
Sono venuta a te portandoti tutto quello che avevo, poco o tanto che fosse, ma tutto. E a te l’ho dato. Tu mi hai insegnato a dividere.
Ora, ciò che ho imparato, lo passo a te.
Mi spiace.
Ma la notte da sola, a pensare alla donna che amo che ama un’altra donna, è troppo lunga, fredda e vuota.
Io amo la faccetta di Monica, la sua dolcezza, la sua resa completa alla mia vita.
Volevo te e tu mi hai regalato la libertà.
Grazie.
Afferra a piene mani quello che vuoi del mio amore, della mia passione, della mia voce, delle mie parole, ma lasciami, ti prego, il lusso della speranza.
Che tu non mi vuoi dare.
Amarti è un completamento.
Quando ti offri a me prendo tutto quanto le mie mani possono tenere, gli occhi sognare, la mente immaginare e il cuore contenere.
Riempio il mondo quando ti accetto.
Il tuo profumo d’amore è una vela tra le lenzuola, che fa salpare la mia anima
Quando mi prendi è una cosa da scrivere sul mio corpo, sulle mie labbra e nel mio sangue, nella mia mente, nei miei ricordi e infine in una poesia, in
modo che chi legga possa averti insieme a me.
Il cucchiaio tintinna contro le pareti del bicchiere del mio latte mattutino che scende fresco e dolce nella mia gola.
e mura della casa mi respirano intorno.
Mi volto e ti rivedo seduta al tavolo, con i capelli raccolti dietro le spalle ben tornite dal colore caldo e ambrato, la linea del tuo collo che invita a posarci sopra le
labbra.
Il pc mi rimanda la canzone che abbiamo ballato lentamente, abbracciate, fuse insieme, ieri sera, in questa stanza intima e amica.
Sento le tue braccia che mi cingono il collo e le tue mani che mi accarezzano la schiena.
Sento il tuo alito buono che sa di sigaretta e della cena appena consumata, che con le mie mani avevo preparato per te.
La vita mi regala questi momenti di perfezione, d’intesa assoluta. Momenti tutti nostri, tutti miei, che continuano a vivere qui e dentro di me, anche quando te ne vai.
Salutarti non è più un dolore, perché so che ritornerai e so che se mi giro, mentre bevo il latte la mattina, ti vedo lì, seduta alla tua sedia, dorata e forte, profumata d'amore e
d’estasi: immagine del mio desiderio.
Ti amo e ti sento sempre qui con me.

CAPITOLO
VENTOTTESIMO
Dana, Monica,
Elisa
Sono in riva al mare, lambita dalle onde.
Il mattino si sta destando lentamente, pigro e leggero.
Un peschereccio veleggia poco lontano sulla distesa calma, liscia e morbida delle acque.
Fa freddo. L’autunno sta lentamente scalzando l’estate che se ne fugge in tutta fretta, indispettita, anche se sa che tra pochi mesi trionferà di nuovo sulle nostre teste
accaldate.
Respiro quest’aria frizzante, densa di umori salmastri, che mi accarezza e mi fa sentire viva.
Un gabbiano strepita in lontananza: non so se arrabbiato o disperato.
Poi mi accorgo che sono molti i gabbiani, appena dietro una piccola ansa. In uno specchio riparato alcuni piccoli pescherecci stanno scaricando il frutto delle reti e ributtano in mare lo
scarto. I gabbiani litigano tra loro per i pezzi più prelibati nel bel mezzo di uno strepito gioioso.
Un pescatore con gli stivali gialli alti fino alla coscia risciacqua in mare nasse e secchi.
Mi aggiro tra questa gente semplice, ascoltando le loro voci e gli odori dei loro corpi cotti dal sole e dall’aria salmastra.
I rumori che mi circondano hanno l’impronta della fatica quotidiana. La moglie di uno dei pescatori, seduta su un panchettino, vende ai pochi avventori i pesci colorati e lucidi, che hanno
appena abbandonato le profondità in cui si celavano e stanno donando la vita a chi ne trarrà nutrimento.
Io pure compro due scorfani, rossastri e sgraziati, con la testa grossa e camusa e un’elegante mormora, arrotondata e liscia, di un bel colore azzurro argentato.
Stasera Dana e Monica verranno a mangiare questo pesce fresco e saporito, che io cucinerò per loro, nel forno della mia casetta.
L’immensa sagoma del sole è sorta all’orizzonte.
Lascia una scia accecante sullo specchio immoto delle acque, trionfando sulle nuvole, sul buio appena sconfitto, sull’aria gelata della notte che già si sta stemperando, sul vento che
diventa una brezza.
Il rosso del disco solare è violento e potente, cattura lo sguardo e impressiona la retina, tanto che, anche se distolgo gli occhi, ancora lo vedo.
Io amo: questo non cambia.
Come il sole che, accada ciò che accada, ogni mattina comunque sorge.
Respiro i profumi della mia vita.
Le gocce finissime delle onde sugli scogli, il vento che accarezza le colline e lievita sulla pianura marina.
L’odore della pelle di Dana è nella mia testa, nelle mie narici, nelle mie mani. Non mi abbandona mai.
Quando facciamo l’amore, me ne inebrio, nuoto dentro alla fragranza forte, aromatica e lievemente salata del suo corpo dorato.
È come tornare nel liquido amniotico dell’utero che mi ha generato, nello
stagno fragrante e vitale dal quale si è dischiuso il mio uovo primordiale. L’abbraccio è totale, permeante, senza soluzione di continuità.
I nostri molteplici esseri nascono e muoiono nella sintesi del
nostro amore. Evolvono, rifioriscono, inventano nuove parole, nuovi gesti e nuovi ruoli, riscoprono antiche forme dimenticate o soltanto allontanate.
Aprono al presente le vie del passato e del futuro.
Il piacere è il veicolo della realtà.
Il piacere è la colata di lava che sconvolge il paesaggio, creandone uno nuovo, inedito, ogni volta più vivo e inatteso.
Il piacere è l’humus di nuovi pensieri, lucidi della zecca della felicità e dell’estasi.
È la fucina di impensate parole, riscoperte, ritrovate, gettate tra noi e poi raccolte. Come sassi levigati e lustri di pioggia a lastricare la strada infangata.
È un gioco serio, coinvolgente, profondamente acuto e tagliente, che apre
il mio cuore, e lo lascia in attesa di domani.
Ma Dana non è ancora pronta a dare questa fermezza alla sua vita.
Dana vuole ancora fuggire.
Vuole ancora pensare di essere libera, anche se non sa che la vera libertà è quella di saper accogliere noi stessi dentro di noi e nella nostra vita, fino in fondo, come
siamo.
Dana si nasconde dietro al dito delle sue paure, delle sue incertezze, delle sue illusioni.
Lei cerca altro, lei non vuole impegnarsi, lei non vuole smettere di essere instabile e dare instabilità a tutto ciò che fa.
Il pensiero che nulla è fissato, che tutto è emozione effimera, senza schemi, la fa sentire viva, le infonde sicurezza, la consola.
Le annulla il senso del tempo che passa, della vita che
si consuma.
Io so che la vita non finisce: questa che abbiamo s’interrompe e poi si riaggrega in un altro essere e ricomincia.
L’oblio non esiste.
Non è quello che lei fa, il suo modo di vivere, ma il sottofondo del suo
animo che non vuole passare di categoria, come se ciò potesse rendere infinito il flusso.
Il brivido dell’incertezza, l’adrenalina al posto della consapevolezza, come se essere donne mature ci privasse della capacità di provare emozioni,
come se approdare alla soglia dell’età che veramente abbiamo potesse spegnerci.
Ma ogni momento che passa è un momento in meno che abbiamo da vivere in questa nostra precisa forma, è un attimo che racchiude tutto il nostro passato, crea il presente e sfocia nel
futuro.
Nulla può fermare il processo della trasformazione, senza il quale tutto sarebbe un’immobile colata di piombo opaco.
Sono una donna che ha sempre vissuto con il corpo e la mente disgiunte. Con il cuore e la vita separate: sono schizofrenica.
Due persone che vivono dentro di me e che per lunghi, lunghissimi 54 sterili anni, non si sono guardate, non si sono parlate, non si sono prese in considerazione, non si sono
amate…
Ora voglio unire me stessa nell’amore, nella pienezza della vita, nella consapevolezza dei miei passi che risuonano su questa terra, nella conoscenza di ciò che è e che mi sta
intorno.
Oggi ricordo: il 15 agosto ho conosciuto Monica.
Era uno dei tanti momenti nei quali Dana mi aveva brutalmente allontanato da lei. Ricordo che non volevo passare il giorno di ferragosto da sola. Ci siamo incontrate così il giorno
dopo.
Vedo il legame forte che è nato subito tra noi, come quando si incontra
qualcuno che si aspettava, che ti aspettava.
Legami che vengono dal passato. Monica si è innamorata subito di me. E io, se non ci fosse stata Dana nella mia vita, avrei fatto la medesima cosa.
Da allora stiamo insieme. Ci sono state fughe sue, rifiuti miei, soprattutto legati alle dinamiche con Dana. Lei vive con me quello che io vivo con Dana ed Elisa. Ma c’è una grande
differenza.
Io so cosa prova Monica, quello che sta passando e quanto sta soffrendo, perché è lo specchio della mia vita.
Dana non lo immagina, forse solo pallidamente.
Lei sa che Elisa, per quanto recalcitrante, è sua anche se la deve dividere col marito o con altre situazioni: anche se sembra tutto il contrario, il coltello dalla parte del manico tra
Dana ed Elisa ce l’ha Dana.
Forse questo, prima di conoscere e frequentare me, non le era del tutto chiaro, ma il mio amore le ha dato sicurezza e coscienza del suo valore e potere.
Neppure io avevo capito come davvero stavano le cose. Vedevo Dana come una vittima dell’egoismo crudele dell’altra, ma non è così.
Elisa ha bisogno di lei, quanto lei di Dana: io sono servita a chiarire questo intreccio. Ed Elisa ora sta cedendo su tutta la linea. Solo che quello che io e Dana abbiamo, lei non l’avrà
mai con Elisa e le è
entrato dentro.
Ma non c’è solo questo. Dana ha ammesso che la fa stare male il pensiero di perdere il possesso su di me, come una bambina capricciosa che desidera spasmodicamente un giocattolo del quale
non le è importato un gran che fino ad allora, proprio quando qualcun altro lo vuole: capricci, adrenalina.
Ho capito che io e Dana non stiamo cercando la stessa cosa.
La mia psichiatra un giorno mi disse che il mio vero problema irrisolto è che io non so capire la realtà.
Sono buona e altruista, ma così piena di me, delle mie emozioni, delle mie convinzioni, così rigidamente calata in un mondo tutto mio, che mi butto nelle situazioni senza veramente rendermi
conto di dove mi trovo, con chi ho a che fare e cosa vogliono o di cosa hanno bisogno le persone attorno
a me. Così mi lancio in tutto quello che si trova alla mia portata, senza risparmiarmi in niente, ma non faccio mai quello che è giusto fare, non offro mai quello che è richiesto, quello
che serve.
Sento che la mia vita è totalmente estranea alla realtà.
Questo è innegabile ed è la reale fonte di ogni mia sofferenza.
Ho inondato d’amore Dana, mentre lei voleva solo sesso, emozioni, giocare, uscire dalla morsa della sua realtà, evadere attraverso i miei occhi e le mie mani.
Io invece l’ho messa al centro della mia vita e mi aspettavo che lei facesse lo stesso con me: non vogliamo la stessa cosa.
Io e Monica, invece sì.
Non posso paragonare quello che provo per Dana a quello che provo per
Monica, ma potrei dire anche il contrario, perché non sto tanto bene con Dana, quanto con Monica.
Dana continua a mandarmi via. In continuazione, a volte con crudeltà. Dice che lo fa perché lei non è la donna adatta a me. Così mi priva delle mie scelte e mi impedisce di decidere
liberamente.
Continua a non capire che quello che io non posso accettare, che quello che mi riempie di sofferenza, che quello che mi fa smarrire, è proprio e solo il fatto che lei mi mandi
via.
Il resto della situazione io l’ho accettato benissimo, Elisa per prima. Quello che mi dà Dana è quello che ho sempre cercato dal primo giorno della mia vita, ma sembra che ciò non le basti,
che non le sia comprensibile.
A questo punto io accetterò di amare Monica.
Non esiste nella vita il rapporto perfetto. Il bene e il male sono una cosa sola, fusi insieme in ogni realtà, perché l’uno è la genesi dell’altro.
Sto lavorando dentro me stessa perché il dolore di staccarmi da Dana non mi uccida e sto dando il tempo a Monica di entrarmi dentro e di prendere il posto che avrei voluto fosse di Dana, ma
che lei non vuole
avere.
Poi, io e Dana diventeremo buone amiche, ottime amiche e io vivrò unita a me stessa, senza avere rimpianti.
Io amo, amo la mia vita: voglio imparare a essere felice.
So che lo posso fare guardando me stessa e la realtà per quelle che siamo, facendo quello che voglio fare e andando nella direzione da
me scelta.
Voglio una compagna che amo e che non mi mandi via: se Dana non può tenermi con sé, non mi avrà.
Cresce dentro di me il senso della mia vita.
L’orgoglio ferito e la tangibilità della mia inadeguatezza mi aprono gli occhi.
Quante volte mi ha detto: «non ti amo», «non sei tu quella che voglio», «per me è solo sesso».
E io no, non le credevo: avevo un sogno e non volevo rinunciarvi.
Ancora una volta ho lasciato che la favola di Walt Disney mi portasse lontano dalla realtà. La favola dove bastano le buone intenzioni perché i sogni si avverino.
Così l’ho asfissiata con le mie parole, con le mie passioni, con le mie sofferenze, con i miei doni, con le mie poesie, con tutto quello che piaceva a me, senza curarmi se la mettevo in
imbarazzo, se le davo ciò che non mi aveva chiesto, perduta nel mio vortice di cui lei era solo spettatrice molto spesso forzata e più ancora infastidita.
Certo che si allontana da me. Certo che mi manda via: dal suo punto di vista ha ragione.
Mi sento stupida e ridicola, penosa e pietosa e io odio sentirmi
così, ma mi fa bene.
Domattina mi alzerò e mi chiederò cosa voglio fare.
E d’ora in poi, prima di dare qualcosa a qualcuno, aspetterò che sia lui o lei a chiedermelo, o almeno mi accerterò che lo voglia davvero: nulla è più importuno di un dono non
gradito.
E se mi sarà chiesta una cosa, ne darò mezza e l’altra mezza la terrò per me, che ne ho bisogno, tanto quello che darò sarà sempre abbastanza.
Smetterò di fare il cagnolino abbandonato, la pianterò di elemosinare qualche manciata di affetto.
So fare a meno di tante cose e farò a meno sempre di quello che non avrò. Senza struggermi e senza piangere. Senza domandare, senza aspettare, senza illudermi.
Imparerò a vivere di quello che ho adesso tra le mie mani, che sia tangibile, sicuro, certo e spontaneo.
I sogni mi hanno stancato: voglio nutrirmi di realtà e di me stessa.
Per chi vorrà venire, la porta sarà aperta, per chi vorrà prendere, le ciotole saranno colme.
Ma guarderò le pareti della mia casa e vedrò me stessa.
Anche con la bocca nella polvere, ma senza stampelle. Farò del mio orgoglio la mia forza e la mia potenza, la leva per risollevare il mio mondo.
E l’amore sarà sorridere insieme, non piangere da sola.
Le parole sono molto potenti anche quando sono menzogne o inganni, anche quando dopo segue il nulla. Anche quando sono fughe o scuse. Possono aprire o chiudere una vita, possono dare un
seguito o spegnere ogni luce.
Ci vuole coraggio, dietro alle parole, ci vuole pensiero, coscienza. Ci vuole
pazienza, ci vuole tenacia e perseveranza.
Dana mi dice «ti amo» solo quando si accorge che mi sta perdendo, o quando facciamo l’amore, entrambi momenti estremi dove ritrova tutte le sue forze e le sue verità.
Parlare quando non si sa quello che si vuole è molto difficile. O quando si vuole qualcosa che l’altra non vuole più.
Parlare significa anche offrire un’altra possibilità, rimettere le carte
in tavola.
E a volte le decisioni che abbiamo preso sono così traballanti, o così sofferte, che rimetterle in gioco è impossibile. Ci appoggiamo sulle nostre decisioni, ne facciamo il fulcro di un
giorno, di un mese, di
un anno.
Di una vita.
Ma la vita è fatta di attimi. Tutti grani di sabbia l’uno accanto all’altro, che devono scorrere uno a uno tra le nostre mani, se vogliamo che il secchio si colmi: uno a
uno.
I silenzi sono nebbie pesanti che inumidiscono la stanza, le pareti e una muffa sottile accompagna i vuoti.
Ogni giorno facciamo cose semplici, ripetendole all’infinito, o almeno, fino alla fine dalla vita: ci laviamo i denti, cambiamo le lenzuola, infiliamo le
scarpe.
Ma si può vivere anche diversamente. E non è detto poi che a piedi nudi si stia peggio.
Certo, è anche una questione d’abitudine. Forse le abitudini possono diventare pesanti, come catene. Cose che sembrano piccole, a volte pesano come massi.
Niente dura in eterno. Solo la vita, ma essa pure cambia abitudini e prende altre sembianze.
Apro la mia mano e ti lascio volare via, Dana.
Non ti stringerò più. Ti amo davvero, ma lascerò che tu viva anche se vorrai farlo lontano da me.
Io aprirò i miei attimi a ciò che entrerà lì dove lascerai un varco.
Sarà dolore, forse disperazione. Delusione, smarrimento.
Ma sarà aria nuova, un nuovo cammino, un nuovo inizio che, forse, mi riporterà da te, o altrove.
Ho pensato di non poter più amare, poi ti ho conosciuto.
Ora possiedo la consapevolezza di sapere amare. In maniera diversa, con altre parole e altri silenzi, con altri fremiti, ma il mio cuore ha imparato la strada.
Tu mi hai portato all’inizio di questo nuovo percorso. Mi hai preso per mano, mi hai fatto aprire gli occhi e mi hai mostrato la profondità dell’amore che è in me.
Non si prosciugherà, se io non lo vorrò.
E sarà stato grazie a te se ho trovato la forza di aprire gli occhi sulla realtà.
Se ogni lacrima è una perla, io oggi sono una persona molto ricca. Raccolgo le tue e le mie perle per farne un diadema e ornarne il nostro amore: anche se poi lo chiuderemo in un cassetto,
avremo un tesoro da custodire.

CAPITOLO
VENTINOVESIMO
Un camion nella
notte
Tutto si è sciolto nelle sue lacrime e nelle mie, fuse insieme nei nostri visi accostati.
Da quando ci siamo conosciute abbiamo cercato d’interrompere il nostro amore tante volte che ormai non si contano più, ogni volta credendo fino in fondo che fosse venuto veramente il momento, che io o lei finalmente
avessimo trovato la forza per farlo. Ma ogni volta le lacrime di dolore del nostro perderci ci hanno stretto di più l’una all’altra.
Abbiamo fatto di tutto, coinvolgendo anche altre persone, ma è impossibile: noi ci amiamo e siamo una cosa sola.
Il suo cuore nel mio, il mio cuore nel suo.
Oggi metto un punto fermo nella mia vita: basta fughe vigliacche. Troverò il coraggio di guardare la realtà e la mia realtà è lei, così com’è.
A chi penserà di me che sono folle, risponderò che ha ragione.
Ora folle di gioia, di amore, di orgoglio per me stessa. Folle di vita.
Alla fine di tutto io farò delle mie mani radici di quercia e afferrerò il mio destino per i capelli, ruggendo di determinazione.
Dana, non strapperai più dai miei occhi una lacrima che non sia forgiata d’amore e sostenuta dalla gioia, partorita dal futuro.
Finalmente io sarò conca per le tue lacrime, circo per le tue risa, palco per le tue danze, terra per le tue speranze, tempo per le tue attese, vino per le tue ebbrezze, acqua per il tuo battesimo.
Io sono un mattino, un autunno di mare che sospira e corre sulla pelle: atteso, sperato, giunto.
Il tempo siede ai miei piedi sorridente.
Ci accarezziamo.
Certezza della certezza, io oggi sono fiore di cardo, sasso di scogliera, spuma di mareggiata, ansa del fiume, canna di palude, volo di gabbiano,
soffio di balena.
Io sono.
Anche solo in lacrime, avrò l’orgoglio per ridere di me e svellere la terra del mio campo.
- ma quanto durò questo stato di grazia?
Due giorni...
Ecco che di nuovo è uscita da me: non la sento più, non voglio più sentirla. Dopo la sua ultima ennesima marcia indietro, dopo che mi ha portato lì, con il suo dolore nel perdermi, con le sue lacrime, con le sue parole, con il suo amore, lì dove volevo essere.
Dopo che per due giorni mi ha ricoperto di tutto quello che desideravo, che aspettavo, che sognavo,stamattina, come tutte le altre volte, mi ha
buttato di nuovo giù.
Ed è un empireo così alto che non ho più un osso sano, a furia di cadute e di spinte violente.
Allora, la fine agognata e temuta è finalmente arrivata.
Stasera, tra psicofarmaci e alcool, sono anestetizzata, ma non soffro per lei.
Soffro per la mia vita che non riesce a decollare, perché non so capire, perché sempre sbaglio, perché lancio sassi e rompo i vetri colorati che amo tanto.
Soffro perché soffro da sempre.
Domani soffrirò e dopodomani ancora.
Poi, forse, verrà il giorno in cui mi stancherò di soffrire e lascerò che la vita costruisca dentro di me i suoi mosaici, godendo dei colori delle pietre, adagiandomi sui miei pensieri senza scavarli come l’aratro che prepara la semina.
Forse arriverà un amore che sarà sostenibile, forse non ne avrò più neppure bisogno.
Paura certo no, ma il bisogno sparirà dal mio vocabolario grazie alla vita che scorre, al tempo che non si ferma, ai visi che se ne vanno e a quelli nuovi che entrano.
Ho vissuto una passione fremente: ha lasciato ricchezza, consapevolezza e tanta stanchezza. Ha lasciato tanti giorni nuovi di zecca da riempire: di
cosa non so. Di me, sicuramente.
Anche Monica è fuggita e io l’ho spinta via: meglio per lei.
Sola, nel silenzio della casa, ascolto Mozart e riempio le mie ore di note. Il mio letto mi darà il sonno che mi manca da mesi.
Domani ancora un nuovo inizio.
E come ho già scritto, la mia porta resta sempre aperta: addio a chi va, benvenuto a chi viene e se qualcuna deve tornare, sarà un nuovo
inizio anche con lei.
- Il giorno dopo.
È ancora buio e sono
La prima alba dell’inverno che si annuncia: un piccolo assaggio, stamattina. La distesa immensa del mare ha cangiato l’azzurro in un verde scuro, biancheggiante di spuma, tormentato e misterioso. Come se avesse trovato tutte le sue profondità e le portasse a galla.
Vecchio, caro, amato mare, piccola goccia dell’infinito, infinito specchio della mia anima…
L’alba è rossa.
Le onde disegnano riccioli sinuosi contro l’orizzonte, sbattendo violentemente sugli scogli.
Ascolto, respiro, cammino affondando i piedi nella ghiaia di queste spiagge impervie e affascinanti: ma fa bene per i muscoli.
Qualche pescatore è insoddisfatto: oggi i pesci hanno altro da fare, si
godono l’altalena.
Oggi sono sola. Nessuno a pranzo, nessuno a cena. Tutto il giorno per me.
Ho fatto tutti i miei progetti: un sacco di cose da fare e questa casetta, la Torretta, che mi accoglie e mi culla.
In spiaggia ho raccolto altre cortecce portate dal vicino torrente.
Le cornici ai miei quadri, fatti con materiali raccolti e completamente inutili, sono quasi finite. Quattro di loro fanno già bella mostra alle pareti.
Accolgo la solitudine, gli ultimi rifiuti.
A che serve lottare contro se stessi?
So che ho fatto quello che ho potuto, fino in fondo, onestamente.
Mi appago di questa sensazione di orgoglio e di pace.
Tra le piccole barche a riva dei pescatori che non sono usciti per il mare troppo grosso, le mie amiche gatte si sono fatte accarezzare, venendomi incontro. Vivono lì, in spiaggia, tra i navigli e lo strano armamentario della pesca. Sono quattro gatte adulte e due piccoline, tutte tigrate, mentre una delle cucciole è nera. A parte una, la più bella, marmorizzata e con incredibili occhi verdi, che è più riservata, la altre sono molto affettuose. Mi manca il mio cane. Ho pensato di portare con me una delle piccoline, la grigetta che mi tende gli agguati, si mette a pancia in su e afferra la mia mano, mordendo e graffiando allegramente, nel gioco tipico dei cuccioli di gatto. Ma i suoi occhi sono già pieni di mare, la sua vita è qui, non posso strapparla alle sue radici.
Ora mi metterò al lavoro con le mie cornici.
Il telefono è muto, ma il mio cuore parla. A volte canta.
Ho amato molto e questo non può portarmelo via nessuno.
Oggi è domenica, domenica per tutti…
Quando finisce un amore il letto diventa l’usuale piazza deserta, così come il tavolo, il libro che leggo, il pensiero, la voce, la musica.
Il cuore ostinato continua a battere e resta asciutto, neppure scalfito dal sogno buttato via dove gli occhi non osano più guardare.
Parlo a chi non ha ascolto per me.
Sono una donna che non scrive più versi, che piange continuamente, si ubriaca, si rincretinisce di ansiolitici, pulisce la casa come una deficiente, gioca con le biglie sul computer per far passare il tempo.
Non riesce a dormire che per due o tre ore ed esce alle cinque del mattino. In spiaggia, cammina fino allo stremo e fa fotografie al mare. Gioca a tennis con un allenatore meccanico col quale si può giocare da soli fino a che il braccio non le duole da non muoverlo più. Va sui pattini, goffa, indurita dagli anni e troppo grossa per farlo, con caparbia indifferenza, imbottita di protezioni per lo skateboard, che sono più robuste, cadendo e dando botte terribili sulla pista d'asfalto, fino a quando le gambe non la reggono più.
Lavora alle cornici dei suoi quadretti incollando per ore sassi, legnetti, sabbia, spago, conchiglie, foglie e tutto quello che le viene in mente, trovato in spiaggia o in campagna.
Si ripete in continuazione: non mi vuole… non mi vuole… non mi vuole.
Lei vuole Elisa, ama Elisa e con me vuole solo parlare e fare sesso.
Recita la sua preghiera Buddhista, a volte per lungo tempo, a volte per pochi secondi, ma aprendo ogni volta il cuore alla luce e aspettando che il buio, questa oscurità fondamentale, se ne vada.
A volte riesco a parlarle: Dana non vorrebbe perdere la mia amicizia.
Ieri ci siamo viste, io l'ho baciata e abbiamo avuto anche un breve momento di intimità, ma dentro di me urlo continuamente: perché non mi ami, amore mio?
La fuga di Monica, vittima di un’incomprensione, è avvenuta per colpa di una storia troppo confusa.
Come il sentimento che provo nei suoi confronti, la speranza che lei aveva acceso dentro di me si arrotola su se stessa e mi slabbra come un elastico vecchio e sfinito.
Sono una povera donna malata e stanca che cerca di stringere i denti, di ridere tra le lacrime, che cerca di lasciare aperta quella porta attraverso la quale sono entrate tutte le persone che ha amato, che cerca di non morire per poter continuare a vivere.
Eppure anche questo dolore, che certamente non sparirà mai, mi porterà dove sto andando.
Pure se tornasse, lei non tornerà più: il sogno è finito.
Ma lo spettacolo deve andare avanti.
Un’aria greve e rarefatta invade, raggela e rapprende il mio cuore, mentre rido sulla mia tomba…
Sono un fiore tra i ghiacci e i venti di tramontana.
Sono una foglia risucchiata via nel dolore del tempo che è culla di ogni bimbo e fucina di ogni sogno.
L’inverno è la mia stagione.
Il sole dentro, tra le nubi del mio destino.
- altri due giorni passano e Dana ritorna...
Ma anche oggi, di nuovo, come una lupa sottomessa, offro la gola bianca alla tua bocca padrona.
Ancora una dolce resa scioglie il nodo che la cingeva.
Infierisci! E lascia che l’amore renda azzurre le vene. Tu che nel mio corpo sempre cerchi e trovi rifugio alle tue giornate prive di sole, pur se mi costa il sangue quel tuo nasconderti in me.
A che servono tutte le parole scritte, tutte le lacrime sparse se sempre torni e se io, come un animale ferito ma prigioniero, sempre mi piego al tuo volere?
Dana è ritornata per l'ennesima volta, ma già stamattina avrebbe voluto scappare, mandarmi via, nella speranza che io trovassi quella forza che ho cercato tanto e che non ho, di rompere.
Ogni volta che mi perde si sente morire e appena le concedo un piccolo spiraglio, mi sommerge di tutto l'amore, la dolcezza, la tenerezza, la comprensione che solitamente mi nega.
Poi, appena la crisi è passata, si inventa mille problemi, i suoi, quelli di Elisa, i miei, va in confusione, non capisce più niente, si sente soffocare e vuole scappare via…
Stamattina ho provato per lei una struggente tenerezza, mentre al telefono mi strapazzava come di consueto e così le ho proposto di stare un po’ di tempo senza vederci, ma senza mettere la parola fine al nostro rapporto.
Le ho detto di prendersi tutto il tempo che le serve per capire cosa vuole, come stanno le cose. Io l'avrei aspettata il più serenamente possibile, senza cercare altro, solo vivendo la mia vita, nell'attesa di una sua maturazione.
Ma lei, questo, lo ha rifiutato.
Io pure, quando mi ferisce così nel profondo, io che sono così fragile, insicura, piena delle mie storie naufragate, dei rifiuti ricevuti da quando sono nata, desidero fuggire via, mettere fine a questa terribile tortura, perché l'amo così tanto che ogni cosa che fa, dice o pensa mi entra dentro ed è me, vive con me, vive di me…
Il grande amore cannibale è, canta Gianna Nannini… com'è vero!
È l'amore per Dana, di Dana che mi tiene sveglia e mi fa dormire, che mi fa digiunare o mangiare in modo compulsivo, che mi fa essere così felice da smarrirmi e così disperata da perdermi.
Mentre basterebbe che lei fosse se stessa, anche con le sue fughe, perché io l’amo proprio per quella che è, come è e non la vorrei diversa. Basterebbe che lei si accettasse e si amministrasse senza mettere ogni volta in dubbio tutto quanto; che capisse che la sua bellezza risiede anche in quelle parti di lei che non le piacciono, perché sono proprio quelle peculiarità che fanno di Dana la persona unica, irripetibile, straordinaria e amabile, sopra ogni altra cosa.
Sopra i vuoti, sopra le stanchezze, sopra le durezze, sopra le mancanze, sopra le assenze.
Lei. L'amore della mia vita.
- ma, il giorno dopo...
Il mare d’inverno colmava la mia anima di spume fredde e pulite.
Le grida dei gabbiani erano solitari lamenti del cielo.
Le nubi in rincorsa erano piombo, oro, argento, acciaio e rame.
Volavo sulle acque, radente gli spruzzi porosi ed esplosivi.
Lasciavo sulla rena intrisa di sale il fiato del mio passo verso il mattino.
Il giorno appena nato vagiva tra le mie mani.
Ero uscita a cercare canne e piante selvatiche per completare una cornice ed ero in riva al mare, vicino ad alcuni scogli, arrampicata a tagliare col mio coltellino le piante che avevo visto qualche giorno
prima e che mentalmente avevo già collocato dentro la mia composizione.
Dana mi fa il solito squillo ed io la richiamo, come sempre.
È stranita e scontrosa, mi parla di cose sue, mi dice che non ha voglia di sentire discorsi.
Sento che dentro di lei si ribella, fa i capricci, pesta i piedi, ma sento, sento qualcos'altro.
Io Dana la sento.
Quando le vengono le mestruazioni, io ho mal di pancia e sono in menopausa da tre anni.
Quando ha qualche cosa che le gira per la testa, e ne ha sempre, gira anche nella testa mia.
Quando soffre o piange, il mio cuore si spacca.
Quando gode io esplodo di piacere.
Cerco di consolarla, forse con discorsi troppo ovvi, ma lei corre impazzita lungo il suo binario e non mi ascolta. Corre, corre.
Intanto sono tornata a casa, e lei pure pochi minuti dopo arriva.
Il viso scuro, gli occhi duri, l'espressione di chi sta sputandosi in faccia allo specchio.
Apriamo una bottiglia di vino rosso, qualche bacio, ma è lontana, arrabbiata, lontanissima.
Ha freddo: lei ha sempre freddo… io ho sempre caldo.
Alla Torretta non c'è un divano e le dico di salire sopra in camera. Ci sdraiamo sul letto e io la copro col vecchio sacco a pelo di mio figlio
Gabriele, quello degli scout, che ho portato con me quando sono arrivata a Gabicce Monte con la roulotte e sul quale abbiamo fatto l'amore non so
quante volte e dentro il quale mi sono rannicchiata quando ancora la notte faceva freddo per cercare calore e un po’ di lei, per trovare il suo odore.
Lei trema, io l'accarezzo, cerco di farle sentire che sono lì, vicina a lei, ma Dana snocciola battute sciocche e ironiche, come fa sempre per non dare peso a quello che per lei pesa troppo. Poi finalmente comincia a parlare.
Di Elisa che fa passi da giaguaro, l'animale più veloce di tutti; di Elisa che fantastica su una casa da sistemare insieme a Dana, guardando due vicine di colore che stanno mettendo a posto un appartamento nel quale sono da poco venute a vivere; di Elisa che le dice di aver capito di amarla; di Elisa che al telefono, prima di chiudere la comunicazione, in fretta come
per non farsi scoprire, la chiama amore e poi al messaggio successivo di Dana, come il gatto che si è appena mangiato il topo, fa le fusa; di Elisa che sta bene, è serena, è felice e Dana le chiede cosa è successo e lei risponde: «non è successo niente».
Io lo so cosa è successo a Elisa, dico a Dana, ha te. Ha scoperto che ha te.
E vedo questa donna che non conosco ma che è padrona della mia vita, che ha quello che io desidero più di ogni cosa al mondo, e spesso sembra non sappia cosa farsene, o peggio, non lo voglia, vedo questa donna strana, contorta, complessa, intelligente e sento il suo cuore che si sta allargando, che sta riprendendo a battere, perché l'amore di Dana, così cocciutamente, caparbiamente, non l'ha mai abbandonata.
Sento la porta che si chiude.
Quella porta contro la quale Dana sta spingendo con tutte le sue forze fin dal primo giorno, dopo averla scardinata con un solo colpo secco, preciso e violentissimo.
Quella porta contro la quale io sono appoggiata tutta quanta, con i miei cento chili di muscoli e dolori, per cercare di non farla chiudere, di non farla cadere a terra e fracassarsi.
Perché è una porta di diamante, preziosissima, durissima, tenacissima, ma
fragilissima.
Lacrime.
Rivoli incessanti di lacrime calde e silenziose scendono dai miei occhi.
Io piango così, senza singhiozzi, perché ho imparato a far scorrere il dolore dentro di me, a non lottarci contro, per non morirci dentro. Le bagno la felpa di grosse gocce scure.
Le dico che è arrivato il momento di essere felice, che sono sei anni che aspetta l'amore di Elisa.
Lei mi risponde che la sta ingannando, che si sta prendendo gioco di quell’amore che sta nascendo, o rinascendo, penso io.
Io le dico di nuovo che è giunto il momento, che il nostro amore è come un animale che agonizza e allora facciamogliela, una pietosa eutanasia, a questo povero vecchio cane.
Anche Dana si mette a piangere e mi dice che lei non uccide neppure i ragni.
- Ma stai uccidendo me —, le rispondo.
E lì arriva il dolore.
Uno scoppio, una cannonata, una palla di fucile deflagrante nel mio petto. Mi lacera. Mi strappa via la vita. Arrivano i singhiozzi, i miei, i suoi. Ci abbracciamo, ci avvinghiamo… Mi dice che non vuole perdermi. Che vuole continuare a possedermi, che adesso avrebbe voglia di far l'amore e di farmi male, veramente male, come spesso ha desiderato e non ha mai fatto fino in fondo.
Io le offro il mio collo e la spalla, slacciandomi la camicia, chiedendole di affondare i denti dentro la mia carne, tanto più male di così non mi potrebbe fare. Ma lei non vuole.
Quando mi dice che non vuole perdermi mi sento sua prigioniera.
Le ripeto che io non voglio rompere con lei, che non voglio che lasci Elisa per me, che può continuare a stare così, con tutte e due, ma che, per pietà, smetta di lasciarmi, di mandarmi via continuamente.
Le dico che quando mi sveglio la mattina, sempre più presto, alle cinque, a volte alle quattro, non mi chiedo più, come facevo prima:
— Oggi mi lascerà, Dana? Ma : - A che ora mi lascerà oggi, Dana?
La imploro, piangendo, guardandola con tutto il mio amore e la mia disperazione e la tenerezza travolgente che provo per lei, di prendere una decisione.
O mi prendi o mi lasci, per pietà. Perché io sto morendo, io non ce la faccio più, io sono malata. Io sto di nuovo desiderando di suicidarmi. Io penso a un treno e a me che mi ci butto sotto, contro. E non lo voglio fare, non lo voglio fare, ma è come il canto della sirena, che mi attira, che mi cattura e mi porta via.
Sembra la pace e invece, è la fine.
All'improvviso, qualcosa, qualcuno, mi afferra per le spalle e mi scuote forte. Come se stessi correndo in macchina in autostrada a duecento all’ora, e mi fossi assopita senza accorgermene e mi risvegliassi all'improvviso, trovandomi di fronte un grosso, enorme camion lanciato contro di me a tutta velocità.
Lo shock, l'adrenalina, il sangue che si rapprende tutto nelle mie vene. Sterzo appena in tempo, come in trance. Rallento.
C'è una piazzola di sosta, metto la freccia e lentamente accosto.
Mi fermo, spengo il motore: il cuore batte all'impazzata, ma sono viva.
Il camion è passato, perduto nella notte. Il camionista è salvo…
Mi stacco dall'abbraccio di Dana, mi giro e prendo il telefono sul comodino. Cerco il numero.
— Cosa fai? —, mi chiede Dana.
— Chiamo Monica.
— Così?
— Così! Monica…. Ciao!! …Monica, scusami, lo so che sei stanca, ma ho bisogno di un favore.
— Che è successo?
— Te lo racconto dopo, mi vieni a prendere per favore, subito? Vorrei dormire da te…
Sì, arrivo, stai tranquilla, parto subito. Ti amo.
Mi abbandono sul letto: ora sono io ad avere freddo. Sono sfinita.
Dana si alza, va in bagno. Sento che si lava il viso.
Poi torna, piena di rabbia, vibra due o tre pugni violentissimi al materasso che sotto ha l'asse di legno.
Da rompersi la mano. Si accascia sul letto.
L'abbraccio, piango, le prendo la mano tra le mie, come per prendermi dentro il suo dolore e forse lo faccio davvero, come sempre.
La mano le fa male, molto, ma poco dopo le passa.
Mi chiede di non abbandonarla del tutto. Io le dico che l'amo, che l'amerò sempre, che ci sentiremo, che ci rivedremo, ma che non ce la faccio più, non ce la faccio più.
L'immagine del camion a un metro da me, mi scuote ancora violentemente.
Ci abbracciamo ancora, ci baciamo, ancora e ancora, ma io ho fermato la macchina, ho bisogno di dormire, non sono più in grado di guidare.
Ci ricomponiamo e scendiamo giù. Monica sta per arrivare e non vogliamo che trovi Dana lì.
Poi è molto tardi: suo marito è sempre più nero e ormai non apre più bocca.
Un ultimo bacio, come volesse entrarmi dentro con tutta se stessa, poi esce e se ne va.
Io comincio a preparare le cose per venire via: do da mangiare e da bere a Buddy, il mio piccolo pappagallo, riordino un minimo la stanza.
Quando Monica arriva, le basta uno sguardo: tra noi non servono parole. Lei sa benissimo cosa è successo perché ormai l'ha visto già tante volte. Mi abbraccia, mi bacia dolcemente, come fa lei, come una farfalla tenera e leggera e mi dice:
— Io ci sono e l'importante è che tu non ti distrugga.
Usciamo, fuori piove. In macchina le racconto un poco dell'accaduto, le dico che non ce la faccio più, e lo ripeto non so quante volte.
Ho smesso di piangere.
Arriviamo a Sant’Agata Feltria, dove lei abita, compriamo qualcosa per cena: pizza.
A casa mangiamo, sul letto. Io ho tanto freddo. Lei accende la tv, c'è un telefilm che le piace tanto, ma io sto crollando e mi addormento così, senza accorgermene.
Dormo profondamente qualche ora, poi mi sveglio e passo il resto della notte in un dormiveglia farneticante.
Sogno Dana e poi alcuni creditori che vengono a riscuotere brutalmente quanto spetta loro e che io non ho e Monica, che fa conti, cento euro, duecento. E io le dico che sono quarantatremila…
Finalmente sorge il mattino. Mi accorgo che mi sto svegliando e sono girata su di un fianco verso di lei.
Ho gli occhi chiusi, ma la sento respirare regolarmente.
Poi sento che comincia a destarsi.
E così, ancora più nel sonno che nella veglia, allunga la mano, cerca la mia, la trova e la stringe, dolcemente, avvolgendola con la sua.
Senza parlare ci destiamo lentamente, insieme.
Penso che quella mano è mia. Capisco che lei mi vuole, che quella è la mia
casa.
È presto. Monica deve andare a lavorare, ma è presto, neanche le sei. Io comincio a dipanare il filo dei miei pensieri.
— Quest'inverno lo passerò a Gabicce Monte —, le dico, — verrei domani, qui, ma è meglio se siamo prudenti e facciamo le cose con calma. All'inizio
dell'estate portiamo la roulotte in un campeggio qui vicino, così sei più comoda e devi fare meno strada. Io passerò l'estate in roulotte e tu andrai e verrai come più ti piacerà. Poi, alla fine dell'estate,
se tutto sarà andato bene, potrei venire qui, se tu vuoi…
E Monica mi risponde:
— Sì, benvenuta, amore mio, nella mia casa, nella mia vita…
Poi ci mettiamo a progettare come rimettere a posto il suo appartamento, che è un po’ trascurato, per così dire, e io le racconto tutte le idee che mi vengono in mente, parliamo di mensole, colori, quadri, finestre, tende, muri, letto, divano.
Ci alziamo. Caffè per lei, latte per me, poi lei fa la doccia.
Recitiamo insieme le nostre preghiere Buddhiste.
Stamattina nello specchio il mio viso sembra quello di un pugile dopo un durissimo combattimento: gonfio e pesto, non sembra neppure il mio…
Ma mentre prego, sento che qualcosa si sta sciogliendo dentro di me: le nostre voci si accordano, trovano l’armonia, si fondono in un dolcissimo
canto mistico.
Penso a Dana, penso che non ho più paura.
Non l’aspetterò più: oggi non mi lascerà, perché io ho fatto la mia scelta. Io sto con Monica.
Penso a quanto l'amo, a quanto amo tutte e due.
Penso ancora che ho scelto Monica.
Che vedrò Dana, che l'amerò per sempre, che le starò accanto tutta la vita, se vorrà, che ci vedremo e faremo ancora tante cose insieme, anche l'amore. Ma non ho più paura.
Finita la preghiera racconto questi pensieri a Monica e lei mi dice che sa cosa siamo io e Dana e che lei lo accetta, che ora sa cosa prova per me, e che ha deciso.
E di nuovo mi dà il benvenuto nella sua casa.
Io la ringrazio di nuovo ed è da ieri sera che le dico grazie, perché sento dentro di me una gratitudine che è speranza, che è dolcezza, che è unguento su tutte le mie ferite che non si chiudono mai e voglio che questo bene arrivi anche a lei, che lo accetti.
Lei mi ringrazia dicendomi che le sto insegnando a riaprire la sua vita, ad accettare i suoi sentimenti.
Poi si è fatto tardi e Monica, dopo le ultime raccomandazioni, come se mi lasciasse in una landa desolata e non in casa sua, esce per andare al lavoro.
Io aspetto ancora qualche minuto, stringendomi a me stessa, con profonda tenerezza, dandomi tutto l'amore che riesco a trovare dentro di me.
In bagno sorrido a quel povero viso disfatto, poi chiamo Dana.
Le racconto del camion, le dico che sono ferma nella piazzola di sosta, che la piazzola è Monica e che non sono ancora pronta a rimettermi
alla guida, che sono tanto stanca.
Lei mi chiede che autostrada avrei ripreso e io le dico che non lo so, che dipende da tante cose.
So che le sto mentendo, che io la scelta l'ho già fatta, ma qualcosa ancora dentro di me urla.
Voglio che lei mi dica quello che deve dirmi, perché so che deve dirmi qualcosa. Lo sento, come sempre.
E penso che l’eventualità di una sua rottura con Elisa mi lascerebbe in un brutto guaio.
I visi di Dana e di Monica si confondono insieme, mi coglie una specie di vertigine che mi fa vacillare.
Così mi sdraio sul letto e mi copro con la coperta di Monica: ho ancora tanto freddo, io che non ho mai freddo, e qui c'è il riscaldamento acceso.
Dana mi dice che deve accettare quello che prova per me e lasciar perdere i sensi di colpa e smettere di fare le mie scelte e pensare a sé e vivere ciò che ha dentro e lasciar vivere a me quello che ho dentro io.
Dana mi dice che mi ama e me lo ripete.
Me lo dice ora che sto cercando con tutte le mie forze di chiudere per sempre quella porta, in un altro disperato tentativo di farmi tornare sua schiava.
Ma io penso che è troppo tardi.
Io l'amo e l'amerò, ma ho spezzato la catena che ci legava: soffocava
lei e stava uccidendo me.
Io desidero, voglio una compagna, una casa, una vita.
Desidero Monica.
Dana mi ha mandato via una volta di troppo e ora è troppo tardi, non posso più accontentarmi delle sue briciole.
Le racconto allora della mano di Monica al risveglio e di tutti i pensieri e i progetti, le dico che ho fatto la mia scelta e che non ho più paura. Che l'amo, ma non ho più paura.
Che ho voglia di vederla, che ci rivedremo presto.
Parliamo di andare a Roma insieme a Monica: c'è Gauguin a Roma e tutte
vorremmo vederlo, anche Elisa… come siamo unite!
Quattro donne unite nell'amore, anche se una non è partecipe, ma comunque unita a noi persino in queste piccole cose.
Dana infatti mi dice spesso che io ed Elisa abbiamo molte cose in comune, e spesso mi accorgo che Dana e Monica, per certi versi, sono una fotocopia l'una dell'altra.
Mentre le racconto queste cose avverto il dolore di Dana, la sua gelosia, la sua disperazione.
Ieri questo sarebbe bastato, anzi, cosa dico, la metà della metà della metà sarebbe bastato per farmi tornare indietro sulla mia decisione, per pensare di dire a Monica:
Grazie tante di tutto quello che hai fatto per me, ma io amo Dana e le voglio dedicare tutta la mia vita.
Ma ieri sera, il camion…
E ora sono qui, stanca, sfinita, ma serena.
Amerò Dana con tutto l'amore che c'è dentro di me e altrettanto ne darò a Monica, perché, io dico sempre, l'amore è un secchio che non si vuota mai.
Ma è tardi: io sto con Monica.
Lascerò che sia lei a guidare, perché io ho tanto sonno e non ne sono in grado.
Il camion è fuggito nella notte, il camionista è salvo e io sono viva e amo.

CAPITOLO
TRENTESIMO
Inaspettatamente...
- a casa di Monica...
Mi desto dopo un sonno profondo. Ho bevuto la notte fino alla sorgente. Ma l’improvviso risveglio alle radici dell’alba è orfano della tua mano.
Se tu fossi qui, Dana!
L’ora antelucana vivrebbe il morbido abbraccio del nuovo giorno.
Sarebbe una carezza del cielo, un bacio del mio destino.
Il fiore di cardo assaggerebbe la tenerezza della viola.
- telefono a Dana...
Piangi, Dana, tra le mie braccia.
Sei più di mia madre, più di mia figlia, più di mia moglie. Più della mia vita. Cade ogni tua lacrima nel mio cuore di sabbia.
Scava ogni tua lacrima nel mio cuore di roccia.
Vive nel mio cuore di acqua.
Anch’io piango.
Ogni battito del mio cuore è come poesia, scritta per te.
La mia anima risplende di luce propria che tu rimandi come fa il mare calmo d’inverno, quando riflette la luna di madreperla.
- torno alla torretta...
Alle cinque del mattino la notte cala nell’alba.
Ottobre finisce: il mare bussa al mio sonno mentre piove.
Assorta nella pioggia che cade, io pure scendo a rivoli e mi spargo. Penetro ogni fessura colmandola di inestimabile tenerezza.
Perdere l’amore di Dana è come una spiaggia inaccessibile, invasa di rifiuti dove onde furiose tengono tutto lontano da me.
Non voglio altro che questa silenziosa desolazione.
La mia voce scandisce il tuo urlo: un grido sulla mia tomba senza fiori. Quello che io sono è un gradino di pietra, uno scoglio.
Una balena che sbuffa all’orizzonte, un gabbiano che grida all’alba.
Un treno impazzito.
Io sono alluvione, sono forza, tenerezza e friabilità: sono un cuore in una
mano. Sono un pugno.
- qualche giorno e di nuovo a casa di Monica
Sono ancora a casa di Monica.
Questa casa che mi veste come una calda mantella. Nel mattino sento sapori d’autunno e me ne avvolgo.
Mi cullo nel letto di foglie rosse, gialle e brune delle sue braccia.
Il mio cuore giace muto e fermo, immobile, inconsolabile.
Nel profondo dell’amore per Dana che non è realtà della mia giornata ma vive nel mio sangue, così che ogni mio respiro è una scia di frantumi.
- Poi accade l'impensabile: l'antivigilia di Natale siamo tutte e tre alla torretta: ognuna di noi ha preparato qualche piccolo pacchetto, piccoli pensieri da
dedicare alle altre due. Io avevo messo un po' di decorazioni in casa, avevo preparato un ottimo risotto per cena, il vino portato da Dana era fresco e vivace, il dolce portato da Monica era una
soffice crema.
Mangiamo e beviamo, allegre, scherziamo. Quando poi apriamo i piccoli pacchetti multicolori, un po' di commozione si mescola alle risate: ' Non dovevi, è
bellissimo... ' ' Ma come facevi a sapere che desideravo proprio questo??? ' di certo i miei consigli dati ad entrambe sono stati utili per azzeccare il dono giusto...
Loro due si guardano negli occhi, con lo sguardo lucente. Siamo in piedi, nel mezzo della stanza, una canzone dolce esce dal pc e ci avvolge. Ci stringiamo, tutte e
tre, ci guardiamo, sorridiamo, sempre più vicine, io bacio Monica, poi Dana, loro ricambiano il mio bacio con semplicità, con amore. Di nuovo si guardano, siamo vicinissime ed io spingo
dolcemente i loro visi l'uno contro l'altro, a sfiorarsi. Le loro labbra si percepiscono si trovano, si allacciano. Dana e Monica si baciano poi si staccano per guardarmi e mi vedono sorridente,
ebbra di gioia: io le amo così tanto e vedere che loro si amino è per me felicità pura, emozione pura.
Non servono parole, è l'amore che dice tutto, fa tutto per noi e ci troviamo unite, come mai eravamo state, nell'amore, nella vita e nel letto.
Amo due donne. Tremo e fremo: vi bramo qui accanto a me, tra le mie braccia, tra le mie mani, sulle mie labbra. Sulle vostre labbra. È come volare lontanissimo, come navigare in vuoti
infiniti di armonie tra gli echi ondeggianti delle nostre parole.
L’amore fuso nelle nostre vene, l’amore diviso tra noi, spartito come un pane dolce e salato, vive, ancora vive. Finalmente vive.
In esso mi sciolgo e mi perdo. Mi lascio, mi accantono, mi abbandono. Mi libero e volo via lontanissimo, senza più affanno: vago nelle pieghe della mia mente cogliendo i fiori della pace,
che per me è un bene sconosciuto, invano ricercato e rincorso.
- io e Monica chiudiamo la Torretta e torniamo a Sant'Agata Feltria. In macchina parliamo, lei è raggiante, io sono così felice che quasi non ci credo. Le chiedo
cosa ha provato, nel letto con me e Dana, lei chiede la stessa cosa a me, ma le parole sono solo una corona, perché il nostro viso parla da solo. Mentre guida ci teniamo le mani strette strette e
ci guardiamo spesso sorridendo. Decidiamo che passerò quattro giorni della settimana con lei e gli altri tre al mare, per poter stare da sola con Dana e la domenica, quando tornerà a prendermi,
ceneremo insieme tutte e tre. Trascorriamo il giorno di Natale con la sua famiglia, mentre il giorno di Santo Stefano ci rechiamo ad Imola per festeggiare con i miei ragazzi. Ormai Monica è di
casa, da loro, è ben accetta ed accolta. Ricordo quel giorno come uno dei più belli della mia vita. Arriviamo cariche di pacchetti e pacchettini per tutti e loro pure hanno preparato tanti
pensieri per noi. Il pranzo è così allegro, io sono così felice insieme ai miei figli che finalmente hanno accettato una mia compagna, sono così felice... e in mezzo a tutta quella gioia, nel
cuore mi stringo a Dana, perché so che la vedrò presto: nella settimana seguente, prima dell'ultimo dell'anno passerò, come d'accordo, un paio di giorni a Gabicce per poter stare con
lei.
Ritrovarci sole, dopo esserci divise con Monica, è forte e sconvolgente.
Vorrei violarti, portarti dove non sai, dove non sei: su rive impervie che non conosci, rivestirti di raso e di seta lucente e poi prenderti.
Allora fermerei i miei occhi e vedrei la perfezione: noi due unite.
Troverò prima o poi in me il gancio a cui attaccare tutto il mio sconfinato dolore.
Oggi scrivo una parola piccola e sicura che tu possa posare dove ieri io ho posato le mie labbra accurate e impudiche.
Ma dove non le ho posate?
Se è rimasto un attimo di te che io non abbia toccato mai, ecco, ora pongo il sigillo d’amore che non conosce pausa né riposo, che non si cura del tempo che passo lontano da
te.
Che suoni come tutti i baci che non ti do.
Perché due donne che si amano sono un sorriso sfuggevole tra capelli biondi e corvini, sono mani gentili su un seno appena fiorito. Sono cosce dischiuse a una carezza rubata nella penombra
della casa vuota.
Hanno occhi lucenti e silenziosi, nonostante la vita.
L’amore di due donne è forte come una radice.
- ma Dana, nonostante l'inaspettata svolta della nostra storia, continua ad avere sensi di colpa nel confronti di Elisa e continua a cercare di
lasciarmi...
Questo amore contrastato è un pugno di lacrime asciutte e inespresse.
È sgomento e rimpianto sgorgato dalla speranza.
Dana è una donna da amare e lasciare ogni giorno: è un viaggio quotidiano senza ritorno.
Sul tavolo, sul letto, alla finestra, lei: la cosa che non avrò.
Il moto dei tuoi fianchi cavalca la piazza acciottolata tra le mie gambe. Come un palio.
- ma io vivo meglio, più serenamente i suoi contraccolpi, perché c'è Monica che mi accoglie, che mi da fermezza, che mi da una speranza, sempre.
Stamattina vesti i tuoi occhi del mio sorriso più nuovo.
In questi giorni d’autunno la mia messe matura sta invadendo il granaio vuoto della mia infanzia.
Nella tua casa, Monica, aspetto l’inverno lieve della raccolta del tuo frutto inatteso, caduto nel mio grembo ormai desolato.
La neve delle mie tempie sarà argento nei tuoi anni di grano.
- eppure quando torno a Gabicce, il groviglio di amore, passione e rifiuti che è il rapporto con Dana, ogni volta sembra prendere il sopravvento dentro di
me.
Un mare sporco rotola incessante e batte i muri di calce. I miei pensieri sono come creste, sono come scogli scolpiti, forze estreme di profonde mareggiate su sabbie invase. Resto
aggrappata come in un naufragio: la mia vita è una zattera infinita.
Tu sei la mia vita, Dana: ancora e sempre ti chiamerà amore la mia voce, che tu ami.
Ancora e sempre le mie dita correranno le vie del tuo corpo e del tuo piacere, ancora e sempre esploderò dentro di te.
Non c’è davvero chi possa interrompere la mia vita e tu sei la mia vita.
Tamburi in lontananza: scrosci, risonanze. Mi avvolgo nel nido di piume del mio cuore: oggi viaggio senza bagaglio.
L’aria fredda domina le stanze di questa casa al mare invasa da una luce diafana.
Sento l’urlo lontano della rupe.
Nascosto nel doppio fondo il sogno dell’amore è sfilacciato ed esausto,
ma ancora vivo.
Le tue labbra sono ali aperte, ubriache di vento.
Le coppe dei tuoi seni sono cirri vertiginosi.
Le mie mani sono aquile impazzite di luce.

CAPITOLO
TRENTUNESIMO
L'incantesimo si
spezza: un antico
omicidio.
- Questo capitolo viene scritto oggi, 29 marzo 2012, quindi è un ricordo filtrato negli anni..
Era bello in tre.
Nulla da nascondere, nulla da evitare di dire. Nessun fremito da trattenere.
Quando io e Dana ci amavamo, parlavamo di Monica, quando io e Monica ci amavamo, parlavamo di Dana.
La casa di Monica non era adatta a contenere un'altra persona. Lei dormiva in un lettino singolo. Aveva si un'altra rete con un altro materasso, ma non era alla stessa altezza e quindi era
molto scomodo per gli abbracci e per dormire vicine. Ed io e Monica volevamo dormire abbracciate, darci tutto l'amore che ci portavamo dentro, colmare tutte le solitudini dei lunghi anni passati
a dormire da sole.
Inoltre l'appartamento era davvero in un stato pietoso ed io, che sono assai meticolosa e pignola, proprio non potevo pensare di vivere in quella disordinata disperazione.
Così facemmo tutto un piano di rinnovo: nuovi colori alle pareti, nuovi mobili per la sala, la creazione di uno studio con un immenso tavolo per il mio lavoro di pittrice ed i nostri pc,
mensole per la cucina e un nuovo letto per noi.
E fu proprio il letto che fu acquistato per primo: lo ordinammo per telefono con e ci venne consegnato nel giro di non troppi giorni.
Nel frattempo io e Monica ci recammo ad acquistare un bel piumone nuovo ed altri svariati articoli per la casa che mancavano all'appello. Comprammo così anche le mensole da piazzare in
cucina, le vernici e i pennelli per il mio lavoro da imbianchina.
Fu così divertente vagare per il grande centro commerciale, scegliendo piatti, posate bicchieri, tovaglie cestini colorati, stendibiancheria e tutta una serie di aggeggi che io
assolutamente dovevo avere per essere la casalinga perfetta che ero prima del mio tragico incidente che mi sarebbe occorso alla fine del 2009.
Allora davvero non potevo immaginare: se solo avessi potuto, la mia vita sarebbe stata drasticamente diversa.
Ma gli esseri umani danno tutto per scontato, tutto per dovuto e non si rendono conto di vivere appesi ad un filo.
Così sciupano tantissimi dei loro tesori.
Ma allora ero così felice che mi sembrava di avere il mondo tra le mani.
Mi misi così subito al lavoro e la prima stanza che tinteggiai fu la cucina, per la quale avevamo scelto un giallo caldo ed intenso, ma morbido, come una crema soffice, e per gli infissi un
giallo sole acceso.
Gli infissi erano di legno vecchio e tarlato in un modo pazzesco. Il lavoro di carteggiatura con la levigatrice orbitale e di stuccatura prima della verniciatura fu abbastanza impegnativo,
ma io ero un imbianchino provetto, avendo cominciato quel bellissimo hobby in giovanissima età e quindi non ebbi eccessivi problemi. In una manciata di giorni la cucina fu ultimata e risultò
bellissima, luminosa, accesa, piena di luce e vita.
Mi dedicai allora alla camera da letto: pareti e soffitto azzurre e grandi vascelli di nuvole bianche e azzurrine che le solcavano, gli infissi blu notte.
Avevo trovato tra i lampadari nel centro commerciale uno da cameretta per bambini: era un aeroplanino di legno modello biplano, verde e rosso. Come una bambina feci bizze perché Monica
acconsentisse a comprarlo, lei che avrebbe desiderato qualcosa di più serio, ma cosa volete che vi dica, so essere convincente e così ebbi il mio giocattolo da appendere.
Come testiera del letto avevo acquistato una assicella larga quanto il letto e per comodini delle cassettine di legno grezzo assai carine, modello baule di una volta o forziere di pirati,
che dipinsi di blu scuro come le finestre.
Un grande poster di stoffa raffigurante Il bacio di Klimt avrebbe concluso la mia opera.
Lavorai alacremente e anche questa volta nel giro di una settimana tutto fu pronto.
C'erano allora da montare le mensole e la testiera e ci voleva il trapano, ma né io né Monica ne avevamo uno.
Si propose allora Dana e quella fu la prima volta che lei entrò nella casa di Monica.
Nel frattempo era arrivato anche il letto.
Quella domenica pomeriggio Dana arrivò con tutti gli attrezzi del mestiere e si mise all'opera aiutata da Monica, mentre io in cucina sfornellavo per preparare il mio famoso risotto
montanaro. Vi erano dolci e vino, che cominciammo a bere come aperitivo.
L'atmosfera era allegra, ma più che allegra, affettuosa, ammiccante e complice. Io guardavo le mie donne che testa contro testa trafficavano attorno ai tasselli ed al trapano, le guardavo
versare i loro occhi negli occhi con franchezza e dolcezza ed il cuore mi si stringeva di amore ed emozione.
Le mensole e la testata furono montate, il materasso tolto dal cellofane posato sulla rete e vestito con le lenzuola ricamate che la madre di Monica aveva tanto tempo prima comprato per un
corredo mai usato e che fino allora erano state custodite nelle loro scatole di cartone demodé. Il grande poster fu appeso così come il lampadario: il risultato era stupendo. Il quadro marino che
avevo dipinto per Monica fu piazzato sopra il comò e al muro sopra i nostri rispettivi comodini collocai le foto di figli e nipoti, ricordi di una famiglia che di certo mai avrebbe messo piede in
quella camera.
In piedi vicino la porta, strette ed abbracciate guardavamo il frutto del nostro lavoro: gli occhi di Monica luccicavano, io mi sentivo ebbra di gioia e da quell'abbraccio scivolammo in
abbracci più intimi sul nuovo talamo d'amore con naturalezza.
Qualche sera dopo io e Monica decidemmo che sarebbe stato saggio e giusto rinunciare alla torretta: l'affitto non era economico e quel denaro io avrei voluto impiegarlo per contribuire alle
spese di casa: essere ospite non mi piaceva affatto, pur se il lavoro che avevo svolto di certo valeva assai più di quanto fino ad allora avevo ricevuto.
Ma non era solo una questione economica: veramente ci sentivamo legate in modo indissolubile, tanto che io e Dana parlando ci eravamo scambiate la medesima impressione e cioè che Monica si
fosse innamorata di lei.
Il modo in cui la guardava, come le parlava erano per noi inequivocabili, inoltre loro avevano uno scambio di messaggi telefonici e telefonate tutto loro nel quale io non entravo e del
quale io non ero affatto gelosa, anzi: vederle così unite mi rendeva felice in un modo profondo, come se i lati di una ferita si fossero finalmente ricongiunti e stessero guarendo.
Così passai gli ultimi giorni nella torretta vivendo con commozione un nuovo distacco e ore tutte dedicate a Dana, poi trasferimmo tutte le mie cose nella casa di Monica e Dana fu di nuovo
invitata da noi, la domenica successiva.
I lavori erano ancora molti da fare, ma l'appartamento stava diventando davvero bellissimo.
Anche quel pomeriggio fu inevitabile trovarci a far l'amore tutte e tre, perché il desiderio che provavamo l'una per l'altra era così forte e vi era una totale franchezza che rendeva tutto
facile e spontaneo.
Di tacito accordo quando io e Dana eravamo con Monica ci dedicavamo principalmente a lei, tralasciando di fonderci così completamente come ci accadeva quando eravamo sole: questo ci veniva
naturale per un innato pudore nei suoi confronti e per una delicatezza che ci impediva di sbatterle in faccia quanto il nostro legame e la passione che scaturiva da noi fosse forte e
travolgente.
Non che Monica non lo avesse capito: le era perfettamente chiaro quanto fosse fatale la forza che ci attraeva, ma di certo il guardarci le avrebbe fatto molto male, dato che avrebbe potuto
facilmente fare il confronto tra quello che succedeva tra me e lei che, pur bellissimo, non era di certo paragonabile; ma quel pomeriggio, non ricordo neppure come accadde, tutto fu irresistibile
e ci trovammo come fossimo sole, io e Dana.
Ci trovammo fuse, allacciate insieme, io perduta totalmente in lei con la mia parte mascolina che si ergeva potentemente pur se corpo non ha mai avuto e mai avrà.
Desideravo fosse mia, lo desideravo così forte, ero sconvolta da quel desiderio, ero rapita trasportata altrove dove lei era davvero mia totalmente, dove i nostri corpi si incunevano
perfettamente l'uno nell'altro, dove lo spasimo voleva essere prolungato, dove vi era una totale cessione della sua vita nelle mie mani.
Sentii il piacere ruggire in me impennarsi e gridai, gridai come un animale, come un felino sulla preda, desiderai avere la sua resa, cercai con le mani la sua gola e la catturai, ancora
gridando, poi sentii defluire fuori di me lava incandescente e mi accasciai sul suo seno ansante.
Come in sogno vidi allora una giovane donna mulatta giacere inerme, morta, sotto di me, io uomo bianco, suo signore e padrone, la vidi con il viola che stava affiorando sulla sua tenera
gola ancora fortemente stretta dalle mie dita convulse. Di certo quel gioco erotico, per aumentare a dismisura il piacere, che avevamo fatto molte volte, quel giorno mi era fuggito di mano ed io,
in preda ad una folle passione, l'avevo spinto troppo oltre.
Mi scostai di scatto da lei e ritornai in quel momento nel presente, dal luogo lontanissimo di una mia vita passata nella quale mi ero ritrovata inconsciamente come molte altre volte mi era
successo.
Ma quando riuscii a scuotermi del tutto vidi per prima cosa il volto terrorizzato di Dana, vidi i suoi occhi sbarrati, vidi le mie mani strette attorno al suo collo che recava i segni delle
mie dita e poi il volto di Monica che, in piedi, nuda accanto al letto, ci guardava con una espressione di raccapriccio e furore che mi scosse profondamente.
Fu difficile per tutte e tre, il seguito, da quel giorno, ancora più difficile.
Si capì che io avevo avuto un tuffo nel mio passato remoto e ricostruii la storia, che si era svolta nella mia mente, di un giovane maschio bianco proprietario di una piantagione di canna
da zucchero nel settecento circa in uno stato dell'America del sud. Che aveva questa giovanissima schiava creola con la quale si congiungevo carnalmente e con la quale spingeva al massimo quel
pericoloso gioco erotico, causandone quindi, pur non volendolo, un giorno la morte. Ricostruii quindi il cammino che da alloro ci aveva portato fin qui riconoscendo il mio profondo debito karmico
nei confronti di Dana, ma questo non bastò a cancellare quanto accaduto.
Anche se non me ne si poteva imputare colpa, eppure io ero comunque l'esecutore antico e il collegamento attuale di quel gesto, il peso del mio destino era mio e di nessun
altro.
E nulla fu più come prima.
Monica non volle mai più incontrare Dana e mi chiese di distaccarmi definitivamente da lei.
Ma questo ora lo leggerete seguendo la narrazione scritta allora, nel mio diario personale.....

CAPITOLO
TRENTADUESIMO
Un nuovo inizio
- questo capitolo è largamente rimaneggiato rispetto all'originale della prima edizione. Anche qui ho aggiunto parti importanti della narrazione che
mancavano
La mia vita è piena di nuovi inizi.
Il 2008 è giunto è ha gettato fuori il 2007, con la sue svolte.
L’anno appena passato ha marcato un profondo cambiamento nella mia vita e in me: le due persone che ho incontrato, Dana e Monica, hanno segnato traguardi e punti di partenza che fino
all’ultimo mio giorno pulseranno vividi e forti nella mia mente e nel mio cuore.
Traguardi che mancavano alla mia vita, partenze che sono appuntamenti con il mio cammino e con il desiderio di vivere un’esistenza preziosa, piena, colma, avventurosa,
insostituibile.
Loro due sono ponti per valicare i profondi baratri scavati in me dal mio passato, quello di questa vita e quello remoto.
Sono espedienti per dare benzina al motore della mia lotta e delle mie vittorie, per trasformare i miei dubbi e le mie mancanze in ricchezza e capacità di proseguire.
Ogni ostacolo vissuto nel nome dell’amore, ogni lacrima versata, ogni goccia di sangue perduto sono stati cibo per la mia anima, per la mia inesauribile voglia di imparare.
Sono colori che potrò buttare in un quadro o parole che potrò unire in una poesia, sono sorrisi per ogni risveglio e cuscino per ogni sonno.
Sono materia per ogni sogno.
La compagnia di queste due donne a me affini, a me sorelle,dell'anima mi ha teso la mano quando mi sembrava impossibile proseguire il mio cammino, mi ha dato nuovi scopi, nuovi stimoli,
nuovi traguardi.
Oggi sento fortemente l’amore per me e per tutte le persone che amo: lo sento proveniente dal mio passato, lo vivo attimo dopo attimo nel mio presente, lo proietto nel mio
futuro.
Ringrazio queste mani che hanno raccolto la mia ascesa faticosa e solitaria, questi occhi nei quali ho riscoperto i miei, queste parole che mi hanno fatto gioire o soffrire, perché devo
loro molto.
Se a Gabicce le casette basse in riva al mare hanno l’acqua che lambisce le fondamenta, la sabbia sulla soglia, il rumore delle onde alle finestre, la mia casa in collina, la casa di
Monica, siede sulla roccia e guarda i monti lontani. Sorride agli ulivi. La notte si accende delle luci dell’antico borgo.
La casa è la mia conchiglia e Monica è la mia donna, il mio scoglio.
Alla metà di febbraio finalmente avevo finito i lavori per rendere abitabile e accogliente questa casa: quando ci avevo messo piede per la prima volta era un magazzino
abbandonato.
Avevo lavorato duramente, ma ne era valsa la pena.
Certo, qui sarebbe stato tutto da rifare: infissi, rivestimenti, pavimenti, impianti, mobili e altro ancora, ma sarebbe stata una spesa insostenibile per Monica.
Io avevo solo dato una mano di colore a tutte le superfici, pulito e risistemato l’intero appartamento, cambiato ogni disposizione, ridando così la dignità a quella povera casetta derelitta
che Monica aveva lasciato andare alla derive proprio come aveva fatto con il suo cuore e la sua disponibilità di amare..
Avevo fatto del mio meglio ed ero stanca, ma contenta.
Il giorno in cui tutto fu concluso in piedi al centro della casa, mi guardavo intorno.
Era un appartamento pieno di sole e il giallo e l’arancio delle pareti e delle finestre mi rallegravano.
La camera da letto aveva un cielo azzurro solcato di vascelli di nuvole bianche e da un aeroplano come lampadario.
I miei quadri appesi non sfiguravano affatto. Ne avevo dipinti altri due. Uno lo stavo finendo: raffigurava due donne, ma forse è meglio se torno a dipingere paesaggi.
Era rimasto ancora qualcosa da fare in casa e soprattutto bisognava rimettere a posto i terrazzi, con tapparelle e ringhiere, ma non mi spaventava: il resto era tutto ordinato e
accogliente.
Monica era molto contenta.
E io ero a posto?
Sabato 16 febbraio avevo deciso ancora una volta di riprovare a rompere definitivamente con Dana.
E pensare che giovedì 7 ero uscita da quella casa pensando di non tornarvi più.
Monica aveva avuto un'altra grossa crisi di gelosia, dopo quella del nostro ultimo incontro a tre, dovuta all’ultima volta che io e Dana ci eravamo viste, il primo febbraio, giorno del mio
compleanno.
Il giorno prima mi ero fatto accompagnare da Monica in stazione e mi ero recata a Gabicce per trascorrere alcune ore con Dana . Erano state le ultime ore alla torretta, perché proprio quel
giorno ne avevo consegnato le chiavi al suo proprietario.
Dana aveva avuto per me regali e bigliettini e una sorpresa che io davvero non mi aspettavo: venne la mattina del primo a prendermi presto, senza passare da Elisa come suo solito e mi
accompagnò a fare colazione in un bar. Era la prima volta che accadeva e ciò mi fece sentire la sua prescelta.
Quando tornai a casa, il pomeriggio, ero così presa di lei che mi fu davvero difficile tornare alla realtà che condividevo con Monica.
Anche lei mi aveva preparato biglietti e regali, era stata deliziosa. La sera mi aveva portato fuori a cena in un bellissimo locale in un paesino abbastanza lontano da lì, in un locale
tutto di pietra viva con il soffitto a volte, dove un cameriere gentilissimo ci aveva coccolato con vini e cibi prelibati. Una bottiglia di Moet Chandon dalla banda arancio carico sul verde
scurissimo del vetro era stata stappata per brindare ai miei 53 anni.
Tutto era perfetto, come una vecchia favola, solo io non lo ero. Io pensavo a Dana e, nonostante mi sforzassi di essere felice di quella bellissima festa, assolutamente non lo
ero.
Il giorno dopo, alla sua sfuriata di delusione, il dolore di Monica mi ha aveva fatto sentire sporca e me ne ero fuggita a Imola, dai miei ragazzi.
Ma lì mi ero accorta che era troppo tardi, che quella era davvero ormai la mia casa, la nostra casa.
La notte a Imola mentre come sempre non dormivo pensavo a quanto Monica stesse soffrendo.
Dopo la discussione, quando mi ero trovata sul treno con poche cose cacciate nel trolley alla rinfusa, avevo provato un senso di sollievo, forse analogo a quello che prova chi esce di
galera.
L’amore per Dana mi aveva allora inondato e aveva preso il sopravvento su tutto il resto.
Ci eravamo viste e avevamo fatto l’amore nella Chiocciolina anche se era chiusa e avvolta dal nylon per proteggerla dall'inverno. eravamo entrate dentro e l'avevamo riordinata quanto
bastava per avere il letto a nostra disposizione.
Pensavo solo: ecco, ci sono di nuovo, per te, sono tua.
Ma a Imola tutto era cambiato: il pianto di Monica che mi risuonava nelle orecchie, i discorsi sensati dei miei figli. E poi… poi il mio posto era con lei, ormai.
Così tornai.
Monica mi aveva accolto come il figliol prodigo. È una gran donna. E mi amava moltissimo.
Io so quanto e come mi ama:va come io amo Dana.
Anche se alla fine questo non era del tutto vero, perché la scelta di abbandonare Dana e tutto il dolore che accompagna la nostra storia io l'avevo fatta.
Il fatto fu che dal giorno del mio ritorno a Imola, quando avevo deciso di trascorrere lì il tempo rimanente dell’inverno fino al giorno in cui sarei potuta tornare in campeggio a Gabicce
Monte, io avevo sofferto non so descrivere quanto, la presenza di Elisa nella vita di Dana: loro due avevano fatto l’amore e Dana me lo ha raccontato, felice e trionfante, scendendo un pugnale di
gelida gelosa disperazione nel mio cuore già dilaniato.
Mi ero sentita travolgere anche dal senso di impotenza.
È inutile: loro due si amavano e io allora cosa ci stavo a fare?
Tra loro due io restavo stritolata e rischiavo così di gettare via quella che era la più autentica occasione per me di vivere serena con una persona adatta a me e che amavo:
Monica.
Così avevo deciso di lasciare Dana, sicura questa volta di non tornare più indietro: sentivo che era finita.
Purtroppo, finalmente.
Anche se ancora piangevo, dentro e fuori di me.
Anche se il dolore di Dana, che io continuo a condividere, mi stava picchiando come un pugile inferocito e mi faceva pensare di aver mancato un appuntamento vitale, di non aver vinto, ma di
essere stata sconfitta ancora una volta.
Ma era finita. Lei aveva scelto Elisa per l'ennesima volta e io sceglievo una vita con Monica.
Amavo Monica: era la mia compagna.
Una compagna perfetta, dolce, allegra, intelligente.
La coltivavo nel mio cuore dal giorno del nostro incontro ed è era incredibile fiore sbocciato in quell'inverno asciutto e freddo, col sole alle finestre e sui balconi.
Pensavo: Avrò cura di lei come ne ho per la piccola pianta di edera che ho collocato nel graticcio del terrazzo della cucina: io resto qui.
Scrivevo: Addio, Dana, amore mio, - e lo facevo mentre piangevo - Ti sono attorno, ti abbraccio, ti sostengo.
Non cesserò di amarti è impossibile: sei la mia vita.
Ma ti dico addio, piccola donna sola e spaventata, orgogliosa e viva, come una paladina dalla lucente armatura che prima della battaglia trema di paura sul suo cavallo bianco.
Non sai se riuscirai a combattere, ma l’alba della tua vita è sorta.
Lascia il passato, scrollati di dosso le mani di pietra che ti hanno ferito. Strappate le catene che ti hanno impastoiato, ora puoi affrontare intrepida la mischia.
E io terrò per sempre stretta al cuore la tua vita.
Ma la gelosia lavorava nel profondo nel cuore di Monica, che vedeva il mio tormentarmi lontano dalla sua rivale e qualche giorno dopo, incapace di contenerla, mi scrisse una mail
:
SAI COME LA PENSO. CREDO NEL TUO AMORE SINCERO CHE È CIECO, VERAMENTE CIECO, TANTO DA NON VEDERE LO SQUALLORE A CUI QUESTA STORIA CHE TU HAI SUBLIMATO TI TRASCINA OGNI VOLTA. ALMENO
SPERAVO
CHE LEI TI PORTASSE A CASA SUA, MA NO, NON NE HA IL CORAGGIO,
SI VERGOGNA DI TE FINO AL PUNTO DA NON PRESENTARTI AGLI ALTRI,
NEANCHE COME AMICA.
CI SONO VOLUTA IO PER FARLO E HA APPROFITTATO ANCHE DI QUESTO: IO ERO L'ALIBI IDEALE PER ELISA, LA SICUREZZA CHE TU NON POTEVI ROVINARE IL LORO RAPPORTO, LA LEGGEREZZA CON CUI POTEVA VOLARE
DA LEI SENZA DOVER SENTIRE IL PESO DELLA TUA RESPONSABILITÀ E AVERTI COMUNQUE LÌ INNAMORATA E PRONTA A FARTI USARE, PRONTA A CORRERE COME UN CAGNOLINO AMMAESTRATO, TANTO DA DIMENTICARE TUTTO, PER
BUTTARTI A FARE SESSO CON LEI NELLA TRISTEZZA DI UN CAMPEGGIO, AL FREDDO.
NEANCHE I QUINDICENNI SAREBBERO TANTO INCURANTI …
MA L'AMORE È CIECO E TU VEDI SOLO LE SCUSE DIETRO CUI SI NASCONDE, PER POI CORRERE DALL'ALTRA CHE, PER SUA FORTUNA, GLI OCCHI APERTI LI HA.
QUELLO CHE MI DELUDE DI PIÙ È CHE TU LA LASCI SOLO QUANDO LEI FA L'AMORE CON ELISA E ALLORA SOFFRI E CAPISCI… FINO A QUANDO LEI AVRÀ BISOGNO DI NUOVO DEL SESSO E PIANGERÀ DI NUOVO E TI
AMERÀ ALLA FOLLIA.
E TU FREMERAI E NON AVRAI PACE SOTTO I PIEDI FINCHÉ NON POTRAI CORRERE DA LEI.
SCUSA LA MIA CRUDEZZA, SCUSA SE NON SENTO LA LIRICITÀ DELLA COSA, MA SAI, SONO ABITUATA A VIVERE NELLA REALTÀ E AD AFFRONTARLA CON TUTTE LE SUE RESPONSABILITÀ E A FARE SCELTE CHE NON
CAMBIANO COME IL VENTO, MA CHE RAPPRESENTANO UN CONCRETO FUTURO, COME I MIEI SENTIMENTI PER TE, CHE POTRANNO ESSERE STABILI E DURATURI SOLO SE TU LO VORRAI.
TI AMO ANCH'IO, MA QUESTO GIÀ LO SAI.
Io le risposi:
SÌ, SONO PAROLE DURE E CHE FANNO MALE, MOLTO. TU HAI IL DIRITTO DI VEDERE LE COSE COME VUOI, MA IO NON POSSO, PROPRIO NON POSSO ESSERE D'ACCORDO CON TE, PERCHÉ SE LO FOSSI VORREBBE DIRE CHE
HO BUTTATO VIA QUASI UN ANNO DELLA MIA VITA.
INVECE QUESTA STORIA MI HA PORTATO A GUARDARE PROFONDAMENTE DENTRO DI ME, A VEDERE COSE CHE PROPRIO NON AVEVO VISTO MAI.
SO CHE SEI UNA PERSONA CONCRETA QUANTO IO SONO PINDARICA: TU E IO ABBIAMO IL NOSTRO RISPETTIVO MODO DI ESSERE, MA LA REALTÀ NON È COME LA DIPINGI TU E MI SPIACE CHE LA RABBIA TI
ACCECHI.
TU DICI CHE SONO CIECA IO. FORSE, ANZI SICURAMENTE LO SONO, MA CHIEDITI PERCHÉ TI DÀ TANTO FASTIDIO, LA MIA CECITÀ.
IO L'HO AMATA, E NON VOGLIO BUTTARE TUTTO NELL'IMMONDIZIA, NON È SPAZZATURA CHE SI POSSA RICICLARE. TENGO DENTRO DI ME TUTTO QUANTO DI BELLO HO VISSUTO CON LEI E TUTTO IL DOLORE, CHE È
PREZIOSO, COME TUTTA LA GIOIA. COME TUTTA LA MIA VITA.
SE OGNUNO FOSSE LOGICO, PRECISO E METODICO, FORSE SAREBBE TUTTO PIÙ FACILE E ALLETTANTE, MA IO NON LO SONO E L'AMORE NON LO È, NEPPURE QUELLO CHE TU PROVI PER ME, CHE COMUNQUE NON
PASSA.
IL SESSO? BEH… L'AMORE DEL CORPO È POESIA: CON TE, CON LEI, CON TUTTI QUELLI CHE HO AMATO E ANCHE CON QUELLI CHE HO SOLO SCOPATO.
IO VIVO COSÌ. ANCHE SE ALTRI VEDONO SOLO LETAME IO SONO COMUNQUE IN PARADISO E SPERO CHE UN GIORNO ANCHE TU POSSA PROVARE QUELLO CHE HO PROVATO IO.
TI AMO…
E pensavo: Ci provo a stare senza Dana; di certo il rapporto con Monica è un mezzo e un fine per uscire dall’impasse disperato e disperante di questa storia.
Ma non era facile amare Monica con Dana che ruggisce dentro di me, nei pensieri, nei desideri, nelle mie vene.
Non si può avere sempre quello che si desidera. La vita è bella, col sole o con la pioggia e i colori riflessi nei nostri occhi sono comunque incantevoli anche se inondati di lacrime:
andavo avanti, un giorno dietro l'altro, come in una lunga scalata faticosa, come nell’attraversamento di un ponte che non finisse mai.
Ormai ero senza fiato, ma non mi fermavo, non mi arrendevo: sentivo che non arrendersi era la vera, unica vittoria finale.
E dicevo a me stessa: Monica, io sono quella che sono e tu l'hai visto, ormai: picchi altissimi e profondissimi baratri, la fatica di vivere e la forza per varcare ogni giorno il giorno che
verrà.
Amo lei, mi spiace.
Vorrei poterla non amare più, ma per il momento non è stato possibile.
Ma anche quella volta Dana non riuscì a staccarsi da me, di nuovo in rotta con se stessa e con il desiderio che sentiva di me ed il vuoto che io avevo lasciato, mi aveva cercato al
telefono, aveva riallacciato ancora più forte quel filo che io stavo cercando di spezzare. Era venuta di nascosto da Monica, più di una volta, era diventata dolce, presente ed io di nuovo persi
la testa e tornai ad Imola, chiedendo tempo a Monica, incapace di reggere al pensiero che forse davvero era arrivato per Dana il momento di accettare il nostro amore.
Ci vedemmo di nuovo nella chiocciolina e fu così travolgente che davvero pensai che il miracolo fosse accaduto, ma Elisa, presentendo qualcosa di particolarmente forte, cambiò ella pure
ulteriormente il suo atteggiamento nei confronti di Dana che allora si sentì davvero in bilico. Mise così Elisa alle strette chiedendole di definire i suoi sentimenti e mi disse che avrebbe
parlato con Elisa e deciso il loro futuro e, ovviamente anche il mio futuro, perché dalla posizione che avrebbe preso l'altra Dana avrebbe deciso se continuare a vedermi oppure
no.
L'assurdo di tutta questa storia era che Dana avrebbe voluto da Elisa quello che aveva con me.
Possibile che non si fosse resa conto che non avrebbe mai potuto averlo? Possibile che dopo tanti anni che loro stanno insieme non avesse capito che la speciale alchimia che c'era tra noi,
con l'altra non sarebbe stata mai?
Eppure continuava a pensare che tutto avrebbe potuto cambiare, che la fiamma della passione che non era mai sprigionata tra loro avrebbe potuto come un incantesimo all'improvviso
accendersi.
Ma tutti i miei discorsi non servivano a nulla, tutto il nostro meraviglioso vissuto non serviva a nulla.
Mi faceva male che fossero loro a decidere per me e sapevo benissimo che non avrebbe dovuto essere così, ma non avevo saputo, o forse voluto, spezzare quella catena.
Sapevo che esistevano veramente pochissime possibilità che Dana avesse scelto me e così feci un estremo ultimo disperato tentativo, aprendole di nuovo ancora una volta la mia
vita.
Sapevo che era tardi, tardissimo, che non c'era più tempo. Ancora qualche giorno e io e lei saremmo passate definitivamente e per sempre.
Dentro di me persisteva un urlo talmente lacerante che da giorni ero senza voce.
Nonostante tutto mantenevo ancora una flebile speranza che lei si incamminasse verso la nostra vita.
L' amavo, sopra ogni altra cosa. Io non ci credevo che fosse finita, non ci credevo.
Perché durante la settimana prima, dopo l’ultimo disperato tentativo di staccarmi da lei, era cresciuto dentro di me a dismisura il senso di questo nostro amore.
Intendo dire che mi ero resa conto che io senza Dana ero la stessa, che questa vita che stavo vivendo con Monica non era quella che desideravo, che se lei c'era accanto a me io potevo amare
l'altra, ma senza di lei non vi era nulla per nessuno, solo disperazione e desolazione.
Passate poche ore dalla rabbia per i suoi reiterati rifiuti, quando il cuore mio si acquietava, ogni proponimento di stare senza di lei, di essere felice senza di lei cadeva miseramente
affogato nelle lacrime della sua mancanza.
Stavo male e avrei voluto piangere tra le sue braccia, rinfrescare le mie labbra arse sulle sue, consolare i miei occhi sulla curva del suo seno e dei suoi fianchi, dove io avevo bevuto il
nettare del mio tempo, dove avevo pascolato i miei sensi e la mia anima.
Ma Elisa non voleva perdere Dana: che l'amasse o meno, aveva bisogno di lei, il loro legame era così forte che neppure quella volta la mia amata riuscì a spezzarlo e si tirò indietro con me
un'altra volta.
Una feroce crisi di dolore mi colse, delusa e tradita proprio quando avevo pensato finalmente di aver vinto la mia lunga battaglia.
Mi graffiai il viso, le braccia e le spalle e il dolore fisico mi riportò sulla terra, trasportandomi dal profondo baratro nel quale le sue parole mi avevano buttato.
Tornai tranquilla, ma mi sentivo in uno stato irreale, mi rifiutavo di crederci: non era vero, non era successo.
Il bisogno di lei era lacerante e sentirla al telefono, così fredda e distante, mentre io sentivo impresse nell'anima le sue parole d'amore, era stato difficilissimo. Come poteva, come
aveva potuto?.
Montò la rabbia, montò la difesa della mia vita.
Monica mi chiese ancora una volta di tornare a casa da lei ed io, affranta ma risoluta a voler vivere nonostante tutto questo, accettai.
Tornai in treno e feci scalo a Gabicce per salutare Dana che mi aveva chiesto di incontrarmi.
Stare accanto a lei era un tormento: piansi, la implorai di accettare il nostro amore, finalmente, le dissi che non ci saremmo più riviste, ma non bastò.
Salii allora sul treno e proprio un attimo prima che partisse Dana mi disse:
' Non andare, non posso perderti, ho capito, accetto, accetto tutto.'
Ma io le dissi che non le credevo, che sapevo che poi, appena mi avesse avuto di nuovo in suo possesso mi avrebbe mandata via come tutte le altre volte e non scesi dal treno, che partì
lentamente cigolando sulle sue parole:
' Questa è la volta giusta e tu te ne vai...'
Tornai a casa da Monica, ma quelle parole furono un ritornello perenne ed infinito.
In ogni respiro, in ogni secondo battuto da un tempo immobile e pesante, in ogni pensiero, in ogni azione, in ogni silenzio ed in ogni voce battevano quelle inesorabili
parole.
' Questa è la volta giusta e tu te ne vai...'
Come era possibile che io abbandonassi la lotta proprio quando avevo vinto?
E come era possibile credere a Dana?
Mi arrovellavo, passando le ore al pc con il mio perenne gioco di palline, senza poter dormire, senza avere pace, con addosso lo sguardo interrogativo e cupo di Monica, alla quale cercavo
di tener celata la mia disperata incertezza per non farla soffrire ancora di più di quanto non stesse già patendo, ma senza riuscirci.
Passò una settimana senza sentire Dana neppure una volta, senza un messaggio, senza nulla.
E il vuoto di lei di nuovo ebbe la meglio su tutto, non ce la feci più e la chiamai.
Mi rispose freddamente. Era passata una settimana e per lei era tutto finito, aveva ripreso la sua vita.
Le chiese come potesse, come le riuscisse di staccarsi da me in quel modo. Se una settimana prima aveva capito che non potava vivere senza di me, che mi amava, come potevano sette giorni
spegnere quello? ma non ebbi una risposta.
Di nuovo piombai in una crisi profonda.
I giorni passavano, io e Dana avevamo ripreso a sentirci. Ogni tanto veniva a trovarmi e mi portava a fare un giro in macchina. Cercavamo un luogo appartato: io bruciavo di lei. Erano
contatti infuocati, veloci, rubati alla routine, di nascosto da Monica ed Elisa che erano sempre più gelose.
Ma poi lei se ne tornava a casa sua e riprendeva il suo altalenante comportamento nei miei confronti.
La tensione in casa con Monica era sempre più alta, io stavo male, avevo ripreso a prendere psicofarmaci, lei mi aveva portato al pronto soccorso una sera che stavo piuttosto male e me ne
avevano prescritti. Un medico si era interessato a me. Ogni tanto Monica mi chiedeva se volessi tornare a parlare con lui, se non fosse il caso di aumentare la dose.
Ma io avevo ormai perduto ogni fiducia nelle cure psichiatriche: prendevo qualcosa solo per stordirmi un po', per riuscire a dormire qualche ora, tutto lì.
Mi sentii soffocare dai sensi di colpo.
Amavo Monica ma davvero stavo ripagando con una amara moneta il suo amore e tutto quello che lei aveva fatto per me.
La vedevo sempre più tesa, sempre più scontenta, e questo non mi era sopportabile: il peso del suo attaccamento e delle sue aspettative divenne ingestibile.
Ormai eravamo alla fine di aprile. Decisi allora di trasferire la chiocciolina dal mare alla montagna. Cercammo e trovammo un campeggio aperto tutto l'anno e portammo là la
roulotte.
Dissi a Monica che assolutamente dovevo risolvere la questione con Dana prima di potermi dedicare a lei con l serenità e l'amore che meritava. Le chiesi di darmi tempo, di concedermi la
possibilità di gestire il distacco con i miei tempi, di permettermi di poter piangere il mio dolore senza dovere vedere le sue lacrime che le mie lacrime per l'altra causavano.
Le chiesi di non abbandonarmi, di venire a trovarmi, di avere ancora pazienza. Lei promise.
- Da qui ricomincia la narrazione del mio diario.
La Chiocciolina è a Campigna, sull’Appennino tosco-romagnolo.
Duro il lavoro di trasporto delle mie cose dalla casa di Monica, duro il lavoro di pulizia e assemblaggio qui.
Stamattina Dana al telefono mi ha chiesto una pausa: è confusa.
Il mio sole è tramontato, oggi piove forte, ma io aspetto di nuovo la luce: sono abituata a vivere nel buio, anche se, quando c'era il sole, per me vivere significava ubriacarmi di
luce.
Domenica mattina.
Il campeggio è ancora deserto: poche persone sono giunte per il fine settimana. Le previsioni davano brutto tempo. Infatti ieri ha piovuto e anche stamattina presto il maltempo
persiste.
Ma adesso è rispuntato il sole e le piccole piantine di petunia che ho messo a dimora pochi giorni fa stanno cominciando a fiorire: campanule bianche.
Alcune piccole formiche stanno correndo sul tavolo del mio computer e ieri ho combattuto una lotta estenuante contro un’enorme vespa, che voleva a tutti i costi trasferirsi nella mia
veranda.
Spero di averla dissuasa, oggi ancora non si è fatta viva. Ma non l’ho uccisa: penso che in questo mondo ci sia posto per entrambe.
Da ieri la temperatura si è alzata, ma la prima settimana ha fatto molto freddo. La stufa a gas della roulotte naturalmente non funziona, così ho comprato una stufetta elettrica, ma ormai
il peggio era passato.
Ci sono state sere veramente fredde e io mi sono sentita del tutto abbandonata a me stessa…
Nessuno si interessa di me. Ieri sera ho telefonato io a mio figlio, perché ho messo su per sbaglio un CD suo che è nel mio computer: l’ho sentito lontano, aveva una voce strana. Mia
figlia, intanto, stava litigando al telefono con il suo ragazzo e non ha neppure voluto parlarmi. L’altra figlia più grande mi chiamava sempre quando ero da Monica, ma ora non lo fa più. So che è
molto stanca e che sta lavorando tantissimo: penso che non approvi la mia scelta di lasciare Monica. Nessuno dei miei figli la approva e la loro reazione è quella di allontanarsi ulteriormente da
me.
Vorrei che stessero bene e fossero sereni, perché sento che non posso fare più molto per loro. È dura la vita dei miei figli, con una madre lesbica e con problemi psichici. In questo
momento di sicuro vivono meglio se io sto lontana da loro.
Monica si sta consolando in fretta. Esce con una ragazza molto più giovane di lei – ha infatti una trentina d’anni – e che si chiama Elisa pure lei.
Come se non ci fosse potuto essere un altro nome al mondo...
Sono già diventate intime e penso che negli ultimissimi giorni abbiano deciso di stabilire una relazione seria. Lei è giovane, molto carina, snella, ricca, poco problematica e tanto
innamorata: tutto il contrario di quello che sono io.
Oggi al telefono Monica mi ha detto che quando ci sentiamo si accorge che le manco. Quando ci sentiamo: se non ci sentiamo, evidentemente, non pensa a me, non le manco.
Invece a me lei manca, manca molto.
Ciononostante, in questi giorni l’ho spinta con decisione tra le braccia dell'altra e ho fatto di tutto perché si allontanasse da me e pensasse a sé.
Mi ha colpito molto il suo dirmi che usciva con un'altra ragazza: non me lo aspettavo. Mi sono resa conto che si scrivevano da tempo, ancora quando io ero in casa sua.
Altrettanto colpita sono stata dalla richiesta da parte sua di incontrare e conoscere la sua giovane amica per vedere se fosse possibile iniziare una storia a tre con lei. Mi sono rifiutata
categoricamente. Non aveva alcun senso allungare la catena di cose dispari che vi era nella nostra vita.
Davvero Monica voleva far vivere alla persona che stava conoscendo il calvario che lei aveva vissuto con me?Mi sembrava assurdo, ma la sua reazione alla mia non accondiscendenza è stata
piuttosto negativa.
Monica ha chiuso con me. Direi che ha sofferto abbastanza e ha deciso di passare oltre e di lasciare tutte le tribolazioni che hanno accompagnato da sempre il nostro rapporto: d’altronde, è
stata lei a mettermi alle strette, in definitiva il suo scontento nei miei confronti era palese ultimamente e questo ha dato la spallata finale alla mia decisione di andarmene.
Io non sono innamorata di lei, ma l’amo, anche se in un modo molto diverso da come amo Dana.
Il mio cuore è sempre stato diviso in due, tra loro.
Se Monica mi avesse dato più tempo per rimarginare la ferita infertami dal distacco da Dana, forse le cose sarebbero andate diversamente, ma in realtà lei non ce la faceva più. Ha fatto
bene a prendere la decisione che ha preso: lei merita di essere felice e con me sicuramente non lo è stata mai…
«Inusuale» è il mio nome di battaglia. Ogni giorno sul campo impugno le mie armi e la lotta infuria.
Nei sogni notturni continua la mia aspra contesa: non c'è tregua nel mio cuore affamato d'amore…
Questa notte sono stata male. Ieri Dana non è potuta venire perché Elisa aveva cambiato i suoi programmi e le aveva chiesto di stare con lei. Naturalmente la mia delusione è stata forte,
come il senso di abbandono, la gelosia e la stanchezza. Ho cercato di essere positiva, di non arrabbiarmi. Di ripetere a me stessa che non mi importava.
Nel pomeriggio mi sono sentita molto stanca e sono andata a coricarmi. Ho dormito fino alle sette di sera. Un sonno agitato, ipnotico, quasi uno stato di trance, dal quale non riuscivo a
destarmi e nel quale però non mi trovavo a mio agio. Una serie di contrattempi con il mio vecchio computer e con internet hanno contribuito a esasperare il mio nervosismo.
Poi Dana mi ha telefonato, era sola in casa. Sembrava allegra, ma la sua allegria suonava stonata alle mie orecchie. Ho provato a raccontarle le mie piccole disavventure, ma lei mi prendeva
in giro e così mi sono richiusa in me stessa.
Questa disarmonia fra Dana e me si verifica sovente. Io sono sempre disponibile ad ascoltarla, ma lei non lo è altrettanto con me: le mie sofferenze le instillano un senso di colpa e non sa
come affrontarle, né si mostra capace di sopportarle.
Così mi sono innervosita ancora di più. So benissimo di essere troppo permalosa, ma lo sono sempre stata sin da piccola e ancora non ho imparato a dominare questa incongruenza del mio
carattere.
Dana si è addormentata mentre ancora stavamo al telefono, sopraffatta dalla stanchezza.
Io ero in preda all’insonnia e così mi sono messa a giocare sul pc, ma, improvvisamente ho avuto un attacco fortissimo di rabbia: avrei voluto spaccare tutto, computer, tavolo, sedie… ho
cominciato a lanciare degli oggetti, poi ho afferrato una mazzetta utilizzata in questi giorni per piantare picchetti e paletti e ho provato l’impulso irrefrenabile di fracassare tutto
quanto.
A quel punto ho incrociato lo sguardo del mio cane che mi guardava allarmato e in quell’attimo mi sono accorta di quanto fossi fuori di me. Ho colpito ripetutamente con tutta la mia forza
il terreno della veranda, che
essendo coperto da un telone plastico, non ha subito danni e l’ho fatto finché ho avuto forza nel braccio che brandiva il grosso martello.
Ero senza fiato. Ho cominciato a piangere e ho sentito il bisogno di un po’ delle mie gocce di ansiolitico.
In effetti mi sembrava la cosa più sensata da fare, per cui le ho prese, poi mi sono coricata sul materassino sgonfio, ma nella mia mente alterata si agitavano mille pensieri disperati:
voglia di morire, paura del futuro, senso totale di inadeguatezza della mia vita, sofferenza nel vedere quanto dolore si annida dentro di me e come io lo rovesci sulle altre persone, proprio su
quelle che più amo e che mi amano.
Avevo bisogno di parlare con Monica. Ho resistito una decina di minuti, persa nelle mie deliranti farneticazioni, poi l’ho chiamata. Alla fine di tutta questa storia, lei è l’unica persona
sulla quale posso contare.
L’unica che, se ho bisogno, c’è.
Dormiva. Ma subito si è svegliata e ha cominciato a parlarmi con affetto, consolandomi. Sarebbe anche venuta a prendermi, se glielo avessi chiesto, ma pioveva a dirotto ed era notte fonda.
Non me la sono sentita di farle percorrere tutta questa strada di montagna con un tempo così infame e a quell’ora.
Abbiamo parlato a lungo, così che io sono riuscita a calmarmi un po’: le gocce hanno fatto effetto, ho preso sonno e mi sono svegliata prima delle sette.
Oggi mi sento sfinita. Nel pomeriggio verrà Dana. E stasera dopo cena verrà Monica e mi porterà a Sant’Agata Feltria. Parleremo.
Forse è meglio che io mi faccia aiutare da qualche medico.
Forse…
Ma sicuramente la cosa che più desidero adesso è morire. Di nuovo.

CAPITOLO
TENTRATREESIMO
Trecento pillole
Ancora la pillola giusta non l'ho trovata: mi piacerebbe davvero poterla trovare, ma ho perso la fiducia
e la speranza e non farò nulla che possa riportarmi nella terribile situazione senza dignità
che ho vissuto durante i sei anni nei quali mi sono fatta curare.
Oggi penso che mi manca qualcosa, una connessione, un meccanismo, un enzima o non so che altro e questo mi impedisce di capire la realtà, interpretarla e adattarmi a essa, rimodellandola
secondo le mie esigenze.
Quando nasce un gattino, se riceve immediatamente le cure di un essere umano, se viene da questo preso in mano e accarezzato nei primissimi giorni della sua vita, la piccola creatura
sviluppa un meccanismo che viene chiamato imprinting, che gli permetterà di stringere relazioni affettive con gli esseri umani.
Se invece non riceve quel contatto positivo, trascorso quel periodo egli catalogherà nella sua mente gli esseri umani come soggetti da temere e se ne terrà sempre alla larga, pur magari
accettando del cibo da loro, ma senza mai lasciarsi toccare o prendere.
Io sono così: non ho ricevuto quel qualcosa e non conosco ciò che mi permette di fare le scelte giuste, di sapere cosa voglio, di vedere come devo agire per attuare quello che mi sembra
giusto e direi che è troppo tardi perché questo possa accadere.
Io non capisco gli altri e non sono comprensibile a loro: la mia mente produce tutta una serie di pensieri ed
emozioni che sono instabili, spesso nettamente contrastanti tra loro e io me ne trovo in balia.
Oggi, in verità, penso che dovrei rompere tutti i pochi rapporti umani che ancora ho in essere e lo
sto in effetti facendo.
Sento Dana lontana e demotivata e non riesco più neppure a esprimerle il mio pensiero, le mie emozioni.
Sento che non può capirmi né più corrispondermi.
Lei dice che non è così, ma per me non è convincente.
Monica ha allacciato un rapporto con un'altra donna.
Ieri sera è venuta da me e voleva portarmi a casa con lei, ma io l'ho mandata via: voglio che si stacchi da me, perché io non ho quello che lei desidera, non posso darglielo, al contrario,
posso darle soltanto sofferenza e ora che ha volto lo sguardo verso un futuro migliore, farò di tutto perché superi lo scoglio che io sono stata per lei.
Certo, l'esperienza con me le ha insegnato molte cose e le è servita per uscire da un immobilismo che durava da quasi venti anni, ma io ora ho esaurito ciò che posso fare per
lei.
Voglio stare sola, voglio smettere di pensare a quello che devo fare per capire le altre persone ed esserne capita, per amarle ed esserne riamata.
Non ho fatto altro, nella mia vita, che cadere dalla padella alla brace, padella dopo padella, brace dopo
brace…
Ieri pomeriggio è venuta Dana, dopo due mesi che non ci vedevamo, che avevamo solo parole al telefono.
Mi aspettavo molto dal nostro incontro, mi aspettavo che magicamente tutto quello che c’era stato tra noi sarebbe immediatamente ricomparso, ma non è stato affatto così: abbiamo fatto
l'amore con la consueta travolgente passione, è vero, ma non mi ha mai detto che mi amava e i suoi occhi erano freddi.
Non ho visto lo sguardo di una donna innamorata che ritorna dopo tanto tempo all'oggetto del suo amore, ebbra di felicità come io mi sentivo, desiderosa solo di dare e ricevere
amore.
Io, l'amore non l'ho sentito.
Lei mi ha detto, parlandone stamattina, che mi ha dato tutto quello che poteva darmi.
Quindi, o quello che mi offre per me non è abbastanza, o io sono talmente persa nel mio malessere che non vedo e non sento più nulla, oltre al mio disagio e al mio dolore.
Penso a Monica, che invece aveva sempre detto di volermi aiutare, che avrebbe affrontato insieme a me il difficile cammino per cercare di risolvere i miei molteplici problemi, ma che era
troppo coinvolta affettivamente con me e soffriva troppo i miei cambiamenti, le mie incertezze, le mie fughe.
Anzi, spesso, esasperata dall'instabilità del nostro rapporto e dalla paura di perdermi, provocava apposta le mie fughe, come l'ultima e definitiva volta che me ne sono andata da casa sua,
quando mi ha messo di fronte alla mia non consequenzialità e al suo dolore: problemi che io non posso affrontare e risolvere in breve tempo.
E ora, dopo che io me ne sono andata, si è rivolta verso un'altra donna.
Non posso certo permettere che lei viva un duplice rapporto come io ho vissuto con lei e Dana, divisa nel cuore, nello spirito e nel corpo tra due amori, dilaniata tra incertezze e gelosie,
né posso permettere che costringa questa povera malcapitata che si è innamorata di lei e che si sta comportando con lei in maniera giusta e motivata, a vivere l'inferno che io ho fatto vivere a
Monica tra me e Dana.
E neppure posso e voglio fare l'errore che ha fatto Dana, che, quando si è convinta l'anno scorso di non essere assolutamente la donna adatta a me, prima mi ha spinto tra le braccia di
Monica, poi, non riuscendo a fare a meno di quello che io le davo e che ero per lei, mi ha impedito con tutte le sue forze di staccarmi da lei, quando io, convinta che fosse per me la scelta
giusta, stavo cercando di farlo con tutta la disperazione che sentivo in me.
Questa assurda storia si sta diramando come un tumore maligno, ha contagiato ormai troppe persone, e io la interromperò: me ne starò da sola e smetterò di far soffrire le persone che
amo.
So che ho energie e cervello, ma non so come usarli: per il momento voglio non fare niente, voglio starmene qui, con il mio cane, lasciare scorrere il tempo.
Ancora una volta penso che la morte sia per me la soluzione migliore…
- Scrivo una lettera a Dana:
Non riesco a parlarti, così ti scrivo. Tutto quello che ti ho chiesto da sempre è un po’ di affetto: sai che ne ho bisogno, non te lo chiedo per essere noiosa.
Io sono qui, da sola: non parlo con nessuno, non vedo nessuno, non ho nessuno, non ho quasi di che mangiare. Hai fatto quasi 100 chilometri per venire fin qui, ieri!?
Ma io ho lasciato quel poco che avevo per starti vicina!
Non me lo hai chiesto?
Non è vero. Me lo hai chiesto con tutta te stessa.
L’ultima volta che mi hai detto «ti amo» è stata tre giorni fa.
Ieri hai risposto a una mia domanda, quindi sei stata costretta. Eri lì, potevi dirmi no?
Ieri il tuo sguardo era freddo.
Io sono pazza.
Pazza da legare: io non sono normale.
Ma tu sei crudele, egoista, cinica.
Ti costa così tanto dirmi che mi ami?
Sì, perché non mi ami.
Quando invece cercavo disperatamente di staccarmi da te, per rifarmi una vita con Monica, allora sì, che mi dicevi che mi amavi, allora sì che mi sconvolgevi con tutto quello che avevo
sempre desiderato e non avevo mai
avuto.
E mi sentivi piangere come un animale sgozzato, perché lottavo contro un amore, contro una passione immensa, ma non ti fermavi. Allora sì che le sapevi trovare le parole d’amore, per
tenermi legata a te.
Ora che sono di nuovo la tua schiava, non mi concedi che qualche avaro contentino.
Il torto è mio che ti ho permesso di farmi questo, ma non contrabbandare per amore quello che amore non è.
Mi hai detto:
— Di questo amore te ne posso dare sempre, quanto ne vuoi, ti posso coprire d’amore.
Lo stai facendo? No.
Allora per favore lasciami andare, stai lontana da me e se ti cerco non mi rispondere.
Se ti pesa persino una piccola parola, allora stai lontana da me.
Dall’altro ieri sto male da morire. Non mi chiedi cosa mi sento, perché sto male, non mi dici: amore
mio vieni tra le mie braccia, io ti amo, stai qui con me…
Per telefono, mi sarebbe bastato per telefono.
Non avevo torto nel pensare che non saresti cambiata mai, che mi ami solo quando non mi hai.
Sono tornata indietro sui miei passi perché mi hai spergiurato che questa volta sarebbe stato diverso.
L’amore che ho per te ha voluto concederti anche questa ultima disperata possibilità e così ho perso anche Monica.
Adesso non ho più niente: ti ringrazio.
Ma sciocca io che ti ho creduta, che mi sono voluta così male.
Stai lontana da me. E se guardi dentro di te, dopo che ti sarà passata l’arrabbiatura che ti provocherà questa mia lettera, vedrai che ho ragione, ho ragione fino in fondo.
Leggi i messaggi di quando stavo con Monica e quelli che mi mandi ora e sempre quando sto lì per te e renditi conto del tuo comportamento.
Stai lontana da me.
E scrivo una lettera al mio secondo marito:
Caro Antonio, ti scrivo perché mi risulterebbe difficile se non impossibile parlarti: la mia condizione si è aggravata molto.
Il rapporto con Monica è finito per motivi complessi, non ultimo il mio effettivo disagio mentale e la mia impossibilità di far fronte a problemi che evidentemente sono più grandi di
me.
L’ultima volta che mi sono rivolta a Betta, nostra figlia, chiedendole alloggio e un po’ di aiuto mi ha trattato assai duramente, gettandomi addosso, come sempre è accaduto da quando mi
sono ammalata, tutto quello che lei ha fatto per me e la mia colpa di averle imposto una situazione che lei non avrebbe mai scelto e la responsabilità del mantenimento di Gabriele, nostro
figlio.
Silvia, la mia altra figlia, tutte le volte che le ho chiesto aiuto economico, me lo ha sempre negato risolutamente, e anzi mi ha rinfacciato più volte di averla sfruttata nel lavoro e
nella vita.
Gabriele naturalmente non è autosufficiente e ha dei problemi suoi e mi ha accusato e forse dentro di sé mi accusa ancora di non essere stata in grado di dargli una famiglia normale, cosa
che dice sempre anche Betta.
Mia madre da quasi un anno mi ha tolto l’aiuto che mi dava e mi accusa di aver fatto sempre di testa mia.
So che mi ha dato tantissimi soldi, ma quei soldi non servivano per me, ma per far crescere i miei
figli.
Da quando ho cominciato ad accettare il suo aiuto economico, io ho sempre rinunciato a tutto.
Mio fratello poco tempo fa, ad un mio ulteriore tentativo di instaurare con lui un rapporto fraterno che da sempre manca, mi ha gentilmente invitato a non scocciarlo con i miei problemi e
non si interessa minimamente a me.
Quando stavo con Monica, i ragazzi mi telefonavano e anche Silvia mi chiamava spesso, ora sono letteralmente spariti.
Io sono in un campeggio a Campigna, a tre chilometri dal paese, senza macchina. Non ho trovato una sistemazione più comoda che fosse a portata delle mie tasche. Spendo 130 euro mensili per
l’affitto della posta e l’energia elettrica. Qui fa molto freddo e devo comunque tenere ancora accesa la stufetta se voglio sopravvivere.
La mia pensione ammonta a 250 euro mensili e capisci che sono alla fame.
Sono abbandonata a me stessa e nessuno di voi si preoccupa di chiedermi se ho bisogno di qualcosa.
Sorvolando su tutto quello che ho fatto per la nostra famiglia, che comunque era mio dovere fare e che ho fatto con gioia, resta il fatto che sono gravemente ammalata, e che nessuno si cura
di me.
Era impensabile che una o più persone estranee potessero fare quello che i miei famigliari non fanno.
Vi fa comodo fare finta che io stia bene e credere quando vi dico che è così, ma dopo cinque tentativi di suicidio, come fate a pensare che io stia bene?
Me ne sono andata da Imola perché Betta e Gabriele mi hanno espressamente chiesto di lasciarli liberi nella loro città e di portare la mia ingombrante omosessualità fuori dal loro
ambiente.
Io li ho assecondati e il risultato è la situazione che si è creata ora.
Ho tentato in questo anno di badare a me stessa e di non pesare sulle spalle di nessuno, cercando in me la forza e le risorse per sopravvivere dignitosamente.
Ma io soffro di un grave disturbo della personalità e per me condurre una vita «normale» è evidentemente impossibile, come individuare e applicare le scelte giuste in questa
direzione.
Sto di nuovo meditando di suicidarmi.
E non per una delusione amorosa, ma, come ovviamente anche tutte le altre volte, perché mi sento e sono sola
ad affrontare problemi più grandi di me e dei quali non vedo la via di uscita: penso che veramente sia l’ultima risorsa che mi resta e che così vi libererei della mia ingombrante
presenza.
Penso a quello che è successo l’estate scorsa, quando mi sono tagliata le vene, alla rabbia furibonda di tutti nei miei confronti: nessuna pena per una povera Crista che stava così male da
desiderare di morire, qualsiasi fosse il motivo che mi ha spinto verso quel gesto estremo, ma solo rabbia e fastidio per aver intralciato le vostre vite e i vostri piani.
Poi il silenzio più assoluto e l’incuria più totale da parte vostra.
Se fosse per voi io sarei sotto un ponte, a morire di fame, a meno che non avessi accettato la carità di Betta, con i relativi aspri rimbrotti.
Quest’inverno è stata Monica a darmi da mangiare, ma ora questo non è più possibile.
Non posso e non voglio tornare da Betta, il suo comportamento è per me intollerabile: non voglio una vita
dove non sono libera di nulla, neppure di stare al telefono o al computer.
Voglio sentirmi a mio agio, per quello che mi è possibile.
Anche qui, in una roulotte, dove mi manca molto e la vita non è certo comoda, sono più serena che non sotto giudizi impietosi che non tengono conto delle mie necessità, che ovviamente non
si possono restringere solo all’abitazione e al cibo e non tengono conto del mio modo di essere.
Ringraziando comunque Betta per tutto quello che ha fatto e, ammettendo che se qualcuno dei miei figli ha fatto qualcosa per me, quella è proprio lei, vi chiedo quindi di unire i vostri
sforzi e di versarmi un assegno mensile che mi permetta di vivere, unitamente alla mia pensione, in modo dignitoso.
Fai leggere questa lettera ai miei figli, a mio fratello e a mia madre.
Mettetevi una mano sulla coscienza e aprite gli occhi sulla mia situazione oggettiva, sulle mie primarie necessità. Non voglio parlare con nessuno di voi, non voglio sostenere discorsi su
quello che dovrei fare o avrei potuto fare o che voi vi sareste aspettati da me.
Io sono malata: lo sono per i medici e per lo Stato, che mi ha riconosciuto l’invalidità.
Voi siete la mia famiglia.
Io mi sono occupata di voi, di tutti voi, mia madre compresa, prendendola in casa mia tutte le volte che lei ne ha sentito la necessità e anche di mio fratello, quando lui me lo ha permesso
e me lo ha chiesto.
Ho cresciuto i figli dando loro tutto ma proprio tutto quello che avevo e anche a volte quello che non avevo. Sono stata per te una buona moglie e ho fatto tutto quello che mi era possibile
per amarti e stare al tuo fianco. Nel bene e nel male mi sono sforzata e impegnata allo spasimo.
Se ho dei disturbi mentali non è colpa mia: forse qualcuno di voi dovrebbe guardare dentro di sé e vedere dove e come ha mancato nei miei confronti.
So che questa è una lettera molto dura, che vi farà arrabbiare, che mi farà odiare da voi e che forse vi allontanerà definitivamente da me, ma la mia situazione è grave e mi dispiace molto
dover essere io a chiedere il vostro aiuto e non vedere che qualcuno di voi, di sua spontanea volontà e con amore, almeno un po’ di quell’amore che pur con tutti i miei sbagli io vi ho sempre
dato, si preoccupi per me e mi tenda una mano in questo momento così buio e difficile della mia vita.
Riconosco di essere e di essere stata una persona difficile e scomoda nelle vostre vite, riconosco di aver compiuto molti errori, anche se tutti in perfetta buona fede e mai per mancanza di
amore nei vostri confronti.
Riconosco che ognuno di voi ha i suoi problemi e che alcuni di questi dipendono da me, soprattutto per i miei figli, che non hanno avuto la famiglia che avrebbero meritato.
Sicuramente io avrei dovuto essere aiutata da bambina, non avrei dovuto sposarmi, né fare dei figli e di questo vi chiedo scusa, con tutto l’amore che ho per voi.
Ma io stessa non mi rendevo conto di quanto fosse drammatica la mia situazione…
Convocate una riunione di famiglia e decidete cosa fare.
Ripeto, non voglio parlare con nessuno di voi: non ne sono in grado.
Troppe cose sono successe. Troppe.
- ma quelle mie richieste di aiuto rimasero totalmente inascoltate. Dana non cambiò atteggiamento e Antonio non mi rispose. Nessuno si fece vivo........
Domenica 25 maggio, verso sera, dopo aver vissuto giorni di furore intenso come mai mi era capitato,
contro tutto e tutti, sola nella Chiocciolina, isolata, rabbiosa, ho preso tutti i medicinali che avevo.
Quelli per la tiroide, il neurolettico per la sindrome delle gambe senza riposo, il diuretico e l’ansiolitico,
due boccette. In tutto, circa trecento pastiglie.
Come sempre, l’ho fatto in trance, senza veramente capire quello che stavo facendo, anche se erano diversi
giorni che lottavo contro lo spasmodico desiderio di morire.
Poi sono caduta in stato di incoscienza.
Al mattino, Dana, sentendo che non rispondevo al telefono, ha allertato con un sms Monica, che è arrivata qui. E mi ha trovata immersa nel vomito e nell’urina. Parlavo, ma ero fuori di
me.
Lei ha chiamato il 118 e poi c’è stato il ricovero in ospedale, dove ho rifiutato ogni cura, lavanda gastrica, flebo, carbone attivo, furiosa di non essere morta, di non aver potuto
ottenere il miracolo della tregua da
questo dolore che mi dilania.
Ricordo pochissimo di tutto, solo le parole gentili e piene di pietà di un medico e la visita di Antonio e Gabriele, ma è tutto avvolto dalla nebbia.
Avrebbero voluto ricoverarmi in psichiatria, ma mi sono opposta categoricamente, non essendoci gli estremi per un trattamento obbligatorio: finché non faccio male a qualcuno, almeno non
possono impedirmi di uccidermi.
Ma non riesco a uccidermi, non ci riesco.
Non ci riesco.
Anche questa volta era più facile morire che vivere, ma la mia vita è così caparbiamente tenace…
Il giorno seguente ho firmato per la mia dismissione dall’ospedale e sono tornata qui.
Forse solo oggi sono del tutto lucida, anche se non possiedo la certezza di esserlo davvero.
Mi manca Monica: il dolore per aver perso lei e tutto il nostro mondo cresce di momento in momento.
Ho cercato di proporle un nuovo inizio, ma lei si è chiusa in se stessa.
Mi offre la sua amicizia, che io d’altronde non posso e non voglio accettare.
Del resto è sicuro, anche se non me lo dice più chiaramente come i giorni antecedenti al mio gesto, che sta portando avanti il suo nuovo amore con l’altra Elisa – una vera e propria nemesi…
– e pensa a sé.
Le compagne di fede a modo loro mi sono state vicine, soprattutto Anna.
E ho conosciuto Carla e Alda che mi aiuteranno e mi hanno accolto nel loro gruppo. Ho ricominciato a pregare con forza e ho aumentato il tempo della preghiera. Ho ricominciato a leggere
assiduamente i testi Buddhisti. Ho trovato nella loro compagnia e nelle loro parole un inatteso conforto.
Ma le due donne che amo e che non posso avere, ognuna per il motivo opposto, continuano a lacerarmi…
Ho analizzato dentro di me, fino allo spasimo, i meccanismi perversi della mia dipendenza affettiva:
ho visto un binario unico, mentre altri, come il senso del valore della mia vita a prescindere dalla presenza di chi possa amare, mancano assolutamente.
L’imprinting della mia prima infanzia è stato devastante.
Con la mente ho capito tutto quello che mi accade e perché mi accade e so cosa dovrei fare perché la mia vita cambi, ma non so come attuare in pratica questo cambiamento.
L’unica cosa che so è che ho assolutamente bisogno di una compagna.
Che ci riproverò, sperando che dentro di me tutto questo dolore, tutta questa preghiera, tutta questa analisi, tutto questo sforzo, stia cambiando veramente qualcosa e la mia vita sia
pronta a ricevere colei che desidero da sempre e della quale ho immenso bisogno da sempre.
So che è questo immenso bisogno che mi porta a sbagliare, lo so, però sola soffro troppo.
Troppo, troppo.
Mi arrotolo attorno al mio dolore, vivo del mio dolore, per il mio dolore e sono il mio dolore.
«Invincibile nella gioia», il nome Buddhista che mi sono data, Ajita Koku, non è stata ancora sconfitta, e ancora sa ridere, anche se la gioia della vita è una sensazione che vibra profonda
e lontanissima, presente ma rarefatta nelle galassie dei miei errori, delle mie mancanze, dei miei vortici, dei miei buchi neri.
Piove ancora, anche se fa più caldo, per fortuna.
Betta vorrebbe che tornassi a Imola e anche Dana mi dice che è la soluzione migliore, come naturalmente Antonio, Silvia e Gabriele, ma io non voglio tornare.
Indietro non si torna mai, non si può tornare.
È come morire, è come essere sconfitte: è come arrendersi.
E io, anche se mi chiedo se davvero avrò tutta la forza necessaria per risollevare questa mia vita distrutta, io ancora non mi sono arresa.
Perché se così fosse, sarei morta davvero.
Vorrei chiedere a Monica ancora una volta perché mi ha voluto a tutti i costi mentre io le dicevo in tutte le maniere che era un errore quello che stava facendo e poi, quando sono arrivata
in fondo all’analisi di me e di quello che sono, che faccio e che vorrei, mi ha lasciato di botto, scavando nella mia vita una voragine ancora più profonda di quella che già
esisteva.
Vorrei chiederle perché ha voluto tentare un’ impresa così difficile e rischiosa con una persona come
me, fragile e complessa, se non ne aveva le forze.
Vorrei sapere perché mi ha regalato una speranza e poi me l’ha cancellata mentre io lottavo per approdare alla trasformazione dei miei meccanismi perniciosi e sconvolti.
Vorrei chiederle perché non ha continuato a lottare con me, perché è fuggita ancora una volta da una responsabilità che aveva scelto con accanimento e tenacia
Vorrei dirle che le mie braccia sono vuote di lei, che le mie serate e le mie notti sono vuote di lei, che il mio cuore è vuoto di lei…
Che l’amo.
Senza l’impeto e il furioso sconvolgimento con il quale ho amato Dana, ma con la profondità di un’affinità elettiva, con il lavorio tormentoso di una lotta che tenta di sgretolare la
prigione mentale in cui sono reclusa.
Con la dolcezza, la tenerezza e la comprensione di un amore nato dal cuore e non dai sensi, nato dal futuro e non dal passato.
Vorrei chiederle perché non è qui con me, a guardare dentro i miei occhi quanto sto lottando per sconfiggere la tenebra e accogliere la luce.
Vorrei chiederle perché non siamo ancora insieme.
E non può dirmi perché io amo Dana, dato che questo lei lo ha sempre saputo.
O che sono folle, perché anche questo non l’ho mai nascosto.
O perché la faccio soffrire, perché sapeva che sarebbe successo.
O perché vuole ritrovare se stessa, dato che io l’ho messa di fronte a se stessa.
Forse è per questo che lei non è qui con me.
Perché io l’ho messa di fronte a se stessa e ne ha avuto paura.
In questi mesi di convivenza io le ho offerto tutto quello che era in mio possesso.
Adesso pretende ancora, ma perché esigere da me un qualcosa che non possiedo, che non ho mai posseduto? Perché immolare ancora la mia anima sull’altare di un abbandono che non
merito?
Io ho lottato per noi, con tutte le mie forze, come le avevo promesso.
I cambiamenti di fronte, le fughe e le incertezze erano inevitabili e scontate, in una situazione del genere.
Ho fatto dileguare Dana nel passato, ma invano, ormai.
E ora il mio presente non ha più né l’una né l’altra, perché Dana ha cessato di essere il nucleo delle mie speranze future, dei miei sensi, dei miei pensieri.
E Monica non vuole più la dolce vita di coppia che in questi mesi aveva ridato una parvenza umana al mio viso e un canto al mio cuore, anche se leggero e sfumato, un canto di speranza e di
crescita.
Ancora una volta ho costruito un progetto sull’aria, su una promessa che è stata disattesa.
Metto in tasca un’altra sconfitta, un’altra follia, un’altra perdita. Un altro pezzo del mio cuore che si è disintegrato nell’amore che non so ricevere e non so dare, ma che ho dato e
ricevuto per vivere e non per morire.
Penso all’aprile dell’anno scorso, quando sono venuta a Gabicce Monte. All’entusiasmo verso un nuovo amore, una nuova vita.
Quanta abnegazione per la persona che amavo.
Penso al mio ingresso nella casa di Monica. Quanto lavoro e quanto impegno sia per costruire la nostra casa e la nostra vita che per staccarmi emotivamente e affettivamente da
Dana.
Penso a quanto lei ha fatto per tenermi incatenata a sé.
A quanto Monica ha rovesciato sulle mie spalle della solitudine della sua vita, delle sue aspettative, delle sue incongruenze nel dirmi che avrebbe aiutato me, mentre in realtà si aspettava
che io aiutassi lei.
Ancora annego nelle mie lacrime, ancora vedo i miei errori solo dopo che li ho commessi, ancora ho affidato la mia vita al vento e sto raccogliendo tempesta e pioggia, tanta
pioggia.
Monica pensa che io la cerchi perché Dana non c’è, ma è in errore, perché Dana c’è, a modo suo naturalmente,
ma c’è.
Quello che è cambiato nel profondo del mio cuore è il sentimento che provo per lei e non è solo la rabbia che parla, o il senso dell’abbandono e del rifiuto, né la gelosia verso Elisa: è il
mio cuore che non parla più a lei come parlava prima.
Sento che il sentimento per Monica ha preso il sopravvento.
Penso al valore della mia vita, a questa corsa senza freni verso qualcosa che non ho trovato mai perché non era dentro di me.
Nonostante le lacrime, ho pregato con forza stasera, per imparare a sentire il valore di questa vita sballata, di questo vuoto cosmico che mi scava dentro, di questa lotta titanica tra la
mia intelligenza viva e pronta e la mia inadeguatezza a interpretare la mia realtà, vivendo di illusioni.
Intelligente e disadattata, amorevole e sola, abbandonata: ma un valore ce l’ho, lo devo avere.
Ce l’avrò, anche se sarò solo il Buddha dei barboni e dei falliti, degli sconfitti.
La mia dignità non affoga nel dolore, il mio coraggio e la mia onestà non affogano nei miei bisogni.
Monica mi ha lasciato perché non le ho mai mentito, perché le ho sempre detto fino in fondo quello che provavo.
Avrei potuto con facilità fare il doppio gioco e godere quello che lei mi offriva, invece ho sempre pensato e sentito la sofferenza che le causavo e ho messo sempre lei davanti ai miei
bisogni.
Pago come sempre a caro prezzo i miei errori e la mia integrità.
Avrà un valore, questo. Avrà un valore essere quella che sono? Avrà un senso nel fluire dello spazio e del tempo?
Io lo credo. E anche se cerco la morte come si cerca il sonno quando si è molto stanchi, anche se la mia instabilità è così profonda da annullare ogni mia volontà, anche se la mia storia è
inusuale quanto dolorosa, credo di essere una parte di un tutto intelligente e saggio, che in me vede senz’altro qualcosa di buono, altrimenti non mi avrebbe creato.
Nonostante nessuno veda nulla di buono in me: forse soltanto un immaginario esercito degli sconfitti dalla vita potrebbe trovare in me lo specchio nel quale riflettersi e
ritrovarsi.
Sento di appartenere a una categoria che questo mondo di vincenti scaccia come insetti molesti e pericolosi e pretendo che mi venga riconosciuto il diritto di vivere anche nella mia follia
e nella mia povertà, come qualsiasi altro essere umano.
- passa ancora qualche giorno nel freddo del campeggio solitario e quasi vuoto, con le vette delle montagne ancora innevate, i boschi che si rivestono di nuovo
verde, il ruscello che canta un'acqua gelata di fonte. Faccio lunghe passeggiate con Jerome in una solitudine totale immersa nei miei pensieri, nelle mie riflessioni. La notte io e lui stiamo
rannicchiati sotto tutte le coperte che ho eppure tremiamo di freddo. Ho problemi ad approvvigionarmi di cibo, il paese è lontano tre chilometri e la strada in salita piuttosto ripida mi
impedisce di usare la bicicletta. Ma d'altronde il denaro è assai poco. Le notti sono lunghissime e tormentate. E il mio lavorio interiore non ha tregua....
Ecco che ho fatto l’ultimo passo. Presa l’ultima e più difficile decisione.
Ora che c’era rimasta solo lei nella mia vita, l’unica persona con cui parlavo, che si prendeva cura di me, in un senso o nell’altro, l’unica presenza affettiva, anche se aberrante, in
questo deserto di calce che è ormai il mio cuore, adesso io ho deciso che non voglio più neppure Dana nella mia vita.
Non provo più amore per lei, lei non appartiene più alla mia vita: sono arrivata fino in fondo a questa storia disperata.
Quello che provavo per lei si è stemperato ed è svanito: mi sono finalmente resa conto di meritare qualcosa di più. Meglio stare da sola, come in effetti sono, che buttarmi via
così.
Amo molto Monica e sento troppo la sua mancanza: devo arrivare in fondo anche a questa storia.
L’una e l’altra anche se in modi diversi, non hanno tenuto conto di quello che sono io in realtà, dei miei bisogni e della mia vera essenza.
All’una e all’altra ho dato cose che non avevo, andando in debito con la mia vita.
Dana mi ha rifiutato e rinnegato fino alla fine,
Monica ha mentito a se stessa, mentendo a me, proponendomi una forza e una sicurezza che in assoluto non aveva.
Io mi sono illusa di poter cambiare Dana e di poter ricevere aiuto da Monica: entrambe le cose sono risultate sbagliate.
Dana cambierà solo se vuole davvero cambiare e non sarò io a poterlo fare in sua vece.
Io mi posso aiutare da sola: Monica non può fare niente per me, soprattutto non può darmi qualcosa che non ha, come io non possa darla a lei.
Ho voglia di Monica, ho voglia di noi. Dei nostri piccoli attimi insieme, delle risate, della sua pelle morbida mentre si sveglia, dell’allungare la mano e sentire che subito mi risponde.
Delle sue labbra tumide, delle sue mani piccole e infantili. Della nostra cucina gialla, del nostro gioco preferito, lo Scarabeo…
Ma l’ho travolta nei miei vortici profondi.
So che mi ha dato tutto e io ho ricambiato con tanto dolore e tanta incertezza.
Ho visto sempre nei suoi occhi e sul suo viso i danni della mia presenza accanto a lei.
Vederla amare un’altra donna e non sentirmi in diritto di reclamare il suo amore perché non me ne ritenevo
degna, mi ha fatto soffrire immensamente, così come mi ha fatto soffrire immensamente vederla andare via, ma sapere che tenerla con me, ancora legata a me, era farle quello che era stato
fatto a me.
E io l’amo così tanto che ho dovuto lasciarla andare via.
Così sono scesa in fondo a me stessa, ho contemplato i guasti della mia mente e del mio cuore, della mia vita e il dolore, la paura di quello che ho visto, la certezza di non poterne uscire
mai, mi hanno portato via.
Ma ora ne sono riemersa, profondamente cambiata e trasformata, pronta a ripartire da me, da quello che sono, da quello che ho conquistato, capito, afferrato, trasformato.
Starò sola se non vorrà tornare sulle sue decisioni e pregherò così intensamente che troverò la nuova via che mi aspetta, avendo già deciso che sarà finalmente una via saggia e giusta, una
via felice.
Ma ora l’amo come lei merita e non è un peccato mandarle ancora tutto il mio amore e il mio bene.
So che è tardi, ormai. Ma ancora io spero, solo un poco, appena un poco, di poterle offrire ancora questo amore, per renderla felice come non lo è mai stata.
So di essere una persona complicata e difficile, ma sto affrontando i miei problemi in profondità, con tutto il coraggio di cui sono capace: le risorse di cui dispongo sono ancora tante,
tantissime.
Dana era la personificazione di tutte le mie illusioni, di tutti i miei ostacoli, la perfetta aderenza a tutto quello che di deviato c’è stato nella mia infanzia e nella mia vita: era la
scelta delle scelte sbagliate.
E così tenacemente vi sono rimasta attaccata, perché staccarmi da lei voleva dire cambiare così tanto di me che era persino impossibile pensarlo.
È stato un processo sconvolgente e devastante, ma vivificatore.
L’ho affrontato per me, naturalmente.
Ma anche per noi, perché credevo nel nostro amore, nato dalla vita e dal futuro e non dai sensi di colpa e dalle catene del passato. Sono state catene terribilmente dure da spezzare e farlo
ha quasi spezzato me e Monica. Lei mi ha infuso tutta la sua energia e io l’ho assorbita dentro di me come nutrimento, come appiglio per lo sforzo disperato che volevo compiere: di questo la
ringrazio, anche se non tornerà da me.
Senza lei non ce l’avrei fatta.
Il tuo cuore di pietra, Monica, è diventato tenero da quando hai bevuto alla fonte squisita dell’amore puro,
inebriato di sottili canti mattutini e di silenziose quieti notturne.
La voce del passato fluisce fra le tue mani innocenti, come sabbia fine e chiarissima di vita.
Tu, vestita di luce, gradino di pietra sotto i miei passi stanchi, hai assorbito la mia ombra.
L’eco, filtrata di giallo e di bianco puro, riverbera nella valle montana lucidando le foglie nuove del verdissimo tempo del risveglio.
La voce del mio cuore canta di nuovo per la mia vita, insieme a chi amo.
La mia voce canta ancora per il mio cuore e per l’esteso seminare.
Lacrime e sorrisi senza fine, pane della vita alla mia mensa, grata di riceverli.
Domani forse lei verrà.
Le ricorderò il nostro progetto, le sue promesse, il suo impegno. Le ricorderò che io comunque sono andata in fondo alle mie promesse. Cercherò di farle vedere nel profondo dei miei occhi
l’amore sincero ma non disperato che mi vive dentro, la nuova dignità che è sorta dalle mie macerie.
Le chiederò di prendere una decisione: le darò tempo, ma non voglio restare per mesi attaccata a una speranza o a un’attesa che fermi di nuovo la mia ascesa.
Le chiederò di guardare dentro di sé e di affrontare le sue paure, le ricorderò che mi ha perso solo perché non ha avuto la costanza di attendere il tempo del raccolto.
Ma se non c’è più in lei il desiderio di portare avanti il nostro amore, se non c’è più quell’amore, perché le sofferenze che io le ho inflitto l’hanno soffocato, io proseguirò per la mia
strada, che ancora non so quale sarà.
So che soffrirò ancora, ma penso che ormai sono pronta a superare qualsiasi sofferenza perché ho capito dove, come e cosa cercare quando soffro.

CAPITOLO
TRENTAQUATTRESIMO
Dolore nel dolore
Il dolore del suo dolore.
Monica è una persona sfinita e distrutta, che ha paura di me e dell’amore.
Io, concentrata come sempre su di me, sulle mie ragioni, sui miei desideri, sui miei bisogni, ho cercato davvero di dimostrarle il mio amore, di trasmetterle quello che era cambiato in me,
ma il suo dolce viso era tirato e i suoi occhi non accettavano i miei che intensamente cercavano i suoi.
Tutti i miei bei discorsi, tutto quello che le volevo dire si è infranto sul suo dolore, che ho causato io.
E certo che non vuole più amarmi, certo che non vuole più amore, se l’amore può fare così male, se io posso fare così male.
Quando se ne è andata da qui, dopo avere dichiarato fermamente che vuole ricreare se stessa e la sua vita, che la sua Elisa è molto innamorata di lei e la sta aiutando a superare questo
terribile frangente, io mi sono sentita svuotata.
La mia mente stranita e malandata ha di nuovo ricominciato tutti i suoi giri viziosi e concentrici: ora faccio
questo… Ora vado lì… No, meglio là… Aspetto, riparto.
Fissi nella mente gli occhi colmi di lacrime di Monica e il suo cuore che mi cerca e mi respinge con la medesima
forza e disperazione.
Lei voleva andarsene e io l’abbracciavo in una sorta di ultimo addio: volevo darle in un attimo tutto quello che le ho portato via in questi mesi di follia, volevo arginare quel dolore che
per la prima volta sentivo più forte del mio ed è la prima volta che io sento il dolore di qualcun altro più forte del mio.
Che essere involuto e arrotolato su se stesso che sono!
Egocentrico, attorcigliato a questa fame d’amore che mi divora e divora tutti quelli che mi stanno vicino.
E finora tutto quello che ho fatto per gli altri e con gli altri è stato fatto per ottenere da loro in cambio l’amore e l’apprezzamento che così freneticamente cerco.
Io sono una creatura malata che deve restare in un certo senso segregata, che deve smettere di far soffrire altre creature: le ho scritto in un messaggio telefonico che sentivo il male che
le avevo inflitto e che la esortavo a vivere con chi la faceva stare bene, senza preoccuparsi di me.
Devo aver rubato molto nelle vite precedenti per ritrovarmi così affamata in questa vita e molto devo dare, per pareggiare i conti.
Cercherò di farlo, cominciando da ora, cominciando dal desiderio infinito e dalla determinazione di non far più del male a nessuno e dal desiderio della felicità per Monica, a prescindere
che io sia ancora nella sua vita o
meno.
E mentre scorrevano le lacrime del dolore di Monica a definire un distacco tra noi che pure io sento in qualche modo necessario, per la rabbia e l’odio malcelato verso di me che ho visto
dentro di lei, anche il dolore di Dana si faceva strada prepotentemente nelle mie sensazioni.
Un dolore che da sempre mi colma e mi invade come un’alluvione precipitata in un lago disseccato, un dolore che potevo lenire, in qualche maniera.
Le ho mandato un messaggio dove le dicevo che se era più felice senza di me, continuasse pure la sua strada, ma che se stava soffrendo per la mia mancanza, potevamo sentirci, se avesse
voluto.
Nel medesimo istante in cui io spedivo il mio sms, al mio cellulare ne arrivava uno suo che mi chiedeva se avessi fatto io squillare il suo telefonino.
È incredibile quello che ci succede.
Siamo così empatiche che io riesco persino a far suonare il suo cellulare col pensiero, col mio amore per lei. Questo è un fatto inconfutabile ed è certissimo che le nostre vite sono così
intrecciate da sempre e per sempre lo resteranno.
Abbiamo parlato a lungo e io le ho raccontato gli ultimi avvenimenti dentro e fuori di me.
Lei mi ha narrato del dolore fisico che le provoca la mia assenza e di quanto fosse stato difficile in questi
pochi giorni stare lontana da me.
So che questo ormai è un copione assai liso di una storia già arcinota, ma come ogni volta in cui ci siamo distaccate e poi riavvicinate in questa odissea d’amore e di rifiuti, un passo
diverso è stato fatto: questa volta il cammino ha deviato dentro di me.
Io lo sento fortemente, così nettamente che, quando mi chiedo se anche questi ragionamenti e sensazioni siano frutto come sempre delle mie illusioni e delle bugie che mi racconto, la
risposta che mi do è un no deciso e secco, un no molto determinato.
Ma Dana è stata qui, oggi e ci siamo amate con la nostra immacolata ferocia, con la nostra angelica riluttanza per le cose normali e scontate, con la divina carnalità che ci
contraddistingue, quando insieme, corpo contro corpo, pelle contro pelle, cerchiamo il nostro piacere a onta di pericoli profondi creati nella nostra vita.
Ci siamo incontrate e contrapposte con tutta la
nostra potenza, possedute e sottomesse in un crescendo rossiniano, ci siamo perdute e ritrovate ancora mille volte e poi ancora mille nel canto che ci viene meglio, quello del nostro
reciproco piacere.
E le sue forme, le fattezze del suo viso, le sue espressioni, plasmate dalle mie mani e dalle mie
labbra, assaporate, bevute, dominate, donate, create, scoperte, abbandonate e poi riprese, ascoltate e
guardate, ancora una volta erano quelle di un angelo precipitato sulla terra per amare anche me, per godere anche di me, per restare accanto a me e per tornare ogni volta alla sua vita, che
non è la mia.
E come sempre io sono qui, sola a scrivere di lei e il mio sentimento canta un ringraziamento per lei, un apprezzamento completo di quello che mi dà, che mi sta spingendo sempre verso
strade nuove e inattese, che mi sta suggerendo sempre nuovi espedienti per correre questa gara insieme al tempo che passa e non ha fine. Schiava e padrona della mia vita, padrona e schiava, in
un’alternanza esaltante e irreale, inusuale.
Ora lei siede a tavola con il marito e io pure parteciperò alla cena, ma non sento nessun senso di vuoto, nessuna delirante mancanza.
Sento le mie membra stanche e sazie d’amore, sento la potenza della mia anima che mi esplode dentro, sento il suo nome e il mio gridati forte nell’infinito siderale.
L’amore del corpo mi scorre nelle vene con la sua taumaturgica potenza…
Mi sento guarita dall’amore e nell’amore di un corpo che mi si è offerto senza volere altro che il piacere, senza che io mi aspettassi altro che il piacere.

CAPITOLO
TRENTACINQUESIMO
Il volo della
rondine
Non avevo capito che la mano gelida che mi artigliava quando, paralizzata nel buio attendevo il sonno, era la mia. Che il mostro oscuro e ghignante dietro la porta socchiusa, il vampiro
assetato di sangue attaccato al mio collo diafano, ero io.
Di giorno ridevo, cantavo, parlavo più forte, infondendo coraggio a chi aveva paura, a chi aveva lacrime che sapevano scendere.
Io, forte di una paura invisibile alla luce del sole, riempivo lo spazio tra i denti marci della bestia che mi divorava dentro, lasciandomi sempre un po’ viva, in modo che potessi alzarmi e
spandere la mia anima sbriciolata, becchime per gli amici.
Orgoglio, appetito, entusiasmo: nient’altro che cibo per cannibali.
Il dono alla nascita accanto alla culla: l’orso di paglia scuro e rigido che mi terrorizzava da piccola
era il mio orco personale, era la mia mente lucida, avida.
Era il Moloch divoratore alimentato dalle mie stesse viscere.
È l’alba. Da parecchio tempo non mi alzavo così presto. Ma è tutto nuvoloso e non c’è niente da vedere, se non le nubi basse che nascondono tutto. Si sente nell’aria il canto sonnacchioso
degli uccelli al risveglio. Fa ancora molto freddo, meglio indossare maglioni e felpa.
Sono stati giorni durissimi.
La sera del 9 giugno Monica è venuta a prendermi.
Ero in preda a una fortissima crisi di pianto, mi ha portato al pronto soccorso e dopo diverse ore,
quando ero stremata, alla fine mi ha visitato uno psichiatra.
Una persona molto umana e comprensiva, che mi ha proposto di entrare a far parte del suo gruppo terapeutico, cosa che ho accettato con immenso sollievo.
Ma il centro di accoglienza legato a questa struttura terapeutica sta per essere smantellato, così io non sapevo dove andare.
La notte l’ho trascorsa all’SPDC di Sant’Agata Feltria, una sistemazione del tutto inaccettabile per me.
Nel primo pomeriggio sono arrivati Gabriele e Antonio: si è svolto un gran conciliabolo tra loro, Monica e i medici. Alla fine mi hanno praticamente sollevata di peso e portata a Imola. È
venuta anche Monica, ma stentiamo a comunicare: ogni contatto fra me e il resto del mondo è quasi interrotto, ormai.
A casa si sono mostrati tutti affettuosi e gentili, ma anche lì la mia permanenza si rivela impossibile a causa di tutti i problemi irrisolti, dei sensi di colpa, di quella sensazione di
totale sconfitta, di essere di peso, di complicare ulteriormente la vita già difficile dei ragazzi.
Per il 12 era fissata la visita con il coordinatore del reparto di psichiatria, che avrebbe dovuto prendermi in carico per far parte del gruppo terapeutico.
Dopo alcune telefonate esplorative, ho deciso di prendere il treno.
La visita è stata esclusivamente un punto di partenza tecnico e burocratico, ma hanno promesso comunque di ricontattarmi.
Il medico che gestisce la terapia mi ha garantito di persona che ha riservato un posto per me e
che mi inserirà al più presto.
Ripongo molta fiducia in lui: in effetti ora come ora non vedo altre possibilità.
Nel pomeriggio sono andata a visitare una casa di accoglienza femminile a Sant’Agata Feltria.
Già il fatto che sia un’associazione cattolica non mi ispira per niente.
La direttrice e councelor, però, mi ha sorpreso, con il suo fare spigliato e partecipativo e anche con la sua bellezza matura: ha gli occhi azzurri e i capelli biondi.
Una camera, un po’ squallida, per me e tutto il resto in comune con ragazze madri, prostitute levate dalla strada, magrebine con bimbi, una delle quali probabilmente
subnormale.
Il posto è un vecchio collegio come ne esistono a Imola e dovunque, pulito ma vetusto, parzialmente in ristrutturazione. Ma il terrazzo è veramente gradevole.
Spero di poter portare i miei fiori e magari la mia amaca, il tavolo e l’ombrellone…
Mentre ero lì, il mio orgoglio e quello che resta della mia dignità si sono ribellati e una rabbia dolorosa è deflagrata dentro di me.
Ho rifiutato.
Ma ieri mi sono svegliata con un senso di solitudine e di vuoto incolmabile.
Dana ha rifiutato più volte di venirmi a trovare. So che ha la madre all’ospedale, ma qualche ora da dedicarmi sicuramente l’avrebbe trovata, se avesse voluto. Lei, come sempre, pensa
unicamente a se stessa. Il suo egoismo è feroce e crudele. Deve sempre dimostrarmi di essere lei la più forte e questa è stata l’ennesima occasione.
Dal giorno del ricovero assumo di nuovo psicofarmaci.
Il tavor mi fa dormire, ma un altro, l’impromen, mi ha causato atroci spasmi e convulsioni, per cui ho dovuto smettere di prenderlo.
Penso ancora al suicidio, non so quante volte ho visto il cutter recidere le mie vene. Non so come ho resistito.
A casa di Monica la foto di Elisa col bambino faceva bella vista sul desktop del computer.
Era tutto sottosopra, alcune delle mie cose gettate per terra.
Un’atmosfera di totale disfacimento e un unico, chiarissimo invito: vattene via!
È la normale conseguenza delle mie azioni, io che ho buttato via la soluzione a tutti i miei problemi, o almeno a molti, per continuare ad amare una donna che assolutamente non mi vuole, mi
usa per i suoi scopi e di me non ha la minima pietà, neppure quando mi vede sul letto di morte.
Davvero il mio comportamento allontana tutti…
In questi due giorni nessuno si è fatto vivo, né di persona né per telefono.
Il 12 sera ho dormito da Monica, ma le mie richieste d’amore, non fisico naturalmente, sono state puntualmente rifiutate con cattiveria e freddezza.
Lei è molto arrabbiata con me e ha le sue buone ragioni.
Io, poi, ho vagato tutta la notte per casa, in preda a spasmi terrificanti. Dati dal medicinale
Ho avuto tregua solo la sera del giorno dopo.
Una compagna di fede, con il figlio, la mattina dopo mi ha riportato a Campigna, dove, sfinita, ho riposato
un po’.
Verso sera ho chiesto a Dana di venire, perché nel frattempo avevo deciso di accettare l’ospitalità
della casa d’accoglienza, ma mi ha risposto ancora, vigliaccamente, di no.
Adesso tra me e lei è davvero finita.
16 giugno, mattina.
Domani Antonio e Gabriele verranno a portarmi al centro di accoglienza.
Io sono esausta e disperata.
Prego, anche se non so dove sia di casa la speranza, anche se i miei occhi oggi non vedono nessuna luce e la mia anima è orfana, naufragata su altissimi scogli.
Il capitano ha perso il suo vascello e tutto l’equipaggio.
Addio Dana, addio Monica, addio vita di Arianna.
16 giugno, ore 22.51.
Dana è appena andata via.
È venuta a salutare la Chiocciolina e anche me, perché anche io sono andata via, non esisto più, non mi illudo più di vivere, di amare e di sperare: non mi aspetto più nulla.
Lascerò trascorrere il tempo nelle mie piccole cose, nei miei giochi innocenti.
Le medicine mi annebbiano la mente e mi annullano la volontà.
Le persone non esistono più, io non voglio più responsabilità.
Non devo più niente a nessuno, nessuno deve più niente a me.
Monica è sparita.
Io non ho mai capito le persone, non ho mai capito come si fa a vivere.
Mi hanno fornito strumenti che non sono validi per sopravvivere: l’onestà, la coerenza, la sincerità, il rispetto
verso il prossimo, l’umiltà di ammettere quando hai torto, l’affermazione della propria identità anche se diversa dagli schemi…
Sono io a essere totalmente sbagliata?
Ma io non esisto più, io non ci sono più: sono andata via. Sorrido come un ebete, con gli occhi semichiusi. Restano i giochi infantili: i miei quadri, i miei colori, le mie parole. La vita
vera è fuori di me: io sono morta.
17 giugno, ore 22.00.
Il computer è al Pio Istituto Femminile di Accoglienza.
E anche io… Sto lottando contro la tristezza e la rabbia, ma il mio orgoglio mi impedisce di lasciarmi schiacciare.
I bagni sono sporchi: domani pulirò a fondo almeno quello che userò io e chiederò una ventosa per sturare il piatto doccia che ristagna.
Anche la pulizia della mia camera lascia molto a desiderare: domani la tirerò a lustro.
In due tornate, Gabriele e Antonio mi hanno portato giù quasi tutta la mia roba, ma mancano ancora i colori, i quadri e molti dei miei libri. Mi hanno promesso che torneranno entro un paio
di giorni.
I ragazzi del campeggio cercheranno di vendere la Chiocciolina, per pagarsi le spese: ho regalato loro la mia bici per il disturbo.
Addio Chiocciolina, eri l’unica cosa che possedevo…
La mia camera è spaziosa, il pavimento è antichizzato, con una greca arancio e marrone. Il resto delle pareti è dipinto a scagliola di grigio chiaro ormai sporco. Qua e là, sul soffitto
alto più di quattro metri con tre mezzi archi intonacati, sono visibili segni di umidità e l’intonaco è scrostato: stanno ristrutturando e mi pare che sia proprio indispensabile.
L’armadio è vecchio e piuttosto logoro. Le porte non si chiudono bene; sullo specchio interno si è depositato un dito di polvere.
Le imposte grigio chiaro non si chiudono bene e anche le finestre interne sono altrettanto malridotte: ma almeno le tendine sono bianche.
E meno male, perché la mia finestra si affaccia su un’ampia terrazza dove tutti passeggiano e giocano, sbirciando tranquillamente dentro la mia camera, che è alta mezzo metro sul livello
del pavimento del terrazzo. Chiederò alla direttrice di rimediare in qualche modo a questa totale assenza di privacy…
Ho aperto il mio altare, da sola, perché nessuna si è degnata di mandarmi una parola e tutte lo sapevano che oggi sarei venuta qui. Povero altare mio, ramingo proprio come
me.
È la sesta volta che lo apro…
Dopo la preghiera ho vagato nel quartiere qui attorno, passeggiando per le strade deserte.
Gioca l’Italia stasera, non c’è un’anima viva in giro.
Ho preso un gelato, un Magnum, nel bar più squallido che abbia mai visto, ma percorrendo la ripida salita le antiche mura calcinate e opache mi hanno catturato, affascinato. La città
diventa suggestiva, quando non c’è nessuno…
Oggi, mentre mettevo a posto le mie cose cercando di rendere vivibile questa infame topaia, ho pensato a quelli che non hanno neppure questo e che io pure potrei essere tra di loro. Ho
pensato che non devo più avere paura che la pioggia o il vento mi portino via la roulotte, come più volte è rischiato che accadesse. Ho pensato a chi ha tutto dopo averlo rubato a chi non ce l’ha
e non è contento lo stesso.
La gioia è amara, stasera, ma ancora resiste.
Ho avuto attimi di buio.
Ma i miei quadri miglioreranno la stanza. L’altro ieri ne ho terminato uno nuovo, intitolato Pioggia sui monti: mi pare ben riuscito.
Ho deciso di non regalare a Monica il quadro che ho dipinto in occasione del suo compleanno: lo doveva accettare al momento della mia offerta, adesso non sopporto più l’idea di separarmene.
Ho composto anche la cornice e mi piace troppo, me la tengo.
Monica pensa che le colpe siano tutte mie, che l’ho trattata come un punching ball, mentre invece io l’ho amata e mi sono sforzata al massimo per allontanarmi da Dana, riuscendovi, ma
invano.
Ora Monica non mi prende neppure più in considerazione: ha detto che lei per me non c’è più. E quante volte mi aveva ripetuto che ci sarebbe sempre stata per me…
Come cambiano le cose: io allontano la gente, non so come faccio, ma succede.
Si vede che voglio stare sola, che devo stare sola.
Mi sento un granello di sabbia, una goccia di sudore sulla schiena di un elefante.
Mi sento secca ma pungo come un cactus.
Sarà un riso sardonico, ma io riderò, fino a che non avrò imparato a farmi beffe delle avversità: come quelli che muoiono in galera ma ridono, ridono.
È ridicolo che a cinquantatre anni, dopo aver amato intensamente, dopo aver dato tutto quello che potevo e anche di più, a figli, mariti, amanti, compagne, madre, parenti, amici, io mi
trovi in una casa di accoglienza per prostitute: si vede che mi sono prostituita pure io.
Io non capisco la gente, le regole della convivenza civile, io non capisco nulla…
So solo che fuori piove e che le gocce battono sul vecchio legno dell’imposta grigio chiaro.
Solitudine, degradazione. Un Buddha avariato…
19 giugno, ore 00.33.
Nel primo pomeriggio sono andata a parlare con una psichiatra al centro di salute mentale, percorrendo più di tre chilometri a piedi, ma questa aliena dottoressa non mi ha fatto
assolutamente niente di niente, anzi, mi ha detto di non illudermi, che tanto gli schizofrenici, psicotici, paranoici come me non possono guarire. Sono imbottita di psicofarmaci: non mangio, ma
stasera ho bevuto una birra.
Soffro da morire per Dana.
Soffro da morire per Monica.
Soffro da morire perché la mia vita è finita: la mia roulotte verrà venduta o confiscata.
Il mio psichiatra è in ferie e fino al 16 luglio non posso cominciare nulla, solo tavor a gogò.
Le mie compagne di fede Buddhista non mi reggono più e cercano di starsene tranquille lontano da me. Io mi chiudo in questi lavoretti, ma non sono più lucida: oggi c'era il sole, ma io
avevo freddo.
La vita mi è esplosa nelle mani.
20 giugno, ora indeterminata.
Oggi sono stata alla mia roulotte, la mia Chiocciolina e l'ho depauperata di tutto quello che era mio, abbandonando il resto a gente che l'userà, che magari ci guadagnerà sopra, oppure allo
sfasciacarrozze.
La mia capanna dello zio Tom, il rifugio di Robinson Crusoe, la mia ultima casa, il mio guscio…
Ma questa stanza del Pio Albergo, ricovero per derelitte, ora ha i miei quadri e le mie cose, libri, fogli, colori. Il cibo nell’armadio, se no lo rubano; il bagno in comune che è sempre
sporco e io sempre lo pulisco con l’anticalcare.
Ho portato sotto il davanzale della finestra le mie petunie bianche e i miei quadri ora sono appesi al muro. Tre tele vergini attendono l’evolversi della mia ispirazione.
Questa stanza bene o male mi offre un tetto sulla testa e un letto comodo in cui riposare.
Anche se non è la vita che desideravo, non intendo sputarci sopra: per 220 euro al mese cosa vuoi pretendere?
In questo Pio Istituto, viene due volte al mese Stefano, uno psicoterapeuta che segue maestri americani e mi ricorda tanto il mio amato maestro Francesco, che mi aiutò con la sua filosofia
e le sue cure tanti anni fa e che ora è in India.
La sua teoria sostiene che è nelle generazioni passate, non tanto a livello cromosomico, ma come influenza dell’ambiente e delle energie dei nostri predecessori, che vanno ricercati gli
intoppi ai nostri meccanismi e le
cause oscure a questi dolori che sembra non abbiano mai fine…
Oggi ho pianto moltissimo. E anche ora sto piangendo.
Ma la cosa che più mi ha sconvolto è stato quando Stefano, dietro mia richiesta, ha composto
la mia Costellazione famigliare.
Funziona così. Io ho posto un problema per me importante e cioè il perché non posso vivere senza
amore: Stefano mi ha fatto scegliere una persona che rappresentasse me e una che rappresentasse mia madre, dato che il primo amore è la madre. Io mi sono seduta a guardare. Per comodità di
narrazione parlerò di queste persone come fossero realmente me e i miei parenti.
Quando io e mia madre ci siamo trovate di fronte, io assolutamente ero freddissima nei confronti di quella che era mia madre, che mi guardava preoccupata e arcigna. Stefano mi ha chiesto di
salutare mia madre, ma il saluto è stato appena abbozzato e freddo, senza alcun contatto fisico.
Allora Stefano ha preso un bel ragazzo di colore per rappresentare mio padre e lui mi guardava con amore. Mi ha fatto salutare mio padre e ringraziarlo di tutto quello che mi aveva dato,
che io avevo apprezzato moltissimo.
Io piangevo, ma la situazione non si sbloccava.
Allora Stefano ha preso altre donne che rappresentavano mia nonna, la bisnonna e la trisnonna.
Subito tra mia madre e mia nonna c’è stato uno sguardo carico di tensione, quasi di odio e nessun
contatto.
Quindi Stefano ha fatto rivolgere mia nonna verso sua madre e immediatamente la nonna ha cambiato espressione trasformandosi in un’esplosione d’amore. Ma tra le due, la madre effettiva era
la figlia, cioè mia nonna, e non la mia bisnonna. Infatti mia nonna cercava di attirare a sé la madre e di tenerla in suo potere, mentre quest’ultima, pur nello sguardo d’amore, malcelava una
profonda insicurezza e una sorta di domanda silenziosa e anche un po’ di paura.
A questo punto il dottore ha fatto entrare in campo la mia trisnonna, che ha abbracciato normalmente da madre a figlia la mia bisnonna.
In questa fase la propagazione dei ruoli e delle energie appariva equilibrata. Ma mentre questo accadeva, mia madre si accasciava al suolo senza forza, pallida e tristissima.
Allora la mia trisnonna si è posta alle spalle della mia bisnonna, appoggiandole i palmi delle mani sulle scapole, per sostenerla, mentre si rivolgeva di nuovo verso mia nonna. Ancora ella
ha cercato di
attirare a sé la madre come fosse una figlia e la tensione è stata tanta, ma la bisnonna non ha ceduto e le cose si sono in parte riequilibrate.
Mia madre però restava sempre per terra, così che Stefano mi ha chiesto se prima di lei ci fosse stato un figlio morto. Infatti Vincenzo era nato poco meno di un anno prima di mia madre,
nel 1923, ed era un bambino stupendo, l’orgoglio di mia nonna: purtroppo morì precocemente di tetano perché la levatrice gli incise il filetto della lingua senza disinfettare le forbici… quindi è
stato richiesto un volontario per impersonare Vincenzo. Il legame tra Vincenzo e mia nonna era fortissimo e nessuno dei due voleva staccarsi dall’altro. Nessuno prestava attenzione a mia madre,
che rimaneva per terra e a me che come assente mi trovavo in un luogo che sembrava non appartenermi (quando dico che vengo da un altro pianeta…).
Stefano ha chiamato un altro personaggio, il Destino e dopo molte reticenze e dolore, finalmente Vincenzo si è staccato dalla mia nonna, che si chiamava Argentina, madre di dodici figli, di
cui due morti in tenerissima età e uno in guerra. E non si sa quanti aborti.
Vincenzo allora ha seguito il suo destino ancora riluttante e ha lasciato Argentina. A quel punto mia madre si è alzata e si è avvicinata a mia nonna, che l’ha abbracciata e le due donne si
rinnovavano ora amore da madre a figlia.
Restavo io, lì, immobile.
Stefano ha preso delle persone e me le ha messe attorno, uomini e donne, amici e partner: ma nessuno si avvicinava a me, né io riuscivo a raggiungere nessuno, tanto meno mia madre, che
guardavo con aria assente e fredda, desolata e smarrita.
Io sola, sola, sola.
Ecco da dove nasce il mio vuoto incolmabile.
Alla fine Stefano mi ha detto che non sono ancora pronta per avvicinarmi a mia madre e alle altre
persone, che ho bisogno di tempo, perché tutti quelli ai quali mi avvicino finiscono per allontanarmi.
Ecco il mio karma.
Mi sento sconvolta e disperata, e non so come farò…
Non so come farò… Non so come farò.
È l’alba.
Sulla tettoia del terrazzo l’aria si colora di bianco rosato e di celestino.
Le rondini fanno la toeletta alle penne ancora nei loro nidi, pronte a spiccare il volo in questa giornata radiosa.
Ho dormito un sonno scarso e agitato, denso di incubi che non ricordo.
Per tutta la giornata di ieri, anche se non mi trovavo in uno stato di dormiveglia, nella mia mente sono fluite visioni inquietanti: una donna che scagliava lontano da sé una lunghissima
collana di perle bianche, come una staffilata; un’altra con un pesante drappo rossastro e un palo…
Vado a camminane nell’aurora, a sentire l’aria mentre regna il silenzio degli uomini.
Lascerò che il canto del gallo scorra nelle mie vene.
21 giugno, verso sera.
Non possiedo parole allineate, ma solo l'urlo dei miei occhi che non smettono di stillare lacrime, lacrime intrise di sangue.
Continuo a perfezionare le tecniche intraprese ieri, ma ne esco devastata perché quello che resta di me è un pugno di briciole rinsecchite e ammuffite, che anche un passerotto affamato
rifiuterebbe.
Le parole, i pensieri pesano e scavano, scavano e pesano, rivoltano e strappano e il disordine ristagna dalla superficie alla forra…
Fermati, mente. Taci, cuore: tutte le vite e le morti prima e dopo di me si dimenano nel mio petto che arde pesante come una galassia bucata.
Domani disegnerò, dipingerò colori e linee: basta parole.
Vorrei andare a nuotare tra i sassi e l’acqua.
Vorrei la mia compagna, quella che credevo di amare in modo troppo tiepido, quella che mi aveva dato tutto e chiesto troppo. Vorrei poter dormire abbracciata a lei, sentirla respirare,
sentire la forza del suo amore e posarvi sopra la forza del mio.
Ora che ho catturato dentro di me la scintilla di un amore che forse non è sbagliato, proprio ora l’amore mi viene negato, anche se sento di meritarlo.
È da una settimana che non chiudo occhio se non per brevi periodi, nonostante il tavor: ma chi semina vento, raccoglie tempesta.
E io sto raccogliendo le tempeste di intere generazioni passate della mia famiglia e di quelle future, anche: l'unica dignità che mi resta è il valore immenso della preghiera
Buddhista.
Pago debiti di gratitudine.
Scusate, ma stasera sono finita.
22 giugno, di prima mattina.
Sono sveglia dalle cinque e tre quarti: le rondini mi chiamavano.
Questo antico collegio è stato edificato a forma di elle e sorge su tre piani, di cui l’ultimo più ristretto, come un attico aggiunto successivamente.
Io abito al piano intermedio: le finestre delle stanzette dove dormiamo sono piccole, mentre i corridoi di uso comune sembrano interminabili. L’antico refettorio è stato trasformato in una
scuola di danza gestita da persone esterne all’associazione e le finestre danno su di un terrazzo col pavimento impeciato e non rifinito, dalle ringhiere arrugginite, mentre, di sotto, si trova
un rumoroso cantiere edile, dove si sta costruendo non so cosa. Le balze dei tetti con le travi di legno e le tegole un po’ muschiate, sbrecciate e scurite dal logorio degli anni, sono la casa e
la palestra per una colonia piuttosto numerosa di rondini balestruccio, quelle col petto bianco, per intenderci. Il loro cicaleccio è continuo e sono sempre indaffarate nelle quotidiane
esperienze della loro vita libera, anche se dura e spartana: all’alba e al tramonto, le rondini danzano il loro
rituale, la loro preghiera per salutare il giorno che viene o che va. Si riuniscono tutte insieme e compiono a velocità vertiginosa giri circolari concentrici, sfiorando temerariamente, con
precisione millimetrica, le tegole del tetto, garrendo a gole spiegate.
Questo rituale è ripetuto più e più volte, con qualche pausa durante la quale sembra che il gruppo si sia sciolto, per poi compattarsi di nuovo e ripartire più forsennatamente di
prima.
Io avevo osservato molte volte questo rituale nelle sere estive della mia infanzia, quando tra i vecchi palazzi della mia via l’abituale carosello mi rapiva gli occhi al
cielo.
Da allora non l’avevo più ritrovato e mi riempie di gioia alzarmi appena sento le loro voci e mettermi a braccia spalancate al centro del lungo corridoio aereo, accompagnando la loro danza
con la mia: il loro sangue di rondine si versa nel mio e volo.
Poi gioco mezz’ora con il mio allenatore di tennis, che non è un uomo, ma un aggeggio che tu colpisci con una pallina legata a un cordino fissato a una molla girevole e ti ritorna indietro,
in modo che tu possa colpirla ancora: tennis per single.
Qualche minuto di stretching e poi una doccia calda. Il pianto ogni tanto accorre ai miei occhi, ma io lascio
che faccia e sento scorrermi giù le lacrime. Ormai, la strada la conoscono.
Davanti alla mia preghiera ho rivissuto l’esperienza della costellazione fatta venerdì, vedendo ancora i momenti drammatici e le espressioni dei miei compagni di gruppo, l’intenso dolore
che trapelava da tutti i loro gesti.
Ma un altro ricordo è tornato prepotente: non so più da quanto tempo non pensavo a questo.
Si tratta di Silvia, la maggiore delle mie figlie.
All’epoca aveva 15 anni. Io spero che scrivendo qui di questa cosa, nessuno possa giudicarla aspramente e spero di non farle un grave torto, ma ho estremamente bisogno di raccontare quello
che successe.
La sua fu una adolescenza precoce e molto difficile.
Mi separai da suo padre quando lei aveva otto anni e Silvia decise di venire a vivere con me, anche se amava il padre molto più di quanto non amasse me e loro due si capissero assai di
più.
Quattro anni dopo, quando è nato il mio terzo figlio, io sono stata ricoverata in ospedale, in condizioni piuttosto critiche: questo le ha fornito lo spunto per chiedermi di trasferirsi dal
padre, al quale era sempre più legata e che viveva ancora nella casa un tempo appartenente alla nostra famiglia.
Con dolore ho acconsentito, ma gli attriti fra il mio secondo marito e mia figlia erano già evidenti, e parimenti la gelosia per i fratellini.
Io continuavo a vederla tutti i giorni, perché dopo la scuola veniva a mangiare da me e a fare i compiti.
Di sera il padre, tornando dal lavoro, la passava a prendere e tornavano a casa: sembrava andasse tutto bene. Ma a un certo punto è arrivata una donna nella vita del mio ex marito, che
prima si è accaparrata l’amore di mia figlia per fare breccia nel cuore del padre e poi, dopo circa un anno, si è stabilita a casa sua e lo ha posto di fronte a una scelta terribile: o la figlia
o lei.
Il mio ex marito ha scelto la nuova compagna.
Dopo poco erano sposati, ma prima, un giorno, così, senza preavviso né a me né a sua figlia, me l’ha riportata con quasi tutte le sue cose, adducendo la scusa di un viaggio e dicendomi,
senza che lei sentisse, che era arrivato anche per lui il momento di rifarsi una vita e di essere felice.
Da quel momento è sparito,e la sua presenza nella vita di mia figlia si è ridotta a qualche breve e imbarazzata telefonata.
Ci sono voluti moltissimi anni perché il loro rapporto fosse recuperato almeno parzialmente, mentre ancora oggi, per la sua matrigna, mia figlia non esiste.
A noi sembrava impossibile che un simile amore paterno, nato insieme a lei, potesse finire così improvvisamente: il suo papà che le dava il biberon e le cambiava i pannolini e appena poteva
se la portava dietro a lavorare nei campi dell’azienda agricola che dirigeva…
I mesi passavano e mia figlia non chiedeva niente, ma si vedeva che soffriva immensamente.
Il nostro rapporto è stato sempre molto difficile.
Io sono stata una mamma molto affettuosa con tutti i miei
tre figli, ma lei ha sempre scansato i miei gesti d’affetto e la mia complicità.
Non ne so il motivo, non l’ho mai capito. Dovrò fare una costellazione anche per questo.
Il suo dolore in una età così delicata cominciò a esternarsi. Divenne dark, cominciò a fumare, e non solo sigarette. Sempre fuori di casa. Problemi a scuola. Cattiva con tutti e soprattutto
con me: povera figlia mia.
Un giorno, dopo circa sei mesi, mi chiese quando sarebbe tornata a stare dal padre e io le dovetti dire che la cosa era impossibile.
Secondo la sua natura, non fece una piega, perché io l’ho vista piangere solo per la morte di suo nonno e per quella dei suoi cani e gatti, occasioni nelle quali ha veramente esternato
tutto il suo dolore.
Altrimenti lei non piange. E non lo fece neppure quella volta. Ma il suo comportamento peggiorò in maniera incredibile.
Allora stava con un ragazzetto, un brutto coso che non sembrava neppure normale e sbandato un bel po’: fuggirono di casa insieme, dopo aver trafugato denaro e i miei pochi
ori..
Me la riportò la polizia ferroviaria che l’aveva trovata su di un treno che portava in Olanda, dopo tre giorni di angoscia che io non so narrarvi.
In quel momento io mi trovavo in ospedale, ed ero appena stata operata di colecistectomia, affrontando anche qualche pericolo di vita per complicazioni improvvise.
Me la ritrovai lì, sul letto d’ospedale, il trucco punk dark sciolto e colato sul suo visetto di bimba arrabbiata, gli occhi azzurri arrossati dalla stanchezza, dal pianto e da chissà quale
sostanza assunta: sporca, lacera, disperata, e… incinta.
Aveva quindici anni.
Io l’abbracciai forte e piansi. Le chiesi di cercare di capire che la vita spesso ci pone di fronte a situazioni che non dipendono da noi, le dissi che le volevo bene, che era mia figlia,
che se avesse voluto tenere il bimbo io le avrei dato tutto il mio appoggio: ma che era suo figlio quello che sarebbe nato, non il mio e che la decisione spettava a lei e solo a lei.
L’accompagnai da una psicologa, che mi ricoprì di improperi e mi diede la colpa di tutti i problemi di mia figlia, gettandomi nel più nero sconforto.
Alla fine questo bimbo non è mai nato.
Non ho visto mia figlia piangere per questa perdita, ma sono sicura che dentro di lei questo dolore è ancora vivo e acutissimo.
Io ho pianto per lui, che ho sempre chiamato il mio piccolo Angelo, dato che gli angeli non hanno sesso e corpo, ma sono presenze poetiche e dolcissime. Ho pianto per molti
anni…
Da allora ne sono passati quasi venti. Ora sarebbe adulto.
Il fiume in piena della mia vita mi aveva sottratto questo ricordo: stamattina è riemerso.
23 giugno, mattina.
Qui non è facile vivere: in questi giorni ho lavorato molto alla mia arte, ho preparato la cornice al quadro La danza dell’albero e ho dipinto un nuovo quadro che ho chiamato
Germogli.
In effetti il germoglio lo sento, ma è ancora così piccolo che a volte mi sembra si sia già seccato.
Oggi è una giornata opaca, come questo cielo bollente e caliginoso che vedo dallo spicchio della finestra. Nel cantiere sottostante fanno un rumore infernale, che la musica non riesce a
cancellare e io oggi non so neppure che musica ascoltare: ho già cambiato non so più quanti CD, mentre di solito ascolto il medesimo anche per giorni interi, ma nessuna musica è sintonizzata con
il mio cuore, oggi…
Le ore sono lente, mi sento stanca. Forse ho lavorato troppo.
Sono convalescente e la mia iperattività, pur aiutandomi a non sprofondare, alla lunga mi fa male.
Inoltre non riesco più a mangiare: da giorni ormai il cibo è ridotto al minimo.
Mi fa bene per la linea, sicuramente, infatti sono dimagrita abbastanza, anche se non mi peso, ma lo vedo dai vestiti: mi dico che se sto cercando di suicidarmi per fame, ho scelto
un’agonia prolungata…
Vorrei essere una rondine e volare su quel tetto arroventato, sentire solo il vento e il pigolio del mio piccolo che mi chiama a becco spalancato. E sentire solo l’acre sapore caldo
dell’insetto che depongo nella sua tenera gola, e sentire solo fremere le mie penne, vivere la vita senza chiedermi il perché.
23 giugno, ore 19.30.
Questa mattina mi sentivo forte… mentre volavo con le rondini e giocavo al tennis per single, pensavo al mio gruppo di recitazione Buddhista, nella mia casa, in quella dove lei ha
continuato a dirmi per mesi: questa è casa tua, l’hai costruita tu.
Prima era un magazzino abbandonato, come il tuo cuore, pensavo io.
E allora ho preso la decisione di tornare: questa sera ci sarebbe stato il consueto appuntamento per la preghiera del lunedì e io ho pensato che il mio posto era là, sarebbe dovuto essere
là.
Così ho deciso: vado. Ma durante tutto il giorno l’ansia mi tormentava e mille domande silenziose sfuggivano al baluardo armato che avevo eretto nella mia mente.
L’ultima
volta che ero stata in quella casa, in occasione della visita dallo psichiatra, avevo vissuto un’esperienza particolarmente dolorosa. Tracce della sua donna ovunque e alcune mie cose
buttate a terra, in dispregio, e tutta la casa che desolata mi si stringeva intorno chiedendomi dove fossi stata per così tanto tempo. Le pareti che avevo dipinto e le finestre allegre tono su
tono, alla stregua di un arredatore… dei poveri…
I gerani nel terrazzo quasi secchi e il povero basilico, un tempo verde e rigoglioso, mi salutava mestamente, chino e scheletrito. I
l letto sfatto dove avevo dormito e vegliato, pianto, riso e fatto l’amore e abbracciato lei e sentito che c’era
un posto al mondo anche per me, nonostante la passione per Dana mi divorasse, nonostante le mie folli incongruenze, nonostante la mia incapacità di amare veramente…
Nonostante tutto questo, avevo trovato una donna e una casa che mi amavano lo stesso, così come ero.
All’ora pattuita Monica è venuta a prendermi: io non sono riuscita neppure a guardarla in faccia, contratta com’ero sulla difensiva, nel desiderio di lasciarla libera di essere felice anche
senza di me. I gerani assetati mi hanno chiamato dal balcone. Le altre compagne di fede non erano ancora arrivate e mentre Monica parlava al telefono, io ho cominciato a dissetare le mie amiche
verdi, ormai sfiorite e sfinite come me, così sono entrata in camera da letto, per accedere al terrazzo. Un foglio protocollo attaccato a uno dei chiodini nel muro sopra il comodino dove io avevo
appeso alcune foto a me care, dei figli, di amici, un foglio protocollo e una scritta con la biro blu:
8 maggio 2008. L’ho baciata.
So che non posso recriminare nulla, o forse sì, ma non lo voglio fare. Le auguro di essere felice.
Sono uscita così, da quella porta, immediatamente e ho camminato piangendo fino a qui, in questa stanza
che ora è tutto quello che sono io, un centro di accoglienza per disperate. Una lunga camminata con quella scritta a prendere fuoco nella mia mente, nel mio cuore, nei miei sensi, nel mio
futuro, nel mio passato, nei miei sogni, nelle mie aspirazioni, nel mio tentativo accanito di cambiare la mia vita zoppa, stravolta, doppia, schizofrenica.
E così oggi le mie due parti, queste due donne-uomo, queste due bestie strane, queste due aliene, queste due sconosciute che abitano lo stesso corpo, oggi entrambe non hanno più nulla su
cui appoggiarsi.
Ogni volta che il mio cuore ha dovuto separarsi da qualcuno dei miei amori, io avevo sempre l’appoggio dell’altro amore che mi viveva dentro, perché ho sempre amato due persone alla volta,
una con la vita e l’altra con i miei sogni e le mie illusioni, con le mie farneticazioni, con la mia poesia, con la mia follia.
Oggi le mie due me sono sole.
Dana… non ti amo più.
Monica… non ti amo più.
Vivete la vostra vita con le vostre donne, che hanno pure lo stesso nome e siate felici: donne delle mie donne, non temete, io non esisto più, io le ho perdute, io non le voglio più. Lascio
che siano felici con voi: non sono riuscita a farlo io, fatelo voi.
A me qualcuno penserà, prima o poi…
24 giugno, ora imprecisata.
Fatima è una piccola donna araba. Non so ancora di preciso da quale paese venga. Occhi scurissimi e lucidi, come fossero sempre bagnati di pianto, ma brillanti e profondi come un lago di
montagna. Occhi che sanno di rassegnazione attiva e presente, di duro lavoro, di amore per quello che fa.
Porta un foulard rosa intrecciato sul capo, ma ha i capelli di un nero corvino, appena ritorti, lucenti, sempre pulitissimi. Snella e raccolta, ha rotondità contenute, ma accoglienti nelle
braccia e nei fianchi, in contrasto con la magrezza del viso e delle piccole mani: brune e curate, dalle unghie corte e discrete, pulite come tutto di lei.
Sorride con i denti appena in evidenza: piccole perle brillanti racchiuse in un guscio di labbra morbide e ben disegnate, leggermente sporgenti.
Parla un italiano rappezzato, ma il calore della sua voce e il suo accostarsi con rispetto mentre ti si rivolge, trasformano i suoi discorsi in una morbida cantilena che sa di deserti
lontani, di tende nella notte brillante di miriadi di stelle, di colline punteggiate di bianche case basse sul mare azzurrissimo.
Fatima vive qui, grazie a questa nostra accoglienza per lei preziosa, insostituibile.
Mi hanno raccontato che al momento dell’approdo sulle coste italiane erano in fin di vita, lei e i suoi due piccoli.
Asir ha cinque anni ed è un bel moretto schivo e timido, ma vivace e sveglio, che ti cerca e fugge, che vorrebbe entrare in contatto con te ma se ne pente subito. L
a madre gli parla a voce bassa e lo chiama sovente, come se il suo nome fosse una cosa davvero importante: è un bimbo ubbidiente, per nulla capriccioso e nei suoi occhi arde uno spirito
selvaggio ma domato, una fierezza mesta e contenuta, come in quelli di sua madre.
Fedua ha due anni: è cerebrolesa. Non vede, non parlerà mai, non camminerà mai, forse da un orecchio sente qualche lontano fruscio, ma la sua pelle è viva, la sua pelle
sente.
Pesa undici chili e se ne sta ancora troppo poco eretta per tenere su la testa da sola, così che le viene una tosse terribile che rischia spesso di soffocarla: da quando è nata, sua madre
quasi non dorme, attenta a ogni suo respiro.
Ha dei lineamenti marcati che la renderebbero assai carina se l’assenza di espressione e l’impossibilità di dominare i muscoli della bocca e del collo non ne distorcessero irrimediabilmente
la fisionomia.
La piccola testa è di una squisita rotondità e i suoi capelli assai crespi e folti, tagliati molto corti e regolari, formano un’aureola morbida e profumata di balsami.
Fedua vive costretta in un passeggino speciale, che la sorregge e la sostiene da tutte le parti, con uno speciale cuscino sotto i piedi che le impedisce di scivolare giù. Ma in questi
giorni fa molto caldo e Fatima la prende spesso in braccio, per darle sollievo, tenendo il suo piccolo corpo semi rigido e abbandonato più discosto possibile da sé, per non scaldarla
ulteriormente: il peso inerte della piccola è notevole per questa piccola donna coraggiosa.
Ieri Fedua era sul passeggino nel corridoio, dove l’aria è più fresca e le ragazze si avvicendavano indaffarate nei preparativi del pranzo. Io mi sono avvicinata alla piccola, che si
lamentava con voce cantilenante.
Fatima era in cucina a preparare il pane fragrante che impasta ogni giorno con le sue mani.
Ho appoggiato la mia mano sinistra su quella guancia vellutata e stanca, che vibrava di parole mai conosciute e mai esprimibili e subito la sua gota di raso caramellato si è affidata al
palmo della mia mano, si è appoggiata, smettendo di lamentarsi.
Gli occhi chiusi, che non si apriranno mai, hanno smesso di tremare e le labbra sempre dischiuse si sono accostate un poco, si sono ammorbidite. Le piccole braccia paffute che tendeva
spasmodicamente verso il nulla, si sono abbandonate e la mano grassoccia, che la madre ha ornato con un diadema colorato di azzurro con perline intrecciato tra le dita come io non ho mai visto
fare, si è appoggiata tranquilla.
La mia mano le sosteneva il viso e il mio pensiero andava ai miei bambini, ai loro giochi infantili, alle loro risa argentine, ai loro capricci.
Non si rendono conto di essere sani e fortunati, in grado di vedere, camminare, udire, parlare, e vogliono solo
quello che non hanno.
Fedua si è addormentata così, adagiata su una mano estranea, affidandosi a chi vorrebbe infonderle un po’ della sua vita, che sente troppo pesante e difficile, ma non può
farlo.
Oggi ho parlato a Fatima e le ho detto che le terrò molto volentieri la bambina quando si sentirà stanca e avrà bisogno di riposare, o quando sarà troppo indaffarata. Lei mi ha sorriso e
non sembrava stupita, ma grata della mia offerta: mi ha detto che io sono una persona molto gentile e io ho replicato che lei è una gran donna, una piccola madre coraggio.
— So che soffri, ma non lo fai vedere —, le ho detto.
E lei mi ha risposto:
— Io chiedo a Dio di essere così.
Stasera a cena mi ha portato un pezzetto del suo pane squisito, orgogliosa e felice di poter fare qualcosa per me, che non vado mai in cucina, dato che raramente esco dalla mia
camera.
Chissà quali mari hanno attraversato quei gesti con i quali lei ha impastato il pane che mi ha donato, chissà quali tempeste ha affrontato quella piccola nave…
Stasera, nella preghiera Buddhista che ho recitato, la mia litania un po’ stentata vibrava di una
emozione inenarrabile, di tempi lontani, di vite che si riallacciano, di fiaccole che si accendono nella notte fonda.
Ora so perché sono venuta qui.
Oggi, 26 giugno 2008, alle ore 9.40, io, Ari Inusuale, sono qui.
Alcune cose le ho, altre non le ho, ma posso fare in modo di averle, e lo farò.
Altre non le posso avere e le lascerò andare.
Oggi è una buona giornata.
La rondine ferita è tornata al suo cielo.
Ancora il volo è lento e incerto.
Ancora la piccola ala nera le duole e si piega un poco.
Ancora il suo cuore batte affannoso per lo sforzo ma batte e combatte.
Ha ritrovato le sue mille, duemila, centomila compagne.
Ha ritrovato il nido del suo cuore, quello al quale la riportano i suoi sogni e garrisce felice, un poco mesta, un poco spaventata, ma con tutta la forza che ha.
Non sa quando morirà.
Sa che morirà e poi tornerà a volare.
Perché una rondine è nata per volare e vola.

ecco il capitolo conclusivo del mio libro..questo capitolo nella prima edizione cartacea non c'è, dato che l'ho scritto oggi e narra della mia vita dalla fine del racconto pubblicato ad
oggi....
CAPITOLO
TRENTASEIESIMO
Ancora sangue, la
Sardegna fino ad
oggi, 6 aprile
2012.
5 aprile 2012
Il libro termina così.
Volutamente l'editore ha voluto fermarlo su una nota di speranza e di coraggio che quel giorno era nato dentro di me.
Ma quel germoglio durò assai poco.
La vita nel pio istituto era assai difficile per me che sono diventata una solitaria e non amo affatto la promiscuità. Inoltre stavo malissimo.
Cercai ancora aiuto economico dai miei, dato che con i 250 euro di pensione e spendendone 220 per la stanza, davvero non mi rimaneva neppure di che mangiare: trovai solo male parole e
litigi.
Dana, con la quale avevo continuato a sentirmi, mi aiutò in qualche modo, ma di certo non poteva fare molto e neppure io lo volevo.
Venne a trovarmi, mi portò tele e colori. Uscimmo per un breve giro in macchina. La passione tra noi non si era sopita, ma come gestirla?
Credetti che se avessi recuperato una parvenza di vita forse avremmo ritrovato il nostro rapporto. Tornai alla carica presso i miei per un aiuto economico e quella volta mia madre e il mio
ex marito si misero una mano sulla coscienza e mi concessero un mensile. Non era tantissimo, ma sempre meglio di nulla. Allora mi misi a cercare un piccolo appartamento sul litorale. Desideravo
tornare al mare. Trovai qualcosa, ma non me lo concessero: le garanzie che potevo dare erano insufficienti. Mi rivolsi ad un altro paio di amiche per cercare aiuto, ma non trovai
nulla.
Dana di nuovo mi tagliò fuori e per me fu troppo.
A fine agosto, non ricordo al data esatta, ma verso il 20, una notte a mezzanotte, quando tutte dormivano e non vi era più nessuno in giro, mi recai in bagno e sul lavandino mi recisi le
vene del solito polso sinistro con il cutter, aiutandomi con l'acqua calda. Resistetti fino a che mi fu possibile. Quando stavo per svenire, con le ultime forze tornai in camera con il polso
avvolto in una asciugamano e persi i sensi.
Mi trovò la mattina dopo la direttrice, forzando al porta. Erano oltre le nove. Ero in coma ed il letto era completamente intriso di sangue.
Ma mi svegliai anche quella volta.
Ho pochissimi ricordi, solo il volto rigato dalle lacrime della bella councelor quando mi svegliai e una caduta tremenda quando dopo alcuni gironi mi alzai dal letto, svenendo. Battei la
testa procurandomi una larga ferita e mi diedero diversi punti.
Poi mi dimisero. Al centro di accoglienza mi dissero che me ne sarei dovuta andare da lì, perché era inammissibile per la loro mentalità ' cristiana ' quello che io avevo fatto e mi
concessero tre giorni.
Non sapevo cosa fare e dove andare, non volevo tornare a casa dai ragazzi, erano troppo arrabbiati con me perché avevo tentato di nuovo il suicidio.
Accettai allora l'aiuto di Ale.
Ale è una mia ex compagna con la quale avevo avuto una convivenza qualche anno prima, ma della quale non ero mai stata innamorata. Ma un grande affetto ci legava ancora. Lei è sarda ma
venne in Emilia assai giovane per lavoro con il marito e i due figli. Poi si separò e più tardi conobbe me. L'estate precedente era ritornata a vivere in Sardegna, nella casa dell'ex marito in un
paesino di collina vicino a Sassari.
Da allora mi diceva: vieni da me, riproviamoci.
Così accettai.
Il primo settembre sbarcò con la sua Micra attraversò l'Italia e mi raggiunse. Io avevo racimolato un po' di denaro vendendo qualche quadro a compagne di fede. Con quello avevo comprato i
biglietti per il viaggio, Ale versava in condizioni economiche peggiori delle mie, anche se sembrerebbe impossibile. Caricammo all'inverosimile la piccola auto, con tutti i miei pochi averi, ma i
quadri tenevano molto posto: legammo anche il tavolo bianco di plastica della chiocciolina sul tetto.
Alle 22 ci incontrammo con Dana e Sara, una mia nuova amica del forum, che erano venute per salutarci.
Io fingevo una folle allegria, ma dentro di me gridavo disperatamente: non mandarmi via, Dana, non lo fare, non lo permettere. La guardavo come avessi voluto mangiarla con gli occhi. Non
l'avrei rivista forse più.
Ma Dana non mi fermò.
Prima di salire sull'auto ci abbracciammo e lei mi baciò.
Cosa mise in quel bacio? Tutto quello che non avevamo avuto e che non avremmo avuto. Mi entrò se possibile ancora più dentro.
Poi si staccò da me e si allontanò.
Salii in macchina, viaggiammo tutta la notte, guidai con il sonno, poi le ore di attesa infinite al porto di Civitavecchia dove arrivammo alle 5 del mattino. La partenza alle 13, la
traversata infinita. Ale si addormentò e dormì, io non avevo pace.
Arrivammo come Dio volle: la terra di Sardegna, che io avevo visitato in vacanza con Ale qualche anno prima, ci accolse: io presi foto, feci in modo che la sua bellezza naturale mi
avvolgesse, ma sentii feroci dita che artigliavano il mio cuore: quello non era il posto mio, non mi ero trovata bene neppure in vacanza, una mentalità troppo lontana dalla mia, il randagismo, la
sporcizia per le strade e nei luoghi naturali, la lingua incomprensibile, la chiusura dei abitanti di quella parte dell'isola. Non erano condizioni adatte a me, ma di necessità,
virtù.
Iniziò così il mio esilio volontario.
La casa nella quale viveva Ale era piccola e malsana, tutta macchiata di nero alle pareti e non vi era l'ordine e la pulizia che io desideravo. Mi misi come una forsennata a recuperare una
parvenza accettabile, appesi i miei quadri, lustrai, misi in ordine, ma il risultato fu assai scarso.
Cercai rifugio tra le braccia affettuose ed ancora innamorate di Ale, ma il mio cuore grondava dell'ultimo bacio di Dana.
Mi sentivo al telefono con Sara, che cercava di starmi vicina, a volte anche con Dana.
Nella polverosa dissestata e disordinata soffitta era stata ricavata una stanzina davvero piccola, senza finestre. Portai il mio tavolo, la mia piccola scaffalatura, i miei libri il
cavalletto i colori e mi rifugiavo lassù a dipingere e a piangere.
Ai primi di ottobre Dana mi telefonò e mi raccontò che lei e Sara si erano incontrate. Era nata una passione che fu consumata e lei me ne descrisse i particolari. Io avevo detto più volte a
Sara di non farsi scrupolo e di accettare la corte che molto evidentemente Dana le stava facendo. Credevo che non mi avrebbe fatto male il saperle insieme. Ma così non fu.
Mi fece così male che non capii più nulla.
La notte presi una bottiglia di vino, feci razzia di tutti gli psicofarmaci che trovai, i miei quelli di Ale e quelli di sua figlia che, affette entrambe di epilessia, assumevano medicinali
molto pesanti: ne trovai una quantità ingentissima.
Quando Ale si addormentò, salii sopra e piangendo le ingurgitai tutte, scolando la bottiglia, adagiata nella poltrona. Poi chiusi gli occhi, sentendo il torpore salire e sorridendo andai
incontro alla fine della mia vita disperata.
Ma all'improvviso qualcosa mi scosse: sentii una crisi convulsiva assalirmi, come quella che avevo avuto la volta del precedente tentativo di suicidio con i farmaci.
Da quel momento non ricordo altro che in qualche modo raggiunsi la camera da letto e svegliai Ale. Non so davvero come feci.
Lei si allarmò moltissimo e chiamò il 118. Pensarono avessi una crisi della mia malattia, la Sindrome delle gambe senza Riposo. Mi agitavo convulsamente. Mi imbottirono di Valium e mi
ricoverarono in psichiatria, all'ospedale civile di Sassari pensando io fossi isterica. Mi legarono al letto di contenzione e giù altri psicofarmaci. Non mi fecero esami tossicologici. Rimasi
legata a quel letto 12 ore, riportando ferite ai polsi ed alle caviglie che guarirono solo molto dopo. Poi caddi in coma. Ad Ale, che era venuta a vedere come stavo, dissero che dormivo e di non
disturbarmi. Lei allora tornò a casa. Cercò il mio cellulare per telefonare a qualcuno di cui non aveva il numero, ma non lo trovò di sotto. Era rimasto sulla poltrona, dato che, mentre mandavo
giù le ultime pillole avevo scritto un messaggio d'amore a Dana, senza però dichiararle le mie intenzioni suicide. Così Ale salì su, vincendo al sua paura per i topi e trovò, oltre al mio
cellulare, le scatole vuote: capì. Mise tutti gli involucri in una busta e corse più velocemente che poté in ospedale, mostrando il suo ritrovamento. Io ero in coma profondo. Mi portarono in
rianimazione, mi fecero una lavanda gastrica, del tutto inutile perché il mio stomaco era totalmente vuoto. L'elettroencefalogramma era quasi piatto, i medici dissero che non vi erano speranze.
Dana allertò il forum nel quale io scrivevo chiedendo alle amiche preghiere per me, anche se, scrisse, sapeva che io non sarei stata contenta del loro tentativo di tenermi qui.
Il coma durò sei giorni. Io sorridevo. Ero finalmente nel luogo immacolato e dolcissimo dove avevo voluto così fortemente andare. Cori di angeli mi cullavano, tutto era perfetto e luminoso
e puro.
Mi sveglia sorridendo. Vidi i volti raggianti di Ale e di Maietta che mi guardavano increduli: erano state chiamate per essermi accanto al mio miracoloso ed inatteso risveglio.
Sorrisi loro impulsivamente di rimando, poi mi resi conto che ero di nuovo viva, sulla terra.
Mi infuriai disperatamente.
Pur con tubi flebo e senza poter parlare piansi gridai senza voce, mi disperai. Non poteva essere vero, non poteva essere vero.
Ma era vero.
Mi tennero a lungo in psichiatria: feci fatica a riprendere a mangiare, avevo la gola devastata dall'intubazione selvaggia che mi era stata praticata, ero sconvolta distrutta furente
furiosa.
Una psichiatra si impietosì di me e mi propose di aiutarmi. Mi disse che aveva bisogno di quadri per arredare il suo studio e mi commissionò alcune opere in cambio di sedute
psicoanalitiche.
Ero viva, distrutta ma viva. Qualcosa dovevo fare.
Tornai a casa di Ale, ma davvero non potevo vivere tra quelle mura derelitte. Cercai un'altra casa e la trovai. Mia madre mi aveva aumentato il mensile, potevo pagare un affitto, entrammo
nella nuova casa il 23 dicembre.
Inoltre la casa aveva bisogno di lavori agli infissi che versavano in pessime condizioni e la padrona di casa mi commissionò l'opera su mia proposta, offrendomi 600 euro, che accettai con
grande gioia: era una casa assai grande su due piani più abbaino e cantina.
Lavorai disperatamente arrampicata sulla scala ad oltre 5 metri di altezza, dati i soffitti vertiginosi. Mi gettai in quella casa, fu un'ancora di salvezza. Dopo quattro mesi di lavoro era
diventata bellissima. Avevo reso tutto perfetto, come mio solito, avevo riempito il balcone le stanze e l'abbaino di piante e fiori, facendone un piccolo giardino tra i tetti.
Lavoravo tutto il giorno, pulendo, cucinando per la famiglia, dipingendo.
Parlavo al telefono con Sara e un poco anche con Dana che mi convinse di pubblicare il mio diario.
Sapevo che sarei andata incontro a problemi con la mia famiglia, anche uscendo con uno pseudonimo, ma a qualche cosa mi dovevo aggrappare. Così trovai un editore che accettò la mia opera,
ponendomi però la condizione di mettere in prosa le parti in poesia e di trasformare il tutto in un romanzo e così mi misi all'opera.
I mesi passavano. Ale era dovuta ritornare in continente ed andammo insieme, così salutai i miei figli e presi con me il mio amato cane, il mio caro Jerome, che, rivedendomi, impazzì di
gioia per poi tenermi il broncio per diversi giorni.
La psicoterapia proseguiva, mentre io scavavo dentro di me e tiravo fuori tutto.
Il dolore era immenso, immenso immenso immenso............
Passeggiavo a lungo con Jerome, ogni sera, l'inverno passò. Facevo il fuoco nel camino che aveva anche un ampio forno per il pane dove cuocevo verdure e frutta. A primavera accolsi un
povero cucciolone, che battezzai Spago per il suo essere sinuoso e filiforme. Avevo già da qualche tempo stretto amicizia con lui, aveva 6 o 7 mesi, gli davo del cibo, ma era randagio per il
paese. Una notte lo massacrarono di botte per nessuna ragione al mondo oltre la cattiveria. Io lo sentii abbaiare e piangere disperatamente, era poco lontano dalla mia abitazione che dava sul
corso del paesino, uscii di casa gridando e mettendo il fuga il vigliacco aggressore che, per sua fortuna, io non vidi e non scoprii mai. Cercai la povera bestiola, sapevo dove si sarebbe
rifugiato perché lui stesso qualche sera prima mi aveva portato al suo ' nido ' ed infatti lì lo trovai, terrorizzato e dolorante, ferito, ammaccato ma vivo. Riuscii a convincerlo a venire con me
e da allora è mio ospite, anche se per sua incapacità di adattarsi alla vita casalinga, ora vive nel giardino della vecchia casa dell'ex marito di Ale con altri due profughi salvati anch'essi da
morte, ed io mi prendo cura di lui economicamente, mentre Ale fattivamente.
I giorni passavano, io piangevo, dipingevo, pregavo, parlavo con la psicologa una volta alla settimana, al telefono con Sara, ogni tanto con Dana.
L'amavo ancora disperatamente. Sentivo che lei stava soffrendo, la sognavo e nel sogno la baciavo l'abbracciavo, l'amavo. Il desiderio e la mancanza di lei mi esasperavano e
dilaniavano.
Il rapporto con Ale stava entrando in crisi: ci avevo riprovato, ma non funzionava, per me: lei mi amava ed io mi sentivo in colpa nei suoi confronti, percepivo le sue aspettative che non
potevo reggere. La vita quotidiana con i suoi figli era sempre più difficile, io troppo pignola, loro troppo trasandati. Spesso la rabbia esplodeva in litigi. A giugno Ale si fece una
indigestione di pillole. Disse che fu un errore, ma io entrai in crisi ancora di più. L'avevo trovata esanime, la corsa in ospedale, la paura. Poi sensi di colpa su sensi di
colpa.
Avevo allestito una galleria in casa, nell'entrata che era grandissima e tenevo aperto ma non veniva mai nessuno: dopo i primi giorni di curiosità nei quali avevo ricevuto visite
imbarazzate di una decina di persone che esse stesse si dilettavano nella pittura, non venne più nessuno. Regalai anche un mio dipinto al sindaco, che non mi ringraziò neppure e che regalò a sua
volta la mia opera, che evidentemente non era piaciuta, ad una delle assistenti sociali. Cominciai a ricevere dispetti: piante rotte o divelte, fiori distrutti, colpi contro la porta, una
zanzariera strappata, furto di decorazioni natalizie, urina contro il portone d'ingresso, - ed era urina di uomo - feci in un sacchetto davanti al medesimo uscio - ed erano feci di uomo, o almeno
di bestia umana - . Il mio rapporto con il popolo sardo davvero non era dei migliori. Avevo invitato il vicinato a visitare la mia piccola galleria, ma solo la vecchietta di fronte venne e fu
l'unica a legare con me. Era una donna deliziosa e gentile, ma morì all'improvviso pochi mesi dopo. Io mi recai a salutarla nella sua camera dove era stata composta, ma di certo non feci quello
che era nelle usanze, che non conoscevo. Seppi poi che fui criticata aspramente perché non ero andata in chiesa, al funerale ecc. ecc. e questo contribuì ad isolarmi ancor di più...
L'estate fu caldissima.
Io dormivo ogni notte sulla mia amaca , sistemata nell'abbaino pieno di fiori. Guardavo le stelle, le lune, i venti, le rondini al tramonto e all'alba, che correvano in circolo nella loro
gazzarra aerea come alla casa di accoglienza. Piangevo, continuavo a piangere Dana. Il suo ultimo bacio mi rovistava dentro, mi accendeva, mi prosciugava.
Era un'arsura di lei.
Continuavo a fare migliorie alla casa, chiusi la tromba delle scale con un tramezzo di cartongesso che affrescai con colori acrilici, dipingendo una cascata tra il verde e i
fiori.
Lavoravo al mio libro, dipingevo e parlavo al telefono con Sara: era l'unica accanto a me eccetto naturalmente Ale e Maietta, che ogni tanto mi veniva a prendere per portarmi a fare un giro
in macchina o a casa sua.
In casa i litigi erano sempre più fitti, i problemi economici di Ale erano pressanti, il figlio ribelle e in aperto contrasto con me. Non ce la feci più e dissi ad Ale che dovevano
andarsene, che volevo stare sola ed in pace, che quella era casa mia, che l'avevo messa a posto io, era il mio rifugio, che facessero quello che volevano, tornassero nella casa dell'ex marito, ma
che mi rendessero la mia libertà.
Ero impazzita di rabbia, di disperazione, avevo bisogno di stare sola.
La povera Ale trovò aiuto dagli assistenti sociali che le trovarono casa e tutto il resto. Capì il mio stato, lo vedeva ogni momento, lo viveva, non si arrabbiò con me, non litigammo io e
lei, non interrompemmo i rapporti. L'avevo aiutata tanto, anche economicamente, negli anni precedenti, quando la disgrazia non aveva ancora bussato drasticamente alla mia porta, ed anche nei mesi
appena trascorsi, dato che molte delle spese comuni erano state sostenute da me con l'aiuto di mia madre e i proventi della cessione di qualche quadro sul forum, per questo si sentiva in debito
nei miei confronti. Ma anche sapeva e vedeva quanto soffrissi..
Venne così dicembre ed ella fece trasloco nella nuova casa. Io avevo acquistato una cucina di seconda mano, vendendo qualche altro quadro, avevo prenotato un volo per passare il Natale con
i miei figli e stavo preparando la casa ad accogliere Sara che sarebbe tornata insieme a me il 28 dicembre e si sarebbe trattenuta qualche giorno. Quello che provavo per lei era un amore quieto e
dolce che mi aveva aiutato molto dal giorno del nostro incontro sul web, a maggio 2008, un amore che purtroppo lei non riusciva a ricambiare, ma che però mi ripagava con un affetto grande e una
presenza costante, soprattutto la notte quando, libera dagli impegni di lavoro e di famiglia, stavamo lunghe ore a raccontarci i nostri rispettivi dolori e cammini spirituali.
Era il 23 dicembre, appena passata la mezzanotte. Lavoravo dalla mattina prestissimo e volevo che fosse tutto perfetto per accoglierla.
Avevo quasi finito, ma c'era quel gancio attaccato al soffitto che rovinava la mia opera pittorica murale sopra ed attorno al camino. Pensai allora di attaccarvi una grossa palla di panno
che avevo comprato dai cinesi per pochi spiccioli e che era tutta colorata. Salii sulla scala, ero stanca ma talmente abituata a quell'attrezzo dato che vi avevo passato centinaia di ore nei mesi
scorsi per accomodare finestre porte muri, e fu quella mancanza di paura che mi tradì: calcolai male la distanza, mi sporsi troppo e, dato che avevo posto una gamba di qua ed una di là ed ero in
cima senza più alcun appoggio, precipitai giù.
Il colpo fu tremendo, il rumore del mio corpo che si schiantava rimbombò in tutta la casa e nel mio cervello.
Ma c'era un divanetto accanto al camino e caddi con la parte superiore del tronco su di esso, salvando così la testa. Sbattei invece fortemente le gambe per terra.
Rimasi ferma e pensai: questa volta l'ho fatta grossa.
Ascoltai il mio corpo, ma non sentii nessun dolore. Rimasi immobile ancora per un poco, poi cominciai a muovere lentamente prima le mani, poi i piedi poi le bracia le gambe la testa: tutto
funzionava, non mi ero fatta nulla. Mi misi allora a sedere sul divano. Vidi una grossa ecchimosi sulla gamba destra che si stava inscurendo, ma altro non vidi ne sentii. Sorrisi tra me e me con
sollievo e, ringraziando la mia ottima stella, risalii sulla scala per attaccare la famosa palla. Poi discesi, misi via quello che ancora era in mezzo e andai a dormire qualche ora prima della
partenza: avevo il volo alle 6 circa.
Il viaggio fu un incubo: nevicò improvvisamente e l'aeroporto di Bologna dove dovevo atterrare fu chiuso. Mi dirottarono così su Siena, trattenendomi fino al giorno dopo, quando mi
portarono a destinazione con un pullman. Nel frattempo, a botta fredda, il dolore del fortissimo colpo subito era venuto tutto fuori. E stavo malissimo
In evidente stato confusionale, non ricordo molto di quel viaggio, solo i soliti problemi con Betta per il mio stare al telefono e le mie recriminazioni nel constatare che loro non si erano
curati affatto di stare con me neppure quei pochissimi giorni, dato che ci vedemmo solo qualche ora di sera. Ricordo un po' la traversata notturna sulle poltrone con Sara e la mia gamba che era
gonfia e rossa violacea e mi faceva un male terribile, null'altro.
Quando lei ripartì io mi recai al pronto soccorso, ma mi rimandarono a casa con una cura antidolorifica, diagnosticandomi una lombosciatalgia: nella lastra non vi era nulla di rotto ed io
mantenevo i riflessi ad entrambi gli arti.
Furono tre mesi terribili. Il dolore aumentava solo, le cure non sortivano nessun effetto. Tornai altre tre volte in ospedale, rimandata a casa ogni volta con cure più forti e la
raccomandazione di continuare a muovermi. Io, testarda e cocciuta, facevo tutti i lavori, portavo a spasso i cani, ma ogni ora che passava era sempre più difficile, ormai mi strascinavo tra
dolori lancinanti. Tornai in ospedale e l'ennesimo ortopedico che mi visitò, mi prescrisse una forte cura di cortisone e 15 di assoluta immobilità. Fra 15 giorni sarà come nuova, mi disse,
dimettendomi.
Io tornai a casa e mi misi a letto, ma sapevo che da quel letto non mi sarei più alzata come prima.
Nel frattempo il mio libro, questo romanzo – diario IO NON SONO DI QUI, aveva visto le stampe ed il mio editore, divenuto mio amico, mi spingeva da diverse settimane a creare un account su
FB, dicendo che era un luogo necessario per farmi conoscere e che il forum era un'area troppo ristretta.
Così quel giorno, dato che avevo di fronte a me 15 giorni di assoluta immobilità e qualcosa avrei dovuto fare per non impazzire, gli diedi retta e così nacque Arianna Amaducci su
FB.
I 15 giorni passarono, ma non il dolore. Mi procurai una sedia a rotelle e scrissi su FB:
2 aprile 2010
La sedia a rotelle
Mi ci sono seduta.
Era tardi ormai, anche l’ultimo acquirente se ne era andato, portando con se un arto inferiore snodabile per sostituire il suo originale che era andato evidentemente perduto.
Il negozio di ortopedia era assorto nel silenzio dei suoi pallidi manichini indossanti cavigliere, ginocchiere, busti e scarpe speciali.. Bastoni, grucce, carrellini d’appoggio,
deambulatori dichiaravano implicitamente la loro comprensione, il loro sostegno.
E lui, il proprietario di quel luogo di dolore e miracoli, pallido come i suoi manichini, alto, col viso magro e appuntito dal
naso fine rivolto verso il basso lungo il quale scivolavano lentamente un paio di occhiali lustri e indefinibili, per venir
poi riportati al loro posto con un gesto meccanico ma accorato, mi stava accanto, lievemente ricurvo su di me,
con una attenzione lieve ma presente, cogliendo in pieno il mio sgomento e il mio dolore, filtrandolo attraverso lo staio del suo sorriso mesto.
La sedia mi ha accolto con un gemito – o era un gemito del mio cuore sanguinante, quello che ho sentito?- e le sue braccia d’acciaio hanno sancito un matrimonio definitivo, forse,
inappellabile, forse, ma sicuramente presente ora.
Ora essa giace nel piccolo ingresso posteriore della mia casa, quello che dà sui vicoli, dove non ci sono scalini, ed attende..
Attende che io decida e accetti di essere diventata un tir, un semi-articolato, una donna su ruote..
Aspetta che io trovi il coraggio di prenderla per le sue corna cromate e la vinca, girandole a terra il suo collo di leone poderoso perché si trasformi in mia amica, in mia preziosa
collaboratrice e non in una condanna.
“Io mi dichiaro innocente, vostro onore! “
Ma se questa gabbia di tela sarà da ora la mia libertà, sia la benvenuta, la benedetta.
Ma non riuscii a spingerla mai, quella sedia a rotelle, per le stradine e stradette sgarruppate e piene di buche di quel paesino, inoltre tutto in salita e discesa, ovviamente, e dovetti
attendere il gennaio seguente per averne una elettrica che potesse ridarmi una parvenza di indipendenza.
Cercai e trovai una collaboratrice familiare che si prendesse cura delle mia necessità e per molti mesi la pagai di tasca mia, solo a settembre il comune si fece carico delle mie necessità
e mi diede gratuitamente un aiuto domestico per 6 ore settimanali.
Il dolore non passava, il cortisone gli antidolorifici, gli antiinfiammatori: acqua fresca.
Intanto il numero degli amici su FB cresceva molto velocemente: in quattro pochi mesi raggiunsi il tetto massimo di 5000 contatti: passavo le ore al pc, pubblicavo il mio diario, parlavo di
me e di quello che provavo, poi i miei quadri e le mie poesie.. la presenza di quelle voci silenziose si era inserita nella mia vita ed era diventata indispensabile.
Andai a Modena a fare una prima presentazione del mio libro, ospite di amiche del forum e lì rividi Dana. Le avevo detto per telefono che l'avrei baciata davanti a tutte che le sarei
saltata addosso, che so, la volevo spaventare, che so.. io stavo così male.. stavo troppo male. Ovviamente non lo feci....
Ero terrorizzata dall'idea di restare così tutta la vita.
Il mio corpo, abituato a muoversi tantissimo, ancora assai muscoloso e forte, ruggiva per l'obbligata immobilità. Non avevo pace né di giorno né di notte. Alternavo disperazioni
profondissime e reazioni altrettanto forti, proclama di non resa. E intanto pensavo al suicidio, ancora e sempre.
Venne pasqua e Dana venne a passare qualche giorno in Sardegna, vicino a casa mia, ospite di una comune amica.
Venne a trovarmi, ma se ne stette lontana da me, guardandomi appena e stette a parlare tutto il tempo con Ale.
Mi chiesi perché fosse venuta.
Rivederla mi squarciò di nuovo.
Alla fine di aprile mi recai a fare la risonanza magnetica, ma la macchina non mi conteneva perché io ero più larga di lei. Questa cosa mi fece adirare in modo terribile: ma come,
macchinari così costosi e come era possibile che una persona di poco più di cento chili, quindi non di trecento, non vi entrasse??????
Ma nulla da fare. Mi diedero un nuovo appuntamento per ottobre all'ospedale di Sassari dove vi era una macchina più capiente.
Furente scrissi la mia rabbia su FB e Vania, un mio contatto che lavorava all'ospedale di Sassari, ebbe pena di me e si adoperò per agevolare il ricovero che da mesi mi veniva
negato.
Davvero se non si ha una conoscenza qui non si va da nessuna parte ed io conoscenze non ne avevo avute almeno fino a quel momento.
A maggio entrai in ospedale: furono dieci giorni assurdi, passati interamente sulla mia sedia a rotelle perché il letto era una fossa delle marianne e la mia povera schiena assolutamente
non lo reggeva. In una camera con povere ammalate allettate, quindi in condizioni di promiscuità assurde. Ma in qualche modo resistei fino alla risonanza ed al suo referto che non arrivava
mai.
Appena ebbi il dischetto mi dimisi, sfinita, ma in tempo per farlo vedere ai neurologi del piano superiore che mi prospettarono una triste realtà.
Le lesioni alla colonna e le ernie erano tali che io non ero operabile e non sarei mai più tornata normale. Inoltre una artrosi deformante degenerativa, scatenata anch'essa dalla caduta,
avrebbe reso il mio decorso peggiorativo, con assoluta certezza.
Quello che in cuor mio io sapevo dal giorno dopo della caduta era l'effettiva irreversibile realtà.
La disperazione mi prese.
A giugno ebbi una crisi micidiale. Resistei non so come all'alzarmi e a porre fine alla mia esistenza con il metodo infallibile che che tenevo pronto, celato nel comodino.
Decisi allora che avrei fatto qualcosa per cercare di migliorare le mie condizioni, che sarei dimagrita, che avrei smesso tutti gli psicofarmaci che stavo ancora prendendo, pur se in dosi
ridotte, che avrei recuperato una serenità, che avrei cercato una compagna. Mi diedi la scadenza di un anno: se alla fine di quel lasso di tempo la mia vita non fosse stata risolta io avrei
salutato questa valle di lacrime definitivamente e nulla e nessuno avrebbe potuto fermarmi perché avevo individuato un metodo sicuro al cento per cento, quello che che tenevo nel comodino: una
dose tripla di veleno per topi, al quale era impossibile sopravvivere dopo sei ora dalla assunzione perché il processo di disgregazione delle cellule del sangue sarebbe stato irreversibile e
quindi avrebbe resistito a qualsiasi rianimazione in extremis.
Mi misi allora a dieta e comincia la ricerca su internet della mia compagna, dato che Sara si riteneva solo una amica, ma gli incontri che feci si rivelarono tutti delle
tragicommedie.
Alla fine di maggio mi recai a Bari per una presentazione del mio libro e l'esposizione di alcuni miei dipinti, ospite di una mia amica di FB, Cris, con la quale avevo legato molto
bene.
A Bari scese per conoscermi una bellissima ed assai giovane ragazza che mi aveva conosciuto su FB, che si era invaghita di me e che io avevo battezzato Sheeva .
Passammo la notte assieme.
Non avevo più fatto l'amore se non qualche tentativo assai poco riuscito con Ale e neppure sapevo come avrebbe reagito il mio corpo così dolente.
Ma non bisogna essere dei ginnasti quando la passione accende. L'incontro con lei fu bellissimo.
Ma neppure lei risultò essere libera. Mi aveva detto che si era lasciata con la sua ultima lei da qualche mese, ma ciò non rispondeva a realtà, perché loro erano ancora in contatto e la ex
era assai agguerrita.
Io spinsi Sheeva via da me: avevo giurato a me stessa che mai più avrei avuto un rapporto con una donna non libera ed ero certa che così sarebbe stato, ma non sapevo che tiro mancino il
destino stava preparandomi e che era già in atto, seppure io lo ignorassi completamente.
Così rifiutai la bella danzatrice del ventre bionda e con due azzurri laghi al posto degli occhi che per una notte aveva riacceso la mia vita, lo feci facendomi odiare, facendo maltrattare,
facendomi tanto male, ma lo feci.
Tornata da Bari presenta il mio libro in una grossa libreria nel centro di Sassari. Fu bellissimo, io recitai le parti scelte con una accorata enfasi. L'amore per Dana era intatto nel mio
cuore. Fu ricoperta di applausi dalla cinquantina di presenti. Ma di libri ne furono comprati solo tre. Fino ad allora anche nelle altre presentazioni non se ne erano vendute che poche copie,
tutte quelle che erano state cedute erano state comprate dalle amiche del forum e di FB. Due mie benefattrici me ne avevano regalato, comprandole dall'editore, 300 copie, che sono, più o meno,
tutte quelle che sono andate per il mondo fino a questo momento. Mi resi conto che di certo il mio libro non mi avrebbe arricchito, ma ugualmente alla fine di agosto venne dato alle stampe la mia
seconda opera, una raccolta di racconti autobiografici a cui diedi il titolo di Kaiki ed altre novelle. Di questo mio libro ne sono andate una 60ina di copie circa. Di certo vivere con la
letteratura non è cosa così facile e da tutti.
A giugno incontrai, sempre su FB, Vanessa che mi chiese in moglie, immediatamente presa da me. Io accettai un po' per gioco, un po' per speranza e ci sposammo pubblicamente sulla mia
bacheca, ricevendo una valanga di auguri, ma in tre giorni tutto finì: lei non era quello che aveva dichiarato di essere, mi aveva riempito di bugie.
Stavo dimagrendo ma il dolore restava invariato. E la disperazione anche. FB era tutta la mia vita, assieme alle telefonate di Sara.
A fine giugno mi recai ad Ariccia per una presentazione del mio libro e rividi Dana. La sua freddezza mi fece tanto male.
A luglio venne a trovarmi Sara e qualcosa sembrò cambiare per lei. Io ero ebbra di felicità, ma Sara se ne andò troppo presto, dopo pochi giorni e a casa ripiombò nelle sue crisi. Non mi
amava, non mi amava. Vennero allora Saura e Lu ed altri due o tre contatti più fuggevoli ma, nulla.. … erano scintille che si spegnevano affogate in storie assurde.....
A luglio fui ricoverata all'ospedale di Ozieri, perché all'improvviso ebbi dei grossi problemi alle braccia, al collo alla testa. Una serie di parestesie al viso alle braccia alle spalle
alle mani mi assalirono e da allora non sono mai passate: quelle parti del mio corpo sono sempre come peste e tramortite, friggono informicolite e una mano mi tira da dentro gli angoli della
bocca del naso e degli occhi. Il mal di testa si alzò notevolmente di tono e divenne perenne.
Mi furono eseguiti tutta una serie di accertamenti ed una risonanza magnetica a tutta la colonna, dato che la prima volta mi era stata fatta solo alla zona lombo sacrale. De essa e da altre
radiografie risultò che il mio bacino era crollato dalla parte destra di più di un centimetro, che avevo discopatia anche alla zona dorsale con numerose ernie e che la mia cervicale era assai
compromessa, pur se non vi erano ernie. Fui dimessa 15 giorni dopo un ricovero in un caldo insopportabile chiusa in una stanzuccia arroventata senza aria condizionata con il collare fisso per 40
giorni.
E il morale distrutto.
Chiesi un letto ortopedico per stare meglio, dato che non avevo pace, ma mi fu rifiutato perché il medico che mi aveva in cura nel reparto di neurologia mi disse che se mi fossi messa a
letto non mi sarei alzata mai più.
Devo dire che aveva ragione: ora il letto me lo sono comprato, ma almeno ho un posto dove giacere con una relativa pace. È vero che ora mi alzo pochissimo, ma anche allora stavo sempre a
letto, con il risultato che però soffrivo molto di più. E se adesso il dolore è quasi insopportabile, prima era da impazzire.
Cominciai una cura di infiltrazioni in un paesino a distanza di 50 chilometri dal mio, prima infiltrazioni di ozono, poi di cortisone ed antidolorifici e mangiai una quantità industriale di
costosissime pillole che avrebbero dovuto farmi bene, ma nulla fece effetto.
Alla fine la dottoressa algologa che si era presa cura di me con grande umanità e gentilezza, mi prescrisse l'oppiaceo, dato che non aveva più risorse.
E a tutt'oggi l'oppiaceo è l'unico medicinale che riesce a portare la mia sofferenza continua 24 ore su 24 ad una soglia sopportabile.
Ma i giorni erano e sono lunghissimi.
Arrivò agosto e Sara mi stupì. Io avevo cominciato a scrivere il mio terzo romanzo: Quello che non dico a nessuno, che terminai qualche mese dopo e che non pubblicherò mai.
Il titolo rende abbastanza chiaro il taglio del mio raccontare: avevo cominciato a narrare di quella parte intima che era la mia avventura, la mia vita erotica, il complesso processo che mi
aveva portato alla omosessualità, il duro lavoro di accettazione, la mia vita sentimentale inusuale ed anche scandalosa, se guardata con un occhio tradizionalista.
Scrivevo fino all'esaurimento delle forze, come sotto dettatura, troppe cose urgevano, come se poi non fossi stata più in grado di raccontarle ed in effetti sarebbe stato proprio
così.
Scrivevo e poi leggevo a lei e questo ci unì e risvegliò in lei quel sentimento di amore che io avevo sempre intravisto tra i suoi no. Mi trovavo assai male in Sardegna e cominciammo a
parlare di tornare in continente, magari a vivere in un qualche paese non troppo lontano da lei, forse a metà strada tra lei e i miei figli, in modo da poter ricevere agevolmente le visite di
tutti.
Ma il fato ha i suoi piani, e non si cura dei nostri.
Agli inizi di settembre ebbi uno stranissimo presentimento e scrissi nella mia bacheca: Qualcosa succederà. Devo aver paura?
Il 19 settembre la donna che io ho battezzato Eugenie mi telefonò per la prima volta e il 21 dello stesso mese ci trovammo indistricabilmente unite da una esperienza di eros
astrale.
Tutto quello che era stato prima di lei, compreso Sara e Dana, sparì all'incanto e da quel giorno esistette solo lei.
Ed ancora è così.
Non narrerò molto di quella storia.
Solo che erano mesi che io e lei ci scrivevamo, che io non sapevo che lei fosse la compagna di quella Vania che mi aveva così gentilmente aiutato, che quando l'ho saputo era troppo tardi
per staccarmi da lei. Che io e lei ci abbiamo provato in tutti i modi, a staccarci ed alla fine lei ci è riuscita.
Che io ho fatto di tutto perché questo non avvenisse, perché ogni volta che lei si è staccata da me, ed è successo innumerevoli volte nei 17 mesi della nostra storia, era come mi strappasse
le viscere, come mi squartasse.
Per questa ragione ho fatto e detto di tutto per convincerla a stare con me, anche le ho fatto ricatti affettivi, certo, minacciando il suicidio e dichiarando che, come tutt'ora credo,
quella nostra storia era il punto focale del nostro karma ed andava vissuta comunque.
Dirò solo che il 3 aprile dell'anno scorso, dopo quasi 7 mesi di un tira e molla micidiale, dopo che ci eravamo incontrate ed amate solo alla fine di dicembre – decisamente la fine di
dicembre per me è assai impegnativa – ho ingurgitato quel famoso mezzo chilo di veleno per topi, rifiutando per tre giorni ogni cura, ma inutilmente, perché anche questa volta non sono riuscita a
morire, anzi, non sono andata neppure in coma, tanto che è stato messo in dubbio la veridicità della assunzione da parte mia di quello, provata poi dagli esami del sangue, anche se inutilmente,
poiché questo dubbio ha minato indelebilmente la sua fiducia nei miei confronti, facendole pensare al mio gesto come una manovra per fini pensionistici e per ricattarla.
Dirò solo che il 17 febbraio di questo maledetto 2012 lei si è staccata definitivamente da me.
Ma continuando la mia particolare storia di vita, ad ottobre 2010 accolsi presso di ma Gine, cucciola di 50 giorni di meticcio simil bracchetto, di color fuliggine, da qui il suo nome che è
per intero Fuliggine Amaducci, che da allora è la mia inseparabile ombra e fonte di amore irrefrenabile ed incontenibile.
A marzo 2011 ho cambiato casa e paesino di residenza trasferendomi in un residence a Sorso, in riva al mare, dove mi trovo molto bene anche se sono molto più isolata e ho spese molto più
alte, per stare più vicina a lei, ad Eugenie, per avere la possibilità di incontrarci anche se solo ogni tanto, facendomi aiutare economicamente da mia madre ed acquistando anche una vecchia auto
usata. Nell'amore di lei avevo ritrovato il coraggio di rimettermi al volante e pur se per brevi tratti, avevo ricominciato a guidare.
A giugno 2011 è morto il mio caro Jerome, a quasi 15 anni di età, minato da un tumore incurabile. Ciao, piccolo grande cane, grazie.
Ad agosto 2011 ho preso presso di me Bainjo, un gattino maschio europeo colour point, comunemente detto siamese, che è diventato amico indivisibile di Gine e mio, micione ora di quasi 4
chili, vivace e con lo sguardo di ghiaccio e dalla espressione agguerrita e nervosa.
A giugno 2011 finalmente sono stata dichiarata invalida civile al 100 per 100 con accompagnamento e legge 162 per gli aiuti domiciliari, che sono partiti solo a gennaio 2012 per un totale
di 4 ore e mezza settimanali, aumentate ad aprile fino a 7 ore settimanali, della cui pensione ho ricevuto gli arretrati a settembre con i quali ho acquistato il letto ed altre cose di assoluta
necessità.
A ottobre 2011 mi è stata sospesa la patente, che di certo non mi verrà mai più riconsegnata anche per i miei gravi problemi visivi che sono subentrati dopo l'ultimo rinnovo, e che quindi
ora sono appiedata definitivamente.
Che a gennaio 2012 mi è stata assegnata anche una seconda sedia a rotelle, dopo quella elettrica, questa volta manuale, che uso in casa e per gli spostamenti in macchina, dato che è
pieghevole mentre l'altra no ed essendo ingombrante, serve un furgone per caricarla.
Oggi è il 6 aprile da 55 minuti, ed io scrivo da diverse ore.
Tante cose, troppe cose doveri ancora raccontare, ho cominciato un mese fa a scrivere la mia autobiografia ed ora che ho finito la riedizione di questo Io non sono di qui, mi ci
dedicherò.
La comporrò mettendo insieme tutto quanto già scritto in precedente, questo libro e gli altri due e scrivendo man mano che ricordo quello che non ho ancora narrato, ma non credo la
pubblicherò, anzi, ne sono certa, perché ho deciso che voglio scrivere tutto quello che penso e sento, ma questo offenderebbe troppe persone ancora in vita. Per questo motivo la mia autobiografia
sarà scritta e lasciata ai posteri, se ne vorranno avere un interesse, cosa che davvero non so..
Nel frattempo farò un sito web con la raccolta di tutti i miei scritti e le poesie e i quadri.
Il mio stato di salute che con l'amore di Eugenie aveva registrato un notevole miglioramento, pur se nei limiti di una vita a metà, ha segnato un repentino peggioramento. Vivo sempre a
letto ma quando mi alzo sto sulle sedie a rotelle. Se prima riuscivo a portare Gina a fare i bisogni a piedi per una ventina di passi e poco più e per qualche minuto, ora non riesco più perché le
gambe non mi reggono ed il dolore alla schiena diventa troppo forte. Ora non riesco più neppure a vestirmi da sola
inoltre un grave problema polmonare mi è subentrato che di certo mi porterà presto, ancora prima, spero, alla agognata fine di questa mia tragedia umana.
Ho qui narrato, in questo libro, un po' della mia infanzia, le parti salienti e dal 2007 ad aggi, anche se gli ultimi due anni possiedono narrazioni e scritti per migliaia di pagine, che
restano, anch'esse, per i posteri, quando io sarò andata ed anche lei, oppure se e quando lei desidererà che questi scritti, in parte suoi, siano resi pubblici.
Ma qui non sono narrati gli anni della mia adolescenza terribile, della mia giovinezza difficile, della mia precocissima maternità, avevo 19 anni quando nacque la mia prima figlia, di
quegli anni e poi della fine tribolata di quel matrimonio e del secondo, che fu per me una prova notevole. Della nascita e dell'infanzia degli altri due figli, dell'inizio dei miei problemi
economici che mi hanno portato alla povertà sulla la cui soglia ancora orgogliosamente siedo, felice di appartenere alla schiera dei derelitti e non degli affamatori. Dei miei primi problemi di
salute, dell'inizio dei miei viaggi tra le dimensioni, della fine dolorosa e tribolata negli anni del secondo matrimonio, dei cinque anni seguenti di solitudine, della beffa atroce di Riccardo,
da me amatissimo e al quale non chiesi nulla, che tutto mi promise e in un giorno mi negò precipitandomi dall'altissimo nel quale mi aveva portato agli inferi, e tutto a causa del vil
denaro.
Non ho narrato dei miei primi cinque tentativi di suicidio, di cui il primo a 12 anni, della mia ricerca della mia identità sessuale attraverso esperienze estreme e finalmente della luce
che arrivò, unendo il mio cuore al mio corpo nell'amore di una giovanissima donna , Kiara, che ovviamente mi amò e mi gettò nell'arco di pochi mesi, lasciando un cordoglio che mai fu sopito se
non da colei che fu ultima.
E neppure ho scritto di colei che venne dopo di questa giovanissima e che era schiava di droghe, che io tentai di salvare, che amai come mai avevo amato prima, ma che alla fine dovetti
abbandonare al suo destino, scegliendo la mia vita alla schiavitù nella quale mi aveva gettato, non della droga che lei usava, ma della sua follia e di quella della sua famiglia. La lasciai
quindi dopo due anni e lei pochi giorni dopo si gettò sotto un camion, in preda alla disperazione ad a quel mostro sintetico che era il suo padrone.
Non morì, ma perdette una gamba ed io ne fui separata allora con la forza e passai mesi e mesi a disperarmi in atroci sensi di colpa e a cercarla, ma quando poi la trovai e volli dedicarmi
a lei, di nuovo la sua famiglia ci divise.
E non racconto della parentesi della storia con Ale che celò nel suo grembo la fine di quella con la giovanissima Kiara, che proprio la notte in cui io fui certa, dopo averla attesa per
cinque anni, che sarebbe stata mia, mi tradì sotto i miei occhi con una di cui non le importava nulla e del dolore che questo scavò in me.
Non narro qui se non in parte dei 14 anni di cure psichiatriche. E dei successivi problemi di salute.
Ma soprattutto non narro delle sconvolgenti esperienze in dimensioni mai conosciute che ho condiviso con la mia Eugene.
Non narro di quanto io l'abbia amata e la ami tutt'ora, di come, di quante volte io l'abbia perduta e ritrovata, fino a perdere completamente la testa e non capire più nulla e non sapere
più nulla e l'abbia perduta nel modo peggiore, senza neppure la sua comprensione ed il perdono dei miei errori.
Non esiste un oceano abbastanza grande per contenere le maree delle mie lacrime, di quelle che ho versato, che verso ogni giorno e che verserò.
Non esiste un infinito abbastanza grande per contenere il mio dolore di lei ed il mio rimpianto.
E soprattutto non esiste qualcosa di talmente vasto perché possa contenere il mio amore per lei, che non avrò più e non vedrò più, di cui non udrò più la voce e vedrò il colore degli occhio
sentirò il tocco della mano.
Non vi è ora o minuto del giorno in cui io non dica a mia madre, ciò che gli umani chiamano morte, ma che io chiamo pace e luce, di venire a prendermi, che tanto ho dato, che troppo ho
vissuto e che troppo soffro.
Io l'attendo, con fede, perché so che verrà, perché ella verrà e su questo non vi è nessun dubbio.
E se ogni donna, ogni uomo che io ho amato mi ha rifiutato e se anch'ella mi ha rifiutato più volte, io so che, come di certo non avrò gli abbracci che ho perso, per cominciare con quelli
di mia madre e di mio padre per terminare con quelli di Dana ed Eugene, ebbene, io quell'abbraccio lo avrò.
E sarà l'unico che non perderò mai più.
Sarà quell'amore bianco che io avrò finalmente e per sempre.
Requiem.
Amen.
-----------------------------------------------------------------------------

CARISSIMI AMICI
inserisco da oggi, 17 agosto 2017, il tasto per ricevere vostre donazioni...
finora non vi ho mai chiesto nulla..
ho messo qui le mie opere perchè fossero a vostra disposizione e l'ho fatto come scelta politica e personale..
ma la mia vita è diventata durissima...
Mia madre non mi aiuta più in maniera costante ma solo molto saltuariamente.
i miei figli non mi parlano quasi...
il denaro che il mio ex marito mi diede in fase di divorzio, nel 2013, che mi ha permesso di sopravvivere fino ad ora, è terminato...
ricevo mensilmente 800 euro dallo stato ma 500 se ne vanno per l'affitto e le spese di casa..
capite che quel che resta non basta neppure per il cibo mio, per Brugola e per Stellina
Non vi chiedo un ingresso obbligatorio, chi non può o non vuole, continui pura a fruire dei contenuti del mio sito in maniera gratuita...
ma
ora tu, che entri qui per leggere, guardare, ascoltare, puoi aiutare arianna amaducci...
grazie se lo farai ..
fare una donazione è molto semplice, clicca sul tasto e segui le istruzioni...
non vi è un tetto minimo... bastano anche 50 centesimi ogni volta che passi di qui...
grazie, sinceramente
pace e luce nel tuo cuore e nella tua vita